IL CAFFÈ
ossia BREVI E VARI DISCORSI DISTRIBUITI IN FOGLI PERIODICI
Tomo secondo
Dal giugno 1765 per un anno seguente
| Testo critico stabilito da Gianni Francioni (Il Caffè 1764-1766, Torino, Bollati Boringhieri, 1998) |
| Indice Al lettore Indice de’ discorsi contenuti in questo secondo tomo Cesare Beccaria, De’ fogli periodici Pietro Verri, Il Singolare Gian Rinaldo Carli, Della patria degli Italiani Pietro Verri, Il Tu, Voi e Lei Paolo Frisi, Saggio sul Galileo Pietro Verri, La buona compagnia Pietro Verri, Le parole Alessandro Verri, Della eccellenza, utilità e giustizia della flagellazione de’ fanciulli. Ragionamento fra un Pedante ed un Ottentotto Pietro Verri, Dialogo fra un mandarino chinese e un Sollecitatore Le qualità dell’uomo Pietro Secchi, Contraddizioni morali Pietro Verri, Su i parolai Il pezzo seguente… Cesare Beccaria, I piaceri dell’immaginazione Luigi Lambertenghi, Sull’origine e sul luogo delle sepolture Pietro Verri, La musica Sebastiano Franci, Del lusso delle manifatture d’oro e d’argento Giuseppe Visconti, Della maniera di conservare robusta e lungamente la sanità di chi vive nel clima milanese Pietro Verri, Badi. Novella indiana Pietro Verri, alcuni pensieri sull’origine degli errori Alessandro Verri, Dei difetti della letteratura e di alcune loro cagioni Pietro Verri, Sul ridicolo Alessandro Verri, voti sinceri agli onesti letterati Alessandro Verri, Ragionamento sulle leggi civili Pietro Verri, Sulla fortuna Pietro Secchi, Del teatro Alessandro Verri, Comentariolo di un galantuomo di mal umore che ha ragione, sulla definizione: L’uomo è un animale ragionevole, in cui si vedrà di che si tratta Alessandro Verri, Degli errori utili Sebastiano Franci, Osservazioni sulla questione se il commercio corrompa i costumi e la morale Alessandro Verri, Le antiche querele… Alessandro Verri, La prova del cuore Alessandro Verri, Due pensieri Pietro Verri, Pensieri sulla solitudine Sebastiano Franci, Della precauzione contro le opinioni Alessandro Verri, Digressioni sull’uomo amabile, sulla noia e sull’amor proprio Alessandro Verri, Alcune idee sulla filosofia morale Pietro Verri, Sulla interpretazione delle leggi Agli scrittori del Caffè Alessandro Verri, Di Carneade e di Grozio Pietro Secchi, Esame d’alcune cagioni che tengono nell’attual mediocrità il teatro italiano Alessandro Verri, Di alcuni sistemi del pubblico diritto Alessandro Verri, La virtù sociale. Lettera di un institutore a Lucillo suo alunno Alessandro Verri, Alcuni pensieri Alessandro Verri, A Demetrio Giuseppe Visconti, intorno la malizia dell’uomo Pietro Verri, Sull’innesto del vaiuolo |
Al lettore
La piccola società di amici che ha scritti questi fogli è disciolta; alcuni hanno intrappreso un viaggio, altri sono impiegati in affari; vuole la necessità che si termini un lavoro che secondo il progetto degli autori non doveva sì presto chiudersi, e ciò accade nel tempo in cui l’accoglimento favorevole del pubblico più che mai invitava a proseguirlo. Se mai taluno prenderà a continuare i fogli del Caffè, come qualche voce è precorsa, è giusto che da noi siano prevenuti i nostri benevoli lettori che sarà questa continuazione lavoro d’altra mano; non è ragione che da noi si arroghi una gloria che non è nostra né che ci esponiamo a critiche non meritate. Noi ringraziamo quelle anime gentili che si sono degnate d’applaudire al nostro progetto e di fare coraggio a chi tentava di accrescere la coltura degli ingegni e diminuire il numero de’ pregiudizi volgari. Sarà questa per sempre la più cara meta de’ nostri studi.
Indice de’ discorsi contenuti in questo secondo tomo
SULLA LEGISLAZIONE ED ECONOMIA PUBBLICA
Dialogo fra un mandarino ed un sollecitatore
Sulle leggi civili
Sulla interpretazion delle leggi
Di Carneade e di Grozio
Su alcuni sistemi di diritto pubblico
Sul lusso delle manifatture d’oro e argento
Se il commercio corrompa i costumi
DELLA MORALE E DEL CUORE UMANO
La buona compagnia
Badi. Novella indiana
La prova del cuore
Precauzioni contro le opinioni
L’uomo amabile, la noia, l’amor proprio
Idee sulla filosofia morale
La virtù sociale
Della malizia dell’uomo
Sull’origine degli errori
Sul ridicolo
Sulla fortuna
Sulla solitudine
STORIA NATURALE E MEDICINA
Sul luogo delle sepolture
Precetti di sanità
Sull’innesto del vaiuolo
DI VARIA LETTERATURA
De’ fogli periodici
Il Singolare
Della patria degl’Italiani
Il Tu, Voi e Lei
Saggio sul Galileo
Le parole
Della flagellazion de’ fanciulli
Contraddizioni morali
Su i parolai
I piaceri dell’immaginazione
La musica
I difetti della letteratura
Voti sinceri agli onesti letterati
Del teatro
Commentariolo sulla ragione umana
Degli errori utili
Cagioni della mediocrità del nostro teatro
Alcuni pensieri
Lettera a Demetrio
)( Fogl. I )(
IL CAFFÈ
De’ fogli periodici
Quello che sono i libri stampati rispetto alla scrittura può quasi dirsi che lo siano i fogli periodici rispetto a’ libri stampati; e come questi tolsero dalle mani di pochi adepti le cognizioni e le sparsero nel ceto dei coltivatori delle lettere, così i fogli le cognizioni medesime che circolano nel popolo studioso comunicano e diffondono nel popolo o travagliatore od ozioso. Negli uni la fame del piacere, negli altri l’imperiosa povertà fanno sì che il più delle volte rivolgano più gli occhi alle cose medesime che ai più intimi rapporti di esse, e non vedendo in quelle altra connessione che quella del tempo con cui si succedono ed altra relazione che quella che influisce immediatamente sul loro ben essere, le considerano come isolate tra di loro, nessun sistema formandone, o se ne formano uno lo prendono ad imprestito da chi vuol loro risparmiarne la fatica. Gli uomini di questo genere, cioè la maggior parte, considerano un libro come un uomo che volesse entrare ne’ loro affari e riformar tutta la loro famiglia; sono ributtati dal timore di rovesciar tutto l’edificio delle loro idee; e gli uomini invischiati, per dir così, nell’abitudine soffrono nel doverne esser tratti. Ma un foglio periodico, che ti si presenta come un amico che vuol quasi dirti una sola parola all’orecchio, e che or l’una or l’altra delle utili verità ti suggerisce non in massa, ma in dettaglio, e che or l’uno or l’altro errore della mente ti toglie quasi senza che te ne avveda, è per lo più il più ben accetto, il più ascoltato. La distanza che passa tra l’autore di un libro e chi lo legge mortifica per lo più il nostro amor proprio, poiché il maggior numero non si crede capace di fare un libro; ma per un foglio periodico ognuno si crede abilità sufficiente, essendo poi sempre la mole e il numero i principali motori della stima volgare. Aggiungasi la facilità dell’acquisto, il comodo trasporto, la brevità del tempo che si consuma nella lettura di esso, e vedrassi quanto maggiori vantaggi abbia con sé questo metodo d’instruire gli uomini, e per conseguenza con quanta attenzione e sollecitudine debba essere adoperato da’ veri filosofi, e quanto meriti di essere incoraggiato e promosso da chi brama il miglioramento della sua specie. Entrate in una adunanza ove siano libri e fogli periodici, troverete che ai primi si dà per lo più un’occhiata sprezzante e sdegnosa, ed ai secondi un’occhiata di curiosità che vi fa leggere e fa legger tutti gli altri; e come la circolazione del denaro è avvantaggiosa, perché accresce il numero delle azioni degli uomini sulle cose, così la circolazione dei fogli periodici aummenta il numero delle azioni della mente umana, dalle quali dipende la perfezione delle idee e de’ costumi. Le donne poi, le leggieri e distratte donne, il di cui tacito impero cresce col numero degli oziosi e sulle quali gli uomini per lo più si modellano, sono dispostissime a trarre profitto da’ fogli periodici. Un libro, una seria e metodica instruzione sono droghe troppo forti per i delicati loro organi. Esse, che i sentimenti più dolci e più sedducenti non adottano per lo più che leggermente; esse, che scorrono piuttosto di quel che passeggino nel regno della sensibilità e che rade volte lasciano profonda traccia del loro cammino, come potranno resistere ai severi precetti della virtù, alla lunga catena delle verità contenute ne’ libri migliori ed al forte urto dell’eloquenza, che perde qualche volta la di lei efficacia per l’eccellenza? Ma un foglio periodico, che sono stimolate di leggere per il bisogno di nuovi oggetti, o perché presentato da una mano non indifferente, o perché la moda lo esigge, può giungere ad insinuare qualche utile verità tra quel minuto popolo di volubili idee che bullica loro nella mente. Felice quel filosofo che dalle amabili donne sarà letto: egli è sicuro di una numerosa schiera di lettori, e per conseguenza di persuadere un maggior numero. Gli uomini, forti e robusti padroni del mondo, se sono più tenaci nel ritenere, si oppongono altresì con una fibra più incallita alle scosse del vero; ma le donne, domatrici della ferocia dell’uomo, se sono più facili al cambiamento, sono anche più capaci di piegarsi alle dolci attrattive della virtù, e ciò che ponno perdere colla facilità della mutazione può supplirsi colla costanza e col rinovellamento delle impressioni. Felice l’umanità, se la virtù divenisse un ornamento alla moda, se la sensibilità alle altrui miserie diventasse un belletto che colorisse le guance delle gentili persone e se una lagrima sparsa su i lunghi e profondi mali dell’umanità diventasse un vezzo che potesse stare tra i merletti e i nastri! E perché non potiamo sperarlo nella bizzaria della moda, che tante cose rinovella e distrugge? La moda, quantunque inquieta e fantastica, può da una forza superiore esser diretta, ma forza che le se presenti non di fronte, ma di sbieco. Basterebbe che le dilicate dame facessero così per vezzo o per capriccio qualche prova di generosa virtù; vedrebbero quanto dolci, quanto durevoli sieno i di lei piaceri, quanto lustro e splendore ne acquisti la bellezza e come il fior di gioventù risalti tra la modestia, la beneficenza e la compassione; queste sole rendono venerabili le rughe della temuta vecchiezza, queste, piuttosto che un liscio che non cela le prede del tempo, rinverdiscono nella memoria degli uomini la ricordanza di un’onorata gioventù. Oh se alcuna di quelle sovrane bellezze che dan norma in una metropoli a tutte l’altre, legislatrici de’ più colti modi, ne cominciasse lo sperimento, qual folla d’imitatori e d’imitatrici si trarebbe dietro… Ma un sì dolce pensiero mi ha travviato dal mio soggetto. Se vi è speranza di una simile mutazione, se le cose scritte possono cangiare le direzioni del costume, ciò devesi sperare da’ fogli periodici piuttosto che da ogni altra sorta di scritto. La difficoltà consiste nell’esecuzione; consiste nel saper contentare i difficili e sdegnosi uomini di mondo, i quali, non avvezzi ad un lungo ragionamento, ma soltanto o alle facezie o alle riflessioni personali, cercano avidamente la felicità ed il piacere senza nemmen conoscerne la natura e le differenti relazioni di essi colle loro circostanze. Un discorso troppo elevato è da loro rifiutato in un foglio, benché mostrino d’intenderlo in un libro; un discorso famigliare, e che ragioni di fenomeni alla loro portata, è da loro considerato con disprezzo, come se nulla di nuovo contenesse, quasi che ogni foglio dovesse essere una nuova creazione, una invenzione di pianta, quasi nulla fosse l’abitudine di ragionar giusto su gli oggetti più comuni, e che per ciò appunto sono dalla più parte interi ricevuti senza analisi, senza discernimento, perché mancanti dello stimolo della novità, che dirigge l’attenzione della mente sulle cose. Il vero fine di uno scrittore di fogli dev’essere di rendere rispettabile la virtù, di farla amabile, d’inspirare quel patetico entusiasmo per cui pare che gli uomini dimentichino per un momento se stessi per l’altrui felicità; il di lui scopo è di rendere comuni, familiari, chiare e precise le cognizioni tendenti a migliorare i comodi della vita privata e quelli del pubblico; ma questo scopo dev’essere piuttosto nascosto che palese, coperto dal fine apparente di dilettare, di divertire, come un amico che conversi con voi, non come un maestro che sentenzi. Uno dei mezzi più efficaci dovrebb’essere l’apologo, antichissima maniera d’instruire nata nel seno del dispotismo, dal quale grandi cose sortirono quasi per ricompensare le generazioni venture della infelicità di chi vi era soggetto. Gli antichi facevano parlare gli animali e facevano maestri dell’uomo la volpe, il bue, la rana, il topo; ma in questo metodo vi è qualche cosa di duro e d’inverosimile, che se non era sentito dai primi uomini, meno sensibili e raffinati di noi, lo è senza dubbio in questo secolo dalle persone più colte e civili. Riescono più evidenti e palpabili gli avvantaggi della beneficenza, per esempio, se si dimostrino con fatti presi dagli uomini, che colla favola del leone e del topo. In questi piccoli racconti voi potete inserirvi mille riflessioni ed incidenti che conducono al vostro fine, anche stranieri al fatto che raccontate, che nelle favole voi siete costretto di non allontanarvi che pochissimo dalle circostanze che sono suggerite dalla natura degli animali che voi prendete per tipo. La cosa è così chiara, che non ha bisogno di ulteriore dimostrazione. Un altro mezzo sono i dialoghi; questi conducono moltissimo a mettere in chiaro una verità, rappresentando con forza e con industria il pro ed il contro di essa, ed essendo una fedele pittura del conversare degli uomini, sono suscettibili d’una infinità di caratteri differenti, sì ridicoli e viziosi che giusti e virtuosi, e possono essere sorgente feconda di vario diletto. Il terzo metodo e vantagiosissimo è quello dei seri ragionamenti, che invitino alla virtù non per i motivi rigorosi del dovere, ma per quelli dell’utile, non colla geometrica dimostrazione, ma col dolce incanto di una mansueta eloquenza non trasportata né sublime, perché mette in guardia i lettori, non vile e triviale, perché genera disprezzo e noia. Qui non si parla né ai sublimi, né ai stupidi e zotici uomini, ma a quella parte del genere umano che trovandosi fra questi estremi oscilla perpetuamente o verso l’uno o verso l’altro. Caratteri e pitture di costume, esempi veri tratti dalla storia di generosità e di virtù, la sferza del ridicolo su i difetti degli uomini e non sui vizi possono condire col diletto e colla dolcezza ciò che la prevenzione e l’inesperienza farebbero credere disgustoso ed amaro. Le cognizioni poi utili al maggior numero sono quelle che devono spiccare ne’ fogli di tal natura, e queste possono esebirsi in due maniere: l’una, col rendere a chiarezza e precisione, e quasi in sugo ed in sostanza, ciò che trovasi sparso, oscuro, confuso e quasi direi nuotante in volumi ripieni d’amor proprio per l’autore e di noia per il lettore. Le verità fondamentali e le conseguenze utili di esse si riducono a un assai minor numero di quello che non si pensa comunemente. L’altra maniera è di dare delle viste e dei lumi che facciano pensare e fermentare le idee di chi legge: i fogli periodici debbono essere una miniera di tentativi e di suggerimenti, scritti in maniera che lusingando l’amor proprio de’ lettori lascino ad essi il merito più che si può dell’invenzione. L’agricoltura, le arti, il commercio, la politica sono quelle cognizioni che ogni cittadino non manuale dovrebbe meno ignorare; feconde di nuove produzioni possono appagare la curiosità di ciascuno, e più universalmente coltivate conducono alla felicità d’uno Stato. La fisica e la storia naturale sono una miniera inesausta di ricerche e di avvantaggiosissime scoperte, ed hanno una connessione più generale e più estesa colle scienze, che paiono anche più remote da quelle che non si crede volgarmente da alcuni. La sovrabbondanza delle ricerche, il superfluo delle cognizioni non possono che da un caustico metodista rigettarsi; gli uomini non avrebbero mai ritrovato l’utile, se al superfluo non si fossero avventati, e compensando la debolezza della lor mente col numero delle combinazioni esercitate sulle cose, cresce la probabilità di qualche utile risultato nella moltiplicità dei tentativi. Finalmente i fogli periodici nontanto devon servire ad estendere le cognizioni positive, quanto contenerne molte di negative, vale a dire a distruggere i pregiudizi e le opinioni anticipate, che formano l’imbarazzo, il difficile e, direi quasi, il montuoso e l’erto di ogni scienza; ad ogni verità grande ed interessante mille errori e mostruose falsità stanno d’attorno, che la inviluppano e la nascondono agli occhi non sagaci, ed è questo sicuramente una gran parte della scienza dei secoli più illuminati; essi travagliano più a distruggere che ad edificare, e così facendo edificano insensibilmente; e questa è la cagione che la verità semplice, bella, che scoperta par quasi impossibile a non discoprirsi, non riconoscesi che difficilmente per la fecondità dell’errore, a cui mille tortuosi labirinti vi strascinano, e per la simplicità del vero, per giungere alla quale non vi sono altre strade che quelle dei pochi veri già conosciuti. Tutti questi metodi devono essere con molta industria variati e misti fra di loro, perché essendo ciascuno eccellente nel suo genere, lasci colla continua mutazione desiderio e curiosità di vederlo proseguito, né stanchi giammai colla noiosa uniformità, che spande su d’ogni cosa il letargo ed il sonno.
Un altro genere di fogli periodici, non meno utili benché meno brillanti dei primi, sono quelli che contengono novelle di ogni genere; questi per lo più non contengono che novelle o politiche o letterarie; ma sarebbe desiderabile che si estendessero ad ogni sorta di fatti politici, morali, di scienze, di arti; così potrebbe la curiosa posterità vedere il nostro secolo in massa ed in dettaglio; così potremmo noi, il che più ci deve interessare, dall’abbondanza delle cose cavarne ogni genere di viste morali, politiche o fisiche, appagando nello stesso tempo quel genere di persone a cui la novità serve d’alimento e di vita. Queste novelle ci rendono quasi concittadini di tutta l’Europa; queste producono un continuo commercio nelle differenti nazioni, e distruggono quella diffidenza e quello sdegno con cui le nazioni solitarie risguardano le straniere. Tutto tende in Europa ad avvicinarsi e ad accomunarsi, e vi è un maggiore niso verso l’uguaglianza che non era per lo passato; tutto ciò devesi alla comunione delle idee e dei lumi, e il moto che scorgesi in essa, e che tanto inquieta coloro i cui sguardi sono circoscritti da un secolo, sembrami simile a quel moto di trepidazione che scorgesi ne’ fluidi prima di mettersi in equilibrio. Parlando poi particolarmente dei giornali letterari, ciascuno ne conosce l’utilità, e l’Europa ne abbonda; ma non tutti veggono gl’importantissimi difetti che accompagnano per lo più questa sorta di produzioni; moltissimi non sono esatti, trascurano di parlare di quei libri, gli autori de’ quali hanno trascurato d’inviarne loro la notizia, quasi che l’utile non indifferente che ne ricavano non esigesse da loro per giustizia le opportune pratiche per le necessarie corrispondenze. Alcuni, in luogo di dare un estratto fedele del libro, perdono il tempo in preamboli e prefazioni, nelle quali spicca bensì l’ingegno dell’autore, ma si manca al fine di un giornalista. Alcuni non citano che pochi squarci del libro, credendo con ciò di darne un’idea ai lettori. Altri, cedendo all’ambizione di divenire dittatori della liberissima repubblica delle lettere, giudicano con sovrana autorità in ogni scienza, in ogni classe dell’intera enciclopedia; quindi continui disinganni ricevono coloro che si dan la pena di confrontar le opere co’ giornali che ne parlano; quindi una perpetua sommessione al giudizio altrui, che fino nelle umane scienze introduce il dispotismo e l’immobilità ne’ progressi del vero e dell’utile; quindi, tolta la spartana libertà dei voti, i giudizi si vendono a prezzo, o sono dettati dalla contemplazione e dagli offici, e dall’odio e dallo spirito di partito avvelenati; ed il timore, la speranza, l’inclinazione o il contragenio sottentrano alla fredda indifferente ricerca del vero. Sembrami che la più utile forma che dar si potrebbe alle novelle letterarie sarebbe quella che più difficilmente potrà trovar chi vi si accinga, perché più modesta e meno brillante, cioè una fedele, completa ed esatta notizia d’ogni libro, contenente la divisione e l’indice delle principali materie che vi si trattano, il sesto, il prezzo, il pregio dell’edizione e lo spaccio di essa, senza giudizio, senza prefazioni e complimenti, lasciando che l’estratto faccia conghietturare da se stesso del valore del libro. Solo, dalle novelle vorrei onninamente proscrivere i libri che contengono contumelie, oscenità, irreligione, calunnie anche contro il minimo privato; questa solenne proscrizione sarebbe una pena forse reprimente la viltà di alcuni scrittori, vedendosi obbliati in quelle novelle, nelle quali il più meschino libretto dovrebbe esservi registrato. La picciolezza della mole, il sicurissimo esito di tali fogli dovrebbe animare coloro che amano un onesto guadagno, dovrebbe animare quei veri filosofi che sanno essere superiori agli immediati e palpabili avvantaggi per altri più sublimi e meno sensibili alle viste comuni: la pubblica utilità, lo spandimento della luce, l’accrescimento del numero de’ lettori, e de’ lettori docili alla verità.
Ognuno de’ nostri lettori si sarà accorto che parlando di fogli periodici non vorremo trascurare di parlare del nostro. Il favorevole accoglimento fattogli l’anno passato ci anima e ci spinge a continuarlo anche per quest’anno, ed a proccurare con ogni studio e buona volontà di renderlo grato, vario e di qualche utilità ai nostri lettori. Chiunque ha veduto i fogli dell’anno passato sa che vi si contiene il risultato delle conversazioni tenutesi in una bottega di caffè, ed altri discorsi che ci vengono esebiti da porre ne’ nostri fogli, a cui perciò abbiamo dato il titolo che portano. L’usanza degli scrittori è di domandar perdono con superba modestia ai lettori dei difetti delle opere. Noi non ne chiediamo alcuno; sarem letti se saremo ragionevoli, non lo saremo se cesseremo di esserlo; né dovremmo proseguire il nostro lavoro se lo giudicassimo degno del pubblico perdono. Noi fortunati, se con questi scritti potremo acquistare un buon cittadino di più alla patria; un buon marito, un buon figlio, un buon padre ad una famiglia; se avremo spinto alle utili cognizioni qualche giovine atterrito dall’austero e puramente fattizio abito che si è dato alle scienze, o ritroso per una insegnata diffidenza, che piega gli uomini agli uomini, ma non gli uomini alle cose! Questi sono i più sinceri nostri voti; e benché amanti come gli altri uomini delle lodi e degli applausi, osiamo di più avere desiderio di meritarli.
C. [Cesare Beccaria]
Il Singolare
Trovai ier sera un uomo nel caffè, d’un carattere e d’un umore tanto curioso che merita veramente ch’io ne faccia qualche menzione ne’ miei fogli. Questo è un uomo che pare che ami la singolarità delle opinioni anche più che non la verità, e che dell’ingegno se ne prevalga più per difendere i suoi paradossi anzi che per indagare la vera indole degli oggetti. Portò il caso che cadesse il discorso sull’architettura, ed ei cominciò col dire che Vitruvio, Palladio, Vignola, Michelangelo e simili non hanno mai ben ragionato sulla maniera comoda d’alloggiare. Qual invenzione, diss’egli, più sgraziata, più ridicola che quella delle scale? Che? Non è forse bastantemente vasta la terra perché gli uomini in lungo e in largo vi si stendino, e dovransi da un canto trovare sterminati deserti abbandonati affatto, e dall’altro dovransi sopraimporre una, due, tre case, e per giungervi poi formare quell’ammasso disordinato di sassi che chiamasi la scala; dove ritrovi il vecchio ansante, il fanciullo col capo rotto, dove perdesi uno spazio inutilmente, senza che l’occhio possa mai esserne pago? Ma, soggiuns’io, signore, come vorreste voi che dal pianterreno si salisse altrimenti al piano superiore? Primieramente, rispose il mio Singolare, primieramente il piano superiore non vi dev’essere; così si vive senza rumore sul capo e senza tanti pericoli pe’ tremuoti. Vedete l’Asia quasi tutta, l’Asia non usa piani superiori; ogni casa è tanto sollevata dal pavimento quanto è alta la stanza d’abitazione; così nelle città si respira un’aria salubre; così le strade non sono più tanti tristissimi canali incavati quasi nella superficie della terra, ma anzi sono ameni viali che invitano al passeggio. Secondariamente poi, quand’anche vogliate ostinatamente aver un piano superiore, fatevi un’andata come la natura la fa nelle colline, e per tutto ove forza è d’ascendere fate un piano inclinato senza quegl’inospiti inciampi che chiamate gradini, i quali sono veramente contrari ad ogni ragione. Parlò poi in seguito delle finestre, e molto declamò contro l’uso di farle o verso strada o verso il cortile, sostenendo che queste sono altrettanti inviti ai ladri, altrettante aperture per le quali entra ad assordarvi il mormorio della strada, o vedonsi gli affari domestici dagli estranei. E dove prenderà Vossignoria la luce? D’onde?, rispose il mio Singolare, dalle cupole che termineranno il volto d’ogni stanza. La luce ci vien dal cielo, e dal cielo si dee prendere, e così potete far uso di tutt’i lati della stanza anche dove le finestre ve lo impedirebbero. Molte sì fatte cose ancora ci disse sull’architettura, indi terminato questo soggetto, taluno della bottega si lagnò col nostro caffettiere Demetrio, perché non fosse bastantemente caldo il caffè. Caldo!, esclamò il Singolare, possibile che il pregiudizio di sorbir caldo il caffè sussista ancora malgrado la più evidente ragione in contrario! Io sono nemicissimo di tutte le bevande o calde o fredde, l’azione sì del calore che del freddo s’esercita sulla lingua e sul velo palatino con tal forza che diminuisce notabilmente il senso che deve farci distinguere la bevanda; non si distingue mai bene verun cibo, o droga, o bevanda se ella non sia a un tal grado da non far sentire né freddo né caldo al palato; il caffè io lo prendo sempre tepido. Oh! a proposito di caffè, prese a dire un altro, il primo tomo del foglio del Caffè è già perfezionato; e a quello che si dice gli autori pensano di continuare ancora per un anno. Sì?, rispose il Singolare, va benissimo. Vi saranno, al conto che ho fatt’io, a quest’ora settecento cinquanta mila libri stampati, e noi dovremo l’obbligazione agli scrittori del Caffè di contare settecento cinquanta mila e uno. Io che procuro di non lasciarmi contaminare dalle malattie degli autori, non ho preso nessun partito contro il mio Singolare; ognuno ha le proprie opinioni; e chi vuol farsi leggere dal pubblico deve essere tollerante dei giudizi diversi che ciascuno ha diritto di proferire; solamente l’interrogai quale opinione avesse del mestiere di far libri; ed ei mi rispose che era l’opposto del mestiere d’un venditore di caffè, poiché i libri fanno addormentare ed il caffè risveglia. Vennero allora ad avvertirlo che era giunta la sua carrozza, ei ci lasciò; e osservai che la carrozza aveva due timoni e un cavallo solo. Se il mio Singolare, di cui non so né il nome né l’alloggio, vuol trasmettermi qualche cosa da lui scritta, io gli prometto d’inserirla nel foglio, e son sicuro che non dispiacerà a’ nostri lettori.
P. [Pietro Verri]
Il Caffè )( Fogl. II )(
Della patria degli Italiani
Sono nelle città le botteghe del caffè ciò che sono nella umana macchina gl’intestini; cioè canali destinati alle ultime e più grosse separazioni della natura, ne’ quali ordinariamente per qualche poco tempo quelle materie racchiudonsi, che se in porzione qualunque obbligate fossero alla circolazione, tutto il sistema fisico si altererebbe. In queste botteghe adunque si digeriscono i giuocatori, gli oziosi, i mormoratori, i discoli, i novellisti, i dottori, i commedianti, i musici, gl’impostori, i pedanti e simil sorta di gente, la quale se tali vasi escretori non ritrovasse, facilmente nella società s’introdurrebbe, e questa ne soffrirebbe un notabile pregiudizio. Tale però, almeno in alcune ore del giorno, non è la bottega del nostro Demetrio, in cui se talvolta qualche essere eterogeneo vi s’introduce, per ordinario di persone di spirito e di colto intelletto è ripiena, le quali scopo delle loro meditazioni e de’ loro discorsi si fanno la verità e l’amore del pubblico bene; che sono le due sole cose per le quali asseriva Pitagora che gli uomini divengono simili agli dei.
In questa bottega s’introdusse ier l’altro un incognito, il quale nella sua presenza e fisonomia portava seco quella raccomandazione, per la quale esternamente lampeggiano le anime sicure e delicate; e fatti i dovuti offizi di decente civiltà, si pose a sedere chiedendo il caffè. V’era sfortunatamente vicino a lui un giovine Alcibiade, altrettanto persuaso e contento di sé quanto meno persuasi e contenti sono gli altri di lui. Vano, decidente e ciarliere a tutta prova. Guarda egli con un certo sorriso di superiorità l’incognito; indi gli chiede s’era egli forestiere. Questi con un’occhiata da capo a’ piedi, come un baleno squadra l’interrogante, e con una certa aria di composta disinvoltura risponde: No, signore. È dunque milanese?, riprese quegli. No, signore, non sono milanese, soggiunge questi. A tale risposta, atto di maraviglia fa l’interrogante; e ben con ragione, perché tutti noi colpiti fummo dall’introduzione di questo dialogo. Dopo la maraviglia, e dopo la più sincera protesta di non intendere, si ricercò dal nostro Alcibiade la spiegazione. Sono italiano, risponde l’incognito, e un italiano in Italia non è mai forestiere come un francese non è forastiere in Francia, un inglese in Inghilterra, un olandese in Olanda, e così discorrendo. Si sforzò in vano il milanese di addurre in suo favore l’universale costume d’Italia di chiamare col nome di forestiere chi non è nato e non vive dentro il recinto d’una muraglia; perché l’incognito interrompendolo con franchezza soggiunse: Fra i pregiudizi dell’opinione v’è in Italia anche questo; né mi maraviglio di ciò, se non allora che abbracciato lo veggo dalle persone di spirito, le quali con la riflessione, con la ragione e col buon senso dovrebbero aver a quest’ora trionfato dell’ignoranza e della barbarie. Questo può chiamarsi un genio mistico degl’Italiani, che gli rende inospitali e inimici di lor medesimi, e d’onde per conseguenza ne derivano l’arenamento delle arti e delle scienze, e impedimenti fortissimi alla gloria nazionale, la quale mal si dilata quando in tante fazioni o scismi viene divisa la nazione. Non fa (seguitò egli) certamente grande onore al pensare italiano l’incontrare, si può dire ad ogni posta, viventi persuasi d’essere di natura e di nazione diversi da’ loro vicini, e gli uni cogli altri chiamarsi col titolo di forestieri; quasicché in Italia tanti forestieri si ritrovassero quanti Italiani.
Da questo genio di emulazione, di rivalità, che dai Guelfi e Gibellini sino a noi fatalmente discese, ne viene la disunione, e dalla disunione il reciproco disprezzo. Chi è quell’italiano che abbia coraggio di apertamente lodare una manifattura, un ritrovato, una scoperta, un libro d’Italia, senza il timore di sentirsi tacciato di cieca parzialità, e di gusto depravato e guasto? A tale interrogazione un altro caffetante, a cui fé eco Alcibiade, esclamò che la natura degli uomini era tale di non tenere mai in gran pregio le cose proprie. Se tale è la natura degli uomini, riprese l’incognito, noi altri Italiani siamo il doppio almeno più uomini degli altri, perché nessun oltremontano ha per la propria nazione l’indifferenza che noi abbiamo per la nostra. Bisogna certamente che sia così, io risposi. Appare Newton nell’Inghilterra, e lui vivente l’isola è popolata da suoi discepoli, da astronomi, da ottici e da calcolatori, e la nazione difende la gloria del suo immortale maestro contro gli emoli suoi. Nasce nella Francia Des Cartes, e dopo sua morte i Francesi pongono in opera ogni sforzo per sostenere le ingegnose e crollanti sue dottrine. Il Cielo fa dono all’Italia del suo Galileo, e Galileo ha ricevuti più elogi forse dagli estranei a quest’ora, che dagli Italiani.
Fattasi allora comune, in cinque ch’eravamo al caffè, la conversazione, e riconosciuto l’incognito per uomo colto, di buon senso e buon patriota, da tutti in vari modi si declamò contro la infelicità a cui da un pregiudizio troppo irragionevole siam condannati di credere che un italiano non sia concittadino degli altri Italiani, e che l’esser nato in uno piuttosto che in altro punto di quello spazio
Che Appenin parte, il mar circonda e l’Alpe
confluisca più o meno all’essenza o alla condizione della persona. Fu allora che rallegratosi un poco l’incognito cominciò a ragionare in tal guisa: Dacché convinti i Romani della gran massima attribuita al primo dei loro re di avere gli uomini in un solo giorno nemici prima, e poi cittadini, si determinarono per la salvezza della repubblica ad interessare tutta Italia nella loro conservazione, passo passo tutti gl’Italiani ammisero all’amministrazione della repubblica: il perché non vi fu più distinzione di Quiriti, di Latini, di provinciali, di colonie, di municipi; ma dal Varo all’Arsa tutti i popoli divennero in un momento Romani. Ora, tutti sono Romani, parlando degli Italiani, dice Strabone. Tutti adunque partecipi degli onori di Roma, e tutti ridotti alla medesima condizione con la sola distinzione del censo, cioè di patrizi e di plebe. Se le nazioni dovessero gareggiar fra di esse per la nobiltà, noi Italiani certamente non la cediamo a nessun’altra nazione d’Europa; perché trattone alcune colonie, e la posteriore indulgenza degli imperadori, allorché spento era il vigor de’ Romani, erano tutte alla condizione di provincia rette da magistrati italiani e da regolata milizia tenuti in dovere; nel tempo che l’Italia rerum domina si chiamava, come prima dicevasi la sola Roma.
In cotesti tempi crediamo noi che un patrizio, italiano fosse più o meno d’un altro, o fosse forestiero in Italia? No certamente; se persino la suprema di tutte le dignità, cioè il consolato, comune sino agli ultimi confini d’Italia si rese. Siamo stati dunque tutti simili in origine; che origine di nazione io chiamo quel momento in cui l’interesse e l’onore la unisce e lega in un corpo solo e in un solo sistema. Vennero i barbari, approfittando della nostra debolezza, ad imporci il giogo di servitù, non rimanendo se non che in Roma un geroglifico della pubblica libertà nella esistenza del Senato romano. Sotto a’ Goti pertanto siamo tutti caduti nelle medesime circostanze, e alla medesima condizione ridotti. Le guerre insorte fra Goti e Greci, la totale sconfitta di quelli e la sopravenienza de’ Longobardi han fatto che l’Italia in due porzioni rimanesse divisa. La Romagna, il Regno di Napoli e l’Istria sotto ai Greci; e tutto il rimanente sotto de’ Longobardi. Una tal divisione non alterò la condizione degl’Italiani, se non in quanto che quelli che sotto a’ Greci eran rimasti seguirono a partecipare degli onori dell’Impero trasferito in Costantinopoli, memorie certe ne’ documenti essendosi conservate di Romagna, d’Istria e di Napoli dei tribuni e degli ipati o consoli; nel tempo che l’altra parte d’Italia sotto il tiranno governo dei duchi e dei re barbari si perdeva. Ma rinovato l’impero in Carlo Magno, eccoci di nuovo riuniti tutti in un sistema uniforme. Questo fu lo stato d’Italia per lo spazio di undici secoli; e questo non basta a non persuader gl’Italiani d’essere tutti simili fra di loro, e d’esser tutti Italiani.
Qui dolcemente interrogò un caffetante, più per piacere che la conversazione progredisse più oltre che per vaghezza di opporsi, s’egli credesse che dopo tali tempi gl’Italiani patito avessero sproporzionatamente qualche deliquio o alterazione di stato, o sia di condizione e di dignità. Dopo tali tempi, il nostro incognito prontamente soggiunse, è noto ad ognuno cosa accadesse. La distanza degl’imperadori, la loro debolezza e la gara fra i concorrenti all’impero diede comodo agli Italiani di risvegliare e porre in moto i sopiti spiriti di libertà; e ciascheduna città dal canto suo tentò di scuotere un giogo che non aveva origine da verun diritto, ma bensì dalla forza sola, e che per la tirannia era divenuto insopportabile. Allora fu che modificandosi in varie guise questo originario e perdonabile trasporto di obbedire alle leggi, e non all’altrui volontà, alcune delle città si eressero, o per meglio dire ritornarono ai propri principii d’un governo repubblicano; ed alcune altre sotto a’ propri capi, o ecclesiastici o secolari, esperienza fecero delle proprie forze. Quindi ne venne che alcuni italiani delle proprie città divenissero padroni o sovrani; ed alcune altre nella condizione di repubblica si mantenessero. Felice l’Italia se questo comune genio di libertà sparso per tutta questa superficie fosse stato diretto ad un solo fine, cioè all’universale bene della nazione! Ma i diversi partiti del sacerdozio e dell’impero tale veleno negli animi degl’Italiani introdussero, che non solo città contro città, ma cittadino contro cittadino, e padre contro figlio si vide fatalmente dar mano all’armi. Allora alcune città, mercé l’industria e il commercio, della debolezza delle altre s’approfittarono; né la pace di Costanza altro produsse, che fomentando la disunione, preparar le città quasi tutte a perdere interamente la libertà per quella medesima via per la quale credevano di ricuperarla. Ora ciò posto, qual differenza ritrovar si può mai fra italiano e italiano, se uguale è l’origine, se uguale il genio, se ugualissima la condizione? E se non v’è differenza, per qual ragione in Italia tale indolenza per non dire alienazione, regnar deve fra noi da vilipenderci scambievolmente, e di credere straniero il bene della nazione?
Ma il nostro Alcibiade riscosso come da un sonno, e come se nulla avesse inteso del seguito ragionamento, prendendo con una certa tal quale impazienza il risultato di esso, cioè le ultime parole, esclamò: Se le vostre massime si rendessero comuni, non vi sarebbe più distinzione fra città e città, fra nobile e nobile, e inutili ornamenti sarebbero i contrassegni d’onore e le decorazioni che ci vengono dalle mani dei principi!
E che male ci trovereste voi, soggiunse l’incognito, in tal sistema? Una muraglia, che chiuda e cinga trentamila case, ha forse per qualche magia acquistata prerogativa maggiore d’un’altra, che non ne cinge che mille; quando tanto nell’una che nell’altra il popolo sia della medesima origine e della medesima condizione? Non nego io già, che dati i pregiudizi e gli scismi presenti, non dobbiamo anche a questi donar qualche cosa, e distinguere le città che non sono ad altre leggi soggette che alle proprie; e dopo queste distinguere ancora le città di primo e di secondo rango: cioè quelle che sono state partecipi della maggiore di tutte le nobiltà, vale a dire della romana, che nel tempo di mezzo ritornarono allo stato repubblicano, e che capitali sono di provincia, o di considerabile territorio; da quelle altre che origine hanno meno lontana, e che in provincia sono ridotte. Rispettabili altresì sono i personali distintivi caratteri degli individui, come pubbliche testimonianze del loro merito, sia per uffizi e dignità ch’essi coprono, sia per onori d’opinione onde sono così coperti, cosicché venerabili sono le insegne tutte dai quadrupedi ai volatili sino all’ultima stella della coda dell’Orsa Minore, e da questa alle intellettuali sostanze dell’Empireo: ma non per questo si dirà mai che un italiano sia qualche cosa di più o di meno d’un italiano, se non da quelli a’ quali manca la facoltà di penetrare al di là del confine delle apparenze, e che pregiano una pancia dorata e inargentata più che un capo ripieno di buoni sensi ed utilmente ragionatore. Alziamoci pertanto un poco, e risvegliamoci alla fine per nostro bene. Il Creatore del tutto nel sistema planetario pare che ci abbia voluto dare un’idea del sistema politico. Nel foco dell’elissi sta il Sole. Pianeti, o globi opachi, che ricevono il lume da lui, vi si aggirano intorno nel tempo medesimo che sopra i propri assi eseguiscono le loro rivoluzioni. Una forza che gli spinge per linea dritta contro un’altra che al Sole medesimo gli attrae, fa che un moto terzo ne nasca; onde secondo le reciproche loro distanze e grandezze mantengano intorno al centro comune il lor giro. Alcuni di questi globi intorno di sé hanno de’ globi più piccoli, che con le medesime leggi si muovono. Alcuni altri sono soli e isolati. Trasportiamo questo sistema alla nostra nazionale politica. Grandi o picciole sieno le città, sieno esse in uno o in altro spazio situate, abbiano esse particolari leggi nelle rivoluzioni sopra i propri assi, siano fedeli al loro natural sovrano ed alle leggi, abbiano più o meno di corpi subalterni: ma benché divise in domini diversi e ubbidienti a diversi sovrani, formino una volta per i progressi delle scienze e delle arti un solo sistema; e l’amore di patriotismo, vale a dire del bene universale della nostra nazione, sia il Sole che le illumini e che le attragga. Amiamo il bene ovunque si ritrovi; promoviamolo ed animiamolo ovunque rimane sopito o languente; e lungi dal guardare con l’occhio dell’orgoglio e del disprezzo chiunque per mezzo delle arti o delle scienze tenta di rischiarare le tenebre che l’ignoranza, la barbarie, l’inerzia, l’educazione hanno sparso fra di noi; sia nostro principale proposito d’incoraggirlo e premiarlo. Divenghiamo pertanto tutti di nuovo Italiani, per non cessar d’esser uomini.
Detto questo s’alzò improvvisamente l’incognito, ci salutò graziosamente e partì, lasciando in tutti un ardente desiderio di trattare più a lungo con lui e di godere della verità dei di lui sentimenti.
[Gian Rinaldo Carli]
Il Tu, Voi e Lei
Gli antichi Italiani, ne’ tempi ne’ quali da Roma si spedivano i decreti all’Inghilterra ed alla Siria, parlandosi l’un l’altro usavano la seconda persona singolare, e così scrivendo Orazio ad Augusto diceva:
Godi piuttosto un nobile trionfo, | Ed udirti acclamar Principe e Padre: | Né inulto cavalcar veggasi il Parto, | Te Duce Augusto.
Né altro modo di conversare era in que’ tempi conosciuto in Italia. Credevasi allora che i precetti dell’urbanità non fossero giammai violati dalla natura delle cose, e perciò per disegnar la persona sola alla quale si parlava, dicevasi Tu. Noi, che grazie al Cielo abbiamo degli oggetti che ci occupano assai più vasti di quelli che non avevano gli antichi Italiani, noi che per conseguenza siamo uomini d’una importanza altrettanto maggiore, non soffriamo che ci venga dato del Tu; e la ragione si è perché ciascuno di noi vale almeno per due, onde in tutta confidenza ci vien dato del Voi, anzi malcontenti di valer per un paio, esigiamo con ogni ragione che nessuno ardisca d’indirizzare il discorso né supponendoci uno, né supponendoci più d’uno, ma bensì che si parli alla nostra Signoria. Noi propriamente siamo tanti sultani, e chi ci parla non deve osar di parlare a noi, ma deve esporre i suoi pensieri alla nostra inseparabile Signoria, che fa l’ufficio di gran visir. I Tedeschi sono andati ancora più oltre di noi, poiché, sembrando troppo modesta la creazione d’un solo gran visir, hanno creati molti gran visir per un sultano solo, e così parlano sempre a Loro, terza persona del numero plurale. Da queste vaghe invenzioni de’ nostri antenati ce n’è venuto il vantaggio di trovarci in continua dissensione colla grammatica, di dover rendere le idee nostre con infiniti giri di parole, di snervare sensibilmente tutto ciò che vogliam dire e di tassellare il discorso con moltissime riempiture che non contengono veruna idea. Nello scrivere poi con tante raffinatissime invenzioni è cosa da rovinar un galantuomo, perché bisogna supplicare divotamente la Sua Signoria a concederci l’onore de’ riveriti suoi comandamenti, e la gloria di protestarci divotissimi ed obbligatissimi servitori, cose tanto gentili e belle, che se le trovassimo scolpite sulle piramidi d’Egitto da que’ scultori medesimi che adoravano le cipolle, i cocodrilli e i buoi, ancora dovrebbero parere strane alla ragione. Se a Tullio allorché faceva la soprascritta delle sue lettere in questi termini, A Cesare Imperatore, avesse taluno detto: Sappi, Tullio, che da qui a diciotto secoli, in questo luogo stesso ove tu scrivi, si dovrà al più meschino avvocatello scrivere così: All’Illustrissimo Signore Signore Padrone Colendissimo il Signor Avvocato Tale, che avrebbe mai pensato il consolare Tullio in que’ tempi? I Francesi e gl’Inglesi si sono dipartiti dalla ragione meno di noi; ma i Francesi camminano già alla terza persona di gran galoppo; e i più naturali e costanti nel bene su questo articolo fralle nazioni a noi vicine sono i Napoletani.
Se io scrivendo a un gentiluomo dicessi per esempio così: Sappi ch’io stimo la tua virtù, bramo la tua amicizia, desidero di provartelo, addio, qual inurbanità o licenza potrebbe mai rimproverarsi al mio stile! Eppure son costretto a esprimere presso poco questi miei pensieri con questa faraggine di palloni da vento: Prego V. S. Illustrissima ad essere persuasa che è profondissima in me la stima delle nobili sue virtù, che sarei felice se potessi ottenere l’onore della sua grazia, e che qualunque volta la medesima si degnerà concedermi le occasioni per contestarle la verità di questo mio riverente desiderio, Ella accrescerà que’ titoli in me, pe’ quali ho la gloria di dirmi divotissimo obbligatissimo servitore. La metà per lo meno di queste parole sono vuote di senso, e la terza parte sono bugie; il gentiluomo che riceve la mia lettera la considera come un foglio di carta sporcato d’inchiostro secondo si usa, me ne spedisce un altro sullo stesso conio, e con questa mutua maniera di scrivere si rimane sempre sul liminare della corrispondenza senza entrarvi mai.
Dico di più, che lo stile diventa talmente languido, che non è possibile l’esprimere bene e nobilmente con esso verun pensiero un po’ superiore alle volgari officiosità. Questa verità la sentono a prova tutti gl’Italiani che vogliono nella lor lingua scrivere conservando un carattere elevato. I tragici singolarmente sono nella necessità di ricorrere alla semplicità antica per sostenere con dignità il dialogo:
Signor, che pensi? In quel silenzio appena | Riconosco Caton. Dov’è lo sdegno etc.
Così si parla a Catone. Se invece l’autore avesse detto: Che pensate, o Signor?, ognuno sente quanto sia meno augusta questa seconda maniera di parlare. Se poi invece dicesse: Che pensa Vostra Eccellenza, Signor Don Catone?, la tragedia farebbe ridere assai. Questa prova facciasi su mille altri esempi, e troverassi che sostituendo il nostro Voi o Lei al Tu, che ci detta la natura, ogni più bel discorso deve necessariamente snervarsi.
I Quaker, fralle molte stravaganze che hanno voluto immaginare, hanno però questo di buono, ch’essi non parlano altrimenti a veruno, né a veruno scrivono, che in seconda persona singolare. Scriveranno essi al re in questi termini:
Sire.
Ci rallegriamo del tuo avvenimento al trono, sappiamo che tu sei giusto, che sei illuminato, che sei clemente, onde renderai cospicuo il tuo regno, e memorabile presso i posteri per la felicità pubblica. Possa tu godere per molti anni delle benedizioni nostre e della gloria di aver beneficata l’umanità. Il nostro amore e la fedeltà nostra per la tua Real Persona sono eguali alle luminose tue virtù. Tai sono i veri sentimenti de’ fedeli tuoi sudditi. Così si scriveva a Cesare, ad Augusto ed agli altri imperatori mentre l’Impero romano comprendeva buona parte d’Europa, e s’estendeva sull’Asia e sull’Africa. Pare che col tempo a misura che son venute meno le cose sieno diventate più ampollose le parole, e che gli uomini abbiano cercato di farsi una illusione con ciò, e nascondersi il proprio decadimento. Le formalità in ogni genere sono sempre tanto più care e imprescindibili quanto è minore la vera forza fisica.
Un certo signor Agapito Stivale, discendente da quattro o cinque oziosi che avevano consumato il grano di alcune pertiche di terra vivendo oscuramente in un villaggio, e che perciò si credeva nobile, ricevette una lettera curiosa, e nella soprascritta vi stava così: Al conosciutissimo che comanda, che ha diritto di comandare, da coltivarsi moltissimo, che comanda, Agapito Stivale. Il signor Agapito fu meravigliatissimo per tutto questo caos di roba, e ciascuno de’ miei lettori lo sarà al pari del signor Agapito sin tanto che non faccia la seguente riflessione: che conosciutissimo rassomiglia molto a Illustrissimo, che Signore è quello che comanda, che Padrone è quello che ha diritto di comandare, e finalmente che Colendissimo è la stessa cosa che il dire da coltivarsi moltissimo; e la stessa impressione che fanno i titoli dati al signor Agapito a tutti noi, la devono fare presso i forestieri i titoli ordinari delle nostre lettere, e probabilmente la faranno anche presso gl’Italiani che verranno dopo di noi. Io vado sperando che torneranno gli uomini ad essere una unità ed a non vergognarsi d’esser uomini; più la coltura dell’ingegno s’avvanza, e più ci accostiamo a quella vera e dolce urbanità che consiste semplicemente nel non cagionare dispiacere o disagio ad alcuno, conformando liberamente i modi nostri alla natura delle cose, e non contorcendo né la persona, né la lingua, né i pensieri su i modelli ereditati. Allora si scriverà e si parlerà come esige la ragione. Frattanto conviene avere la santa flemma, e presentare le nostre imbarazzatissime circonlocuzioni alle Signorie, acciocché le passino agli uomini possessori di quelle Signorie, e lasciar che la grammatica si lagni se scriviamo in femminino anche agli uomini: Ella sa, Ella ben conosce, ec. E indirizzare le nostre lettere agli Illustrissimi Signori, Signori Padroni Colendissimi, poiché tali mutazioni sono l’opera del tempo, non mai della ragione.
P. [Pietro Verri]
IL CAFFÈ )( Fogl. III )(
Saggio sul Galileo
Due assai diversi giudizi intorno alle scoperte e al merito del Galileo sono comparsi al pubblico ne’ tempi nostri in due illustri opere franzesi, cioè nella prefazione degli Atti dell’Accademia di Dijon e nel discorso preliminare al Dizionario enciclopedico. In quella prefazione si dice che mentre Francesco Bacone in Inghilterra segnava il cammino della verità, il Galileo in Italia vi correva a gran passi; che il Galileo fu assai perspicace per iscoprire le leggi della caduta de’ corpi gravi, leggi che poscia generalizzate dal Newton ci hanno spiegato l’universo; che conquistò alla filosofia un nuovo mondo co’ suoi maravigliosi stromenti, e che parve che il cielo si ampliasse d’avanti a lui e la terra si popolasse di nuove specie. Si aggiugne che il Galileo non appagossi della semplice gloria delle nuove scoperte, ma volle unirvi anche quella di ricavare dalle scoperte i maggiori vantaggi al genere umano, e che però dopo di avere osservato per 27 anni i satelliti di Giove, distese le tavole esatte del loro moto, per determinare le longitudini e perfezionare la geografia e la nautica; che le sue sperienze sopra il peso dell’aria fecero nascere una fisica tutta nuova, perché condussero il Torricelli a spiegare la pressione dell’atmosfera e la sospensione del mercurio ne’ barometri; e che le sue osservazioni sopra il moto dei pendoli misero gli astronomi e i fisici a portata di misurare il tempo con precisione, di fissare le variazioni de’ pesi in diversi climi e dedurne la vera figura della Terra ec. Così si conclude che il Galileo ha scoperto molto ed ha acquistato dei diritti evidenti sopra molte scoperte degli altri.
Nell’Enciclopedia il cancellier Bacone si mette alla testa di que’ spiriti illustri che prepararono nell’ombra e nel silenzio la luce da cui poscia si rischiarò tutto il mondo. A Bacone si fa succedere il Cartesio, come uomo dotato di tutti i talenti necessari per far cangiar la faccia alla filosofia, che come filosofo fece brillar dappertutto il genio dell’invenzione, e come geometra arricchì moltissimo l’algebra già creata in qualche maniera dagl’Italiani. Si dice che Huygens avea preparata la strada al Newton, e che il Newton comparve alla fine e diede alla filosofia la forma che deve conservare. Dopo cotesti geni primari sono nominati alcuni altri: Galileo, Harvey, Huygens, Paschal, Malebranche, Boyle e Leibnitz. Si dice di essi, che quantunque non avessero viste tanto grandi, contribuirono però molto coi loro travagli all’avanzamento delle scienze, e alzarono per così dire un angolo del velo che ricopriva la verità. Si dice particolarmente del Galileo che la geografia gli deve tanto per le sue scoperte astronomiche e la meccanica per la sua teoria dell’accelerazione de’ corpi gravi.
Gl’Italiani parrebbero forse sospetti di qualche parzialità se entrassero a sciegliere fra i due giudizi già riferiti, e non bilanciassero punto a riconoscere il divino Galileo come il genio più grande che dopo il Newton abbia onorato il genere umano. Né mancano autori esteri del prim’ordine che facciano i più luminosi elogi del Galileo. In Olanda Ugo Grozio disse che le sue scoperte superavano le forze umane, e Huygens lo chiamò un uomo massimo. In Germania il Leibnitz e Giovanni Bernoulli lo riconobbero come le plus clair voyant de son tems, e Keplero scrisse ch’esso saliva sopra le più alte muraglie dell’universo e comprendeva tutto dalle ultime cose alle prime. Il Newton in Inghilterra citò molte volte i teoremi e i ritrovati del Galileo. Il Keill scrisse che il Galileo colla scorta della geometria penetrò negli arcani della natura e creò una nuova scienza del moto; e il Mac-Laurin esaltò molto i servigi che esso ci ha reso col telescopio e colla maniera chiara e geometrica con cui ci ha spiegato la teoria de’ corpi gravi che cascano e che sono gettati con qualsivoglia direzione. David Hume, nell’appendice alla Storia del regno di Giacomo primo, fece un parallelo più esatto tra il Lord Bacon e il Galileo. Disse che Bacone era inferiore al Galileo suo contemporaneo, e forse ancora al Keplero; che il Bacone avea solo accennato le vie in cui si avanzava a gran passi il Galileo; che il primo non sapeva la geometria, posseduta dal secondo eccellentemente e applicata alla naturale filosofia; che il primo disprezzava il sistema di Copernico, stabilito dal secondo con tante prove cavate dalla ragione e dal senso; che lo stile del primo era rigido, e quello del secondo era piacevole e brillante sebbene qualche volta prolisso ec.; aggiunge gentilmente lo storico inglese di non parer che l’Italia faccia del Galileo quel grandissimo conto che merita, forse per la gran copia degli uomini illustri che vi fiorirono.
Galileo Galilei nacque in Pisa nel 1564, e fu fatto ivi lettore di matematica nel 1589, tre anni dopo passò lettore di matematica a Padova, nel 1610 fu fatto matematico del gran duca Ferdinando Secondo e restituissi in Toscana, dove morì l’anno 1642 nella villa d’Arcetri vicina a Firenze; e però nacque l’anno che morì in Roma Michel Angelo Buonaruoti, e morì l’anno che nacque in Inghilterra Isacco Newton. Fino nell’anno 1583 ritrovandosi nella Chiesa Primaziale di Pisa, come attesta il Magalotti nei Saggi dell’Accademia del Cimento e nella di lui Vita il Viviani, osservò che una lampada smossa faceva le sue vibrazioni in tempi sensibilmente eguali, quantunque gli archi descritti fossero sensibilmente diseguali tra loro. Quest’importante osservazione fu poi portata tant’oltre dal Galileo, che pensò di servirsi d’un pendolo per misurare il tempo esattamente, e lo applicò all’oriuolo nella sua età più avanzata. Il Bechero, in una dissertazione sopra la misura del tempo, attesta d’avere inteso dal conte Magalotti che il Galileo fece fabbricare in Firenze il primo oriuolo a pendolo da Marco Trefler, orologiaro del Gran Duca; quantunque lo stesso Magalotti nei Saggi dell’Accademia del Cimento dica che il Galileo ideò bensì l’applicazione del pendolo all’oriuolo, ma ch’essa fu messa in pratica l’anno 1649 da Vincenzio suo figliuolo. Abbiamo però le lettere del Galileo al Beaugrand, e le altre del Realio e dell’Ortensio, che, oltre il Viviani, fanno indubitata fede che il Galileo applicò veramente il pendolo all’oriuolo. Elia Diodati nel 1637 mandò al padre del celebre Huygens la descrizione dell’oriuolo a pendolo fatta dal Galileo; ed aggiugne il Bechero che ne fu mandato in Olanda anche un modello. Tutto ciò basta per rispondere all’Huygens, al Musschenbroeck e a molti altri, che non vorrebbero riconoscere dall’Italia questa grande invenzione. Huygens inventò un pendolo che faceva le sue vibrazioni negli archi d’una cicloide. L’invenzione fu ingegnosissima, e la teoria geometrica che l’inventore ne ha dato è uno dei più bei getti di geometria. Ma perciò che risguarda la comodità della pratica, fu presto abbandonato il pendolo cicloidale, ed ora noi si serviamo di pendoli che si muovono in piccoli archi circolari, come sin da principio avea ideato il Galileo.
Fatto lettore in Pisa, incominciò varie pubbliche sperienze intorno alla caduta de’ corpi gravi, e fece a tutti vedere che i legni e i metalli e gli altri corpi, quantunque assai diversi di peso, cadevano in egual tempo, e però con eguale velocità da tutta altezza del campanile; e quindi ne ricavò l’importante teorema che la gravità assoluta dei corpi è proporzionale alla quantità della materia. L’anno 1597 in Padova inventò il suo compasso di proporzione, che sarà sempre un istromento di molto uso. Fu il primo a immaginare il termometro, e ritrovò la maniera di accrescere ottanta e cento volte la forza della calamita. Poi sentendo a dire nel 1609 che un olandese avea fatto un occhiale che avvicinava gli oggetti all’occhio, ne indovinò subito la fabbrica, e ne fabbricò un altro il seguente giorno, e sei giorni dopo ne portò uno a Venezia che ingrandiva 33 volte il diametro degli oggetti. Espose egli medesimo nel Saggiatore il breve e facile discorso, o piuttosto la semplice sperienza con cui vi era arrivato. Conobbe subito che gli oggetti non potevano ingrandirsi e rischiararsi con uno né con più vetri piani; né con una lente concava, che piuttosto gl’impicolisce, né con una sola lente convessa, che gli accresce e insieme gli confonde. Onde si restrinse a volere esperimentare quello che facesse la composizione del convesso e del concavo, e vide come questa dava l’intento. Si sono poi fatti de’ canocchiali, che ingrandivano di più gli oggetti e abbracciavano maggior campo, con due lenti convesse e con altre combinazioni di vetri. Ma nel discorso del Galileo non v’è una parola a ridire.
Alcuni autori hanno ritrovato le traccie di un tal discorso nelle opere di Rogero Bacone e di Gian-Battista Porta, anzi hanno ad essi attribuita la prima invenzione del telescopio. Ma il celebre Roberto Smith nella sua Ottica, dopo di avere esaminato tutti i frammenti di fra Rogero, ha fatto vedere chiaramente che quell’uomo, chiamato già dal Voltaire un or encrouté de toutes les ordures de son siecle, né avea idea del telescopio né intendeva gli effetti delle lenti prese separatamente. Il de la Hire, negli Atti dell’Accademia di Parigi, nel 1717, ha provato che il Porta in quel passo specioso della sua Magia naturale non parlava veramente d’altro che d’un semplice occhiale, in cui avea combinato talmente un vetro convesso e un concavo che aiutava la vista di quelli che ne voyoient plus que confusément. Il Montucla nella sua Storia delle matematiche, sempre ottimo giudice e apologista delle invenzioni italiane, è pure del medesimo sentimento, che innanzi ai tempi del Galileo non vi sia stato il telescopio. Il Galileo non cessò d’applicarsi a migliorare la construzione, e ne inventò anzi uno con cui nello stesso tempo vedevasi da’ due occhi. L’anno 1618 mandò il suo binocolo all’arciduca Leopoldo d’Austria: onde fa meraviglia che il Rheita, in un libro stampato l’anno 1645, abbia voluto comparirne per inventore.
Qui però è dove il buon uso deve stimarsi assai più dell’invenzione. Il canocchiale in Olanda fu come la calamita alla China, oggetto della semplice curiosità. Il Galileo nello stesso anno 1609 riguardando col nuovo occhio la Luna, osservò che il progresso dell’illuminazione dopo il novilunio e i confini della luce e dell’ombra erano irregolari, spuntando successivamente alcune punte rilucenti nel fondo ancora oscuro. Libero com’era dai pregiudizi dell’antica scuola, conobbe subito che la Luna era simile alla nostra Terra, sparsa anch’essa di valli e di montagne ancor più alte delle nostre. La somiglianza dei due pianeti fu poi spiegata eccellentemente dal Galileo nel primo Dialogo sopra i sistemi del mondo e fu portata più oltre da altri autori, che riconobbero intorno alla Luna diversi indizi d’un’atmosfera assai più rara e variabile della nostra, e vollero così spiegare l’anello lucido che circonda la Luna in tempo dell’ecclissi del Sole, e le variazioni che Mairan, Cassini, de la Hire, Maraldi, Kirk e de l’Isle molte volte osservarono ne’ pianeti e nelle fisse vicine al disco lunare. Né solamente le prime scoperte del Galileo dopo l’invenzione del canocchiale, ma le ultime ancora furono intorno alla Luna. Mentre pochi anni prima di perder la vista, come dice il Viviani, scoprì la librazione del corpo lunare, e la ricavò dall’osservazione della stessa macchia Grimaldi, e del Mare delle Crisi, che poi occupò tanto il Grimaldi, l’Evelio e il Bullialdo. L’osservazione è descritta nel dialogo già citato, dove anche pare, che al numero 59 sia prevenuta la congettura del Newton intorno alla causa per cui la Luna rivolta sempre la stessa faccia alla Terra, leggendosi: di qui è manifesto la Luna, come allettata da virtù magnetica, costantemente riguardare con una sua faccia il globo terrestre, né da quello divertir mai.
In tutto il cielo si presentarono nuovi e curiosi fenomeni al Galileo. La Via Lattea gli parve sparsa d’innumerabili e piccolissime stelle. Ne contò più di 40 nel solo gruppo delle Pleiadi, e più di 500 nella costellazione d’Orione. La sola nebulosa d’Orione gli apparì composta di 21 stelle tra loro vicinissime e quella del Cancro di circa 40. Poi vide quattro satelliti intorno a Giove, scoprì le macchie del Sole e le fasi di Venere e di Marte, e osservò certe apparenze in Saturno, che poi furono più longamente considerate dall’Huygens e spiegate all’ipotesi di un annello. Le osservazioni di Giove furono portate dal Galileo al più alto grado di perfezione. Colla fatica di tre anni incominciò la teoria dei satelliti, e sino nel principio del 1613 osò predire tutte le loro configurazioni per due mesi consecutivi. Poi s’immaginò di farne uso per il problema delle longitudini, e nel 1636 per mezzo di Ugo Grozio s’offrì agli Stati di Olanda d’applicarvisi di proposito. Gli Stati Generali accettarono volontieri l’offerta, destinando al Galileo una collana d’oro, deputando quattro commissari per trattare con esso lui: uno de’ quali, Martino Ortensio, si trasferì ancora in Toscana poco prima che mancasse la vista al Galileo. Dopo questa disgrazia il Galileo comunicò le sue osservazioni e i suoi scritti al Renieri, che fu poi matematico in Pisa, e che venne incaricato dallo stesso Gran Duca di distendere le tavole e le effemeridi dei satelliti di Giove. Le distese veramente il Renieri, e le mostrò al Gran Duca e a molti altri, come attesta il Viviani, ed era anzi sul punto di pubblicarle nel 1648, quando per una repentina malattia perdette esso la vita, e per non so quale altro accidente si perdettero tutti i suoi scritti, e quelli ancora che avea ricevuto dal Galileo.
Le fasi di Venere dimostrarono ciò che alcuni astronomi antichi aveano solamente supposto, che Venere si movesse non intorno alla Terra, ma intorno al Sole. Il Copernico abbracciò quest’ipotesi, e aggiunse ancora essere necessario che le fasi di Venere s’assomiglino a quelle della Luna. Il canocchiale del Galileo fece vedere la somiglianza delle fasi di Venere, e scoprì ancora qualche gibbosità in Marte: fenomeni che chiaramente provano il moto di Venere e di Marte intorno al Sole, e fanno subito argomentare che si muovono pure intorno al Sole gli altri pianeti principali. E quale sarebbe stato il trasporto del Copernico, dice ottimamente il Montucla, se avesse potuto allegare simili prove a suo favore? Il Galileo co’ suoi Dialoghi sopra il sistema del mondo contribuì molto al trionfo a cui arrivò poscia il sistema dell’illustre prussiano, e che fu tanto funesto al nostro grande italiano. Nel secondo dialogo sono così bene spiegati tutti i fenomeni terrestri, e nel terzo tutti i celesti, è tanto rilevata per ogni parte la semplicità dell’ipotesi del Copernico, e sono così spiegate le incongruenze delle altre ipotesi di Tolomeo e di Ticone, che il moto della Terra incominciò a comparire nei dialoghi con tutta quella certezza che si può avere nelle materie fisiche, ancora prima che l’aberrazione della luce fosse scoperta in Inghilterra dal Bradley e verificata in Italia da Eustachio Manfredi, celebre astronomo che viverà sempre nella storia e ne’ fasti dell’astronomia.
Prima di partire da Padova avea scoperto il Galileo le macchie del Sole, e nel mese di aprile del 1611 ritrovandosi in Roma le avea fatte vedere a diversi conspicui personaggi, che l’attestarono. Furono posteriori di sei mesi le prime osservazioni dello Scheinero, che le pubblicò poscia nel 1612 col nome di Appelles post tabulam e con tre lettere indirizzate al Velsero. Rispose subito il Galileo, e assicurò a se stesso l’onore della prima scoperta delle macchie. Di più fece vedere che il finto Appelle ne avea dato la teoria a rovescio credendo che si movessero le macchie da oriente in occidente, quando si muovono veramente da occidente in oriente, e che declinassero verso mezzo giorno, quando declinano verso settentrione. L’Appelle, forse attaccato alle antiche opinioni dell’incorrutibilità de’ cieli, pensò che le macchie fossero pianeti. Il Galileo, come uomo libero, sino nelle prime sue lettere al Velsero disse che le macchie erano materie assai prossime alla superficie del Sole, che quivi continuamente se ne producevano molte, e poi si discioglievano a somiglianza de’ vapori della nostra atmosfera; e dal moto delle macchie argomentò poi che il Sole si rivolge intorno a se stesso in un mese lunare in circa. Il Montucla lasciò al Galileo ancor l’onore di avere discorso subito più giudiziosamente degli altri sopra le macchie.
Il Galileo incominciò a pubblicare le sue scoperte sulle macchie solari l’anno 1612 nel Discorso sopra le cose che stanno in su l’acqua o che in quella si muovono. Ristabilì in quel discorso le dottrine idrostatiche d’Archimede, e dimostrò che il discendere de’ solidi in un fluido o il galleggiare non dipende altrimenti dalla figura de’ solidi, ma dalla loro specifica gravità. Nel Saggiatore, che dal conte Algarotti riconoscevasi come la più bell’opera polemica di cui si vanti l’Italia, è stabilita copiosamente la dottrina, che più che al Cartesio dovrebbe attribuirsi agli antichi filosofi, che le qualità sensibili, il colore, il gusto ec. non risiedono altrimenti ne’ corpi, ma in esso noi. Che se il Galileo fissò i principii dell’idrostatica e della fisica, creò poi la meccanica interamente. Sino nel 1602 scrisse al marchese del Monte di avere osservato che le vibrazioni dei mobili pendenti da fila di differente lunghezza si fanno in tempi che sono tra loro come le radici delle lunghezze. E in una lettera scritta da Padova l’anno 1604 annunziò il teorema che i spazi percorsi dai corpi gravi in cadendo sono come i quadrati dei tempi, e che però i spazi percorsi in tempi eguali sono come i numeri 1, 3, 5, 7, ec. I suoi Dialoghi sopra la meccanica furono stampati la prima volta nello stesso anno in cui uscì alla luce il Trattato del moto del Baliani, cioè nel 1638. Ma i suoi scritti e le sue scoperte meccaniche s’erano molto prima divulgate di qua e di là dai monti: onde non è verisimile che il Cartesio e molto meno il Baliani ne indovinassero varie senza sapere del Galileo.
Tra le principali scoperte che si ritrovano nei Dialoghi della meccanica, io conto in primo luogo il principio della composizione e della risoluzione del moto, espressamente insegnato dal Galileo nel teorema secondo del moto de’ proietti e nello scolio al teorema secondo del moto accelerato. Conto in secondo luogo le leggi del moto equabile e del moto accelerato, dalle quali risultano le due notissime formole, comunemente chiamate del Galileo: 1. che la forza moltiplicata per l’elemento del tempo uguaglia l’elemento della velocità; 2. che la forza moltiplicata per l’elemento dello spazio uguaglia l’elemento della velocità moltiplicato per tutta la velocità. Il Galileo considerò le sue formole nel caso della forza costante, e il Newton le stese poscia generalmente a tutte le ipotesi della forza variabile. Ma quanto si è detto dopo nella meccanica, tutto dipende dalle due formole, e dal principio della composizione e della risoluzione del moto. Il trattato del moto ne’ piani inclinati e nelle corde degli archi circolari è pieno d’eleganza geometrica, e farà sempre meraviglia che un uomo solo senz’algebra sia arrivato tant’oltre. Sono dell’ultima finezza i problemi nei quali si cerca l’inclinazione del piano, per cui un corpo possa passar più presto o da un punto dato a una linea orizzontale data di posizione o da una linea orizzontale a un punto dato. Nel dialogo quarto è pure maravigliosamente trattata tutta la ballistica, di cui nulla sapevasi innanzi al Galileo, se non che il Cardano e il Tartaglia sospettarono che i proietti si movessero in una linea composta da una retta e da un arco circolare. Il Galileo col principio della composizione del moto non solo dimostrò che i proietti descrivono una parabola, ma inoltre insegnò tutto quello che appartiene all’ampiezza del getto, sublimità, altezza e direzione, onde da due di queste quantità si potessero sempre ricavar le altre due. Finalmente nel dialogo secondo gettò ancora i principii di tutta la dottrina della resistenza de’ solidi, che fu poi portata tant’oltre dal Viviani e dal Grandi.
Nel dialogo primo e terzo, trattando il Galileo del cilindro scavato da un emisferio e de’ spazi scorsi col moto accelerato, ci lasciò le traccie del metodo degli indivisibili, considerando i solidi come composti d’infiniti piani e i piani d’infinite linee. Ma qui la verità ci obbliga ad osservare: 1. che il Keplero nella sua Stereometria avea già introdotto l’infinito nelle matematiche e somministrata l’idea degli indivisibili; 2. che il nostro Cavalieri adoprò assai cautamente coteste frasi metafisiche, come apparisce dalla prefazione del libro settimo della sua Geometria ed ha ottimamente avvertito il Mac-Laurin; 3. che il Galileo quantunque avesse in animo di comporre un trattato geometrico sopra gl’indivisibili, non ebbe però alcuna parte nella grand’opera del Cavalieri. Senza tant’altre prove che se ne potrebbero addurre, la lettera scritta dal Cavalieri al Galileo ai 21 marzo del 1626 fa indubitata fede che quello avea già terminata l’opera mentre questi non avea ancora incominciata la sua: quanto all’opera degli indivisibili, avrei molto caro che si applicasse quanto prima, acciò potessi dare spedizione alla mia, quale fra tanto anderò limando ec. L’opera del Cavalieri fu resa pubblica tre anni dopo, e fu la principal base del calcolo differenziale e integrale.
Ma per ritornare ai Dialoghi, nella prima edizione del terzo di essi prese come un assioma il Galileo che un mobile passando da un punto dato per qualsivoglia piano inclinato a una data linea orizzontale, vi arrivi sempre colla medesima velocità. Il Viviani fu il primo a fargli vedere che quel principio avea bisogno di qualche dimostrazione, e il Galileo già cieco la trovò subito, e la fece distendere al Viviani nella maniera che può vedersi nelle altre edizioni dei Dialoghi. Nel discorso sopra il fiume Bisenzio fu applicata dal Galileo quella proposizione al caso delle acque correnti e fu spiegata in un altro teorema, che le velocità rimangono le medesime in due canali di differente lunghezza e tortuosità, quando abbiano solamente la medesima altezza, cioè quando restino fissati tra i medesimi termini. Nel caso particolare dei fiumi vi sono le resistenze e molte altre cose da considerare. Ma la proposizione generalmente presa è verissima, e fa molto onore al Galileo che abbia incominciato ad applicare la geometria alla scienza delle acque correnti.
Il Varignon rilevò uno sbaglio nel teorema decimo sesto del terzo dialogo, dove suppone il Galileo che un corpo passando da un piano all’altro di diversa inclinazione ritenga tutta la velocità corrispondente alla prima caduta. Ma il Grandi nelle note allo stesso dialogo disse che il passo del Galileo dovea intendersi non assolutamente, ma in una semplice ipotesi, da cui dovea esso partire per poi arrivare alle leggi della caduta de’ corpi gravi negli archi circolari. E negli archi circolari, anzi in tutte le curve, è verissimo che non vi è alterazione sensibile di moto per la diversa inclinazione dei piccoli archetti dai quali s’intende composta tutta la curva, come è stato dimostrato dal Varignon, dal Grandi e da molt’altri. Né può essere più elegante il teorema a cui s’è fatto strada con quell’ipotesi il Galileo, che un corpo discende più presto per un arco circolare che per la corda. Giovanni Bernoulli ha inteso più generalmente il teorema, come se avesse creduto il Galileo che per un arco circolare la discesa si facesse più presto che per qualsivoglia altra curva compresa tra i medesimi termini, e poi ha dimostrato il Bernoulli che la curva della più breve discesa è una cicloide e non un arco circolare. Ma basta lo scolio del teorema 22 per vedere che il Galileo non ha voluto dir altro se non ciò ch’è verissimo: Quo igitur per inscriptos polygonos magis ad circumferentiam accedimus, eo citius absolvitur motus inter duos terminos signatos.
IL CAFFÈ )( Fogl. IV )(
È pure stato imputato generalmente al Galileo d’aver creduto che la curva parabolica in cui si muovono i proietti fosse la stessa a cui si conforma una catena sospesa nelle estremità, e che chiamasi catenaria. Ed è cosa curiosa che sia toccato al Krafft in questi ultimi anni di farne l’apologia nel tomo quinto de’ Nuovi commentari di Pietroburgo, citando il passo che siegue alla proposizione 14 del dialogo quarto, e in cui si dice unicamente che le due curve non si differiscono molto tra loro. La corda tesa, e poco o molto tirata, si piega in linee, le quali assai si avvicinano alle paraboliche, e la similitudine è tanta che se voi segnerete in una superficie piana ed eretta all’orizzonte una linea parabolica, e tenendola inversa, cioè col vertice in giù, e colla base parallela all’orizzonte, facendo pendere una catenella sostenuta nelle estremità della base della segnata parabola, vedrete allentando più o meno la detta catenuzza incurvarsi e adattarsi alla medesima parabola; e tale adattamento tanto più esser preciso, quanto la segnata parabola sarà men curva, cioè più distesa; sicché nelle parabole descritte con elevazioni sotto ai gradi 45 la catenella cammina quasi ad unguem sopra la parabola.
Poco dopo passò il Galileo ad un’altra proposizione, che una corda orizzontale, cavalcante sopra due perni e considerata come nulla pesante, che sia tesa con due pesi gravissimi attaccati all’estremità, se nel mezzo sarà attaccato un altro peso quantunque piccolissimo, verrà subito smossa dalla sua rettitudine e piegata nel mezzo. Il Viviani scrivendo a monsignore Ricci rilevò alcuni dubbi intorno alla dimostrazione del Galileo, cavati primieramente dal non essere equabile il moto di due pesi che salgono, mentre la corda si piega. Una tale difficoltà, quantunque approvata da uomini insigni, non pare adattabile al caso del Galileo, in cui supponendosi i pesi infinitamente grandi rispetto al corpicello aggiunto nel mezzo della corda, il loro moto non può essere che infinitamente piccolo e però equabile. È vero che il caso dell’equilibrio non è precisamente quello che ha supposto il Galileo nella sua dimostrazione, come prima sospettava il Viviani e poi fu dimostrato dal Simpson nel problema 38 dell’Applicazione dell’algebra alla geometria. Ma la dimostrazione del Galileo si può adattare egualmente al vero caso dell’equilibrio, e la proposizione principale rimane sempre verissima.
A queste difficoltà meccaniche se ne aggiungono alcune fisiche ed astronomiche, che principalmente si riducono a tre: 1. che il Galileo abbia attribuito il salir delle acque nelle trombe alla ripugnanza del vacuo; 2. che abbia voluto spiegare il flusso e riflusso del mare colla combinazione del moto diurno ed annuo della Terra; 3. che non abbia creduto che le comete siano corpi perenni che girano intorno al Sole. Quanto alla prima obbiezione, il Galileo nel primo dialogo ha descritto semplicemente il fenomeno che l’acqua nelle trombe s’alzi a 18 braccia e non più, e ne ha quindi inferito semplicemente che la forza necessaria a indurre il vacuo uguaglia un cilindro d’acqua di 18 braccia d’altezza. E in ciò non v’è nulla a ridire, quantunque non reggano egualmente alcune congetture, aggiunte dopo e messe in bocca a Salviati, intorno alla cagione della coerenza de’ corpi. Il Galileo ha proposto ancora un ordigno per misurare quant’è maggiore la forza della coesione di quella che si ricerca ad indurre il vacuo, ed ha poi suggerito due diverse maniere per misurare anche il peso dell’aria e sebbene colle proprie sperienze non abbia ricavato altra proporzione tra i pesi dell’aria e dell’acqua che quella di uno a 400, bisogna però riconoscere in esse il fondamento e il principio di quanto gli altri hanno aggiunto a tal proposito.
L’ipotesi intorno il flusso e riflusso, esposta nel quarto Dialogo sopra il sistema del mondo, è molto ingegnosa, ed è la prima con cui gli uomini hanno tentato di spiegare fisicamente quel curioso fenomeno; e quantunque non sia vera l’ipotesi, il Cartesio, che ha scritto dopo il Galileo, non ne ha dato un’altra migliore. Per ciò poi che risguarda le comete, il Galileo obbiettò al suo avversario che non era ancora provato che le comete fossero corpi solidi e perenni, e che la parallasse serve bensì a misurare le distanze dei corpi, ma non può applicarsi alle semplici apparenze ottiche, come sarebbero le corone e i pareli e come allora si sospettava che fossero le comete. Il Cassini, in un libro stampato del 1653 e dedicato al Serenissimo di Modena, seguitò a sostenere che le comete erano un ammasso d’esalazioni della Terra e de’ pianeti. Fu poco dopo, come osservò il Fontenelle, che avendo ritrovato il Cassini che le irregolarità del moto delle comete erano meramente apparenti, e che le comete medesime non meno dei pianeti potevansi sottomettere al calcolo, incominciarono tutti gli astronomi a credere fondatamente che le comete fossero corpi perenni che insieme agli altri pianeti girassero intorno al Sole.
Il Fontenelle nell’elogio del Viviani risguardò il Galileo come un genio raro, il cui nome sarà sempre alla testa delle più importanti scoperte sulle quali è fondata la filosofia. Il Cartesio, tanto inferiore al Galileo, riprese in lui ciò che appunto era più da lodarsi, che si accontentasse dei fatti e delle dimostrazioni senza rimontare sino alle cause prime. Il Newton, che superò coll’ingegno il genere umano, ha forse più sbagli del Galileo. Noi dobbiamo ammirare nel Galileo un filosofo, un geometra, un meccanico ed un astronomo non meno teorico che pratico, quello che ha dissipato tutti gli errori dell’antica scuola, il più elegante e solido scrittore che abbia avuto l’Italia, il maestro del Cavalieri, Torricelli, Castelli, Aggiunti, Viviani, Borelli, Paolo e Candido del Buono. Gli ultimi quattro formarono la principal parte dell’Accademia del Cimento, i cui saggi erano scritti collo spirito del Galileo ed erano degni del secolo di Newton, come si legge nella stessa prefazione degli Atti dell’Accademia di Dijon, da cui abbiamo incominciato il presente saggio.
X. [Paolo Frisi]
La buona compagnia
La maggior parte degli uomini hanno un vero bisogno di passare il loro tempo più che possono nella compagnia di molti uomini, per tal modo che qualora per circostanze particolari venga ciò loro impedito, gli vedi abbatuti, tristi, desolati più che se loro qualche mal fisico fosse veramente accaduto. Osservo in oltre che a questi tali, punti da quest’artefatto bisogno, nemmeno il mal di capo, nemmen la febbre bastano a superare l’interna voce di questo, a meno che non giunghino a un grado insigne. Questo bisogno io lo chiamo artefatto, e perciò tale lo chiamo, perché presso varie nazioni egli è perfettamente sconosciuto, e forse se daremo una libera occhiata alla terra troveremo ch’esso va sempre crescendo a misura che i popoli vivono sotto un più pacifico governo ed abitano una porzione meno ingrata del globo. La sapienza è sempre stata il patrimonio di pochi, perciò non è dato a molti il sentire questa grande verità, che l’uomo è tanto più indipendente quanto sono minori i bisogni di lui, e che quanti più bisogni si forma tanto più crescono le catene, che lo riducono a soffrire nel breve corso de’ suoi giorni una esistenza precaria e subordinata ai capricci altrui. Sì fatti principii non possono mai rendersi universali, ma bensì diriggono la vita di alcuni pochi sparsi con molta parsimonia sul nostro pianeta, e questi pochi sono realmente più paesani fra di essi di quello che non lo sieno coloro che hanno comune la patria. Quello che fa maraviglia piuttosto si è il vedere come la maggior parte degli uomini, avendo un vero bisogno della società degli uomini, trascuri talmente l’arte di vivere in essa società, che invece di riportarne quella dolcezza e quel conforto che gli animali deboli ricercano dalla compagnia de’ loro simili, ritornino per lo più alla loro solitudine amareggiati e guasti da infinite passioni e idee oppostissime al fine propostosi. In questo breve discorso vuo’ provarmi se posso a illuminare alcuni principii relativi a quest’argomento.
Ognuno m’accorderà facilmente che si dia la buona compagnia e che si trovi la cattiva compagnia; ma se dovessi raccogliere le diverse definizioni che ciascheduno dovesse dare di queste due diverse sorti di società, troverei un vero caos. Riduciamole però ai primi elementi. Ognuno chiama buona compagnia quella dove passa bene il suo tempo, cattiva quella dove lo passa male, e ognuno passa bene il suo tempo dove non resti offeso il suo amor proprio, e lo passa male dove all’incontro l’amor proprio venga offeso.
Poni una bella dama, di cui la più forte passione sia quella di ottenere il vanto di bellezza, attorniata di altre ancor più belle e leggiadre di lei; qualunque sia il fortuito giro delle idee e de’ discorsi tenuti in quest’adunanza, stia sicuro che la bella dama ha sofferto dai volti delle più belle continue mortificazioni al suo amor proprio, ch’ella avrà passato male il suo tempo e conseguentemente ch’ella nell’intimo del suo cuore darà il nome di cattiva compagnia a quell’adunanza. Poni un uomo mediocre, ma che pure abbia una costante passione di passare per uomo di spirito, attornialo di uomini d’uno spirito al suo superiore, fa che essi brillino a segno d’offuscarlo, e lo vedrai uscire dalla compagnia con que’ sentimenti che porta seco la bella dama. La superiorità de’ talenti o dell’avvenenza non si soffre dalla umana debolezza giammai, sintanto ch’ella non sia tanto insigne da rendere affatto ridicola la pretensione di gareggiarvi; e questa è forse la vera cagione per cui rarissime sono le vere amicizie fra due belle e fra gli uomini di lettere comunemente; e quando colla ragione giunghino a superare gli ostacoli fortissimi che l’amor proprio loro frappone, v’è ragione di credere che le facoltà del loro animo s’esercitino ancora più sul cuore che sulla fantasia o sull’ingegno. Basta non esser vile per sacrificare alla virtù le ricchezze; vi vuole della forza per sacrificarvi i piaceri; vi vuole una robusta e benefica filosofia per sacrificarvi l’ambizione.
Ma per formarci una universale e limpida idea dell’essenza d’una buona società, vediamo in prima qual sia il fine per cui viene essa formata. Gli uomini ubbidiscono al bisogno di passare delle ore del giorno socievolmente a fine di passare quelle ore bene. Da ciò ne deriva dunque per conseguenza che la buona compagnia si è quella d’onde maggior numero d’uomini partono contenti. La buona compagnia dunque deve rassomigliarsi assai più al governo democratico che a qualunque altro; fors’anco può ella sussistere sotto l’aspetto d’una aristocrazia clemente; fors’anco può ritrovarsi in figura d’una moderata monarchia; ma se il dispotismo o l’anarchia vi s’introducono, la buona compagnia non è più da sperarsi. Chiamo conversazione anarchica quella dove gli uomini radunati non obbedendo a veruna legge sociale formano un tumultuario mormorio; dove più parlano in una volta, e s’interrompono, e si urtano, e s’incomodano vicendevolmente; dove si mette a prova la forza polmonare, e si urla, e si schiamazza; dove l’uomo educato se per sventura vi si trova, deve essere asperso dell’eloquente saliva degli infuocati declamatori e spalmato potentemente dal loro eterno gesticolare; dove una idea o non viene proposta o viene spezzata prima che interamente sia prodotta, e la contraddizione, e la inurbanità, e la scurrile maniera di schiamazzare e smascellarsi rattristano, annoiano ed amareggiano alla perfine ciascuno, e lascianlo ritornare a casa stanco, svaporato e pentito di aver avuta parte a quel congresso, che potrebbe chiamarsi la Noce di Benevento. Chiamo conversazione dispotica quella dove un solo arrogandosi, o per causticità naturale del suo umore o per una inordinata voglia di mostrarsi superiore ad ognuno, il primato, con tuono imponente di voce lascia ad ogni tratto travedere la disistima e il nessun conto in cui tiene gli uomini che gli sono presenti, e trascurando il merito modesto dell’uomo ben educato, ed avvilendo, e mortificando, e profittando d’ogni presa per slanciare mordacissimi tratti nel fondo dell’animo altrui, sparge la confusione ed il rossore sulla faccia degli uomini sensibili; ovvero impadronendosi implacabilmente del discorso, trasmuta la sala della società in un ferocissimo liceo e costringe gli uomini alla noia d’essere eterni uditori. Le società di queste due classi, anarchiche o dispotiche, non si frequentano mai senza pentirsene; la prima non può chiamarsi buona compagnia da nessuno; l’altra può chiamarsi tale da un solo.
Acciocché il crocchio in cui ti trovi possa meritare il nome di buona compagnia, bisogna prima di tutto che chi lo compone sieno tutti onesti e virtuosi; poiché non ti sentirai mai l’animo libero veramente e aperto a quella dolce fratellanza, che è il massimo diletto d’una radunanza d’uomini, se hai ragione di temere o che taluno stia in aguato per contraddirti, ovvero che i discorsi che sei per fare possano essere ridetti, o contrafatti, o mutilati altrove, dal che te ne nascerebbero e brighe e inquietudini infinite. Un uomo solo d’una probità sospetta basta dunque a guastare la buona compagnia.
Si richiede dappoi che ognuno che compone la compagnia sia dirozzato bastantemente, ed abbia una certa dose di gentilezza sì che non offenda alcuno. Due leggi di convenzione reggono gli uomini mentre vivono insieme: la prima è il cerimoniale, la seconda è la civiltà. A misura che gli uomini si sono resi più socievoli s’è diminuita la seccagine del cerimoniale, uso che realmente altro non produceva che un perenne commercio d’inutile falsità ed un ridicolo imbarazzo da tutte le parti. Ma se la ragione va persuadendo agli uomini la destruzione del cerimoniale, la stessa però prova la necessità di conservare quella che chiamasi civiltà in vigore. Si è questa civiltà una quasi virtù ed una attenzione costante a non lasciare che nelle parole o negli atti nostri traspaia cosa che offenda o dispiaccia agli altri; essa è una emanazione di quel primo principio che c’insegna di non far ad altri quello che dispiacerebbeci fatto a noi. Se vai a cercare la compagnia degli uomini per riceverne un bene, ragion vuole che tu non faccia ricevere un male agli altri uomini che per un fine eguale al tuo si son radunati, ma che anzi contribuisca quella porzion di bene che per te puossi in tributo agli altri.
Non pretendo io già che portando questi principii all’estremo, gli uomini debbano radunarsi per amministrarsi l’un l’altro un insipido pascolo d’adulazione; dico bensì che non è virtuosa né urbana cosa il convivere sì che colle parole, col tuono di voce o co’ gesti un uomo persuada agli altri di averli in nessun conto. Vi vuole un punto di mezzo fra la sciapita dolcezza e la rusticità; vi vuole una cert’aria di libertà e di bontà d’animo; vi vuole in somma una vera voglia di passar bene il tempo e di lasciar la brigata contenta di noi. Sì fatte dilicate differenze è impossibile esprimerle bene colle parole; dipendono però da questo primo principio universalissimo, e che non è soggetto a veruna eccezione: quando un uomo parte dalla tua compagnia contento di se stesso, parte contento di te.
Alcune volte nella vita socievole si suol dare il nome di uomo amabile a taluno che realmente non lo sembra a nessuno; questo nome talvolta si dà per timore della lingua altrui, talvolta per adulazione e per altri riguardi; l’uomo amabile non è già quello che sappia con maggiore vivacità d’ingegno superare gli altri in un racconto, in un bel detto, in una spiritosa e pronta risposta: entriamo nel centro del cuore, e vedremo che l’uomo che ciascuno di noi trova amabile è colui parlando col quale ciascuno di noi crede di far buona comparsa; l’uomo amabile per ciascuno di noi è colui dal quale crediamo d’essere tenuti in conto; l’uomo amabile per fin è colui il quale sa dare risalto allo spirito nostro anzi che far pompa del suo. Il nostro amor proprio è sempre il più costante distributore degli elogi o de’ biasimi.
Posto ciò, ella è cosa per sé manifesta che l’uomo che ragionevolmente entra in una compagnia per passarvi bene il suo tempo deve essere sollecito non tanto d’impadronirsi della conversazione, quanto di dare risalto e pregio alle cose buone che per ventura venghino dette da altri, e fare il mestiero di Socrate, la levatrice de’ pensieri altrui aiutandoli ad esprimersi, e adornando e rendendo nobili le altrui espressioni. Questo è il solo genere di talento di cui non si può mai far uso con eccesso nella società.
La maldicenza sugli assenti fa alcune volte l’effetto di piacere in una compagnia, poiché l’amor proprio di tutti gli astanti al primo incontro sembra migliorar di condizione quanto altri si deprime; ma un momento dopo viene la riflessione in soccorso e fa nascere l’aborrimento verso il maledico, da cui ciascuno teme a ragione egual trattamento assente ch’egli sia.
L’arte di scherzare riesce essa pure, ma acciocché il suo effetto sia grato costantemente vi vuole una delicatezza somma di spirito ed un fino accorgimento del cuore umano. Lo scherzo non deve mai cadere su un difetto vero d’alcuno, ma sibbene su que’ soli difetti i quali appena meritano questo nome, anzi suppongono delle virtù: tu puoi vivacemente scherzare con un uomo di studi profondi e di chiaro nome sulle distrazioni che gli accadono ne’ minuti oggetti, perché appunto queste distrazioni in lui provano l’energica spinta del suo animo verso gli oggetti più grandi. Tu poi scherzare sulla cattiva compera fatta da un uomo generoso e ricco, poiché appunto questa mancanza di esattezza è un difetto compagno dell’indole generosa; e così dicasi di mille simili soggetti di piacevoli scherzi. Ma chiunque voglia secondare il talento della celia, conviene in prima ch’ei la distingua bene esattamente dall’ingiuria. Alcuni pretendendo di scherzare dicono delle grossolane villanie; il mestiere degli scherzi non è fatto per essi, e si ricordino di quel giumento, il quale vedendo accarezzato un cagnuolino, perché festosamente saltellava d’intorno al suo padrone, volle imitarlo, e n’ebbe il destino che si meritava.
Il mestiere di contraddire poi è per comune consentimento uno de’ più sciagurati che si dieno al mondo; io lodo molto che i progressi della ragione abbiano tolta in buona parte l’antica barbarie longobarda de’ duelli, e che per una contraddizione non si obblighi più un uomo a ricorrere al giudizio della spada; ma starebbe assai bene che con una universal legge sociale venisse obbligato il contradditore ad accettare la scommessa qualora vengagli proposta; e diverebbe così la seccatura un fondo censibile d’onorato lucro per gli uomini che sanno vivere, dispensandoli da una noiosa disputa.
Le compagnie dove sì fatti doveri si eseguiscono sono le compagnie ch’io chiamo buone; di tali ne conosco, ed è interesse di ogni uomo il fare in guisa che quanto è possibile le altre cerchino d’accostarsi a sì fatto modello. Se così vivono gli uomini insieme, allora veramente la società è un vero ristoro della vita, in essa si prende l’illarità che rinnova vigore e lena agli uomini per occuparsi lodevolmente il rimanente del giorno ne’ doveri di cittadino, di parente o di amico; in essa nasce e si fomenta la santa, la adorabile amicizia, che è forse il più gran dono umano che il Cielo abbia fatto agli uomini per consolarli dalla schiera infinita de’ mali che circondano la carriera di questa vita mortale.
P. [Pietro Verri]
Le parole
È già stato detto che ogni virtù consiste nelle parole, nelle erbe, nelle pietre: col trascorrere de’ secoli le erbe e le pietre hanno perduta buona parte della loro virtù nell’opinione degli uomini, ma le parole né l’hanno perduta, né v’è apparenza che sieno per perderla giammai. Sinché Cesare si contentò di usurpare la libertà pubblica e di rendere sudditi della sua persona i Romani, che eran sudditi delle leggi, Cesare visse onorato, libero e forse amato; cercò Cesare la parola re: i cittadini romani, che gli avevano cedute tutte le cose, non gli vollero cedere quella parola e lo trucidarono. Cromwell ben intese questa verità, e si contentò di prendere agl’Inglesi le leggi e la libertà senza cercare altra parola che quella di protettore. Gli uomini sono generalmente ben rappresentati da quella sentinella, la quale lasciava passare per una porta chiunque diceva voglio uscire e rimandava chiunque diceva voglio entrare. Alcune sere fa mi trovai in una adunanza dove un uomo lesto faceva il giuoco de’ bussolotti con mirabile destrezza. Uno de’ spettatori poco da me discosto con un sorriso di compiacenza di se stesso pretese di spiegare la cagione di tanti portenti, attribuendola alle candele artefatte, le quali illuminavano la stanza. Un’altra volta trovandomi presente ad alcuni maravigliosi equilibri di persona fatti da un uomo del mestiere, udii un altro che ne spiegava la cagione ad un vicino sostenendo che era per forza della calamita. Né l’uno né l’altro di que’ bravi spiegatori di prodigi rifletteva che sarebbe stato un prodigio ancora più difficile a comprendersi se vi fossero candele col lume delle quali comparissero e sparissero gli oggetti a piacere; se vi fossero delle calamite disposte in guisa di tenere un corpo umano appoggiato col capo su una punta in equilibrio; e che ricorrendo alla disinvoltura ed all’abituazione d’entrambi la spiegazione era molto più vera e naturale. Uno si accontentò della parola candela, l’altro si accontentò della parola calamita, in guisa che ne cavo un teorema generale, che gli uomini sono difficilissimi a contentarsi delle cose e facilissimi a contentarsi delle parole, trattine i soli grammatici, i quali per l’opposto difficilmente s’appagano delle parole e ricevono pazientemente le cose significate da esse, buone o cattive. In generale gli uomini sono come coloro i quali immaginavano che la Terra fosse una vasta superficie orizzontale. Chi porta questa superficie? dicevano alcuni. Un elefante sul suo dorso, rispondevano i dottori. E l’elefante dove appoggia i suoi piedi? (erano i begli spiriti che andavano sin là colla indiscreta domanda). L’elefante preme la schiena d’una testugine, soggiungevano i dottori. E questa su di qual base venisse sostenuta nessuno s’immaginò di domandarlo. Il popolo va sempre appena un dito al di fuori degli oggetti che immediatamente feriscono i suoi sensi, e tosto ch’ei sia alla schiena dell’elefante, non cerca più in là. Le parole, le parole sono le arbitre dell’universo. Le parole antico, moderno, guelfo, ghibellino, teorica, pratica e simili sono le vere parole magiche. Queste riflessioni è vero che non fanno nascere in noi una molto vantaggiosa idea della ragionevolezza universale degli uomini; ma questa palpabile verità è sempre bene conoscerla, è sempre bene il valutar gli oggetti per quello che intrinsecamente meritano, il prevenirci noi medesimi per non essere contaminati, se è possibile, dall’errore comune, ed amare con tutto ciò gli uomini nostri fratelli, e far loro del bene, e perché lo vuole il dovere, e perché gli errori umani, a ben esaminarli, sono una sorta di febbre morale, più degna della compassione del saggio che di verun altro sentimento.
P. [Pietro Verri]
IL CAFFÈ )( Fogl. V )(
Della eccellenza, utilità e giustizia della flagellazione de’ fanciulli. Ragionamento fra un Pedante ed un Ottentotto
Siccome si è potuto vedere nel breve ragionamento di quel selvaggio del Canadà,[1] che talvolta anche questa miserabil razza di uomini s’ingegna di ragionare così un poco sensatamente, benché sieno poveri ignoranti in paragone di noi altri uomini socievoli, che sappiamo tante belle cose; così io voglio far note a’ miei lettori alcune dotte risposte che furono date da un Pedante ad un Ottentotto per sua instruzione. Già si sa che un selvaggio, che veda per la prima volta i costumi di una civile nazione, si maraviglia di molte cose e le ritrova contrarie alla ragione ed al buon senso. Beati noi, che avvezzi sin da’ primi anni a certe usanze, punto non ce ne maravigliamo!
Era adunque venuto in una certa città d’Europa un Ottentotto. Egli altro non faceva tutto dì che passeggiar per le strade, tanto gli era grato il nuovo spettacolo di una città. È inutile ch’io vi dica quant’egli trovasse maravigliose le nostre case, i nostri vestiti, ogni cosa perfine in paragone de’ boschi e delle capanne di Caffreria. Incontrossi a caso un giorno il nostro selvaggio per via in un fanciullo, che piangendo e gridando misericordia se ne fuggiva verso lui da una vicina stanza a pianterreno. Una figuraccia d’uomo arrabbiato lo inseguiva, e gli stava già sopra con un flagello alzato in atto di percuoterlo. Il buon Ottentotto, seguendo i dettami della sua troppo semplice natura, corse ad un tratto in aiuto del fanciullo, ed afferrando per un braccio quell’infuriato onest’uomo: A che tu perseguiti, gli disse, sì meschina creatura? Non hai vergogna con membra sì robuste d’avere un sì debole oggetto di tua lotta? Io non so punto che vi diciate, rispose colui, io so che questi è un mio scolaro, ch’io sono il suo signor maestro e che ho ragione di punirlo. Ma chi siete voi che vi impacciate delle cose mie? Io sono un uomo, disse l’Ottentotto. Ma avete una curiosa fisonomia, riprese il Pedante, …di che paese? …Di Caffreria, come dicono gli uomini di Europa. Allora il Pedante, dimenticatosi del fanciullo e calmata l’ira, divenne tutto occupato della strana fisonomia del selvaggio, e volendo un po’ provare che razza di gente si fosse questa, ritrovò piacevol cosa l’intrattenersi con lui; ed avendogli dimandato l’Ottentotto qual mestiere fosse il suo, quello gli rispose d’instruire la gioventù. Oh vedi, ripigliò l’Ottentotto, e mi dicono poi taluni fra gli Europei che venite educati nella mollezza, se per fino entrano nella vostra educazione le sferzate? Noi non ne facciamo altrettanto. Eh voi v’ingannate, disse il Pedante, noi altri insegniamo principalmente la grammatica, il latino ed i primi rudimenti delle lettere e delle scienze. Ma il latino non è ella una lingua, soggiunse l’Ottentotto, di certi uomini che sono stati molti secoli fa?… Certissimo, e bene? …E bene, come c’entrano le sferzate in questa lingua? E per grammatica intendereste voi forse i precetti di questa lingua, come mi pare d’aver inteso da taluno? Certissimo, è così, disse il pedagogo compiacendosi della dabenaggine del suo selvaggio. …E poi, io vi replico, come qui c’entrano le sferzate? Allora il pedagogo, per mettere il suo ignorante interrogatore in istato di capire le cose per i suoi veri principii, incominciò: Conviene che voi sappiate che dappoiché da noi s’è preso moglie e se ne hanno avuti figli, i padri loro, siccome amano molto di vivere con meno d’imbarazzi che si può i pochi giorni che passeggiano su questo globo, così lasciano ad altri la cura di educar la propria prole, e perfino molte fra le madri danno ad altri l’incomodo di allattarla. Perché voi dovete sapere che siete così un poco ignorante, e per questo fate le più ridicole interrogazioni che sian mai; per esempio, sapete voi cos’è l’amor naturale e simpatico, il gius di natura, l’Alvaro, il Decolonia e l’alfabetto? Ma di grazia, disse l’Ottentotto, io non capisco per anche quelle sferzate di poco fa. Eh, ripigliò il Pedante, a poco a poco vi renderò conto d’ogni cosa, un po’ di metodo e vi convincerò. Or dunque, per seguire la traccia del discorso instruttivo che ora vi faccio per vostro bene, conviene che sappiate esservi vari uomini, i quali si prendono il lodevole incarico di far ciò che non istimano bene di fare i genitori, per le già enonciate ragioni: onde vari di questi onesti uomini, come son io, si danno la briga di educare quaranta, cinquanta, cento ed anche mille fanciulli. Dal che ben potete comprendere come non si ammettano a tal mestiere che gli uomini più grandi e virtuosi; poiché se vi vuole un uomo grande a far bene un sì importante officio, quale è quello di educare gli uomini dove anche si trattasse di un solo, ve ne vorrà uno, quaranta, cinquanta, cento, mille volte grande per educarne quaranta, cinquanta e così via dicendo. Sappiate di più (perché io voglio non lasciar luogo alla vostra indiscretezza, né voglio che abbiate a burlarvi di noi in conto alcuno), sappiate adunque di più che come non si ammette nessun cittadino a fare il mestiere di calzolaro, di legnaiuolo, di sarto e simili se non ha dato un pubblico saggio di saper fare tal mestiere a cui vuole appigliarsi, onde subir deve un rigoroso esame; così ancora non si ammette nessun uomo a fare l’institutore della gioventù se non ha provato avanti i pubblici magistrati d’esser uomo dabbene, uomo dotto, uomo insomma che meriti tanto onore. Perché vedete bene che alla fine un cattivo calzolaro farà delle scarpe malfatte, uno sciocco legnaiuolo de’ mal proporzionati armari, uno stolido sarto degli sconci vestiti; ma un cattivo, ma uno sciocco, ma uno stolido institutore farà de’ cattivi, sciocchi e stolidi cittadini: onde benché abbiate la disgrazia di esser Ottentotto, mi accorderete che grandissima è la differenza del male, e perciò sapientissimo il provvedimento. Ma andiamo avanti. Le leggi stabilite in questi pubblici depositi di ciò che v’è di più sacro nella repubblica, qual è la buona instituzione de’ futuri cittadini, sono corrispondenti in tutto ad un fine sì importante. Io ve ne darò un saggio, quando però siate in caso d’intendermi. Per esempio, noi insegniamo per prima cosa una lingua bellissima ed utilissima, e quantunque per lo più ivi non la si impari, perché le cose di questo mondo vanno sempre alla peggio, ciò non importa, avvegnacché alla fine tal lingua non si parla quasi mai in vita nostra. Or dunque sappiate che oltre la grammatica v’è un altro mezzo d’impararla, che in pratica riesce a maraviglia, e questo si è quest’istromento che vedete in mia mano. Un bel pezzo di legno fatto al tornio, della miglior grazia che sia mai, con attaccate varie funicelle di cuoio è come quella verga che dinota la nostra giurisdizione. Voi saprete da quel poco che vedeste da noi che la persuasione, la dolcezza ed i tranquilli ragionamenti vagliano poco, perché gli uomini sono troppo cattivi, perciò abbiamo inventato questo elegante istromento, e non passa giorno che a tre, a quattro e ancor più di questi fanciulli a mia custodia commessi io non comandi di stendere le loro mani, sulle quali vibro i colpi a mio arbitrio e con somma umanità. Voi capirete bene come i delitti non debbano essere impuniti in una ben regolata repubblica, e come altresì le leggi debbano provvedere al bene universale, senza eccezion di persona; d’onde ne viene che generali ed inesorabili sono le leggi di questi pubblici luoghi. Chi che sia che faccia cinque errori nella lezione di quel giorno, il che si chiama pessimamente fare, deve per suo bene stendere la mano e farsela flagellare, né l’ineguaglianza de’ talenti scusar puote, né vale il dire che uno sarà negligentissimo facendo due errori ed un altro avrà fatto tutto ciò che ha potuto facendone dieci, ciò non importa, le leggi devono essere universali. E siccome nei delitti provenienti dall’intelletto sembra che la pena più naturale sia quella di punire la sua sede o le cose vicine a lei, così di tempo in tempo viene interrotta la troppo uniforme pena di flagellar le mani col batter forte sul capo del piccolo reo colla destra vendicatrice, e col tirargli le orecchie, e le unghie ancora inserirvi, onde n’esca il pessimo sangue, ciò che serve mirabilmente a svegliare l’ingegno intorpidito ed a spargere il buon umore ne’ studi altronde noiosi. In altre guise ancora si usa d’adoperare il suddetto stromento; ma troppo si richiederebbe perché voi doveste capire l’utilità di tal fonzione e l’edificante maniera di solennizzarla, voi che siete ancora un povero ignorante. Altri poi tra gli institutori, i quali ebbero dalla natura il dono di raffinare le cose, hanno inventate altre utilissime maniere d’insegnare la lingua di cui trattiamo. Vi fu perfino in una città d’Italia uno di loro, che metteva in una corba i suoi scolari e li calava nel pozzo, altri perfino sono giunti ad ucciderne taluno, tant’era il loro zelo. Fatto sta che tutti questi fanciulli hanno un salutare timore del loro maestro, e che non imparano che tremando di riverenza, il che è ottima cosa per raffrenare l’impeto delle passioni e svegliare ne’ cuori ancor teneri una proficua umiliazione di spirito. Di mano in mano poi questi flagellati ascendono a cose maggiori, e passano di una all’altra classe sempre battuti per loro maggior bene finché giungano ad una certa età, nella quale egualmente robusti che i loro institutori non hanno più il privilegio di essere flagellati. E la ragione è molto naturale; poiché potrebbero restituire l’ammonizione, e noi altri institutori abbiamo fissato per massima di dar sempre e non ricever mai. Arrivati dunque costoro all’altezza di due e più braccia, non soffrono più le salutari torture, ed allora loro vengono risparmiate, perché si suppone che non ne abbisognino. Voi direte, perché siete seccantissimo nel far difficoltà, che dovrebbero essere più severe le pene per giovani più forti e più difficili a contenersi nel loro dovere che per i fanciulli, i quali essendo più deboli e meno fatti per commettere delitti importanti, meriterebbero più dolcezza. Io vi lascierò dire, se ’l volete, tutto ciò che il vostro selvaggio e rozzo senso vi suggerisce, ma bisogna sapere quello che non sapete voi, cioè il gius di natura. Ditemi un poco, se io dando un pugno a voi sono sicuro che me lo restituiate tale e quale l’avete ricevuto, trovate conforme alla ragione ch’io ve lo dia? No certamente. Ma se io dando un pugno ad un bambino alto due palmi sono persuasissimo ch’egli altro non farà che lagrimare e chiedermi mercé, non trovate voi conforme alla bella madre natura ch’io glielo dia, perché non corro nessun rischio? E ben vedete ch’io non sono poi sempre obbligato a fare una buona azione, quando v’è pericolo del mio individuo. Questi principii chiari ed evidenti appo noi derivano da quell’altro luminoso principio fissato da’ nostri pubblicisti, che colui che è praestantioris naturae è determinato da questa istessa natura a comandare a chi è meno eccellente di lui. Il maestro è praestantioris naturae dello scolaro finché è più forte di lui, onde finché dura tale ineguaglianza di muscoli, questi non ha che ad essere meramente passivo, ma quando questa eccellenza di natura non è più dalla sol banda del maestro, quando le braccia dello scolaro sono eccellenti come quelle del suo institutore, allora cessa ogni diritto naturale e rientra ciascuno nello stato d’indipendenza. Voi non potreste credere quanto uso si faccia da noi di questa sanissima dottrina. Qui interruppe il suo silenzio l’Ottentotto, dicendo: Gran cose mi dite voi, ma v’è qualche cosa di recondito nelle vostre scienze. Io non v’intendo bene. Ditemi un poco, uno di questi giorni passati ho inteso ch’era stato messo in prigione un uomo che aveva dato uno schiaffo ad un altro, e che si riputava questa azione un delitto gravissimo, e che seriamente si pensava a punirlo, perché le leggi vostre proibiscono di percuotere chi che sia, se non a cagione di propria difesa. Or dunque come queste vostre leggi lasciano schiaffeggiare e flagellare come più torna a conto a’ vostri institutori, e loro abbandonano sì gran numero di cittadini da percuotersi impunemente, senza che alcuno ne chieda ragione? Non è ella una pena grande qui da voi il far flagellare un uomo per la città, come m’è stato detto, e tal pena usate contro ladri ed uomini infamissimi, e non la date senza legittime procedure e sentenza conforme alle leggi; e poi senza sentenza, senza esame della qualità del delitto, se tal pena meriti, senza che alcuno se ne impacci, potrà un tale od un tal altro che non è magistrato, giudice o principe non solo far leggi che si flagelli quello o questo de’ cittadini alla lor cura commessi, ma essere perfino egli stesso giudice, legislatore e carnefice ad un tempo? Ah qual ridicola obbiezione mi fate voi, ripigliò il maestro. Per altro parmi anche che sappiate i termini, e ciò non è poco per voi. Del resto crediate che da noi quando si flagella un briccone per le vie, tutti dicono: oh pover’uomo! egli fa pietà! Il che è conforme alla umanità; ma quando si dice: un fanciullo è stato bastonato dal suo maestro, ognuno ride e si diverte di questo scherzo innocente. Troverete ben pochi che come voi, pover’uomo, prendino la cosa in serio. Ma non è egli vero, ripigliò il selvaggio, che avete de’ magistrati che invigilano alla pubblica sicurezza ed alla privata di ciascuno, che avete leggi che difendano ognuno da privata violenza; e perché queste non estendono la loro benefica protezione sino ai più miseri, ai più deboli, ai più innocenti cittadini? Un fanciullo riceve cinquanta colpi di flagello sulle mani, sulle spalle, sulle gambe, poi vi si aggiunga una gran tirata di orecchie, poi schiaffi, poi calci, poi percosse d’ogni genere; e perché non v’è nessuno che entri di mezzo fra lui ed il suo maestro per riconoscere la giustizia di tal supplizio? Se ad uno di quelli che chiamate conti o marchesi, o ad un padre di questi fanciulli taluno s’invogliasse di fare altrettanto, tacerebbero le leggi? E perché tacciono esse e cessa la loro vigilanza dove d’imbecilli e sventurate creature si tratta? Io vi ripeto, signor Ottentotto, gli rispose sorridendo il maestro, che tutti questi vostri soffismi nascono dal non ritenere i principii di natura e delle genti che vi ho già evidentemente dimostrati. Voi troverete in tutte le nazioni antiche e moderne ove più ove meno osservato questo lodevolissimo costume d’insegnare le lettere colla sferza e col pianto, né voi mi proverete giammai come ciò che sempre si è fatto non debba farsi, e come questo unanime consenso di tante nazioni non vaglia il vostro tenuissimo parere. Che se non v’arrendete alla ragione, ciò non è strana cosa in un selvaggio. E così finì questa conversazione, dopo la quale tuttavia seguitarono gl’institutori a flagellare i scolari per ogni cinque errori finché furono più deboli di loro, e non li flagellarono più quand’essi potevano flagellare a vicenda i loro maestri, e la cosa non si mutò per le obbiezioni d’un Ottentotto, ed altri che gli Ottentotti furono ancor persuasi che non sia giusto flagellare i fanciulli, e tutti i flagellanti dissero male delle indiscrete riflessioni del selvaggio, e tutti i flagellati ne disser molto bene, e gli altri che le seppero, risero, e se ne dimenticarono.
A. [Alessandro Verri]
Dialogo fra un Mandarino chinese e un Sollecitatore
Mand. Perdonatemi, signore: io viaggio l’Europa per istruirmi; compiacete, vi prego, alla mia curiosità, perché vi chiamate voi Sollecitatore? Che sollecitudine avete per professione?
Sol. Volontieri ve lo spiegherò. Io mi chiamo Sollecitatore perché sollecito, acciò si decidino le cause.
Mand. E che vuol dir le cause?
Sol. Vuol dire le dispute di giurisprudenza.
Mand. Cosa è questa giurisprudenza?
Sol. La giurisprudenza è la scienza delle cose umane e divine, l’arte del giusto e dell’ingiusto.
Mand. Voi dunque sapete la giurisprudenza?
Sol. Sicuramente; è mio mestiere.
Mand. Sia ringraziato il Cielo che finalmente mi trovo ben ricompensato de’ miei lunghi e pericolosi viaggi. Eccomi un uomo che sa le cose umane e divine, cioè tutte le cose, il quale potrà rischiarare i miei dubbi. Ditemi dunque, Sollecitatore, ditemi come il grand’Essere Creatore dell’universo abbia impresso il moto ne’ corpi celesti, ditemi come mantengasi vivo senza consumarsi o scemare sensibilmente il fuoco del Sole: è tanto tempo che vi ho pensato senza poter penetrare questi misteri, ne ho consultati tanti inutilmente per averne idea chiara, che merito finalmente d’essere illuminato.
Sol. Mandarino, mi fate ridere. Che volete voi ch’io sappia di queste cose? Voi dovete domandarle all’astronomo. Noi giurisperiti non badiamo a queste sottigliezze; il nostro mestiere c’insegna le cose di questo mondo, non già dell’altro.
Mand. Ma perché dunque mi diceste che era vostro mestiere la scienza delle divine e delle umane cose?
Sol. Mandarino, voi non sapete i primi principii: Divinarum, humanarumque rerum notitia, recti atque iniusti scientia. S’impara nella prima lezione. Ognuno lo sa.
Mand. Veramente io non v’intendo troppo, Sollecitatore; pure, lasciamo le cose celesti e veniamo alla scienza delle cose umane. Ditemi di grazia, perché mai l’ago magnetico si rivolge verso il nord; perché i corpi gravitino sulla terra; perché l’aria sembri pesar meno quando è pregna di particelle umide; perché la luce sia un composto di sette diverse materie, come ho veduto chiaramente da che sono in Europa; caro Sollecitatore, ditemene qualche cosa.
Sol. Mandarino, siete veramente Mandarino. Sapete che se qualcuno ci ascoltasse, riderebbe di voi ma sonoramente? Che volete ch’io sappia di queste inezie; son giuochi da fanciulli, Mandarino, cotesti.
Mand. Sollecitatore mio, la contemplazione dell’universo e de’ miracoli della natura giuoco da fanciulli! Cosa è dunque che tu chiami scienza; cosa è che tu chiami grande, se non lo sono prima il Creatore, poi le stupende opere della sua mano? Ma giacché questa tua scienza delle divine e delle umane cose non comprende né le cose divine né le cose naturali, illuminami almeno sulle cose degli uomini. Dimmi un po’, Sollecitatore, quando è stato che i tuoi Europei hanno principiato ad aver qualche idea dell’antichissimo impero dov’io son nato, e che in Europa si chiama la China?
Soll. Che vuoi tu ch’io m’impacci degli affari de’ tuoi Chinesi! Ho ben altro da fare.
Mand. Ma non sai tu la giurisprudenza, mi dicesti?
Soll. È il mio mestiere; te l’ho già detto.
Mand. E la giurisprudenza non è, m’hai pur detto, la scienza delle umane e delle divine cose?
Soll. Ogni principiante te lo dirà, se non lo sai.
Mand. Ma a che si riducono queste divine e umane cose che sai per tuo mestiere?
Soll. Ti voglio compiacere. Ora, per esempio, ho due punti brocardici per le mani…
Mand. Brocardici! Non intendo questa parola.
Soll. Voglio dire due articoli difficili. Gran pazienza che vi vuole con voi altri Mandarini! Questi due punti brocardici sono, il primo, per vedere se il maschio dalla femmina debba essere preferito nel fedecommesso in concorrenza d’un estraneo; l’altro è per fare la graduazione d’un concorso fra i chirografari e gl’istromentari, e distinguere le poziorità, e liquidare le doti e i beni vincolati.
Mand. Sulla mia parola, Sollecitatore, io non intendo che ti voglia dire.
Soll. Vuol dire… Quando una madre viene a morire nel tuo paese, chi diventa padrone della sua roba?
Mand. Suo marito, se vive, e se è morto i suoi figli.
Soll. E se vi fosse un fedecommesso in contrario?
Mand. Che vuoi tu dire colla parola fedecommesso?
Soll. Povero Mandarino! Fedecommesso è una legge fatta da un uomo privato, con cui dispone in chi devono passare i beni suoi in infinito.
Mand. Nel mio impero i privati non fanno leggi, e se osassero farne sarebbero puniti come rei di lesa maestà. Il far leggi non spetta che al sovrano.
Soll. Ma un uomo non dispone del suo? Se è suo un bene, deve pur poterne disporre.
Mand. Ne dispone sin che è uomo; ma tosto che la morte ha distrutto l’uomo, e che i due principii che componevano l’uomo si sono separati, uno andando in altre regioni, l’altro corrompendosi nel sepolcro, non è più chi debba disporre di que’ beni. La legge ha regolate le successioni secondo i gradi di parentela, e non abbiamo altra norma, e non ne vengono disordini.
Soll. È impossibile ch’io mi faccia intendere su questo punto; l’ignoranza è troppo crassa. Dirò qualche cosa dell’altro. Quando nella China un uomo fallisce, cosa si fa?
Mand. Se è per sua colpa, si fa appiccare come reo d’aver violata la fede pubblica de’ contratti e d’aver rubbato l’altrui; se è per semplice disgrazia, v’è un fondo destinato per soccorrerlo in caso che abbia capacità di regolare i propri interessi.
Soll. Non cerco questo. I beni d’un fallito come si dividono?
Mand. A proporzione del credito di ciascuno.
Soll. Ma i creditori più antichi non hanno fra di voi alcun privilegio?
Mand. I creditori più antichi hanno ricevuto gl’interessi per più anni, e non v’è ragione per prediligerli. La sostanza del fallito in quindici giorni si divide, e se basta a pagare la metà de’ crediti, si dà a ciascuno il cinquanta per cento, e così termina.
Soll. Ma chi ha i suoi crediti per istromento, volete voi paragonarli a chi gli ha su un semplice biglietto?
Mand. O il credito è provato, o non lo è; se è provato, qualunque sia il mezzo con cui si prova, è tutt’uno; se non lo è, non si paga.
Soll. Mandarino, la vostra legge non mi quadra; io colla giurisprudenza, co’ fedecommessi e co’ fallimenti guadagno due mila scudi all’anno.
Mand. Se non avessi altra mercanzia, Sollecitatore, tu morresti di fame a Pekino.
Soll. Perché voi altri Chinesi siete ignoranti, siete stati ignoranti e sarete sempre ignoranti; né v’è paragone fra di voi altri e noi Europei.
Mand. Vedete voi in Europa molti Chinesi che venghino a chiedere qualche cosa del vostro?
Soll. Voi siete il primo che abbia veduto in vita mia.
Mand. Ed io degli Europei nella China ne ho veduti migliaia prima che ne uscissi. Voi altri venite a comprare il nostro the, le nostre porcellane, le nostre vernici, le nostre stoffe di seta, i nostri colori, i nostri profumi, le nostre carte, le nostre pitture, e le case europee quasi tutte ne hanno. Delle mercanzie vostre, e dei vostri fedecommessi, giurisprudenze, scienze divine e umane, e sollecitatori, non ne ho mai inteso a parlare nemmeno alla corte di Pechino.
P. [Pietro Verri]
[Le qualità dell’uomo]
La più bella qualità dell’uomo è quella di esser uomo, cioè di essere sensibile ai mali degli uomini, di essere buono, benefico, compassionevole e discreto; l’avere dello spirito e delle cognizioni è una qualità secondaria. L’uomo onesto, virtuoso, fedele alla sua parola, veridico ne’ suoi discorsi, umano e dolce nel suo tratto, abbia o non abbia spirito e coltura, sarà sempre presso di me un uomo di merito della prima classe.
IL CAFFÈ )( Fogl. VI )(
Contraddizioni morali
Il signor de Voltaire ci ha dato ne’ suoi opuscoli un saggio sulle contraddizioni ed inconseguenze che s’incontrano ad ogni passo nella sempre bizzarra condotta degli uomini; ma il campo è sì vasto e sì fecondo che ha lasciato molto che fare a chi voglia seguire le sue tracce, e non sarà a me per conseguenza molto difficile di riempierne delle più obvie un mezzo foglio, sebbene io mi sia prescritti necessariamente limiti molto più ristretti de’ suoi.
Il destino, per esempio, delle più grandi verità e delle più utili scoperte è stato in ogni tempo d’incontrare le maggiori opposizioni ed i più forti ed ostinati ostacoli, di modo che si può dire con ragione che siasi sempre dovuto fare il bene agli uomini per forza e contro lor voglia. Pareva veramente che questo dovess’essere soltanto in que’ secoli ne’ quali la barbarie, l’ignoranza e la superstizione non avevano ancor fatto luogo ai lumi ed alle cognizioni che ha in seguito sparse a’ giorni nostri la buona filosofia; ma la gran questione[2] che tuttora si agita, per determinare finalmente se l’innesto del vaiuolo debba dirsi utile o pernicioso, da addottarsi o da proscriversi, parmi che sola possa bastare per provarci che siamo poco avanzati da questa banda, e che il maggior numero degli uomini ed è e sarà in ogni tempo lo stesso.
Fu sempre mai egualmente universale il sentire per una banda deplorare amaramente i disordini e le critiche circostanze de’ tempi. I difetti della legislazione, la cattiva distribuzione de’ carichi e la rovinosa maniera di esigerli, la decadenza dell’arti, dell’agricoltura e del commercio; il corso, in sostanza, ed il sistema intiero attuale degli affari; e dall’altra il vedere come si procuri poi al tempo stesso di screditare chiunque da buon cittadino ed a solo oggetto del publico bene, scostandosi dalla strada battuta e scuotendo il giogo delle massime ricevute e consacrate dall’autorità e dall’uso, cerchi di rimontare alle cagioni de’ mali che si deplorano, d’analizarne la natura e di proporne i confacenti rimedi. Egli è un bel sentirli gridar tosto al riformatore, al politicastro, al progettista e, Dio la mandi buona, all’autore di questo foglio.
Ma d’onde mai la pubblica quasi universale prevenzione contro questa sorta di scrittori, che a prima vista sembra tutto all’opposto che meritar piuttosto si dovessero dall’umanità, a prò della quale impiegano i loro studi, tutta la gratitudine e la maggiore riconoscenza?
La questione è affatto fuori del mio soggetto; ma siccome il più de’ miei lettori non l’avrà forse prima d’ora esaminata a fondo, così mi lusingo che in favore della propria curiosità mi perdoneranno facilmente questa piccola digressione.
Procede ella dunque, a mio dire, primieramente dai pregiudizi di alcuni pochi, che senz’esame, perché non troppo avezzi a servirsi della lor testa, credono veramente e di buona fede utile ciò che sia antico e fu loro tramandato da’ suoi maggiori, e cattivo per conseguenza tutto ciò che porti l’aria di novità e di riforma. Secondariamente dalla mala fede e dal mal talento di quelli che o trovano il proprio interesse ne’ disordini, o sogliono detestare tutto ciò che non furono eglino i primi a pensare ed a proporre. In terzo luogo, dal pannico timore che spargono nel pubblico alcuni falsi e poco illuminati zelatori, per quella indiretta connessione ed influenza che possono talvolta avere alcuni politici provvedimenti sui costumi e sulle opinioni degli uomini, ma sopra tutto su i privilegi e su gl’interessi il più delle volte mal intesi di qualche corpo. E finalmente dall’abuso che fece in altri tempi de’ progetti gente che non essendo occupata che dal sentimento di fare una rapida fortuna, ed in luogo de’ necessari talenti non possedendo che una sfrenata arditezza, dotata più che di giudizio d’una vivida e fertile immaginazione (attributi che sgraziatamente si vedono pur troppo molto difficilmente uniti nello stesso soggetto), poco si curò poi della convenienza, utilità, riuscita e conseguenza di quanto proponeva.
Ma ad onta di tutto ciò, un abile facitor di progetti sarà sempre un uomo stimabile agli occhi di chi sappia distinguere il vero merito. So che non è di tutti il ben giudicare della bontà d’un progetto, come non è di tutti il formarlo, richiedendovisi egualmente sì per giudicarne che per formarlo non solo una favorevole disposizione sortita dalla natura, ma una profonda cognizione delle passioni e de’ costumi, delle opinioni e della costituzione d’una nazione, de’ diversi suoi rapporti, circostanze ec. Ciò non ostante non è gran fatto difficile il distinguere generalmente i buoni da’ cattivi progetti. Ogni gran progetto, dice un moderno autore, deve aver di mira il ben pubblico; s’egli non porta questo carattere divino, sarà un temporale, che scaricando l’aria di alcuni vapori nocivi, va desolando le provincie per le quali ei passa. Uno spirito superiore non profonde le sue vigilie a fondar la grandezza equivoca d’un sol uomo sulla miseria di più milioni, egli saprà giugnere allo stesso termine per strade molto più nobili; la potenza del sovrano va sempre di conserva colla felicità de’ suoi sudditi, e l’umanità è d’accordo colla vera politica. Le opere dell’abate S. Pierre, che alcuni chiamarono vaneggiamenti d’un buon cittadino, hanno fatto più bene alla Francia che non gliene fecero quegli immensi in foglio che trattano di questioni quanto più sublimi, altrettanto al ben essere degli uomini inutili affatto e forastiere.
* Un’altra non meno considerabile e non meno universale contraddizione, e, che se riguardiamo i fatti, pare che più di tutte tenga alla natura stessa dell’uomo, io scorgo in vederlo quanto proclive ed inclinato a rigettare, ed a sprezzare tutto ciò che sia semplice, naturale ed evidente, altrettanto poi facile e disposto a credere, addottare e sostenere le cose le più inverosimili ed assurde,[3] purché sieno o involte da una sempre dal volgo rispettata oscurità, o corredate dallo straordinario, dal portentoso e dal mistero; cosa, a mio dire, che più d’ogn’altra s’oppone ai progressi dello spirito e delle cognizioni umane, sviando la maggior parte da quelle strade piane e dritte che condurrebbono alle più grandi scoperte, che questa falsa opinione ci persuade lontane e astruse, quando sono vicine ed a portata d’ogni mediocre intelletto. Di fatti e qual fu mai, se noi eccettuiamo il solo Confucio,[4] quel legislatore che possa gloriarsi d’aver persuasi o commossi gli uomini colla sola e nuda verità, d’averli ritratti da’ più grossolani pregiudizi colla sola forza della ragione, e non abbia tutt’all’opposto dovuto servirsi dell’impostura ed interessare a suo favore l’umana imbecillità? Rivolgiamo per un momento indietro un’occhiata, e vedremo ogni popolo, ogni nazione pretendere e vantare un’origine prodigiosa, vedremo il mondo intiero condotto dagli oracoli, dagli augurii, dalla magia e dall’astrologia, vedremo tutto pieno di spiriti, di geni, di silfi, di gnomi e di professori delle chimere di Tessaglia, e vedremo finalmente autorizzate le idee le più stravaganti e ridicole, le pratiche le più bizzarre e spesse volte le più crudeli. So che la stampa, il moto della Terra, le leggi invariabili della natura, i microscopi, i telescopi hanno data una grande scossa a questo incantato edificio; ma ce ne rimangono tuttora de’ gran resti, ciò che ci fa bastantemente comprendere ch’egli non era già fondato, come alcuni pretendono, sulla sola ignoranza, ma in buona parte sull’ambizione dell’uomo, che tutto a sé rapporta e si fa centro dell’universo. Non è credibile a qual folla d’errori e d’inconseguenze apra la porta questa sciocca prosonzione. Ella introduce in noi una falsa idea di perfezione e di superiorità, che non ci lascia né apprezzare al giusto, né conoscere a fondo la nostra essenza. Strascinati così fuori di strada, tutto allora diventa illusione, e noi restiamo poi attoniti, e non sappiamo comprendere come mai troviamo all’occorrenza e gli altri e noi stessi sì diversi da quel che ci eravam figurati e sì lontani dalla meta che ci eravamo proposti.
Lagnavasi l’altro giorno Filone dell’ingratitudine di certo tale, che sì male corrispondeva a’ beneficii ch’aveva da lui ricevuti. Deplorava un soffista la corrutela del secolo, perché non ostanti le continue declamazioni contro le passioni degli uomini, eglino proseguissero più che mai ad essere avari, ambiziosi e dediti al piacere. E l’uno e l’altro avete torto, io gli dissi allora. Voi, o Filone, non soffrite che la pena d’un vostro errore. Convien disingannarsi, l’uomo opera da uomo e secondo i principii ch’egli ha, non secondo quelli che voi gratuitamente gli attribuite. Che meraviglia, dice pur bene un certo autore, che meraviglia che la talpa non voli ed il cocomero non produca le rose! Chi benefica gli uomini perché la religione lo comanda, opera da saggio, poiché si procura il massimo fra tutti i beni. Chi benefica gli uomini pel piacere che prova facendolo, opera da saggio finché la somma del piacere attuale non sia sorpassata dalla somma del dispiacere futuro. Chi benefica gli uomini aspettando la loro gratitudine, getta per lo più il seme in un fondo sterile e sabbioso, e si procura la tristezza al tempo della raccolta. Gli uomini insignemente beneficati sentono la propria umiliazione, e da questo sentimento per gradi passano all’odio, se non vi si contrappone la speranza di nuovi beneficii, movimento dell’animo dolce e piacevole, che corregge quello della dipendenza da un creditore impagabile. E rivolto al soffista: Finché cercherete, io dissi, di distruggere le passioni degli uomini, e finché non declamerete che contro il male attuale, cioè contro gli effetti, voi vi sfiaterete inutilmente senza render gli uomini migliori. Volete un buon consiglio? Piuttosto che di distruggerle, cercate di bene ed utilmente diriggerle; lasciate da banda gli effetti ed ascendete alle cagioni; succede nel morale appunto ciò che succede nel fisico: se voi opponete di fronte un argine ad un torrente, eccovelo tosto rovesciato, se voi v’opponete direttamente alle direzioni delle passioni, esse vi scaccieranno sconciamente da una banda ciò che non li permetterete di deporre regolarmente dall’altra; chi applica un rimedio locale ad un male che dipenda dal vizio universale degli umori, o perde le sue cure od al più non ottiene che un soglievo momentaneo e passaggiero. Sovvengavi sopra tutto che una società d’uomini senza passioni, un aggregato di uomini perfettamente saggi e virtuosi è una vera chimera, che bisogna cercare fuori di qua. E ben lo sa il povero Memnone, il quale dopo d’aver formato la mattina l’insensato progetto di voler esser tale rinunziando alle donne, al giuoco, alla crapola, ai litigi e sopra tutto alla corte, prima di notte poi si vide ingannato da una donna, s’ubriacò, giuocò, attaccò briga, perdé un occhio e dovette presentarsi alla corte, dove molto si burlarono di lui e della sua figura.
Non è poi meno strano il vedere come d’ordinario, in tutte anche le più interessanti questioni, non si ascenda giammai preliminarmente all’esame e verificazion de’ principii, dal che ne siegue che se, come non rade volte succede, questi sieno falsi, quanto più giusto si ragioni, altrettanto più divergenti sieno le conseguenze che se ne traggono, e mostruose a segno di dovere o rinunziare a’ principii stessi, cosa molto difficile e rara, o di rimanere dubbi ed incerti, e bene spesso in positiva contraddizione entro noi stessi. La storia del dente d’oro è notoria abbastanza, ed ognun sa quante belle ed erudite cose si sieno in quella occasione scritte da valent’uomini per provare e far vedere come ciò potesse essere naturalmente, finché un uomo cauto esaminata la cosa un po’ più da vicino scoprì la frode e l’impostura. E guai a chi voglia farneli rissovenire. Parlavasi un giorno nella bottega del nostro Demetrio d’una singolare avventura d’una pecora, che aveva parlato a un pastore pochi giorni prima ne’ contorni della nostra città. Era riscaldata assai la disputa, e pretendevano alcuni che dovesse avere la lingua assai più grossa che non hanno comunemente le pecore; altri sostenevano che bastava che avesse i muscoli più vigorosi delle altre, e che anche colla lingua sottile si parlava; e la disputa s’era riscaldata a segno che la cosa andava facendosi seria, quando un certo tale, che stava ascoltando in disparte, si fece per rappacificarli modestamente avanti, e: Di grazia, disse, è egli ben sicuro che questa pecora abbia parlato? Bastarono queste poche parole, perché fatta per quel momento tregua fra loro, tutti d’accordo contro di lui si rivolgessero. E come! Voi ne dubitate? gridò il più violento della compagnia, voi siete un pirronista, un cattivo cittadino: forse che non vi furono in altri tempi dei buoi ch’hanno parlato? Lo dice Livio, e il negarlo è voler togliere ogni fede umana. So benissimo, rispose l’altro, che Livio lo ha scritto; ma perché una cosa sia scritta, e stampata, e in latino, e antica, e d’un classico autore, non perciò, s’ella ripugna al buon senso apertamente, dobbiamo bevercela; né perciò io credo di meritare d’essere caratterizzato per pirronista o per cattivo cittadino. Sì, signore, un cattivo cittadino, un pirronista, replicò il primo, e questo è un prendersi gioco e beffarsi amaramente di noi. E sa il Cielo dove andava a finir la facenda, se il buon uomo non avesse stimato d’andarvi al riparo con una pronta ritirata, barbottando nel partire, fra’ denti, che non sapeva che bastasse d’offendere l’amor proprio delle persone per meritarsi la taccia di cattivo cittadino e di pirronista; eppure questa è, pur troppo, di cert’uni la solita maniera di ragionare.
Dal non rimontare a’ principii ne vengono per necessaria conseguenza l’abuso delle parole e le arrabbiate dispute sul diverso significato ed interpretazione delle medesime:[5] dispute interminabili, poiché non cercasi già di trovare in esse il vero sentimento, ma quello che serva a sostenere le opinioni ed il partito al quale sia ciascuno preventivamente attaccato.
Cosa strana veramente che il bene od il male, il vero od il falso, il torto o la ragione debban dipendere dall’interpretazione d’una parola, d’una frase di lingue molte volte mal conosciute e meno intese. Sarebbe dunque desiderabile che i commentatori[6] e gl’interpreti si persuadessero alla fine, tra l’altre cose, che non son le parole che debbano decidere della verità e de’ fatti, ma bensì i fatti e la verità che devono decidere delle parole; regola che non so poi, per quanto triviale ed inutile ella sembri, se finora siasi da loro scrupolosamente osservata.
Dal fin qui detto si potrebbe dunque conchiudere quanto sia necessario, anzi indispensabile per chi cerchi di buona fede il vero, prima di determinarsi e decidere sugli oggetti sottoposti alla ragione, d’adoperar la ragione istessa, e colla maggiore imparzialità esaminarli e metterli al più rigoroso sindicato.
S. [Pietro Secchi]
Su i parolai
Ne’ fogli nostri dell’anno scorso abbiamo in diversi luoghi parlato di quel ferreo rigorismo di lingua che alcuni grammatici vorrebbero pure che fosse nell’Italia la prima legge delle lettere; e ci siamo assai chiaramente e co’ fatti e co’ discorsi mostrati ragionevolmente libertini in questo genere. So che taluni de’ rigidi osservatori di que’ principii hanno mormorato contro di noi; né in ciò troviamo noi motivo di maraviglia o di lamenta veruna. Ma cosa importante assai pel progresso delle lettere e delle scienze si è che nella universale opinione vengano una volta fissati i giusti confini che aver debbe l’autorità de’ puri grammatici, acciocché l’ufficio loro non resti né affatto destituito di forza, né inalzato sino alla tirannia degli ingegni, alla quale tentono di giungere qualora non trovino valide opposizioni. Lo scoraggiamento che inspira negli animi de’ giovani inclinati alle lettere la ferrea voce di tanti accigliati grammatici, lo sconvolgimento d’idee che con ripetuti e incessanti colpi fanno essi nelle tenere menti, rivolgendole tutte alla considerazione mecanica delle parole e spegnendo co’ gelati loro precetti ogni felice germe di filosofia e di genio, sono un male sì importante per gl’ingegni italiani, che noi non ci stancheremo mai di tratto a tratto di ragionarne e opporvici per quanto è a noi permesso; giacché come l’errore, così anche le verità più facilmente s’imprimano presentandosi alla mente con replicati tentativi e sotto diversi aspetti. Ella è cosa per sé evidente che l’essenza d’un discorso consiste nelle cose che si dicono, e le parole altro non sono che i mezzi coi quali vien significato il discorso: quindi è evidente pure che il primo oggetto dell’attenzione d’un uomo ragionevole devono essere le cose, e le parole devon essere un oggetto assai secondario. Per giudicare del merito d’un’opera, la prima importante vista deve esser quella della natura delle idee ch’ella contiene, se giuste ovvero false, se grandi ovvero volgari, se importanti ovvero frivole. Dopo di ciò deve aversi di mira il metodo col quale esse idee sono disposte, dal qual metodo dipendono principalmente la chiarezza, la facilità e l’impressione più o meno efficace che esse idee possono fare nella mente. Dopo ciò deve pur porsi mente alla diffusione o ristrettezza del discorso: due estremi, i quali egualmente rendono noiosa e difficile la lettura; uno, perché essendo molto da loro distanti le idee principali e interessanti dell’opera, difficilmente lo spirito umano si risoviene di tutte le antecedenti, onde non restano impressi con esatti contorni, dirò così, gli annelli di quella catena la qual rappresenta il passaggio dalla verità conosciuta alla incognita; l’altro, perché accavallandosi le idee forti e primitive l’una all’altra, richiede troppa fatica e contenzione nell’animo del lettore per interrompere con continui ragionamenti del suo la lezione. Dopo tutti questi oggetti vengono le parole e la disposizione di esse, e chiunque ne’ suoi precetti o nella sua pratica insegna o fa vedere di anteporre il pregio delle parole ad ogni altro, e di giudicare d’un autore sull’osservazione di alcuni capricciosi precetti dettati da alcuni privati e non mai addottati universalmente dall’Italia, offende il senso comune ed ogni principio di ragionevolezza.
Sappiamo esattissimamente che gli uomini già inzuppati di principii di tirannia grammaticale non si convertono mai; poiché non è possibile convertire altrui se non col ragionamento, e chi è avvezzo a posporlo alle parole non lo sente. Coloro non leggono i nostri fogli, né ad essi intendiam noi di ragionare; ma i nostri fogli son letti da molti uomini illuminati e discreti; son letti da alcuni giovani minacciati dalla tirannia de’ pedanti, e deve esser caro ai lettori nostri il vederci in guardia per combattere questi nemici degl’ingegni italiani, acciocché, se è possibile, colla generazione presente sia spenta la setta de’ parolai, che da tre secoli a questa parte non ha mai fatto nulla di buono. Di essa potrebbe dirsi quello che Quintiliano scrive nel lib. 2 delle Instituzioni, cap. 2: Nihil enim peius est iis qui paulum aliquid ultra primas litteras progressi falsam sibi scientiae persuasionem induerunt, nam et credere praecipiendi peritis indignantur, et iure quodam potestatis quo fere hoc hominum genus intumescit, imperiosi atque saevientes stultitiam suam perdocent. Sono costoro degni del titolo che dà Cicerone nelle Questioni accademiche di opiniosissimi homines; e vedendo con quale ostinazione ricusino di piegarsi alla luce dell’evidenza, pare che siano dipinti da Quintiliano, Institut. orator., lib. 12, cap. 11, dove dice: Velut sacramento rogati, vel etiam superstitione constricti, nefas ducunt a suscepta semel persuasione discedere.
L’autorità degli antichi è perfettamente contraria alle pretensioni del dispotismo grammaticale. Noi vediamo presso Quintiliano come cura verborum derogat affectibus fidem. Noi vediamo presso Orazio che la bellezza d’un’opera in ciò consiste,
… ut sibi quisquis | Speret idem, sudet multum, frustraque laboret | Ausus idem.
Vediamo che gli ornamenti e le lisciature del discorso furono disapprovate, quando giunsero alla tirannia a cui si vorrebbero portare dai grammatici, da Cicerone, Ad Herennium, lib. 4, dove così: Gravitas minuitur exornationibus frequenter collocatis, quod est in his lepos et festivitas, non dignitas neque pulchritudo. Vediam presso Salviano delle proteste simili a quelle che abbiamo fatto noi, e che prima anche di noi han fatto tutti gli uomini ragionevoli: Nos, rerum magis quam verborum amatores, utilia potius quam plausibilia sectamur; non id quaerimus ut in nobis inania saeculorum ornamenta, sed ut salubria rerum emolumenta laudentur. Seneca poi fu de’ più decisi oppositori contro la tirannia de’ puristi grammaticali, ivi leggesi chiaramente nell’epist. 115: Cuius cumque orationem videris sollicitam, et politam, scito animum quoque non minus esse pusillis occupatum. Oratio vultus animi est, si circumtonsa et fucata est et manufacta, ostendit illum quoque non esse sincerum, et habere aliquid fracti; non est ornamentum virile concinnitas. Ed altrove dando precetti al giovane Lucilio così s’esprime: Nimis anxium esse te circa verba et compositionem, mi Lucili, nolo: habeo maiora quae cures; quaere quid scribas, non quemadmodum.
In somma tutti i più accreditati scrittori dell’antichità ed in fatti ed espressamente ci hanno lasciato testimonianza di aver pensato l’opposto di quel che vorrebbero farci pensare i dispotici grammatici, de’ quali alcuni c’incolpano di novatori, sebbene da noi non si sostenga che un’antichissima opinione favorevole alla libertà della repubblica letteraria; ma, dice pur bene il gran Galileo ne’ suoi dialoghi, è l’istesso esser le opinioni nuove agli uomini, ed esser gli uomini nuovi alle opinioni. Noi non disprezziamo chiunque fa un esatto studio della propria lingua; anzi molto lo lodiamo, purché egli con questa cognizione sola non pretenda di giudicare altro che della lingua; purché egli conosca che il merito della lingua solo non fa un libro buono o cattivo, un autore stimabile o dispregievole. Ogni parola che sia intesa da tutti gli abitanti d’Italia è secondo noi una parola italiana: l’autorità, e il consentimento di tutti gl’Italiani, dove si tratta della lor lingua, è maggiore dell’autorità di tutti i grammatici, sebben anco s’unissero a ricusarla. Questo è uno de’ nostri principii, il quale è pure il principio di tutti gli uomini ragionevoli in quest’affare. Ogni frase o parola poco intesa per tutta l’Italia, sebben anche fosse registrata su tutti i dizionari, non deve usarsi qualora vi sia in sua vece altra parola comunemente intesa. Qualora uno scrittore dica cose ragionevoli, interessanti, e le dica in una lingua che sia intesa da tutti gl’Italiani, e le scriva con tal arte d’esser letto senza noia, quell’autore deve dirsi un buono scrittore italiano. Questi sono i canoni che la ragione suggerisce a chiunque la consulti.
P. [Pietro Verri]
IL CAFFÈ )( Fogl. VII )(
Il pezzo seguente, che ci è stato trasmesso, lo pubblichiamo ben volontieri, persuadendoci ch’ei debba piacere ai lettori sensibili alle bellezze della fantasia. Noi lo diamo al pubblico non già come un trattato contenente una catena d’esatti sillogismi, ma bensì come un ameno delirio ed un dolce errore d’una fervida immaginazione, alla quale compete il privilegio accordato alla poesia. Eccolo.
I piaceri dell’immaginazione
Sono grandissimi i beni e i mali che agli uomini derivano dalla loro immaginazione. Siami permesso per ora di considerarne solamente i vantaggi e la maniera di procurarseli. Forse scoprirò a molti ricchezze che ignoravano di possedere, forse potranno alcuni fare un uso migliore di una facoltà che loro era funesta. I piaceri che immediatamente ci sono forniti dagli oggetti esteriori sono pochi in numero, né colla varietà loro suppliscono per se stessi al pronto passaggio che fa l’essere sensibile dal conseguimento al disprezzo. Aggiungasi che l’uso di essi, o sia diritto di procurarsegli, è per l’infelicità degli umani stabilimenti con sì grande disuguaglianza distribuito, che il numero de’ piaceri somministrati dagli oggetti esterni è per lo più in ragione inversa dello sforzo che si fa per ottenerli; chi più travaglia, minor numero ne ottiene. Qual obbligazione non hanno dunque gli uomini, in questo stato di cose, all’immaginazione, che supplisce in parte, per chi sa farne uso, a questa estrema disugualianza! Ella semina di fiori e rende piano e facile il sovente lungo e disastroso intervallo che passa tra un piacer fisico e l’altro. Gli uomini vorrebbono annientar questo intervallo; sforzati a correrlo, lo fanno con troppo precipizio, e perciò con pericolo, se l’immaginazione non gli arresta per via, divertendoli co’ suoi grati fantasmi ed incantandoli coll’infinita varietà dei piaceri dell’opinione, che non sono meno reali perché cominciano e finiscono nella sede delle nostre sensazioni. Egli è dato a pochi il gustar veramente e in tutta la loro estensione questi piaceri, poiché la maggior parte degli uomini hanno bisogno delle scosse attuali degli oggetti presenti per sentir voluttà, e questa tracannano a grandi sorsi anzi che la assaporino: ma l’uomo saggio, che conosce quanto scarsi e brevi siano i piaceri che le fuggitive occasioni ci presentano, sa, della piccola porzione che gli è toccata in sorte, per mezzo della incantatrice immaginazione prolungarne la durata, abbellirla ed ampliarla.[7] L’immaginazione chiama dal tempo predatore i passati diletti, e spingendosi nell’oscuro avvenire ne invola qualche particella per mezzo della dolce ingannatrice speranza per trasportarla sul presente momento, che senz’essa sarebbe languido ed insipido. Così l’immaginazione stende su tutti i momenti della vita di un uomo quei piaceri che furono a salti e disugualmente distribuiti. I piaceri dell’immaginazione sono meno vivi, ma più variati dei fisici. Anzi, ogni piacer fisico come monarca ha sotto di sé un immenso popolo subordinato di piaceri d’immaginazione, che gli fan corteggio, che ne aumentano il lustro e lo rendon potente nell’animo umano; anzi, egli è questo popolo solo che gli apre una comunicazione ed un commercio coi piaceri fisici d’un altro senso.
Gli uomini corrono ansanti, si urtano, si sterminano tra di loro per rubbarsi scambievolmente i pochi fisici piaceri sparsi qua e là nel deserto dell’umana vita, ma i piaceri d’immaginazione si acquistano senza pericolo; tutti nostri, poco invidiati dal maggior numero, che non li conosce né li pregia, se non rendono un’anima estremamente felice, la rendono almeno tranquilla. Oh, innocenti deliri, parte migliore di nostra vita, parte intatta dagli artigli della iniquità, se il vostro fine non è brillante, se non riscuote l’ammirazione, se non produce un’ubbriachezza di gioia che poco dura nell’animo, almeno la vostra carriera non è circondata di precipizi, né le spine dell’invidia, né gl’inciampi della malizia slanciano chi vi possiede dalla speranza al timore e dal timore alla speranza. Mirate la faccia dell’ambizioso anche fortunato nelle sue mire, mirate i profondi solchi del dolore, mirate il pallore steso dall’inquietitudine su i loro volti, paragonateli coll’aria tranquilla ed indolente, col quasi invisibile sorriso che appena scorre sul volto di uno de’ miei deliranti, e ditemi chi è stato più saggio. Egli scorre su una moltitudine di oggetti tutti aggradevoli, gli guarda in tutti gli aspetti, ne fa tante diverse combinazioni, tanti quadri ridenti e graziosi, che la somma volubilità loro e varietà supplisce a quella vivacità ed a quella forza di cui mancano, la quale pare che gli uomini considerino per dato principale nei calcoli che fanno sulla loro felicità.
Quest’uomo, che è felice senza parer di esserlo, non è che di tanto in tanto si rifiuti qualche onesto piacer fisico. No; egli ne ha di bisogno per non desiderarli troppo, ne ha di bisogno per rimontare gli organi della immaginazione e per fornirsi quasi di materia prima, per travagliarla poi a suo modo e tingerla di tutti quei colori che sono forniti da quelle tante piccole pazzie che ha l’arte di saper celare, e farne un uso qualche volta men funesto d’un freddo ragionamento.
Ma per esser così saggiamente pazzo fa di bisogno un poco d’industria, e forse delle riflessioni anche più fine che per esser pazzamente savio. In primo luogo è mestieri avere una copiosa raccolta di oggetti versatili e maneggievoli, che si lascino combinare, paragonare, volgere e rivolgere per tutti i versi, come repubbliche immaginarie, tesori nascosti e fino palazzi incantati, e cose simili, se siete un po’ credulo. Qualche assurdo, qualche contraddizione può scappare, perché in fatto di pazzia non bisogna esser così difficile come in fatto di sapienza. Raccomando lettura di poesie, drammi, poemi epici, e romanzi principalmente, ma non di quelli che vanno noiosamente al suo fine, né di quelli che ti strascinano la sensibilità verso un solo oggetto, ma di quegli altri che te la dividono e te la sminuzzano in tante parti differenti, ed ora ti fanno imperadore, or Caloandro, ed or ti conducono a viver solo in isole deserte, ed or ti trasportano nel fracasso di una capitale. Fa di mestieri render agile l’immaginazione e rispettare la ragione, sovrana nostra, senza esserle cortigiano troppo assiduo, altrimenti ella t’impiomberà l’immaginazione e ti sforzerà a scavare, mentre tu hai bisogno di scorrere. Non si tratta di analizare, ma di comporre. Sia avaro degli errori aggradevoli, e per carità non ti lasciare sfuggire dalle mani una bella chimera di Platone per un freddo ragionamento di Locke. Una cosa molto confacente al tuo scopo è di acquistarti nelle cose umane un poco d’indolenza filosofica, sì negli affari che nella ricerca della verità, della quale tu non sarai né infedele, né ribelle suddito, ma solo oscuro ed inoperoso coltivatore. Vi sono dei libri che sono ottimi magazeni di simil mercanzia: Montaigne, il Trattato dell’opinione di monsieur le Gendre, ed altri che non devi ignorare, ti si presenteranno all’occasioni. Essi ti rintuzzano la sensibilità non perché la estinguino, ma perché la rendono estremamente volubile e la tengono sempre in equilibrio.
La massima politica dividi e comanda può essere addatata al tuo caso. Dividi la tua sensibilità, dividi la forza delle tue passioni in tanti piccoli desideri, e che gli uni succedendosi agli altri, niuno possa imperiosamente occupare il posto e soprastare a tutti. Gli oggetti quando entrano nella nostra mente hanno una forza espansiva, che se tu non ristringi e metti in equilibrio con altri oggetti che producono altri desideri, essi s’impadroniscono del tuo cervello, di tutte le facoltà da cui nascono le passioni perturbatrici del riposo, e qualche volta la pazzia grande e fuori d’uso, che è la sola condannata alle catene ed allo spedale. Se le tue passioni son vive, se i tuoi bisogni troppo pressanti, l’incertezza ti amareggia ogni momento e l’immaginazione diventa tua tiranna in vece di esser tua amica. Non tracanna le sensazioni, non abbia fretta di vivere; ricordati che ciò che accumuli troppo per un istante è infallibilmente tolto ad un altro; spettatore degli uomini, che ciechi corrono e si confondono tra di loro, ritìrati destramente da lato, sminuendo per quanto sia possibile le relazioni che hai con essi, e fa loro del bene in quella giusta lontananza che non possino arrivare a sconvolgerti e strascinarti nel loro vortice. Poche anime felici ed elevate sopra il comune livello possono all’immensa turba opporsi, e svolgendone e riordinandone il corso trarla all’ara del comun bene, ara quasi inacessibile e quasi subito demolita che edificata. Ma tu, beato contemplativo, tacito godi i brevi istanti che corron tra il tuo nascere e sparire. Che importa che il verme lasci una traccia di sé nella polvere e l’universo ascolti forse il sussurar d’una farfalla? Volgi gli occhi agli innumerabili ed immensi globi gettati dal Grand’Essere nell’immensità dello spazio, a quei torrenti di luce, a quello spirito di vita che circola nell’universo, e trovandoti or colosso, or atomo, ti riderai egualmente di chi sopra tutto e di chi nulla s’aprezza. Lascia gli uomini combattere, sperare e morire; tu nella serena ragione de’ pazzi tuoi simili ridi di loro, ridi di te stesso e riposa mollemente su quella illuminata indifferenza delle umane cose, che non ti tolga il piacere vivissimo di essere giusto e benefico, ma ti risparmi gl’inutili affanni e le tormentose vicende di bene e di male che sbalzano continuamente gli uomini inaveduti, cioè la maggior parte.
Ma perché gli uomini ti lascino in pace bisogna che tu sia in pace con te stesso. Non màcchiati di verun delitto, sia giusto con tutti gli esseri che ti circondano. Fino gli animali calpestati dall’uomo superbo e crudele godino la tua giustizia, ricordati che un raggio di vita brevissima e limitata scorre ne’ loro membri. Se sarai ingiusto e cattivo, il rimorso e l’inquietitudine circoleranno col sangue nelle tue vene: il timore e l’incertezza della tua sorte ti spingerà tuo malgrado nel tumulto degli affari umani.
Ma sopra tutto non abbia la chimera di esser perfetto,[8] desiderio inquieto ed inutile, che ti renderà sprezzabile a te medesimo e inimico degli altri uomini; sentimento che porta seco la pena della sua ingiustizia; non fòrmati un modello ideale di perfezione, a cui rapportare tutta la varietà dei fenomeni morali; perché troverai in ogni evento un disinganno, in ogni azione un vizio, in ogni cosa un’imperfezione.
Sia amico della beata solitudine, togliti spesso dalle chiuse città. Va nei soggiorni della libera natura, nel più antico tempio della divinità. Le montagne ripetano le tue canzoni e i flutti romoreggianti del mare accompagnino i tuoi inni. Ivi meditando vedrai qualche anello principale dell’eterna catena; ivi sentirai la piccolezza de’ nostri affari e de’ nostri sistemi. Se da per tutto troverai le tracce distruttrici dell’uomo, da per tutto vedrai la saggia natura che ripara alle sue rovine, perché l’uomo modifica, ma non può diminuire quel fondo inestinguibile di vita che accogliesi nel di lei seno.
C. [Cesare Beccaria]
Sull’origine e sul luogo delle sepolture
La morte, fenomeno che pochi guardano con tranquilla filosofia, come una necessaria conseguenza delle infallibili leggi dell’universale meccanismo stabilito dall’Eterno Autore della natura, si è quel punto che fa rientrare nella folla de’ corpi non organizzati la spoglia nostra e la confonde col resto della materia. Incapace allora d’azione, di sentimento, di piacere e di dolore, pare che non dovrebbe dagli altri uomini meritare cura alcuna. Ciò non ostante quello è il tempo in cui maggiori tributi riceviamo dall’altrui umanità. Un uomo a disagio è sempre l’oggetto delle altrui beneficenze, a meno che non lo vieti l’incallita sensibilità, male incoreggibile, o che qualche altra passione forte non vi s’opponga. L’idea della morte, sempre accompagnata da quella del dolore che la precede, ci fa rivolgere su di noi stessi, ed il timore di quelle medesime circostanze e d’una misura uguale di sensibilità risvegliano in noi l’inquieto e tanto utile sentimento sul male altrui chiamato compassione. Se a questo si aggiunga la lunga abitudine d’una costante associazione tra l’idea d’un cadavere e quella d’un parente e d’un amico, si avranno nella umanità e nella congionzione di sangue ed in fine nell’amicizia i veri principii degli onori resi a’ corpi de’ morti.
In fatti il vivo dolore per la morte d’un uomo, che ci appartiene, il desiderio di sollevarlo, che non possono mai negli accessi d’una passione violenta e forte? Si crede capace di sentimento un freddo cadavere, e dopo pianti lunghi e sospiri inutili, tutto si rivolge lo studio ad onorarne la memoria ed a procurargli quel piacere a cui lo crediamo sensibile. Questo è il linguaggio del cuore, linguaggio ugualmente universale. D’onde mai se non da questo trassero origine le libazioni de’ Romani? D’onde le cerimonie de’ troppo ammirati Chinesi, tanto simili a quelle de’ selvaggi? I morti di questi, dipinti il viso ed abbigliati della migliore e più magnifica maniera da’ parenti e dagli amici, in dirotto pianto ed in lamentevoli strida accompagnati alla sepoltura, sono ivi deposti in cellette tapezzate di pelli e di verdi rami, e con accanto le più onorevoli insegne ricoperti di terra, ed in seguito sempre ivi portati de’ cibi, perché volendo possano mangiarne. Così onorandoli credono di potergli riparare dalle ingiurie degli animali ed anche dall’aria, delle quali tanto orrore avevano i popoli di Palestina, che per la sola idea che i loro corpi o quelli de’ loro amici potessero restarvi esposti, a nissuno negavano la sepoltura fuori che ai colpevoli di suicidio, e questo ancora per poche ore.
Schivate in questo modo delle sensazioni disaggradevoli, schivato pure era il rischio che per la sanità poteva aversi dalle esalazioni di materia che si corrompe, e rese costanti delle opinioni, alle quali la dissoluzione di conosciuti corpi avrebbe potuto far argine. L’uso d’imbalsamare, e d’avere così impunemente presenti i cadaveri, le mantenne in seguito e le fortificò.
Egli è naturale che i principii di questi riti gl’istessi sieno che quelli della idea dell’immortalità e d’un altro mondo, comuni anche alle nazioni barbare non rischiarate dalla religione. L’immaginazione animata da’ sentimenti d’una dolce amicizia rappresenta facilmente le situazioni migliori e le più piacevoli. Le più belle pitture sono lo scopo de’ suoi desideri e di poi d’un’intima persuasione. Così in preda ad una deliziosa illusione si fabbrica la dimora delle Houris, e di lontano guardansi in una bella prospettiva, e si realizzano i piaceri e le estasi d’un incantato soggiorno. Ecco da qual velo si ricopra la tormentosa idea della morte, e quali sorgenti di errori ne vengano dalla smisurata licenza di conghietture che la vera religione ci mostra tanto false.
L’onore della sepoltura dovette già un tempo essere la misura del merito degli uomini e del dolore della lor perdita. Tra gli Egizi erano dopo morte sino dalla più grande antichità giudicati gli uomini, e tanto de’ re quanto del popolo sulle azioni era approvata o condannata la vita. Privati ne erano di sepoltura i cattivi, ed onorati i buoni. Esempio grande d’una buona legislazione, dove le ricchezze, la nascita, le dignità, doni della fortuna, non determinavano i voti, ma bensì la pietà e le virtù.
La riconoscenza, l’interesse, il timore, le virtù, i vizi dovevano solo accrescere l’impressione del dolore per la morte d’alcuno, scemarla od annientarla. Il costume poi, al sentimento l’apparenza, alle virtù le ricchezze, al merito la vanità e la forza de’ viventi congiunti sostituendo, adoperati furono de’ piagnitori, che un imprestato dolore fingendo, offerissero lo stesso apparente spettacolo, come e tra selvaggi, e tra’ Romani, e tra altre nazioni si vide e tuttavia si vede.
Il crudele uso di abbrucciarsi co’ cadaveri de’ sovrani e di non sopravivere alla morte de’ mariti, primo effetto della desolazione e d’una insoportabile tristezza, fu quindi autorizzato, e ad onta della umanità si sacrificano ancora nelle Indie delle sfortunate vittime ad esseri detestati.
La vanità in fine e l’incessante desiderio di gloria spingendo gli uomini a portare nell’avvenire la fama della loro esistenza, come se la voce degli applausi potesse arrivare ad agire sulle fredde ceneri, s’innalzarono e le immense piramidi in Egitto ed i superbi mausolei di Palmira, magnifici avanzi della follia e del dispotismo, i quali che non abbiamo in Europa, più dipende dalla indole de’ governi che dal desiderio degli uomini. Questo è l’ultimo periodo a cui la troppo avida ricerca d’un bene immaginario fa giungere nelle città già formate e colte.
Dal tempo poi diminuito il dolore, scarso a’ sepolcri troppo accresciuti il luogo e da frequenti sperienze dimostrato il danno che da’ cadaveri sì vicini se ne aveva, dovettero senza dubbio tanto essere scostati, che più non potessero essere nocevoli. Le storie delle nazioni manco colte di quelle nelle quali la semplice natura e l’inestinguibile amor del piacere a pochi e non fattizi bisogni limitato è la pura sorgente d’una vera felicità, ne sono la maggior prova. Voi vedete sempre dalle loro capanne discosti i cemeteri, a’ quali quei che nelle caccie di lontano muoiono sono riportati. Voi trovate in mezzo ad un’errante via scelti i più alti luoghi ed appartati per le sepolture, e tra le più barbare e ridicole costumanze voi scoprite sempre la non affatto spenta forza di ragionare sulla ripetuta sperienza.
Lo stesso bisogno tra le sì diverse opinioni che dominano sulla terra, opinioni che tanto strana e tanto vana rendono la teologia delle nazioni, ha il loro diritto sulle sepolture dettato. È sempre ne’ principii certi che gli uomini fabbricano le loro chimere, e di là partono co’ loro deliri, prova continua degli errori a’ quali la loro debolezza li conduce.
Di là solo in Egitto sotto le immense piramidi, e ne’ profondi laberinti, e nelle scavate grotte alle sole conservate mummie, s’immaginò che nell’eterno soggiorno de’ sepolcri unite le anime riposassero. Di là nacque l’ansiosa cura di procurarsi de’ freschi e solitari sepolcri tra’ Chinesi, occupati e persuasi d’una fallace metemsicosi.
Per questo pure Solone stabilì nissun cittadino ateniese potersi dentro la città sepellire, fuori che que’ soli la virtù de’ quali fosse stata alla patria utile. Così un piccolissimo e raro male serviva di stimolo a formare de’ grandi cittadini ed a rendere illustre la patria. Tale saggia legge fu poi nelle XII Tavole da’ Romani ricevuta ed in seguito obbedita. Era tra essi necessaria la sepoltura per religione, né le anime de’ loro trapassati si pensò che senza d’essa potessero attraversare la palude Stigia. Era per legge ordinato che fuor di città ciò si eseguisse, e così colle leggi la religione mirabilmente concorreva a mantenere la police.
Da Silla innanzi, che per timore di vendetta ordinò che il suo cadavere fosse abbrucciato, divenne quest’uso universale come già comune lo era tra altre nazioni. Ciò né fare si poteva in città, né più vicino di due miglia da esse, perché ogni pericolo di nocumento dalle esalazioni nell’aria tolto fosse. Le ceneri poi in urne deposte erano collocate lungo le strade consolari, e principalmente lungo la Flaminia, Appia, Aurelia ed Ostiense: oggetto di meditazione e spinta alla gloria.
Sino ai tempi di Diocleziano in pieno vigore si mantennero le leggi che le sepolture nelle città proibivano, le quali esso confermò, e sino a’ tempi di Carlo Magno si trovano osservate.
Cercherà forse alcuno quale fosse appresso gli Ebrei il luogo alla sepoltura, se nelle città, se nel Tempio essi ponessero i loro morti, quali in somma fossero su di ciò i principii di quell’eletto popolo, quali fossero le leggi ad esso dall’Onnipossente dettate.
Era immondo chi toccava i cadaveri, né poteva accostarsi al tabernacolo del Signore senza esserne mondato. Era immondo chi toccava o le ossa o le sole sepolture. Era finalmente immondo il luogo dove un cadavere era posto. Per questo voi vedete sempre o ne’ boschi, o nelle campagne, o appiè de’ monti, o negli scogli le sepolture. Quelle de’ soli re erano nella città, forse vicine al Tempio, siccome pare che si raccolga da Ezechiele, quando dice che la dimora dell’Eterno Dio non sarà più contaminata da’ vicini cadaveri loro.
Ne’ primi secoli della Chiesa erano queste pure le massime ricevute. Al Concilio secondo di Braga del 563 s’ordina che in niun modo sia permesso il sepellire dentro alle chiese; giacché, dicesi ivi, se è costante per le leggi (nam si firmissimum manet) che dentro alle città non si sepellisca, quanto più ciò è conforme e dovuto alla riverenza dell’Altissimo? Nel Capitolare di Teodulfo d’Orleans verso il 781, monumento prezioso della disciplina de’ suoi tempi, si dice che necessario è l’avvertire che le chiese non divengano cemeteri. Molti ordini monastici, dove più regna l’antica osservanza, anche oggigiorno s’astengono dal sepellire i loro morti nelle chiese, siccome i Certosini, i Benedettini, ec. Nel Concilio di Nantes dell’anno 658 si proibisce secondo le antiche leggi (secundum maiorum instituta) ed usanze che sia sepellito alcuno nelle chiese, e solo si permette che ciò lecito sia negli atri che le circondano, ciò che incominciava per abuso ad introdursi.
Sì fatti principii e sì fatte pratiche non si possono abbastanza ammirare; ma il mettere come tra di noi si fa i morti dove s’adora la Divinità; il contaminare con esalazioni pestilenziali que’ luoghi dove l’aria dovrebbe esser grave d’incenso e di fiori; il mantenere l’odioso costume che nelle città e ne’ più rispettati frequenti luoghi di esse i cadaveri corrompendosi cagionino delle malattie e ne diffondano i mortali semi, e così ancora estinti sieno di danno, non è certamente conforme alla ragione, né è degno d’un secolo tanto colto e tanto illuminato. Quanto sarebbe da desiderare che l’esempio del Verheyen, famoso professore d’anatomia e di chirurgia in Lovanio, fosse seguito! Si scrisse esso l’iscrizione al sepolcro fuori di chiesa fatto scavare: Philippus Verheyen medicinae doctor et professor, partem sui materialem in coemeterio condi voluit, ne templum dehonestaret, aut nocivis halitibus inficeret. Requiescat in pace. Ecco dove la pietà e la filosofia unite portano.
Non si può dubitare in alcun modo che le esalazioni animali, principalmente quando nelle sepolture rimangonsi senza potersi disperdere, non sieno un veleno il più terribile che si possa immaginare. S’imbevono alle volte le sepolture di queste esalazioni tanto che gli uomini e gli animali che le toccano ne sono infettati, come ne racconta un funesto esempio Haguenot negli Estratti dell’Accademia di Monspellier dell’anno 1745. Alle volte ne è contaminata l’aria per molte leghe all’intorno pel fetore, e delle migliaia d’uomini malati e morti ne sono, siccome d’un pozzo riempiuto di cadaveri dopo un fatto d’arme del 1552 riporta Ambrogio Pareo, lib. 10, c. 13; ed il Mead nel suo Trattato della peste; ed il Camdeno d’alcuni carcerati quasi resi cadaveri in un’assemblea tenutasi del 1577 nel castello d’Oxford, in cui i giudici ed altri molti, fino al numero di trecento, furono uccisi per il mortale vapore che da quelli alla loro presenza condotti vi fu portato.
Tali funesti accidenti non sono rari appresso agli scrittori, né rari sono i casi di uomini che malgrado le maggiori precauzioni ne sono le vittime. Questa è una cosa che tutti quelli che sotterrano sanno pur troppo, poiché avanti d’entrare nelle sepolture le lasciano aperte per lungo tempo, perché ne escano e si diradino que’ vapori che altrimenti per loro sarebbero mortali. Quante volte pure non osano discendervi, ma bensì con delle corde sepelliscono? Di questo modo alla loro particolare salute provvedono, inondando tutto giorno le città di mortali vapori.
IL CAFFÈ )( Fogl. VIII )(
Niente v’è che più contamini l’aria delle esalazioni di questa sorte e della traspirazione animale ad esse affatto omogenea e simile. Niente v’è di più dannoso alla sanità. I mendichi, che in angustissime case dimorano, ne sono una trista prova. L’aria ivi respirata ed assorbita inutile presto diviene,[9] ed è cagione di quello squallore e di quelle malattie delle quali immuni sono i ricchi ed agiati cittadini, che vivono sparsi in comodi e spesso variati appartamenti. Questa è una delle principali cagioni per cui sono più frequenti le morti nelle città che nelle campagne, secondo tutte le tavole mortuarie.[10] Questa è parimente una delle principali cagioni per cui nelle città più popolate maggiori sono le morti rispettivamente, perché più piene di gente sono ivi le case, e perciò manco libera e pura l’aria che si respira;[11] quindi pure nelle città sono più pericolose e funeste le malattie. Perché dunque, col proibire che i cadaveri sieno sepelliti nelle città, non togliere una sicura cagione alla diminuzione di popolazione ed a pericolose malattie? Quale differenza tra l’aria delle campagne imbalsamata di mille grati odori e continuamente da’ freschi zefiri agitata, e tra la malsana e stagnante atmosfera delle città, prodotta dalla traspirazione de’ cadaveri degli uomini e degli animali!
N.N. [Luigi Lambertenghi]
La musica
Quasi tutte le nazioni del mondo hanno una sorta di musica, ma quasi nessuna delle nazioni del mondo trova diletto nella musica che gli è straniera. Da qui nasce un ragionevole sospetto che la disposizione sia naturale all’uomo di formarsi un diletto fattizio col suono, ma che questo diletto sia puramente fattizio e di convenzione, non mai intrinsecamente inerente alla natura della cosa stessa. Le nazioni tutte risguardano come musica quella alla quale sono state avvezze coll’educazione, e risguardano come un rumore barbaro quella detta musica altrove, a cui non abbiano con moltiplicate azioni addomesticato l’udito. La musica de’ Chinesi, la musica degli Ottentotti, la musica de’ Peruiani, la musica degli Irochesi, la musica per fino degli Europei cessa d’essere musica coll’espatriare, e diventa, straniera ch’ella sia, un barbaro rimbombo d’un mal accordato mormorio. Io non oserò alzar quel velo sotto cui i profondi geometri celano ai profani le ingegnose loro investigazioni che risultano dai paragoni delle quantità; io non oserò violare i sacri penetrali, dove con acutissimo occhio investigatore degli arcani di natura si esamina se un suono sia un fascetto di più voci consonanti, le quali corrispondino ad alcune date dimensioni di corde che fra di esse inviolabilmente conservano una data proporzione: sì fatte investigazioni, illustrate principalmente in questi ultimi tempi dai più benemeriti e chiari geni del nostro secolo, non sono l’oggetto del mio discorso, nel quale io vuo’ parlare della musica e non dell’armonia. Convien dunque in prima ch’io dichiari cosa io m’intenda col nome di armonia, ed è quella sensazione composta che risulta dalla combinazione di più voci che percuotono l’orecchio ad un tratto. Pare che questa abbia certe leggi fisiche e universali, e che in favore di essa debba ogni orecchio decidere; pare che in favore di essa tutto il genere umano debba non aver dispareri nel chiamare alcune combinazioni più dolci e naturali consonanti, altre più aspre e straniere dissonanti, né su di ciò penso io di stabilir cosa alcuna. Della sola musica vuo’ io scrivere quel che penso, e per musica intendo quello che chiamano altri melodia, cioè un dato stile di successione d’un suono all’altro, il quale diversifica o per la celerità o per la diseguaglianza o per la distanza de’ passaggi da voce a voce, ovvero per fine per l’arte diversa di rattenere o spingere la voce medesima con maggiore energia. Per musica, in una parola, intendo quella successione di suoni che sveglia negli animi di chi ne è appassionato diversi affetti di tenerezza, di ardire, di compassione, di orgoglio, e così andiam dicendo degli altri movimenti dell’animo, i quali per una sorta di magia co’ suoni si destano. Distinguerò dunque in tre classi tutto ciò che è compreso col nome universale di musica: il semplice suono, l’armonia e la musica. Il semplice suono io lo considero come una semplice tessitura di parole d’una lingua, le quali non contenghino veruna idea; l’armonia la paragono a una serie di parole giudiziosamente rappresentanti un ragionamento; la musica nella mia idea è simile ad una serie di parole, le quali ben declamate sieno atte a svegliare i sentimenti del nostro animo, onde la musica è del regno armonico l’eloquenza. Non so se quella che noi chiamiamo eloquenza, ossia l’arte di suscitare i moti dell’animo, sia universale a tutto l’uman genere, risguardo ai mezzi che adopera; anzi son molto disposto a credere che sebbene ogni nazione possa essere commossa da un eloquente dicitore, pure essendo diversificata in mille guise la sensibilità de’ vari popoli per la moltiplice forma di legislazione e per le fisiche differenze de’ climi sotto ai quali vivono, l’arte dell’eloquenza pure deve variare colla sensibilità degli ascoltatori, e benché sia universale e immutabile il principio di quest’arte di andare al cuore dell’uomo e determinarlo per quel mobile, pure i mezzi per giungervi devono modellarsi sulle varie strade che trovansi aperte in ogni nazione. Sì fatte dubitazioni che mi passano per la mente avrebber bisogno degli aiuti de’ viaggiatori, e se per beneficio delle cognizioni umane si moltiplicassero i Chardin, i la Caille, i Maupertuis, i la Condamine, e i viaggiatori in lontani paesi preferissero sempre, come questi benemeriti uomini, il piacere d’essere esatti e veridici, e la costante fama presso ai posteri, alla mal intesa voglia di imporre per alcuni anni ai loro paesani per finire poi tosto o tardi discreditati nel mucchio de’ romanzieri, allora ci sarebbe dato l’esporre non solo i dubbi che un po’ di filosofia fa nascere nelle menti, ma anzi le vere e dimostrate teorie di molti importantissimi oggetti, tanto più sicure quanto che appoggiate su molti fatti inconcussi.
La musica dunque come eccitatrice delle passioni è un’arte la quale forse è universale a tutta la terra, ma dipendendo essa dalla diversa catena di idee delle nazioni diverse, deve cambiare di mezzi per eccitar le passioni cambiando i gradi di longitudine o di latitudine. Forse quello che io chiamo musica altro non è che l’occasione per cui noi da noi medesimi facciamo nascere le passioni che a lei attribuiamo; forse la musica non è altro che quello che sono alcune macchie fatte a caso sulle pareti, ovvero alcune nubi accozzate pure a caso nel cielo, nelle quali gli uomini d’immaginazione più agile e fervente ravvisano facilmente ogni sorta d’oggetti esattamente disegnati per la pittura. In fatti come mai spiegheremo noi altrimenti quel fenomeno che pure assai famigliarmente vediamo accadere, cioè che mentre alcuni all’udire il medesimo cantore e lo stesso suonatore d’istromento mostrano i trasporti della interna sensibilità, e ne’ muscoli della fisonomia, e nell’inquietudine del loro corpo, e nelle involontarie esclamazioni di applauso, o quasi dimentichi d’ogn’altro oggetto, tutti assorbiti e incantati mostransi dalla magia dell’arte; nel tempo stesso alcuni altronde dotati di squisito, di dilicatissimo senso nel gustare e distinguere le bellezze e i difetti delle altre arti, immobili e insensibili ascoltino quasi per compiacenza la stessa musica, e attentamente notino i piccoli difetti e quelle minime negligenze, le quali talvolta apposta vi si lasciano, acciocché come co’ tratti aspri del pennello posti a lor luogo si rendono più efficaci i tratti finiti e dilicati d’una pittura, così avvenga nelle dolcezze e maestria della musica? Se noi divideremo gli uomini in due classi, una degli amatori della musica, l’altra degli indifferenti per la musica, troveremo che la classe de’ secondi è la maggiore; che se dagli amatori della musica vorremo levar fuori tutti coloro i quali sono ipocriti in musica e fingono di trarne diletto per ciò soltanto che credon cosa di fino gusto il farlo, se da questa classe sottrarremo pure coloro i quali per pura imitazione altrui si dichiarono partigiani della musica, pseudo amatori tutti quanti, i quali co’ loro poco giudiziosi applausi talvolta innalzano alle stelle le più mediocri cose ed avviliscono i professori che hanno anima e affetto, se, dico, da questa classe vi si torranno tutti coloro che non meritano di esservi annoverati, troveremo forse che assai più piccola è la classe di quei che amano la musica che non si crede comunemente. Dal che sempre più mi confermo nella opinione che il soavissimo diletto che cagiona la eloquenza della musica col movere deliziosamente gli affetti dell’animo nostro sia un diletto totalmente fattizio e formato dalla artifiziosa flessibilità che l’educazione ha data ai nostri organi; ma perché l’origine del diletto che fa nascere in noi la musica non sia dipendente dalla originaria natura delle cose, non è perciò ch’egli, poiché è prodotto in noi, non sia un vero e reale diletto che dolcemente agita le anime sensibili, né perciò dobbiamo noi averlo men caro, e mal uso farebbe un filosofo, il quale sa quanto saggia sia l’economia dei piaceri innocenti in questa vita, della ragione, se l’adoperasse a diminuire la sensibilità alla musica col discoprirne la vanità intrinseca dei mezzi che essa adopera per eccitarla.
Le verità di questo genere voglion sempre esser troppo pagate, ed io preferisco que’ momenti beati d’un soave delirio, che di tempo in tempo provo all’udire la vera musica, a tutte le scoperte de’ problemi più elevati che possono farsi sulla natura di essa. Io potrei stendermi ben lungamente se volessi presentare a’ miei lettori un pomposo corredo di erudizione; ma tale non è l’idea che mi sono proposta, e le opinioni di Platone sulla musica, e i prodigi del teatro greco, e le favole della virtù sua che si sono sparse per la medicina, e simili anticaglie o errori non fanno al mio proposito.
E in che consiste mai la magia colla quale la musica eccita le nostre passioni? Qual è l’arte con cui può sperarsi di eccitarle? Sono questi articoli d’un tal genere che è più facile il sentirli che il definirli con parole. Io provo che una voce anche sola può eccitare i movimenti del mio animo; io provo che persino parlando, siccome vi sono de’ tuoni di voce che riescono disagradevoli al mio orecchio, così ve ne sono che grati moltissimo li ritrovo, e ciò independentemente dalle relazioni ch’io posso avere con chi mi parla: cantando poi questa differenza s’accresce notabilmente. Osservo che vi sono alcune voci naturalmente appassionate, le quali, poche note che cantino, bastano a togliere il mio animo dalla inazione e imprimervi i dolci movimenti della musica. Alcuni stromenti pure riescono appassionati naturalmente al mio orecchio; l’oboè singolarmente. Non pretendo io già che lo stesso accader debba presso ogni orecchio disposto per la musica; dico semplicemente quello che accade dentro di me; credo bensì che ogni orecchio sensibile distingua le voci in appassionate e in non appassionate. Osservo di più che le cose le più semplici, le più naturali sono quelle appunto che fanno maggior impressione. Vi vuole nella musica come nell’architettura la schiettezza, la nudità, dirò così, dell’ordine toscano: gli ornamenti gottici, gli arabeschi, le bizzarrie ammassate e sovraimposte l’una all’altra eccitano ammirazione talvolta, spessissime volte tedio, non mai diletto. Un’aria flebile cantata da una voce appassionata è ben difficile che non faccia il suo effetto. Un’aria parlante, dove il compositore abbia potuto colpire il segno, cosicché la modulazione de’ tuoni rappresenti naturalmente quel che dicono le parole, sicuramente riesce: ma sì tosto che le voci umane prendono a gareggiare cogli usignuoli, e scorrere su e giù per infinite scalette, e balzare con mortalissimi salti da’ tuoni più acuti ai più gravi, e tremolare incessantemente di voce con una incostanza che appena può l’animo porvi mente, allora potrà bensì il musico aver gli applausi de’ professori, ma difficilmente dagli uomini sensibili alla musica.
Io distinguo molto il giudizio de’ professori dal giudizio degli uomini che sono particolarmente affezionati alla musica; fra i primi la maggior parte non amano il lor mestiere che per il bene che ne rittraggono, e a forza di rendervisi abituati s’incalliscono all’azione della musica e la riguardano come quella penosa carriera per cui forza è che s’affatichino per vivere; osservo di più che i differenti professori di musica hanno ciascuno o per la scuola a cui sono stati formati, ovvero per la disposizione primitiva de’ loro organi, hanno, dico, ciascuno il loro forte e il loro debole. Uno è singolarmente esatto anche nelle più scabrose intonazioni, un altro si distingue per la volubilissima agilità, un terzo riesce singolarmente nel brillante di alcuni giri di modulazione, e così vadasi dicendo; quindi i professori per lo più anzi che abbandonarsi senza prevenzione all’azione della musica e di giudicarne dall’effetto che fa nell’animo (il che sogliono gli uomini sensibili alla musica considerare per l’unica e vera pietra di paragone), invece esiggono dal musico quel genere di maestria che l’amor proprio ha fatto che preferissero ad ogni altro.
Non v’è cosa che faccia più pena quanto il vedere alcuni compositori di musica, i quali possedono esattamente le leggi dell’armonia e la maneggiano con ogni destrezza, come un facitor di anagrammi, volgendo e rivolgendo le consonanze e le dissonanze co’ piedi ora in giù ed ora rovesciate, senza cercare nemmeno la strada per eccitare le passioni del cuore e senza provarle mai; e questa pena poi si converte in una sorta di sdegno, quando ascoltando io le loro composizioni, la mia immaginazione supplisce, e dando forza alla musica fa nascere in me quegli affetti che il compositore non conobbe mai. Pare che il mio amor proprio si offenda, che un uomo senza perdere la tranquillità si prenda giuoco della sensibilità mia: e vorrei che per agitarmi l’uomo si desse almen la briga di agitar prima se medesimo. Insomma io trasporto nella musica i sentimenti che son comuni agli amanti, cioè il desiderio di non esser solo inquieto.
Molte cose vi sono nella musica, le quali mi sembrano affatto inutili, e potrebbero chiamarsi pedanterie musicali. Una di queste si è il trillo. Ogni periodo di melodia deve avere nella penultima nota un trillo; ogni aria deve terminare con una lunga rivoluzione di voci, ossia cadenza, e nella penultima nota deve avere un trillo. E qual piacere può mai risvegliare ne’ sensi umani quel tremolare di voce e quell’incostante oscillazione d’una nota all’altra reciprocamente che chiamasi trillo? E quand’anche potesse in alcune occasioni servire quest’artificio che chiamasi trillo ad esprimere o il canto dell’usignuolo o il tremolar delle frondi o simile oggetto, come mai sarà possibile ch’ei desti negli animi nostri qualche affetto, se ne abusiamo continuamente facendolo diventare un metodico finimento di tutt’i pensieri musicali? Non so se le cadenze sieno sempre necessarie al fine delle ariette, anzi credo di no; ma quando anche si voglian fare, io credo che possano terminarsi con molta grazia anche senza il trillo con una ben situata appoggiatura. Io so che le voci che vanno sino al mio animo sono quelle che non sono né troppo gravi, né troppo acute; quelle che per una recondita connessione delle mie idee mi sembrano appassionate; quelle voci le quali sviluppandosi descrivono una curva, cosicché non mai formano angoli, dirò così, né urtano mai nel mio orecchio; io so che il mio cuore è commosso allor quando una di queste voci, ferma e non tremolante, scorre dolcemente su vari mezzi tuoni e tocca singolarmente delle corde minori non aspettate da me, senza che ne’ passaggi d’una voce all’altra vi sia distacco alcuno, ma anzi vi sia una brevissima sì, ma artificiosissima strada, la quale per degradazioni insensibili mi trasmuti un tuono coll’altro senza ch’io m’avveda del momento in cui ciò sia fatto.
Oh quante volte accade di dover dire ad alcune arie quello che suoleva l’ingegnosissimo autore dei Mondi, il signor di Fontenelle: Musica, che vuoi tu? S’ascoltano delle arie eccellentemente intuonate, dette con una prodigiosa agilità, con una perfetta eguaglianza di corde nella voce, con esatissimo rigore di tempo, con trilli, con lunghezza mirabile di cadenza senza prender fiato: Musica, che vuoi tu? Ancora non lo so, se non mi desti nel cuore verun sentimento. Io ho ascoltato delle voci alle quali non si poteva rimproverare verun difetto, ma il mio animo faceva loro il rimprovero massimo, poiché non sentiva nulla. I ballerini da corda si pagano perché ci faccian maraviglia; i musici si pagano perché ci movano: eppure la massima parte de’ musici vuol fare da ballerino da corda.
P. [Pietro Verri]
Del lusso delle manifatture d’oro e d’argento
Accordano tutti i politici che il lusso ristretto nei prodotti e nelle manifatture interne d’uno Stato, che non corrompe i costumi, che non offende la sanità, sia profittevolissimo e degno da promoversi dai saggi legislatori. Quasi tutti però sono di parere che un lusso tale non debba estendersi alle filature d’oro e d’argento, alle dorature e a tutte l’altre opere composte da questi preziosi metalli che l’industria degli uomini, il loro costume incivilito ha introdotti ne’ tempii, sopra le mense e fra i mobili d’un ricco casato. Le prime, dicon essi, distruggono quella materia, nella quale essendo convenuti gli uomini da epilogare le ricchezze, vi trovano la sorgente dei loro comodi e dei loro piaceri, sorgente che va dissecandosi a proporzione che la materia medesima va mancando. Le altre manifatture poi se non distruggono l’oro e l’argento, li tolgono certamente dal commercio, ne privano la nazione dell’uso e riducono i metalli medesimi a quella inutilità in cui trovavansi allorché sepolti e sconosciuti giaceano nelle loro miniere; parlo di quell’uso proprio d’un corpo generico che viene permutato e surrogato indistintamente a tutti gli altri corpi; parlo di quell’utilità generale portata all’umana società da un metallo di potenza e di stima universale, come lo è appunto l’oro e l’argento ridotto in moneta. In fatti l’abbondanza della moneta circolante pare che costituisca l’essenziale felicità d’una nazione. Dove comincia ella a farsi copiosa, tutte le cose cangiano faccia. Il popolo si moltiplica, il travaglio e l’industria prendono vigore, il mercante diviene più coraggioso, l’operaio più diligente, l’agricoltore stesso si attacca più allegramente all’aratro.
Con tutto che le ragioni di questi saggi politici sembrino convincenti, io al contrario sono di parere che il lusso delle manifatture d’oro e d’argento lungi d’essere dannoso ad un popolo, gli apporti dei vantaggi considerevoli. Osserva David Hume ne’ suoi Discorsi politici che una nazione viene felicitata dal denaro nel tempo preciso in cui questo vi entra e vi si distribuisce, ma che stabilitosi in essa costantemente e con abbondanza, le sia poi d’un gravissimo pregiudizio, perché fa montare a maggiore prezzo ogni spezie di derrata. Allora l’artista innalza il valore del suo travaglio ed il mercante quello delle sue merci. Il forastiere non trova più il suo conto nel fare le sue proviste nel paese; cessa in questo il commercio attivo, ne sorte precisamente il denaro acquistato ed in fine resta egli affatto impoverito. Per cagione del maggior prezzo delle derrate, soggiunge che un’armata di 20 mille uomini dimorante in Inghilterra costa al regno quanto costarebbero 60 mille uomini mantenuti in Francia, e che nella penultima guerra la flotta inglese fu così dispendiosa come lo furono al tempo degli imperatori romani le loro legioni, che tenevano in soggezione il mondo intero. Per rendere conto di questo fenomeno passa il celebre scrittore a considerare che l’alto prezzo delle cose, benché sia una conseguenza necessaria dell’abbondanza delle monete, non segue immediatamente quest’abbondanza medesima, ma bisogna che vi trascorra qualche tempo prima che il denaro circoli per tutto lo Stato e vi produca i suoi effetti. Da principio non v’è chi si accorga d’alcun’alterazione, indi il valore d’una derrata aumenta, poi quello d’un’altra, in seguito s’incarisce la mano d’opera, tanto che alla fine il tutto monta alla giusta proporzione colla nuova quantità di denaro che si trova nel regno. Conchiude poi che appunto l’intervallo, ossia la situazione intermedia fra l’acquisto del denaro e l’alzamento del prezzo delle cose, è favorevole alla popolazione ed all’industria, che sole senza limitazione portano il vantaggio più sicuro alla nazione. Supposta la rettitudine di questa dottrina, cui non so contraddire, ognuno comprende che le dorature e le filature d’oro e d’argento prolungano quest’intervallo, e conseguentemente promovono la popolazione, somministrando il modo da mantenersi a molte famiglie, aumentano l’industria sostenendo un’arte adattata ai costumi del nostro secolo; trasmesse agli stranieri guadagnano allo Stato grosse somme di denaro, e consumate in esso distruggono opportunamente quella copia d’oro e d’argento che trasformata in moneta corrente produrrebbe i sopracennati disordini. Sempre è costante (dirà alcuno) che la distruzione dei nobili metalli successa per le dorature e per le filature molto impedisce l’esazione dei tributi in denaro, perché viene a mancare la materia che si contribuisce. Se si trattasse che il suddito dovesse dare annualmente al suo sovrano tutto l’oro e tutto l’argento che possiede in conto di tributo, la proposta distruzione porterebbe qualche impedimento al pagamento dei tributi; ma siccome egli non esigge che una porzione delle ricchezze del suddito, così basta che questo col perdere i preziosi metalli nelle dorature e nelle filature non s’impoverisca, e con ciò si renda impotente a compiere a’ pubblici pesi. Chi batte e fa passare per la traffila l’oro e l’argento, nulla perde, perché lo dà con qualche guadagno all’indoratore, al ricamatore o al tessitore di galoni. Questi artefici lo fanno passare in mano del mercante, che pure rende loro altrettant’oro ed argento monetato, e gliene paga al di più la fatica. Il mercante finalmente lo vende con suo utile al ricco, che unicamente lo consuma. Chiamasi ricco colui il quale possiede maggior copia di denaro di quello ch’esiggano le sue private naturali indigenze e le obbligazioni della società di cui è membro. Egli ama di vestire nobilmente, di abitare una casa sontuosamente mobigliata e di vivere con lusso, come richiede l’utile generale della nazione. Che male v’è se getta il denaro superfluo in vesti ricamate ed in fregi dorati? Men bene operarebbe se di seta, stoffe, di merletti e di panni finissimi si circondasse, se di vernici, di porcellane, di vetri e d’altre simili manifatture ornasse la propria abitazione. In questo caso non porterebbe altro profitto alla sua patria che di mantenere i fabbricatori di tali merci; all’incontro nel primo caso sosterrebbe ugualmente un buon numero di operai, toglierebbe alla sua nazione parte del danno che l’abbondanza del denaro potrebbe cagionarle, ed in fine non consumerebbe il tutto, come nel predetto secondo caso, ma una qualche porzione d’oro e d’argento potrebbe raccogliere dopo l’ultimo estremo uso che ne avesse fatto. E perché mai molte saggie repubbliche e molti illuminati regnanti hanno vietato le vesti e gli ornamenti d’oro e d’argento nelle persone e nelle case de’ loro sudditi? Una sana politica insegna alle repubbliche di non permettere
IL CAFFÈ )( Fogl. IX )(
ad alcuno de’ propri cittadini il superchiare col fasto d’un lusso singolare l’altro cittadino decorato d’eguale grado, degno di una non inferiore considerazione, ma non fornito di tante ricchezze, e con tale mezzo procacciarsi dal popolo sempre abbagliato dalle luminose comparse un’indebita venerazione. Come poi ad un regno possa giovare questo divieto, io certamente non lo comprendo. Conviene credere che ad esso non siano opportune le regole generali, e che una qualche incognita cagione abbia suggerite contrarie disposizioni.
Gli altri preziosi lavori d’oro e d’argento, dei quali non se ne distrugge la materia, hanno l’influenza di popolare le città somministrando il vitto a molti utili cittadini, di regalare i ricchi di non ordinari comodi e di togliere alla circolazione il troppo copioso denaro. Ma di più portano seco il gran vantaggio di potere in ogni straordinario bisogno dello Stato e del principe ridursi in moneta, riporsi in circolo e ristorare il mancante erario. Gli avari, i tesoreggiatori sono viziosi e obbrobriosi uomini, che servono però mirabilmente al ben pubblico; son essi i soli che senza volerlo preparano in mezzo alla felicità pubblica le risorse per i bisogni pubblici a venire. Se l’oro e l’argento è ridotto in opere, pare men proprio a corrompere la morale ed offendere la sanità, e giova nello stesso tempo ad infiniti usi della vita senza perdere l’attitudine di potersi convertire in un corpo che procuri al suo possessore ogni qualunque genere di comodi.
F. [Sebastiano Franci]
Della maniera di conservare robusta e lungamente la sanità di chi vive nel clima milanese
… Quod coeli mutantur in oras | Temperies, hominumque simul quoque pectora mutant. | Vida, Poetica, lib. 2.
Se le mie osservazioni sulle meteore del clima milanese sono forse state in qualche parte interessanti, mi lusingo che lo abbiano potuto essere unicamente perché ciò che immediatamente tiene al lucro o alla salute degli uomini è impossibile che non chiami a sé la loro attenzione, o almeno la loro curiosità. Dato ciò per supposto, azzarderò alcune altre mie riflessioni intorno la maniera di conservare o difendere la salute di chi respira quest’atmosfera o vive sotto questo clima.
Io distinguo due sorta di cagioni delle malattie dell’uomo: le une le chiamo cagioni interne, le altre esterne. Le interne chiamo quelle che dipendono dalla naturale costituzione buona o cattiva, cioè bene o malamente organizzata. Le esterne intendo quelle che sono fuori di noi, cioè quelle che potendo o no attualmente essere con noi, danno occasione che la naturale nostra costituzione venga alterata. Delle prime non intendo qui parlare, imperocché per rintracciare le cagioni e il come la nostra atmosfera e il nostro clima agisca sopra il nostro corpo ad alterarne o no la salute, ed i mezzi perché ciò succeda col minor danno possibile, parmi essere indispensabile il supporre tutti gl’individui, che vivono e respirano in questa nostra milanese atmosfera, perfettamente organizzati giusta le differenze della loro naturale costituzione o meccanismo, onde partire da un punto fisso nell’esame degli effetti diversi cagionati dagli stessi o da differenti fenomeni del nostro clima. Delle cagioni esterne solamente intendo io dunque di qui ragionare, e queste primamente io separo in più classi. La prima è di quelle che annovero tra le cose che entrano o sortono dal nostro corpo, e ciò principalmente col cibo e l’aspirazione dell’aria, l’evacuazioni e la traspirazione; la seconda tra quelle che ci circondano, cioè l’atmosfera nostra e le vesti che ci coprono; la terza, quelle che metto tra’ volontari movimenti del nostro corpo o la quiete; la quarta finalmente negl’interni moti dell’animo e delle nostre passioni.
Seguitando la indicata divisione delle cagioni esterne delle malattie, tra le cose che entrano nel nostro corpo il principal luogo tengono li cibi. In questa classe più cose differenti io distinguo: cioè li cibi che hanno bisogno di una artificiale preparazione prima che entrino nel nostro stomaco; quelli che mangiamo tali e quali ci sono prestati dalla natura; li solidi e i liquidi; finalmente la digestione, che si opera per loro cagione nello stomaco.
Ecco il risultato di alcune esperienze da me fatte quattro anni sono intorno a questo proposito, le quali potranno dare occasione ad alcune conseguenze forsi non ancora da altri vedute.
Ne’ primi giorni del mese di agosto, avendo in una camera esposta al meriggio, nella quale il termometro reaumuriano segnava 25 a 28 gradi, posto in distinti vasi aperti, e difesi dalla polvere con un semplice foglio di carta, del latte vaccino, di quello di amandole, del brodo di carni e delle infusioni in acqua chiara di farina di frumento, di mollica di pane e di carni, e finalmente di polte cotte e liquide di farina di frumento, dopo alcune ore ed anche dopo un giorno sottoposte queste materie al microscopio, vi ho veduto de’ filamenti e delle particelle moventisi, non molto dissimili da quelle descritte nelle osservazioni microscopiche dal signor Needham e dal signor Buffon, con quest’ordine però e con queste differenze: il latte vaccino è il primo a mostrare codesti filamenti e queste particelle moventisi, e più nettamente ed in maggior quantità delle altre materie; in seguito viene il latte di amandole; quindi le polte cotte di farina; poi l’infusione di mollica di pane; indi quella di farina; in seguito li brodi di carne; e finalmente le infusioni di carni crude. I latti e le infusioni di farine in questo stato rendono un odore acre e niente schifoso, e quella di mollica di pane e veramente anche le polte di farina cotte ottengono in questa circostanza un odore parimenti acre, ma più forte e tirante un tantin tantino al fradicio, o piuttosto all’odore della muffa. Al contrario l’accennato fenomeno ne’ brodi e nelle infusioni di carni in genere succede molto sporcamente, rendendo un odore verminoso, cadaverico e ributtante. Finalmente lasciando le sovraccennate materie andare sino all’intiero loro corrompimento, ho veduto che le infusioni di carni e i brodi erano li primi a corrompersi, anzi quelli soli che propriamente in senso volgare hanno mostrato una vera corruzione, formando vermi e puzzando insopportabilmente; quando in egual tempo i latti e le infusioni di farina e di pane non si sono che inacidite, e non mi hanno mai mostrato un vero corrompimento. Mescolandovi differenti liquori vi ho osservate alcune rimarcabili differenze, delle quali il risultato è, che allor quando vi ho gettato dello spirito di vino, i filamenti e le particelle moventisi restarono senza moto ed in minor volume costipati; coll’aceto affatto morti, ed alcuna volta sciolti; ma impastati colla saliva gli stessi filamenti e particelle moventisi si manifestavano in più breve tempo più vive, e anche in maggior quantità. Finalmente aumentandosi o diminuendosi il grado di caldo dell’aria circondante li vasi suddetti, ho veduto che più presto o più lentamente succedevano li sovraccennati fenomeni, senza cambiamento perciò sensibile delle descritte circostanze. Io non ho portate e continuate le accennate esperienze a quel segno come allora avevo in mira. Se alcuno voglia ciò intraprendere onde perfezionarle, consulti in prima le già nominate osservazioni de’ signori Needham e Buffon, e il libro intitolato: Le microscope à la portée de tout le monde.
Ciò premesso, così ragiono. In virtù della digestione, che si opera nello stomaco e negli intestini,[12] si separa quella porzione di materia che passa in nutrizione di tutto il corpo; e siccome le osservazioni de’ citati Needham e Buffon hanno mostrato che la parte più pura e la quintessenza di quella porzione di materia la più nutritiva che si trova ne’ corpi viventi non è altro che un prodigioso ammasso di filamenti e molecole moventisi in una linfa, non sarà dunque improbabile che nella stessa maniera o poco differentemente succeda in noi la digestione naturale nello stomaco e negli intestini, come appunto le mie esperienze hanno fatto vedere artificialmente addivenire ne’ vasi ed in differenti materie all’aria aperta; cioè che la digestione altro non sia che dolcemente o lentamente le materie vegetabili ed animali nello stomaco fermentando, da quelle si separino que’ filamenti e particelle moventisi, che natanti in un fluido passino in chilo e quindi in nutrizione di tutto il corpo. E molto più sembrerà ciò men lontano dal vero se si rifletta che il calore nello stomaco di un uomo sano è niente più di gradi 31 incirca al termometro del signor di Reaumur, calore di poco maggiore di quello al quale sono state le mie digestioni artificiali operate; e che allor quando, come ho già detto avermi le mie osservazioni dimostrato, si mescoli co’ cibi la saliva, più facilmente ne succede la digestione, ossia separazione delle particelle moventisi; e finalmente che appunto dal latte vaccino, ch’altro non è che puro chilo passato nelle mamme dell’animale, più d’ogn’altra cosa, come si è veduto nelle indicate esperienze, si separa fermentando quella parte semovente ch’io chiamo nutritiva. Tutto ciò è immediatamente appoggiato all’esperienza ed all’osservazione, e fintanto che non si avrà alcuno il quale faccia all’occhio vedere questo molino, o questo fornello, che opera nel nostro stomaco la digestione per triturationem, ovvero per concoctionem, nessuno altrimenti che con l’indicato sistema potrà spiegare gli fenomeni della digestione e della nutrizione.
Altre verità emanano immediatamente dalle riportate esperienze, e sono che i latti, le polte di farina cotte e il pane con lievito sono generalmente più d’ogn’altra cosa le più facili alla digestione; quindi le cose farinose crude, e in ultimo luogo le carni; che i latti, le polte farinacee e ’l pane onde digeriscano nello stomaco è d’uopo che s’innacidiscano, ed al contrario le carni s’accostino ad uno stato di schifosa putrefazione; che il principale fermento o lievito per una buona digestione è la saliva; che lo spirito di vino, le acquevite[13] e i vini la ritardano; e finalmente che l’aceto e le bevande acide sono quelle che tolgono ed impediscono una troppo grande putrefazione.[14]
Per quanto spetta a’ cibi che si chiamano pitagorici, e che in genere non sono che di cose vegetabili, non ne parlerò io qui di molto: ciascuno può leggere a questo proposito l’elegante, grazioso e dotto scritto del celebre dottor Cocchi. Solamente dirò, che sebbene sembri quel dotto medico inclinevole a generalmente consigliare doversi, come più comunemente utili, usare de’ cibi leggieri (com’egli chiama) e della più facile digestione, o meno crudi, cioè più delle cose animali che delle vegetabili, come sarebbe di piccioni e de’ polli novelli, di qualche uccelletto piccolo e di nido e di qualche pesce di fiume, e simili cose giudicate da lui le più utili, probabilmente perché, quando così scriveva, la di lui poca salute e ’l di lui men robusto fisico temperamento esigeva forse un tal regime; ciò non per tanto a me pare che generalmente dovrebbe l’uomo più delle vegetabili cose mangiare che delle animali. Che se mi si dica coll’eloquente ed ingegnoso storico naturalista il signor Buffon, che l’anatomia comparata fa vedere che gli animali ad intestini larghi sono carnivori e quelli ad intestini lunghi sono frugivori, e conseguentemente l’uomo, che è animale ad intestini forse proporzionatamente più d’ogn’altro larghi, è necessariamente carnivoro, io rispondo, per riportare un solo esempio, che il maiale (l’animale internamente il più simile all’uomo e ad intestini de’ più larghi, e però anche per la figura e positura de’ denti annoverato fra li carnivori) il più squisito è quello ingrassato colle ghiande e col grano-turco ed altre granaglie; ed al contrario tutti possono vedere come li polli e le galline, che sono de’ primi animali chiamati frugivori, sieno nelle cucine e ne’ pollai delle case in campagna ghiotti del cuore e di altre viscere di uccelli sventrati, delle grisalidi de’ bacchi di seta, di vermi di terra e simili cose. Dunque l’esperienza non è ancora bastevolmente costante perché sia dimostrato che la differenza delle dimensioni degl’intestini sia la caratteristica tra gli animali carnivori e frugivori.
La ricerca delle cause finali non ha mai condotto allo scoprimento di grandi verità, trovandosi sempre a capo della questione in tutte le conseguenze derivate con un tal metodo di ragionare; ciò se attentamente si considera si vedrà più che altrove avverarsi in fatto di anatomia. Però chi dicesse: il bue ha due stomachi, ed il bue non mangia che fieno od erba; dunque il doppio stomaco è fatto perché l’animale che lo ha sia frugivoro, non ragionerebbe certamente giusto: imperocché dovrebbe in primo luogo dimostrare coll’esperienza costante che il bue non può vivere allorché mangia di cose animali; e quindi la conseguenza diretta del superiore raziocinio sarebbe questa: dunque il bue non può mangiare che de’ vegetabili perché ha due stomachi. A me pare che nella stessa maniera che le prime associazioni d’idee nell’infanzia influiscono sulla morale dell’uomo nell’altre età, così l’abituazione fisica presa in senso generale agisca per la maggior parte sulla maniera del mangiare e su tutte le operazioni, non solo dell’uomo, ma di qualunque altro animale. Se per animale carnivoro o frugivoro s’intenda quello che per costante esperienza, giusta le differenze di conformazione degl’intestini e dello stomaco, più facilmente o meglio comparativamente si nutrisca, o in ragione di qualità o in ragione di quantità, con alcune piuttosto delle cose vegetabili ovvero animali; in tal caso l’eloquente filosofo naturalista, il signor Buffon, ha ragione. Tanto è vero che le verità della scienza umana non dipendono che dalla esperienza e dall’esattezza delle definizioni.
Continuando l’esame delle cagioni delle malattie dell’uomo, ch’io giusta la succennata divisione ho sopra annoverate tra quelle che chiamo esterne, trovo che il risultato di tutte le esperienze per la prima volta tentate dal Santorio, quindi ripetute dall’Accademia delle Scienze di Parigi e dalla Società di Londra, intorno le naturali evacuazioni di un corpo sano, costantemente ha dimostrato che maggiore deve essere la quantità di materie tramandate in un giorno per via di traspirazione di quello sia per le altre solite strade; e che generalmente maggiori in quantità sono le urine nella stagione d’inverno che di estate, come parimenti ne’ climi più freddi di quello sia ne’ climi più caldi.[15]
Intorno agli effetti dell’aria sul corpo umano, tre cose differenti si distinguono: la compressione dell’atmosfera, la qualità dell’aria respirata e ’l di lei grado di calore e di freddo.
Circa il primo, risulta da tutte le esperienze de’ più celebri fisici di tutta l’Europa che ’l corpo umano generalmente non soffre pena né malore passando gradatamente, e non tutto in un istante da una atmosfera che lo comprima con una forza di 14982 libbre milanesi, a quella con una forza di 8400. Il primo a sospettare la gravità dell’aria è stato il precessore della vera fisica, il gran Bacone di Verulamio; a dimostrarla il Toricelli; a confermarla il Boyle. Non do qui, come fuori di proposito, l’intiero calcolo di questi numeri, avverto soltanto che il maggiore è derivato dalla maggiore altezza del mercurio nel barometro finora osservata al livello del mare; e ’l piccolo dalla minore sul monte Chimboraco nel Perù, osservata dal signor Bouguer; ed io per risultato delle mie osservazioni barometriche (vedi il Caffè, tomo I, fol. 7, pag. 52, col. 2) trovo che la maggiore pressione sopra di noi della nostra milanese atmosfera è di libbre nostre 14875, la media, ossia quella che più comunemente ci sovrasta, è di 14568 libbre e la più piccola di libbre 14087; cioè noi in Milano viviamo in una atmosfera la quale senza che ce ne accorgiamo ci comprime con pesi così enormi e così differenti che variano fino di quasi 800 libbre.
Della qualità dell’aria respirata io non riporterò le tante osservazioni confermate da tanti fisici ed osservatori diligenti sul danno cagionato all’umano corpo che attualmente respira o abbia respirato un’atmosfera impregnata di eterogenee esalazioni, come sarebbero metalliche, bituminose, mofete e simili. Ma della qualità dell’aria che respirasi in Milano parmi averne bastantemente ragionato altra volta,[16] perché non debba le medesime cose io qui ridire; ed a proposito di quanto influisca sopra di noi un’atmosfera umida ed impregnata di esalazioni che si sollevano da terre bagnate e macerate, è cosa degna da rimarcarsi ciò che il celebre botanico, il metodico Lineo, ha già fatto costantemente e generalmente osservare, cioè che le erbe e le piante corrosive, fetide e velenose crescono e si nutriscono appunto in terreni umidi o bagnati, e che le odorose e balsamiche non si trovano, le migliori almeno, che in siti alpestri ed asciutti.
Per quanto poi appartiene al grado di calore e di freddo dell’aria, accennerò brevemente che gl’infaticabili accademici di Parigi, allorché misuravano il grado terrestre sotto la linea dove il sole stava sulle loro teste a piombo, non hanno mai altrove provato il maggior freddo che colà sulle più alte cime de’ monti Cordilieres, ed il maggior caldo insopportabile e penoso che al piede de’ monti medesimi; e ciò perché appunto su quelle cime di nudo sasso non erano circondati che da una atmosfera la più rara e la più pura possibile; ed al contrario alle loro radici non trovavansi che sopra un terreno bagnato, macerato e di ampie paludi. Che comparativamente si soffra da chi vive sopra terreno basso, umido e bagnato maggior caldo in estate e freddo maggiore nell’inverno, di quello che si senta da chi abita un paese più elevato ed asciutto, ciascheduno lo potrà ridire per propria esperienza di quelli che si sono trovati, come io ho avuta occasione più di una volta di verificare in persona nelli mesi di luglio e agosto, di novembre e dicembre sulle nostre più vicine colline al piede del monte da noi chiamato di Brianza. Anzi dal paragone di quanto è stato osservato da questi accademici, e da quelli che trovavansi in Laponia sotto il circolo polare, per la misura parimenti del grado terrestre, nel mezzo inverno, tempo in cui per mesi non vedevano il sole, in una continua notte sepolti ne’ ghiacci e nelle nevi, si ricava che l’uomo vive e soffre con minor danno un maggior freddo che un maggior caldo, essendo costante che gli uomini e quasi tutti gli animali soffrono molto allorché li circonda e respirano un’aria di tal grado di calore che sia come quello del loro sangue. Qual sia il maggior grado di caldo e di freddo che per risultato delle mie osservazioni in Milano si soffra, ho già altrove notato;[17] ma perché possa paragonarsi a quello d’altri climi è d’uopo avere un punto comune d’appoggio; questo è a mio avviso, come hanno creduto molti altri fisici, quello che volgarmente chiamasi temperato, e non quello della congelazione dell’acqua. Trovo dunque per le mie ed altrui esperienze, e per le mie osservazioni meteorologiche di più di otto anni continui, che il grado temperato qui in Milano all’aria aperta e libera, tranquilla e serena, ed all’ombra del sole nelle stagioni di primavera e d’autunno, per un corpo umano sano e di una delicatezza media di sua pelle, è circa li gradi 14 del termometro reaumuriano, e che generalmente i limiti del temperato in Milano, per qual siasi persona ed in qualunque stagione di tutto l’anno, è circa dalli 10 alli 16 dello stesso termometro.
Benché il grado di calore del sole sembri dover variare giusta la differenza delle latitudini, ciò non ostante non così esattamente succede, imperocché pare che il grado più o meno grande di calore de’ raggi solari molto venghi modificato dalla natura del suolo e del paese sul quale essi cadono. Io qui in Milano non ho mai veduto il termometro di Reaumur, esposto a’ più cocenti raggi del sole, in diversi tempi di estate marcare più di 35 a 40 gradi circa, benché qualche volta, ed in alcuni siti particolarmente del territorio nostro milanese, sembri il calore de’ raggi solari alla nostra sensazione insopportabile. Lo stesso succede degli effetti de’ raggi del sole sul corpo umano che sia a quelli immediatamente esposto. In Parigi, per esempio, in certi tempi di estate le persone esposte al sole, anche per breve spazio di tempo, corrono pericolo di certi accidenti, chiamati coups de soleil, ciò che in Milano non s’è mai veduto accadere. In alcuni paesi dell’America, se li viaggiatori non si coprissero la testa e tutto il corpo di grosso e duro panno di lana, li raggi del sole vi solleverebbero con grave danno
IL CAFFÈ )( Fogl. X )(
tutta la pelle. In Milano al contrario li coltivatori delle nostre campagne in tutta la state fanno tutti i loro più faticosi lavori esposti continuamente al sole, né mai havvi tra essi malattia che venghi attribuita all’azione de’ suoi raggi. Gli effetti cagionati da’ raggi del sole su di chi di noi in questo clima per alcun tempo vi si espone, altri non sono che l’imbronzarvi la pelle, e in chi non vi è avvezzato cagionarvi, massime ne’ giovani, alcuna volta qualche pesantezza o dolore di capo, o qualche emorrogia di sangue dal naso, sintomi tutti di breve durata e di nessun seguito.
Resta ad esaminarsi un’altra sorta di calore, ed è quello ch’io chiamo artificiale, cioè quello che proccuriamo alla nostra sensazione coll’arte, o per opporla a quella disaggradevole e dolorosa del freddo, o per difesa di nostra salute. Qui in Milano, generalmente parlando, nell’inverno male ci difendiamo nelle nostre camere dal freddo, gelandovi l’acqua anche in quelle che si dicono le più difese, ed in quelle che si credono le più calde ascendendo giusta le mie osservazioni il termometro di Reaumur a soli 4 o al più 5 gradi,[18] ma siamo in vece obbligati ad arrostirci a gran fuochi avanti a’ camini o a cavallo delle bragiere; e le delicate donne a covare de’ giorni intieri, attorniate di loro gonne, ardenti bragie di carbone. Dall’esperienza si ha che la pelle esposta al fuoco sino a certo grado di calore si stende[19] e si dilata, oltre il quale si ragrinza e si costipa, ed abbruggia. Le nostre gambe ben lo sanno alla fine dell’inverno; e non sono rari gli esempi di chi è costretto al letto per le piaghe cagionatevi dalla lunga e troppo replicata azione de’ nostri focolari. Tutti quegl’italiani che hanno passato degl’inverni in Germania unanimemente confessano che hanno trovato comodissimo l’uso delle stufe. Io mi vi trovo assai bene dacché ne ho fatta una costruire nella camera dove passo la maggior parte del giorno d’inverno; e dalla mia esperienza e di tutti quelli che vi ho introdotto ritrovo che, generalmente parlando, basta per trovarci noi qui in Milano nell’inverno in un ambiente temperato, che l’aria di una camera ben difesa venghi riscaldata dalla stufa a gradi 10 o 11 circa del termometro reaumuriano ne’ giorni nuvolosi, piovosi ed umidi; e ne’ giorni sereni e secchi un tantin più; avvertendo però che nella medesima camera non vi si trovi proporzionalmente alla di lei grandezza molta gente, mentre in tal caso dovrà la stufa essere meno riscaldata.
Benché l’esperienza mostri che l’uomo viva e non provi una sensazione dolorosa in un bagno di acqua riscaldata fino vicino a 40 gradi del termometro di Reaumur, ciò non pertanto fa altresì l’esperienza vedere che l’uomo medesimo non può respirare senza danno un’aria più calda del proprio sangue, né vivere senza pena in un’atmosfera (molto più se sia umida o carica di eterogenee materie) di un grado di calore eguale a quello del sangue proprio.[20] Si prendono cibi e bevande molto calde ed anche aghiacciate senza danno e senza pena; al contrario l’acqua tiepida eccita universalmente nausea e vomito. L’esperienza fa vedere quanto sia utile l’uso dell’acqua gelata contro la febbre ardente ed acuta, ed io medesimo ho provato, come ho altresì in altri osservato, che l’uso continuo dell’acqua molto calda proccura la stitichezza, ciò che non succede mai coll’acqua fredda. Da tutto ciò si deduce che più sano per noi, generalmente parlando, è che tutto quello che entra nel nostro corpo sia freddo di quello che sia caldo e che esternamente possiamo soffrire un grado di calore molto maggiore di quello sia interiormente entro le viscere.
Quasi tutte le antiche nazioni hanno generalmente fatto un uso grande de’ bagni. Li Turchi e li Russi ne fanno un uso continuo presentemente. In molte città della Germania e in Inghilterra si frequentano; nell’Italia appena si credono utili in alcune malattie. Io non mi tratterrò, come fuori del mio proposito, qui ora su di ciò, ma dirò solamente quello che le altrui e le mie osservazioni mi hanno fatto rimarcare, cioè che l’uso giornaliere de’ bagni è cosa non solo utile alla sanità, ma necessaria per la robustezza del temperamento. Li giovani romani, dopo avere affaticato nelle loro palestre tutto il giorno, polverosi e grondanti sudore si gettavano a nuoto nel Tevere; e i raffreddori, le tossi e le podagre erano mali incogniti con tal mezzo a quel popolo vigoroso. Molti inglesi coll’uso de’ bagni freddi, anche l’inverno, si garantiscono da ogni raffreddore e flussione ne’ passaggi anche più improvvisi de’ gran caldi a’ rigorosi freddi. Il bagno quotidiano deve essere appena caldo, di maniera che chi vi s’immerge non senta freddo né caldo, e in tal maniera potrà per insensibili gradi col tratto di reiterate esperienze accostumarsi al bagno freddo, il quale però dovrà essere sempre della temperatura delli 5 alli 10 gradi circa del termometro reaumuriano. Al bagno freddo non speri di accostumarsi chi è già in qualche età o che abbia incallita la pelle. Con molta facilità e con gran vantaggio vi si avvezza da’ teneri anni. Ma nel caso che li bagni siano necessari caldi, allora la persona istessa che vi si deve immergere dovrà essere il giudice del grado di calore del medesimo; imperocché, immersovi tutto il braccio o tutta una gamba nuda, deve esperimentare un grado di calore molto sensibile, ma che non lo scotti o gli faccia pena; e quando vi sia tutto immerso, dopo alcuni minuti deve cominciare a provare una sensazione come se sudasse, al che se fosse ciò non ostante difficile, potrà aiutarsi il sudore col bere dell’acqua calda mentre sta nel bagno istesso, mezzo unico e sicuro per proccurare il sudore e la traspirazione.[21] In somma il bagno più caldo di cui possa farsi uso in qualsiasi circostanza per il corpo umano è niente più di 28 a 30 gradi del termometro di Reaumur.
È degno altresì di qualche riflessione il grado di calore dell’ambiente della camera di un ammalato e di quella dove ordinariamente si dorme. Egli è un errore comune il credere che la camera di un ammalato debbasi scrupolosamente custodire e chiudere, onde l’aria vi si conservi ben calda. Per la stessa ragione per cui nelle febbri ardenti è utile l’acqua fresca ed anche gelata, per la medesima, dico, è utile che l’ammalato respiri un’aria fresca ed elastica, e ciò massime ne’ mali di petto e di polmone.[22] Dormendo è necessario di trovarsi ben coperto, onde proccurarsi una placida e non forzosa traspirazione, il che ottiensi allor quando il letto non è niente più caldo di quello sia il proprio corpo; per il che è più sana cosa che il letto non sia riscaldato con fuoco; e siccome dormendo la respirazione nostra è meramente macchinale, essendo proporzionale in tal caso la dilatazione de’ polmoni alla compressione dell’aria che vi entra, così egli è evidente che l’aria, dormendo, è necessario che si aspiri fresca ed elastica. Ond’è che l’ambiente di una camera, sì dell’ammalato che di quella dove si dorme, non deve avere un grado di calore maggiore di quello sia il temperato fresco, cioè al più di 10 a 11 gradi del termometro reaumuriano.
Merita pure seria attenzione la qualità dell’atmosfera che si respira nelle nostre case, nelle chiese e nel teatro. La maggior parte delle delicate nostre donne temono il minimo soffio di una finestra, ond’è che la maggior parte del giorno stiamo generalmente in camere serrate, e molto più con persone respiranti tutte l’aria istessa, e con più lumi accesi nelle nostre conversazioni. Ognuno sa per propria esperienza il genere di atmosfera che respiriamo le notti intere d’inverno principalmente nel nostro teatro. Chi entra alla mattina in una camera non ancora aperta, ben sente al naso il genere d’atmosfera cagionatavi dalla respirazione e dalla traspirazione di chi vi dorme. Un volgare timor panico generale è tra noi sparso, l’arrischiare cioè di dormire in una camera dove esattamente non siano chiuse tutte le aperture; aggiungasi che la maggior parte vi tiene lume acceso. Il suolo di quasi tutte le nostre chiese, e delle parochie principalmente, è intieramente ricoperto di sepolcri: l’odore e l’alito ributtante, che ne’ giorni umidi particolarmente così frequenti qui in Milano da quelli s’alza, è una prova più che dimostrante delle fetenti esalazioni che nell’aer sacro de’ templi nuotano d’intorno.[23] Generalmente nella state credesi che il mezzo migliore di conservare fresche le camere sia il chiuderle e il bagnar molto con acqua il pavimento; è però cosa facile l’avvedersi dell’inganno all’odore che in esse si sente de’ sali, delle materie eterogenee sciolte dall’acqua su’ mattoni e nell’aria innalzate coll’evaporazione dell’acqua istessa, e ciò massime in quelle a pian terreno, che sono ordinariamente umide; imperocché ella è osservazione costante che il nitro universalmente non s’attacca alle pareti che vicino a terra.
L’acqua è uno de’ principali alimenti di nostra vita. Io ho raccolto in vasi molto grandi dell’acqua piovana di estate, parte che immediatamente dal cielo cadeva in alcuni di detti vasi e parte che colava da un tetto vicino. Tutta quest’acqua conservai in grandi bottiglie di vetro accanto ad altre ripiene d’acqua de’ nostri pozzi. Dopo due anni sul fondo di quelle che contenevano l’acqua colata dal tetto vi ho trovata una leggier patina o sedimento color di terra creta, ed in quelle dove conservavasi l’acqua de’ pozzi vi ho veduto un leggier sedimento color cenericcio; al contrario l’acqua piovana, che dal cielo ho immediata mente raccolta ne’ vasi, ho sempre trovata ne’ fiaschi limpida e netta. Da ciò ricavasi che l’acqua piovana, tal quale immediata mente cade dal cielo, è la più netta e conseguentemente la più sana a beversi. Aggiungasi che il peso dell’acqua piovana è più leggiero di quello dell’acqua de’ fiumi di nove millesime parti.[24] È dunque da preferirsi l’acqua piovana raccolta e conservata nelle cisterne, purché vi coli netta, e che sieno esse ben construtte, nette, coperte e situate in luogo dove non vi tocchi il sole; imperocché io sospesi per una intera estate a’ cocenti raggi del sole esposte due bottiglie grandi di vetro, l’una ripiena di acqua piovuta in un forte temporale, che aveva impetuosamente colato da un vecchio tetto, e l’altra ripiena di acqua del medesimo temporale, ma che aveva immediatamente all’aperto raccolta in un vaso netto. Nella prima bottiglia si fece un gran sedimento, dal quale sorgevano, allorché vi dava il sole molto caldo, de’ filamenti ed una specie di vegetazione, che alzavansi di giorno in giorno fino alla superficie dell’acqua, ma che cadevano piegati sopra se stessi quando di notte l’aria era più rinfrescata;[25] ma nell’altra bottiglia ho osservato il fondo e l’acqua sempre netta e chiara. È frequente la lamenta, che sentesi qui in Milano, che l’acqua di molti e molti de’ nostri pozzi risenta odor crasso e di marciume. Veggansi le cagioni da me altra volta in questi fogli accennate.[26] Di tre pozzi che trovansi nella casa dove avvi la mia abitazione, l’acqua dell’uno, che è poco distante da una latrina, non è in alcun modo bevibile; dell’altro, che trovasi vicino ad una cisterna che raccoglie le colature di una corte e della vicina cucina, l’acqua risente per lo più di un odor crasso e di lessivio; e l’acqua del terzo, vicino al quale altre volte, non vi essendo di simili cose, era perfettamente netta, dacché vi hanno costruito poco lungi (alcuni anni sono) una cisterna per ordine pubblico, affine di raccogliervi le colature di una stalla di cavalli vicina, onde non scorressero per la strada, comincia anch’essa già da qualche tempo a risentirsi di alcun odore disgustoso.
Quanto agisca l’esercizio e ’l moto del nostro corpo ad aumentarne la robustezza basti il ricordare la forza prodigiosa de’ soldati romani, li quali immediatamente dopo lunghe marcie, coperti da capo a piedi di ferro, con scudi ed armi pesantissime, carichi del loro vitto per quindici giorni, combattevano vittoriosi; e certamente ciò con ragione ci sembrerebbe favoloso se non sapessimo essere a tal genere di fatiche addestrati da’ teneri anni colla corsa, colla lotta, con armi e cesti ancora più pesanti di quello realmente usavano combattendo davvero sul campo di battaglia contro l’inimico. A qual genere di destrezza e di forza possa coll’esercizio il nostro corpo assuefarsi è incredibile pel volgo ammiratore della più piccola cosa che sorti dalle ordinarie sue idee. Li saltatori che pochi anni sono abbiamo veduto sul nostro teatro, li ballerini da corda che ne’ passati mesi ci hanno intrattenuti sulla nostra piazza, ne sono un esempio ben rimarchevole. In somma, per le esperienze fatte dall’Accademia delle Scienze di Parigi e dalla Società di Londra, egli è incontrastabile che l’uomo proporzionalmente alla massa del di lui corpo è il più forte di tutti, del cavallo e del bue istesso e di qualunque altro animale fin ora conosciuto, potendo un uomo di ordinaria grandezza, quando gli sia giustamente applicato alle braccia, alle spalle, ai lombi, ed alle gambe, portare un peso di 400 libbre nostre, cioè di 12 oncie cadauna.[27] E dove si trovano qui da noi gli uomini più robusti e più forti, se non tra li coltivatori delle campagne, assuefatti fino da’ primi anni a forzosi esercizi delle braccia e di tutto il corpo?
Tra le esterne cagioni delle umane malattie ho, sopra, le passioni violenti annoverate. Per passioni violenti intendo quelle li di cui moti o azione sopra di noi ci portino oltre quei limiti per li quali l’Autore della natura ha le medesime ordinate. Che poi queste influiscono sopra la nostra salute basti il ricordare, per tacere di molti altri esempli, l’esinanizione e l’etisie veneree; lo squallore, la dimagrazione e la consunzione in lunghe affannose tristezze di un’anima sensibile; le febbri ardenti dopo un trasporto d’ira e di collera sono fenomeni abbastanza conosciuti perché si possa dubitarne. Io ho veduti de’ giovani, ad alcuni de’ quali dopo una forte collera restava per qualche tempo un tremore ben sensibile in tutto il corpo, ed altri che per lo spasmodico dolore di testa erano obbligati al letto. La metà del libro del Tschirnhausen intitolato Medicina mentis et corporis è impiegata a indicare i mezzi onde prevenire le malattie che traggono la primaria loro origine dallo spirito.
Finalmente è cosa degna da rimarcarsi che qui da noi, allorché il vento vi soffia un po’ forte, per fortuna non molto frequente, l’impressione che fa sul corpo umano che vi è esposto è il cagionarvi intronamento, o dolor di testa, o anche qualche dolore alle braccia o alle spalle o al collo, o alcuna volta non di rado, nelle persone non giovani principalmente, delle flussioni, dolori o strettezze di petto, fenomeni tutti che credo particolari solamente al nostro clima, a cagione della grande di lui umidità, essendo rari tra di noi li venti che si possono dire veramente asciutti e secchi; cosicché è più da temersi qui da noi il vento, perché ordinariamente umido, che le sole nebbie nelle quali siamo quasi continuamente immersi.
Fin qui ho riportato li risultati delle mie osservazioni intorno a que’ fenomeni, massime relativamente al nostro clima milanese, li quali ho io sopra annoverati tra le cagioni esterne di alcune malattie. Quali sieno però queste malattie che possono giusta le differenze degl’indicati fenomeni del nostro clima in noi essere cagionate, brevemente accennerò. Da Ipocrate fino a’ più celebri medici de’ dì presenti si ha da tutti unanimemente che le ordinarie malattie di coloro che vivono tra le paludi in mezzo a’ terreni bagnati ed umidi sono le flussioni di testa, del collo, delle spalle e di petto; li tubercoli, le tossi catarrali, li mali di polmone, febbri lunghe e periodiche, ordinariamente con insulto al petto, le umorali, le putride e maligne, e finalmente le idropisie. L’età più lunga dell’uomo è, generalmente parlando, di circa 80 anni. Nella nostra città, di cento venticinque mila abitanti circa non so se se ne troveranno venti di questa età, li più vecchi sono ordinariamente tra li 60 e li 70 anni; e la maggior parte muore verso li 50. Se da Milano discendete nel Lodigiano, nel Cremonese ed in tutta la parte della Lombardia la più comunemente e la più continuamente bagnata, questi numeri d’anni di vita troverete ancora minori. In somma, chi dal più basso Mantovano gradatamente per il Cremonese, Lodigiano e Milano sino alle colline del Monte di Brianza e di Varese esaminasse i libri delle parocchie, troverebbe aumentarsi in ragione della diminuzione de’ terreni bagnati e dell’alzarsi del suolo l’età più lunga degli abitanti, e minore relativamente al totale il numero di chi in un dato tempo, per esempio in un anno, vi muore. Da’ registri e da’ libri delle parocchie di tutta la città nostra e di tutta quella parte di campagna immediatamente intorno alle mura della medesima che volgarmente chiamasi Corpi Santi, si è estratto che per adequato dal 1754 al 1764 li morti in un anno sono circa poco più 5000. Dunque facendo per adequato ne’ suddetti anni il numero degli abitanti della città di Milano e de’ suoi Corpi Santi circa tra li 130 mila e li 135 mila, risulta che di ogni 26 in 27 persone in un anno ne muore una. Da’ cataloghi mortuari e de’ viventi fin ora fatti in diversi paesi dell’Europa si ha che in que’ paesi di aria migliore, e dove ordinariamente la vita degli uomini è relativamente più lunga, il minor numero di quelli che in un anno vi muoiono è d’ogni 28 in 30 persone una. Dunque la differenza del maggior numero de’ morti in Milano in un anno relativamente ad altri paesi (giacché sossopra li costumi e le maniere di vivere in quasi tutta l’Europa sono le medesime), ad altra cagione non potrà attribuirsi che alla poca salubrità dell’ordinariamente troppo umida nostra atmosfera. Aggiungasi che appunto il numero per adequato de’ morti nell’anno 1759 è stato di 6244, numero maggiore dell’adequato di ogni altro anno; e che appunto l’intemperie delle stagioni dell’anno precedente 1758 è stata la più cattiva, piovosa ed umida di ogni altro anno, come risulta da’ giornali delle mie osservazioni meteorologiche. Dunque la mortalità sarà, generalmente parlando, maggiore dopo un tempo cattivo ed una stagione molto umida e piovosa.
Ma eccoci oramai ad alcune regole, le quali immediatamente da quanto si è fin qui esposto derivando, e conseguentemente alla sola esperienza ed alla osservazione appoggiate, possono, moralmente parlando, accertare in chi vive nel clima milanese una robusta salute.
1. Sieno li cibi più usuali e comuni, di latte, di pane, di cose farinose, di frutta, di erbaggi, e pochi di carne.
2. Preferite i latti di animali che si pascolano di erbe e fieni di terreni asciutti ai latti di quelli che sono pascolati di erbe e fieni in prati bagnati e di marcita. Preferite il riso, il frumento e l’orzo a’ legumi, l’erbe novelle e più tenere alle più vecchie, benché alcuna volta credute dal volgo le più salubri, ed alle più resistenti alla masticazione. Le frutta sieno ben mature, e piuttosto vicine al cominciare a marcirsi che acerbe. Preferite le ova alle carni; e le carni sieno piuttosto di uccelli e di polli, né troppo novelli né troppo grossi, a quelle de’ quadrupedi; la carne di bue a quella di vitella ed a quella di ogni altro quadrupedo. Le carni sieno succolenti e fibrose, ma si lascino onninamente le crasse o troppo onte. Non temasi colle carni far uso di sale e di droghe; e generalmente co’ cibi frequentisi l’aceto, il citrone e tutti li succhi acidi.
3. La maggior quantità del cibo sia pane con lievito, e ben cotto. Il cibo sia piuttosto molto che poco. Nessuno soffri con pena la fame senza mangiare, ma guardisi di troppo mangiare fino alla totale sazietà.
4. La bevanda usuale sia l’acqua, abbondante in ogni tempo, e sia fredda, ben netta e senza alcun sapore o odore. Preferite la piovana a quella de’ fiumi e de’ pozzi. Poco vino, e solamente quando si è di molto mangiato; e senza aver mangiato non ne bevasi. Preferite il vino rosso al bianco; badate che sia netto, trasparente e non denso; piuttosto sia inclinevole al subacido e all’amaro che dolce; né temiate poi che sia nuovo o vecchio. Allorché si dimori per alcun tempo in sito di un’atmosfera molto umida ed impura, e dove bevasi acqua paludosa o men pura, facciasi qualche uso moderato di vino, ed alcuna volta prendasi alcun poco di acquavite o altro liquore generoso, ma guardisi il frequentarli di troppo.
5. Dopo il pranzo frequentate senza timore il caffè, e ciò massime allorché trovasi in un’aria paludosa e molto umida; ma non bevasi mai solo a digiuno: unito con latte o col rosso d’uova usatene quanto v’aggrada. Chi inclina ad ingrassarsi lo frequenti; ma chi tende al dimagrarsi non vi si famigliarizzi. Per il tè non molto carico non temasi beverne in ogni tempo e in abbondanza.[28]
6. Chi tende ad impinguarsi, mangi
IL CAFFÈ )( Fogl. XI )(
frequente e non molto per volta; non ceni, o molto poco; usi cibi asciutti, e s’allontani dal vino, dalle carni, o preferisca piuttosto quelle salate. Al contrario colui che è inclinevole al dimagramento mangi molto, ma a’ soliti pasti; e frequenti cibi umidi e succolenti; ceni, e bene. Generalmente l’ora de’ pasti sia quella della fame.
7. Tutto ciò che entra nel proprio corpo sia piuttosto freddo che caldo; né inghiottiscasi mai cosa che scotti la lingua o levi la cute dal palato.
8. Il sito dove si dorme sia piuttosto freddo che molto caldo; piuttosto in camere grandi che troppo piccole; non dormasi in camere a pian terreno,[29] ossia in camere umide, né bagnate, e piuttosto esposte al settentrione, ossia alla tramontana, che ad altri aspetti. Guardisi di dormire in camere dove havvi calcina nuova, bagnata e non perfettamente seccata. Stiasi dormendo coperto in modo onde proccurare una placida traspirazione, ma guardisi di trovarsi in letto talmente coperto e caldo a segno di troppo sudare. Impedite che l’aria, massimamente se è umida, soffi sul corpo immediatamente, ma è necessario che ventili o cangi da una camera all’altra, ond’è pessima cosa il chiudersi intorno nel letto con tutte le cortine e lo stivare scrupolosamente tutti gli usci. Non tengasi fuoco (non intendo però quello de’ camini, che anzi è sana cosa, imperocché vi cambia continuamente l’aria) e nessun lume acceso nella camera istessa dove si dorme; o altrimenti fate in modo che vi entri la luce sola, ma in nissuna maniera il fumo.
9. Le vesti ci coprino egualmente in ogni stagione e sieno piuttosto leggieri, ed il loro peso sia, poco più poco meno, lo stesso in ogni tempo. Esse non stringano più una parte del corpo che tutto il resto, né impediscano in minima cosa i liberi moti delle membra: di estate di una tessitura più rara, e di una forma larga; ma d’inverno di una tessitura più fitta, e che si addattino bene alla forma di tutto il corpo. Non temasi il sole di marzo, purché con cappello abbiate difesa la testa, esponetevi pure liberamente senza timore a’ di lui raggi in ogni tempo; è anzi ottima cosa per tutti generalmente l’accostumarvisi alcun poco, ma guardatevi dal dormirvi esposto.
10. Se il freddo obbliga ad accostarsi al fuoco, non stiavisi che fintanto che basti a sufficientemente riscaldare il corpo. Guardatevi di non dimorare tanto tempo e tanto presso al fuoco ch’egli vi faccia sudare; né molto tempo fermatevi sopra le braggiere ardenti, mentre elleno vi cagioneranno delle forti vertigini. Accanto a’ camini riparate sempre la testa dall’impressione del fuoco. Non temino le delicate donne il riparare dal freddo li piedi e le gambe col sacco di pelliccia, purché le pelli sieno ben asciutte e non, per essere troppo nuove, ancora umide. È un errore il credere che la pelliccia cagioni delle flussioni; il minor inconveniente che può il frequente uso delle cassette da fuoco cagionare è l’indebolire il vigor delle gambe e delle ginocchia, e ’l gonfiare li piedi. Se vi hanno stufe preferiscansi quelle che chiamansi volgarmente tedesche a quelle che ultimamente introdotte diconsi moscovite. Della maniera e grado di riscaldarle veggasi quanto ho già dissopra indicato.
11. Il mezzo più sicuro perché il freddo cagioni una minor possibile sensazione disgustosa si è l’accostumarsi a’ bagni freddi; e nella state, per sentire con sensazione meno disaggradevole possibile l’impressione del caldo, è ottima cosa bagnarsi in acqua calda quanto l’aria esterna all’ombra.[30] Della necessità e del vantaggio de’ bagni veggasi quanto ne ho già sopra indicato.
12. Cambiate frequentemente l’atmosfera delle camere, e molto più se elleno sono piccole. Non temasi l’aprire in ogni tempo e in ogni stagione di frequente, di tanto in tanto, gli usci e le finestre, purché l’aria esterna non sia molto umida o paludosa. Se l’atmosfera esteriore è di risaie, di prati e simili terreni bagnati, tenetevi in camere serrate, ma in esse fate de’ gran fuochi, massime di fiamma a’ camini, e di tanto in tanto profumate l’aria coll’abbrucciarvi delle gomme ed altri aromi odorosi, come sarebbe la gomma d’ulivo, il zuccaro, il legno d’aloe e simili cose. Guardatevi che nelle camere resti odore di puzza o di esalazioni di cose fetide. In tali circostanze è ottima e necessaria cosa lo spargere per le camere dell’aceto, ovvero farne svaporare in esse bollendo in un vaso aperto posto sulle braggie di uno scaldino portatile, mezzo il più sicuro fin ora esperimentato nelle navi maritime per purificarvi l’aria, onde garantirsi dallo scorbuto e dalle febbri pettecchiali. Il miglior mezzo per cambiar l’aria ne’ siti chiusi si è il ventilatore, che è una macchina molto semplice, colla quale si estrae l’aria che vi ha dentro, introducendovene della nuova.[31]
13. A’ nostri venti non espongasi a testa e petto scoperto. Allorché l’aria è molto umida o carica di nebbia non sarà male, esponendovisi, il tenere della bambagia negli orecchi e il tenere in bocca alcuna cosa aromatica. Se abitate in sito molto umido usate alcuna volta della pippa; ma guardatevi di troppo famigliarizzarvi. Non temasi di bagnare i piedi, è anzi bene l’accostumarvisi; ma in que’ giorni che avete molto camminato nel bagnato ed umido, usate a’ piedi de’ bagni di rosmarino, di vino e di acquavite. Non vi fate uno scrupolo allorché o vi affacciate alla finestra o sortite dalla porta di non aver sempre il cappello in testa e di non esser involto sino agli occhi nel mantello, e molto meno non vi accostumate in casa di aver sempre in testa la beretta; fuori delle occasioni che ho indicate, è necessaria cosa il lasciar libera la traspirazione della testa e l’accostumare il corpo nostro a tutte le impressioni dell’atmosfera.
14. Usate non di rado le fregagioni secche, ed alcuna volta con panni bagnati di acquavite. È sana cosa nella nostra atmosfera, sortito dal bagno allorché il corpo è ben asciutto, bagnarlo alcuna volta, massime il petto, con acquavite o altri simili liquori odorosi e spiritosi, il profumarlo con fumo di zuccaro, d’incenso e altre gomme simili odorose, giusta il gusto d’ogn’uno abbrucciate, ed anche col fumo di aceto bollente.
15. Guardisi ognuno dalla vita sedentaria: tengasi il corpo tutto accostumato al moto, e tal volta anche violento. Eccovi però accennati alcuni mezzi: cavalcare frequente; camminare lungamente, ed alcuna volta correre; viaggiare delle miglia a piedi; alzare e movere de’ pesi; il ballo; il giuoco del pallone, della racchetta; il trucco di terra; il billiardo. Non credasi però, benché alcuna volta si passeggi per un’ora di tempo o abbiasi a cavallo fatto il giro delle mura della città, di aver fatto un gran moto e di potersi gloriare di un forte esercizio di corpo. Come il nostro corpo abbisogna più d’una volta ogni giorno di cibo, altrettanto è al medesimo necessario ogni dì un movimento non piccolo. La più delicata e fina costituzione fisica delle donne non le esentua da questa legge. Le principali cagioni delle universali convulsioni nelle delicate nostre dame è il poco cibarsi e ’l nessun moto ch’esse fanno.[32] Se al corpo umano è necessaria cosa l’esercitarsi ogni giorno col moto forte, ma non violento fino al principio della stanchezza, è altrettanto per il medesimo dannoso lo stare lungo tempo in piedi fissamente o con poco moversi. Ognuno sa per propria esperienza quanto ciò rende in breve stanco, e le gambe dolenti e i piedi.
16. Dopo il forte esercizio e moto di corpo è d’uopo il riposo; ond’è necessaria cosa il dormir ogni giorno molto altresì, ma non di troppo. Ad un corpo sano e robusto bastano comunemente sette ore al più di sonno. Se inclinate ad impinguarvi dormite meno, se alla dimagrazione dormite di più. Guardatevi dal dormire mai in alcun tempo al dopo pranzo, e molto meno in aria umida ed impura, né subito immediatamente dopo aver cenato molto; piuttosto dormasi pria di pranzare. Ordinariamente sia in circa la stessa ogni giorno l’ora di porsi a dormire; né temasi poi sia ella di giorno o di notte.[33]
17. Nelle cucine guardisi di usare utensili di rame. Essi, in qualunque modo sieno stagnati, sono sempre dannosi alla salute; gli utensili di cucina di ferro imbianchiti con lo stagno, ovvero quelli di terra cotta, ma bene inverniciati, sono li più utili d’ogn’altra sorta.[34]
18. La giusta e la vera filosofia morale, che non vuole annientate le nostre passioni, ma che insegna con dolci e facili modi a diriggerle a giusti fini entro que’ limiti onde furono a noi date dall’Autor dell’universo, non è così sconosciuta nel secol nostro perché io debba in questo foglio ricordarne i precetti. Rammenterò dunque solamente come regole necessarie alla conservazione della salute, che non così piccole sono, come volgarmente credesi, le impressioni della collera sul fisico del nostro corpo, e massime su quelli della più fina costituzione, cioè della donna, più facile universalmente all’ira ed alla collera, perché questa passione non possa meritare qualche attenta riflessione, sicché non valga a trasportarci di troppo. Degli effetti d’altre passioni sul nostro fisico, e più particolarmente della Venere, come quella che più d’ogn’altra esterna cagione è comunemente la principale della maggior parte delle malattie e delle cagionevoli costituzioni, veggasi la Medicina statica del Santorio, libro di piccol mole, non troppo sparso, ma li di cui aforismi dovrebbero come proverbi essere universali, e da tutti e dal volgo istesso ripetuti a mente.[35]
19. Chi a tutt’altro genere di vita fino da’ primi anni accostumato volesse a quella che nelle sovraesposte regole ho indicato come più utile e ragionevole appigliarsi, non pensi di riuscirvi subito con un totale cambiamento, senza incontrare qualche incomodo. Le grandi mutazioni in cose fisiche non riescono se non per gradi, né creda potervi riuscire se ha di qualche anno passati li 30 di sua età, e molto meno se con tutt’altro regime ha di molto ingracilito il proprio temperamento.
Le regole che sopra ho esposte sono generali ed utili a tutti noi che viviamo nel clima milanese, e in qualunque età, usandole in pratica colla sola restrizione del più al meno, giusta la differenza più o meno vigorosa della naturale fisica costituzione. Hannovi però alcuni mezzi, li quali, praticandosi più in una che in un’altra età, possono unitamente a quanto ho già indicato concorrere alla conservazione di nostra salute in questo nostro clima e farci sperare una più lunga vita. La cagione interna della decadenza insensibile che fassi cogli anni e coll’età di nostra vita, questo seme di morte che chiudesi in seno fin da’ primi momenti dell’esser suo di ciaschedun uomo, allorché nessun’altra esterna causa vi concorri a precipitarne gli effetti o prevenirli, altro non è che un necessario incallimento, un induramento indispensabile di que’ tubi, di que’ canali, di quelle parti per le quali scorrendo i liquori differenti della nostra macchina idrostatica, il sangue, le linfe, le secrezioni, gli spiriti animali ec. erano atti a que’ moti principalmente per cui stiam vivendo, ed a quelli conseguentemente rendendosi col tempo in questa guisa meno obbedienti, restano al fine senza moto per gradi differenti fino a quel segno che chiamiamo morte. Di ciò, se si eccettuano alcuni pochi metafisici, che ne vagliono più per le loro sole idee che per il fatto e l’esperienza, convengono generalmente tutti li fisici giudiciosi, tutti gli anatomici li più diligenti, tutti li veri medici. E siccome vediamo che questo incallimento, questo induramento arriva ordinariamente a quel grado d’impedirci que’ moti necessari onde ci chiamiamo in vita ordinariamente circa al più tardi in 80 anni; non sarà dunque stravagante il dire che questi mezzi istessi, li quali possono impedire e ritardare codesto induramento, codesto incallimento di nostre fibre, quelli stessi saranno che potranno proccurarci una più lunga vita dell’ordinaria; e certamente l’amor proprio può facilmente inclinarci a riporre almeno un tal sistema nel numero de’ possibili.
In quella maniera istessa che vediamo a qualunque macchina addivenire, che da’ primi momenti che venga messa in moto, da que’ momenti istessi si comincia ad usare, non altrimenti al nostro corpo succede che fino dal principio dell’esser suo vi abbisogna di riparazione o almeno di cura, perché si usi o si frusti col minore svantaggio possibile. Ciò dunque spetta particolarmente all’infanzia, né su di ciò mi tratterrò io qui. L’educazione fisica de’ fanciulli e de’ giovani è cosa troppo interessante su tutto il resto della vita perché io voglia parlarne brevemente, come sarei costretto a far ora. Ecco però alcune mie idee sulla maniera di prolungare la vita nostra.
Ciascheduno può da sé vedere che mettendo in acqua della pelle, degl’intestini, delle carni e delle ossa di qualsisiasi animale, come si conservano molli, pieghevoli e morbide, e ciò molto più se l’acqua non è né troppo fredda né molto calda, anzi ad ogni piccola forza in qual maniera cedono esse o si estendono in un maggior volume, ciò che non vediamo succedere allorché si conservano nel vino, nell’acquavite e nell’aceto, o altri simili liquori spiritosi e costipanti, ne’ quali divengono più compatti e più resistenti, e molto meno allorché si tengono queste cose istesse poco umide; imperocché benché non ancora secche s’induriscono, si ragrinzano e si scorciano. Ciò premesso, chiara cosa è che il frequente uso esterno ed interno dell’acqua, nella quale abitualmente tutto il corpo nostro e le nostre fibre sieno bagnate e natanti, sarà il più sicuro e il più facil mezzo, onde conservarle molli, pieghevoli e ubbidienti a que’ moti per cui restiamo in vita. Ciò non pertanto egli è d’uopo il rammentare che li fluidi, le linfe, il sangue e gli spiriti animali non scorrono per il nostro corpo e per le nostre fibre per il solo proprio lor moto d’impulsione, di peso, di adesione e di attrazione, ma altresì per la elasticità propria, per quel moto intestino delle fibre istesse; ultimamente coll’osservazione più fina e colla più delicata esperienza confermato, conosciuta col nome d’irritabilità; per la qual cosa essendo il principal effetto dell’acqua il diluere e l’amollire, potrebbe essa, sovverchiamente abbondando, talmente sminuire, col farle meno tese e renderle floscie, la elasticità delle fibre componenti il corpo nostro, onde fossero meno atte a que’ moti, per li quali o stagnando o lentamente circolando i fluidi che portano lena e vigore a tutte le membra, estinguerne col tempo per gradi la vita. Dal che viene in conseguenza che in mezzo al continuo abbondante necessario uso dell’acqua pura sì all’esterno quanto interiormente,[36] è indispensabile l’usare altresì qualche volta interiormente parimenti quanto all’esterno di alcuna cosa onde ridonare alle fibre componenti troppo molli e rilasciate quella tensione e quel tono necessario ad eccitarne ed equilibrarne le vibrazioni a’ moti e alla qualità de’ fluidi circolanti, dal quale equilibrio è dipendente la durazione di quell’istesso costante grado di vita, di cui un corpo umano è giusta la naturale di lui fisica costituzione fino da’ primi momenti del suo essere di tanto e niente più capace. Al qual effetto è ottima cosa alcuna volta il bevere moderatamente del vino e de’ liquori spiritosi; il mischiare co’ cibi il sale e gli aromi, e sopratutto il frequentare l’aceto e tutti li succhi subacidi; il bagnarsi esternamente qualche volta coll’acquavite o altri simili liquori spiritosi ed odorosi; le fumicazioni, le fregagioni e i fomenti; tutto ciò in quella maniera ed in quel grado, poco più, poco meno, come ho già di sopra avvertito; ma più d’ogn’altra cosa a questo medesimo effetto, oltre a quel regime che nelle succennate regole ho già indicato, ella è cosa di primaria, indispensabile necessità l’esercizio continuo, il moto forte volontario delle nostre membra e di tutto il corpo; ciò che parimenti ho già sopra dichiarato, ma che non basterà mai il nuovamente ricordare e ripetere agli uomini, li quali pur troppo con grave lor danno sono alla inazione inchinevoli.
Da questo raziocinio vengono direttamente alcune regole differenti atte alla conservazione della sanità e della vita in differenti gradi di nostra età, che qui esporrò brevemente.
1. Il giovine dovrà attenersi a quello stesso regime di vivere che ho già nelle sovraccennate regole esposto.
2. L’uomo di mezzana età comincerà a frequentar meno l’uso del vino, de’ liquori spiritosi e forti, delle fumicazioni e de’ fomenti; ma aumenterà e si renderà più familiari i bagni, le fregagioni e le bibite abbondanti di acqua, mangiando de’ cibi un poco più succolenti ed aumentando del proprio corpo l’esercizio e ’l moto,
3. Il vecchio farà meno uso che in ogni altra età del vino[37] e de’ liquori spiritosi; ma frequenterà più ch’altri i bagni caldi ed emollienti, le bibite d’acqua, e benché gli sia necessario un maggior riposo, quanto più potrà non rallenti il moto e l’esercizio del proprio corpo; si cibi molto più di pane di frumento con lievito e d’ogn’altro cibo farinaceo, e di cose succolenti; si guardi dalle ontuose e crasse, e preferirà le cotte alle crude. Aumenti finalmente più che in tutte le altre età le fregagioni e i mezzi onde eccitare la insensibile cutanea traspirazione.
Ma perché le nostre cure intente non solo esser devono a ciò che alla salute e alla durazione di nostra vita appartiene, ma a quelle cose altresì che possono conservarne ed accrescerne li comodi o i piaceri, e dirò meglio a rimoverne e sminuirne quelle pene e quelle sensazioni disgustose indispensabili alla caduca e frale costituzione nostra; così parmi indispensabile dover in fine alcuna cosa rammentare, che su di ciò le mie osservazioni e le mie esperienze mi hanno dato occasione di rimarcare.
Le esperienze fatte dal signor Maraldi[38] intorno al guardar fisso alcune diverse figure di differenti colori, hanno mostrato quanto gli occhi sieno sensibili alla impressione de’ colori. Ella è altresì cosa nota generalmente che li cacciatori e coloro che vivono sulle alture, sulle colline, su’ monti, accostumati a riguardare oggetti in molta
IL CAFFÈ )( Fogl. XII )(
lontananza, quanto più acuta dirò col volgo sia la loro vista e quanto con maggior facilità vedono oggetti lontani, ch’altri non possono scoprire se non col cannocchiale. E finalmente moltissimi lo sanno per propria esperienza, che la continuazione dell’uso degli occhiali gli obbliga di tempo in tempo a doversene appigliare ad altri sempre più forti, non gli servendo più li primi, e ciò qualunque sia il genere di lor vita. Da queste osservazioni deriva perciò ch’egli è necessario l’accostumarsi di frequente a risguardare oggetti lontani, il tardare quant’è più possibile a far uso degli occhiali, e di abitare ordinariamente in camere in cui la luce sia talmente languida e raddolcita che piuttosto tenda all’oscuro che al molto chiaro; per il che ella è ottima cosa l’avere avanti le finestre delle cortine di color verde, e che questo sia il colore dominante su tutti li mobili e le pareti più d’ogn’altro colore, massime del rosso e del citrone. Né le galanti donzelle temino il color verde come forse il meno vantaggioso, imperocché se elleno in virtù delle mode della Senna amano les couleurs tendres, il verde è uno di quelli che più d’ogn’altro merita questo delicato e grazioso nome. Se leggete e scrivete molto, sia il tavolo coperto di un tapeto color verde; e di color verde pure usate degli occhiali, ma perfettamente piani, oppure fate in modo che la luce che si riflette sul libro sia non molto forte, e quella che sola basti a poter leggere senza fatica o sforzo degli occhi, ed inclini a questo colore. Né temiate poi che ciò sia di giorno o di notte, purché il lume non traballi. Tengasi quant’è più possibile la testa e il corpo dritto e meno inclinato, e badisi che non tocchi e premi il petto contro l’orlo del tavolo.
È generalmente osservato che li denti de’ poveri coltivatori delle campagne, che non mangiano ordinariamente carne, sono più bianchi e più sani, e massime in coloro che abitano siti montuosi ed asciutti; e ciò massime per più lungo spazio d’anni ed anche fino alla vecchiezza in coloro che abitano in siti montuosi o asciutti, di quello sia in chi mangia carni ed abita in città, e principalmente in un’atmosfera molto umida e nebbiosa. È però indispensabile dunque che noi nella nostra milanese atmosfera, e che generalmente mangiamo di molta carne, abbiamo molto cura de’ denti, ripulendoli di frequente e lavandoli con acqua calibeata mista con acquavite pura, nitro o sal gemma e succo di coclearia.
La pelle del nostro corpo è altrettanto più bianca e sensibile quanto più è dalle impressioni dell’aria difesa. Ciò è noto a tutti; onde per incallire quanto meno è possibile la sensibilità delle nostre mani (principale istrumento della giustezza delle nostre idee) è d’uopo il lavarle e coprirle di frequente, né mai, dopo che si sieno o al fuoco o altrimenti ben riscaldate, esporle immediatamente scoperte all’impressione dell’aria fredda. E le donne gelose de’ loro volti per questa medesima ragione non mai dopo essersi accostate al fuoco immediatamente esporsi debbono ad un ambiente più freddo. A questo proposito è necessario l’avvertire ch’egli è un errore, benché universale, il credere che gli ontuosi, come sono le pomate e simili cose, conservino la pelle; imperocché elleno impedendovi la traspirazione, otturandone li pori, infallantemente col tempo la anneriscono e la rendono floscia e cascante, facendovi prematuramente perdere la naturale di lei elasticità e confondendo insieme la diramazione, che va per ogni verso delle di lei fibre, unica cagione della di lei bianchezza e bellezza. Il lavarsi il viso con acqua semplice, ovvero di rose, o di fior di sambuco, o di fragole pria di coricarsi al letto, ed alla mattina alcune rare volte pria che si esponga all’ambiente dell’aria esterna, il passare leggiermente sul volto un pezzetto di burro di cacao, levando via dopo con un fino pannolino l’onto rimastovi,[39] sono i soli mezzi che si possono usare onde in chi vive in mezzo un’atmosfera umida e crassa, dove facilmente la pelle ingiallisce e si fa livida, sperare con qualche probabilità di conservarsi la pelle nella primitiva naturale di lei bianchezza ed impedirvi le rughe troppo premature. Ogn’altra cosa è dannosa; o per lo meno impostura.
L’aria introducendosi per gli orecchi allorché è ventosa, o molto umida e di eterogenee esalazioni impregnata, vi può cagionare delle flussioni, delle ostruzioni, de’ dolori e la sordità; imperocché è altresì certo che in maggior numero vi hanno de’ sordi in siti bassi, paludosi ed umidi che tra coloro che vivono in paesi alpestri ed asciutti; ond’è bene qui da noi, esponendosi al vento o all’aria nebbiosa, il mettere leggiermente della bambagia negli orecchi. Per la medesima ragione è cosa buona qui da noi, che siamo quasi continuamente circondati da un ambiente umido e crasso, l’usare moderatamente il tabacco in polvere per il naso, ed alcuna volta di qualche odore spiritoso od aromatico. Ma guardatevi per qual siasi cagione dal masticare tabacco in corda.[40]
Finalmente ella è cosa sorprendente il grado di squisitezza e delicatezza al quale può arrivare la sensibilità degli organi sensibili del corpo umano: ne accennerò un solo esempio. In Olanda eravi un giovine, il quale allorché gli si dava a bere (senza averlo in nessuna maniera avvertito in prima) del tè fatto con cinque o sei qualità differenti di quest’erba, sapeva ogni volta, senza ingannarsi mai, all’odore ed al sapore distinguere la diversità, differenziandole tutte esattamente col loro proprio nome. Ma è altresì poco consolante per tutta l’umanità ciò di che nostro mal grado ci convince l’esperienza giornaliera, cioè che la sensibilità nostra sminuisce e declina coll’uso; ed al contrario ella è nulla o si perde qualora è in ozio totale. Per la qual cosa li mangiatori di molta carne o di cose ontuose e crasse e li bevitori abituali di molto vino hanno il palato molto incallito, né sanno ben distinguere il gusto de’ sapori. Chi usa odori forti guardisi di troppo frequentarli; imperocché essendo la sensibilità dell’odorato una delle più fine e delicate, si renderà sicuramente meno atto a gustarne la fragranza; ed al contrario le delicate donne non temino l’accostumarvisi, mentre se con un più ragionevole e conseguentemente più comodo regime di vita, come ho fin qui indicato, si renderanno la loro costituzione più robusta e vigorosa, non solamente non soffriranno danno dagli odori, ma anzi avranno riacquistato un sentimento di più, che in prima o non avevano o che loro era soltanto a carico, cioè l’odorato.
Sembreranno forse ad alcuno di color se-dicenti medici meno solidi, se non anco stravaganti, li risultati e le conseguenze che brevemente ho io qui riportate. Queste ho io imediatamente derivate dalle altrui e mie esperienze ed osservazioni, non da vaghi ragionamenti. Fuori di questi fogli, in uno scritto più esteso, avrei potuto con altri fatti ed altre esperienze maggiormente le medesime confermare; ma a me basta che venghino esse da’ veri fisici e da’ veri amatori dell’umanità giudicate utili e ragionevoli.
[Giuseppe Visconti]
Badi. Novella indiana
Eravi nell’India un giovane ricco di beni di fortuna, d’ottimo carattere, il di cui nome era Badi. Questi avea sortito dal cielo un cuore sensibile e un animo schietto e sincero. Se per virtù intendete uno sforzo, ei non era virtuoso, poiché tutte le azioni le più benefiche e generose era anzi spinto dal suo cuore medesimo a farle. Badi era il più favorevole interprete delle azioni degli uomini, e le risguardava sempre dal lato migliore che aver potessero; dolce nel suo tratto, nobile nelle sue idee, fedele amico, generoso cittadino, ottimo giovane in una parola. Al corredo di queste qualità, alla ricca sua condizione s’accoppiava l’eleganza del suo aspetto, da cui traluceva la bontà e dolcezza del suo carattere. La educazione ch’egli avea ricevuta nella solitudine dei bracmani l’avea già iniziato nella sapienza orientale; ed era sul punto di cominciare il corso della vita civile entrando nella società degli uomini. Badi prima di farlo si ritirò in una sua villa per riflettere agiatamente alla nuova situazione a cui dovea passare, e scegliere quel sistema che gli paresse più conforme alla ragione e più confacente all’indole propria. Io sono, diss’egli, conscio a me stesso di non avere malignità nel mio animo; nessuna parte de’ miei affetti mi farà arrossire, quantunque sia palese; amo a far del bene; sono incapace di verun tradimento: perché dunque dovrò io dissimulare quel che ho nel cuore, come taluni mi hanno suggerito? Finga chi ha ragione di nascondersi, io non ho motivo di farlo. Gli uomini dicono alcuni che sono esseri cattivi: forse lo saranno quando hanno interesse di esser tali, come il leone che affamato assale l’uomo; con me, che non vuo’ far male ad alcuno e che voglio anzi far tutto il bene che posso, qual interesse possono mai avere di nuocermi? Il leone pasciuto vede l’uomo e lo lascia pel suo viaggio. Io vuo’ dunque essere sincero perfettamente; questa virtù mi concilierà la benevolenza degli uomini; nessuno potrà di me diffidare; se io tratterò gli uomini come se fossero miei amici, essi tratteranno me per conseguenza da amico. Io credo che coloro che hanno l’imaginazione melanconica e che tanto dicon male della specie umana sieno maltrattati, perché essi i primi non sanno essere buoni e sinceri. I serpenti istessi non fanno male se non sono offesi: diranno costoro che l’uomo, quest’artificioso animale che ha saputo fabbricarsi città, inventar lingue, inventar scrittura e registrare in un volume i doveri d’un uomo verso un altro ridotti in precetti, debba essere men benefico di un serpente? La cosa è chiara che questa diffidenza è un sogno d’una nera fantasia. Io mostrerò a chi così pensa che basta esser veritiero e buono, ma esserlo decisamente, per essere ben voluto dagli uomini.
Tale fu il ragionamento presso a poco che fece il giovane Badi; e se ne venne alla capitale risoluto di secondar sempre i moti del suo buon cuore, e sopratutto di non tradire giammai la verità. Appena ivi fu, che molti congiunti ed amici vennero a ritrovarlo ed a conoscerlo, giacché da molt’anni era stato assente, vivendo nella solitudine de’ bracmanni. Ei si mostrò cortese e buono con tutti. Un suo cugino diforme assai d’aspetto: Badi, gli disse, io mi consolo con voi poiché vi vedo formato di una figura che deve conciliarvi la benevolenza d’ognuno. È vero, rispose Badi, ch’io son bello, ma ciò non basta per essere caro alle persone colle quali s’ha da vivere. All’udire sì fatta risposta di Badi tutto il crocchio de’ congiunti e degli amici volle scoppiar dalle risa, e l’un dopo l’altro se ne partì; e per tutti i quartieri della città si riseppe che il giovane Badi s’era chiamato da se medesimo bello; e universalmente si cominciò a spargere il ridicolo sopra di lui. Badi ne fu inteso, e quasi non poteva indursi a crederlo. Il mio specchio mi dice che la mia fisonomia è fatta come le fisonomie che si chiamano belle; ognuno lo vede, non è cosa nascosta; perché dunque non potrò vederlo anch’io? E se l’ho veduto, perché non potrò dire d’averlo veduto? Se fossi gobbo direi che son gobbo; son bello, e dico che son bello; nemmeno perciò muterò il mio sistema.
Dovette l’indomani presentarsi il giovane Badi ad un ministro favorito del re; lo fece; fu accolto con singolare benevolenza, che fé stupire tutti i cortigiani circostanti: il ministro gli disse Buon giorno. All’udire una distinzione sì onorevole tutti si affollarono intorno al giovane Badi; ognuno volle toccargli la mano; ognuno lo trovò amabile e di un merito singolare; ognuno si affrettò a cercare la di lui amicizia, e Badi si compiacque d’aver ben definiti gli uomini per animali innocui e buoni. Passò d’indi Badi nell’appartamento della moglie del favorito, dov’era già precorsa la notizia del graziosissimo saluto che avea ottenuto Badi; la signora ricevette la riverenza di Badi con un sorriso pieno di bontà, indi gli permise di sedere in circolo cogli altri. Un cagnolino della signora, frettolosamente entrato, ricevette in giro le più amorose carezze da tutti gli astanti; la signora lo amava teneramente e lo chiamava il suo Lillì. Che ne dite, Badi, disse la signora, del mio Lillì? Lillì era un cane mezzanamente bello; Badi francamente rispose: Signora, io ne ho veduti di più belli di lui. Un profondo silenzio si fece all’istante nella stanza: la signora morsicavasi le labbra, e ciascuno rimase immobile per la sorpresa. Poscia, rinvenuti che furono, si parlò di varie materie. Badi prese commiato; ciascuno se ne andò pe’ fatti suoi; e nella città si sparse la novella della inciviltà di Badi, il quale fu giudicato come il giovane il più stolido e brutale che si fosse mai veduto dopo la creazione del mondo. Un buon parente volle avvertirne Badi, sebbene Badi medesimo erasi già accorto dal freddo accoglimento che dovunque gli veniva fatto, e da alcuni sorrisi che travvedeva, che l’opinione pubblica non era in suo vantaggio. Ma questo non bastò a fargli cambiar sistema. No, amico, gli disse, io vuo’ costringer gli uomini a forza di candore e di rettitudine ad amarmi.
Pochi giorni dappoi trovossi in casa d’una signora illustre per nascita e per beni di fortuna. Era ella giunta circa al quarantesimo anno dell’età sua, e conservava tuttavia delle memorie della passata bellezza: una leggiadrissima fanciulla di lei figlia stavale accanto come la giovanetta Iride si dipinge vicina alla maestosa Giunone. Un urbanissimo cortigiano, che ivi era a farle visita: Signora, le disse, vi vuole niente meno che tutta la credenza che io ho in voi per persuadermi che la signorina sia veramente figlia vostra e non sorella, e sorella gemella. Che ne dite, Badi?, soggiunse la signora, vedete se i cortigiani sanno adulare! Sicuramente, replicò Badi, e d’una adulazione poco nascosta. Il viso della signora impallidì, poscia s’infiammò; le parole si perdettero, sintanto che Badi si licenziò. Ciò pur si riseppe nella città, e Badi fu universalmente riconosciuto come un giovane stolido, malnato e da fuggirsi.
Di là a pochi giorni, un poeta venne a visitar Badi una mattina. Badi gli diè un ottimo caffè a bere. Poscia l’aganippeo con un melato complimento cominciò a palesare al giovane Badi la stima che faceva de’ talenti di lui e l’opinione che aveva del di lui giudizio assennato e sincero… Oh per sincero non dubitatene, l’interruppe Badi, ma per assennato potreste ingannarvi. Ho fatt’anch’io de’ versi bene o male, ma non perciò credo di poter essere buon giudice. Eccellente giudice sarete, o signor Badi, ed io ne son tanto sicuro che or ora vi leggo una cosuzza fatta così a schiribizzo sopra un certo mio collega. Ascoltatela, e ditemene schiettamente il parer vostro. Poi cominciò a leggere una villanissima satira piena di vituperi, e di sciocchezze, che cominciava così, traducendola in nostra lingua:
Oh somaro da basto e da cavezza! | Oh bestiaccia spolpata scarnata! | Ve’ che un mio colpo la tua nuca spezza; | Ve’ ch’io ti meno giù alla disperata | Su quella nuca tua da’ lunghi orecchi | Febea onnipossente sciabolata.
E così proseguì il poeta per una buona mezz’ora con una tessitura di parole da ubbriaco cucite felicemente in rima. E poi che l’ebbe finita: Eh bene, signor Badi, che ve ne pare? M’avete promesso d’esser sincero, ora mantenetemene la parola. La manterrò, rispose Badi. La poesia è cattiva, cattivissima, detestabile; un uomo dabbene deve vergognarsi d’esser poeta in tal guisa; ed un poeta deve arrossire d’imbrattar col fango della satira il vezzoso linguaggio della poesia. Il poeta rimase assai malcontento di Badi; partissene disposto a fare una satira contro di lui.
Vari altri sì fatti incontri ebbe Badi nel breve corso d’un mese, ch’io tralascio. Finalmente un vicino ingiustamente gli mosse una lite, e nel tempo stesso venne a vacare un posto al quale aspirare con ragione, poiché nessuno aveva più diritto di Badi ad ottenerlo per privilegi della sua famiglia e per le disposizioni sue naturali a ben esercitarlo. La signora di quarant’anni era sorella del Primo Presidente del Consiglio di Giustizia; il poeta era familiare con molti consiglieri: Badi perdé la lite. La moglie del favorito del re si ricordò del suo cagnolino; dipinse con colori abominevoli al ministro la persona di Badi; il posto fu dato ad altri. Un suo zio venne a morte, e mosso dal discredito pubblico in cui era caduto Badi, lo privò della eredità. Cercò Badi una sposa; tutte quelle che potevano convenirgli gli si rifiutarono.
Allora Badi ritornò al suo casino di villa, e riflettendo alla propria situazione, ed al sistema seguito sin allora: Ah, disse, io ho creduto che bastasse non offendere essenzialmente gli uomini nell’onore, nella libertà o ne’ beni per essere accetto; insensato ch’io fui! E la gloria, la vanità, l’orgoglio altrui, perché mi son io proposto di maltrattarli così? A che giova una sincerità che umilia l’amor proprio altrui senza far bene? Che crudeltà è stata la mia senza avvedermene di frizzar dardi così avvelenati e duri nel cuore degli uomini! Una nuova luce risplende agli occhi miei. Ogni virtù umana dev’essere utile agli uomini; ed a che lo è stata la mia eccessiva sincerità? Poniamovi i confini. Io non dirò mai il falso; ma nemmeno dirò tutte le verità. Quelle che umiliano l’amor proprio altrui senza far bene le tacerò. Così stabilì e così fece. Ritornò Badi in città, ognuno lo trovò amabile; nessuno lo riconobbe quasi per quello di prima; si appellò della lite e la vinse; vacò una nuova carica e l’ottenne; chiese una sposa e l’ebbe; e visse tranquillamente i suoi giorni; e lasciò scolpita sulla facciata della sua casa questa sentenza: I fanatici sanno far cose grandi e gli uomini di giudizio san viver bene.
P. [Pietro Verri]
Alcuni pensieri sull’origine degli errori
Tre sono le principali sorgenti de’ nostri errori: l’ignoranza della connessione d’un fenomeno cogli altri, gli stretti limiti della nostra sensibilità e l’imparagonabilità dell’estensione coll’intensione delle sensazioni nostre. Limitati a quel solo numero d’idee che ci somministrano i sensi, la natura istessa ha allontanati con uno spazio insuperabile da noi gli elementi delle cose, ed ha circoscritta la sicurezza de’ nostri giudizi alla sola convenienza o disconvenienza delle idee nostre. Non parlo io perciò di quella intima connessione che forse unisce con annelli non interrotti la universal catena de’ fenomeni dell’universo; ma parlo soltanto di quella connessione di cui il tempo ci fa nascere l’idea, onde costantemente dopo un tal fatto veggendo succederne un tal altro, s’inventarono i nomi di cagione e d’effetto. Se le azioni della vita non si dovessero intraprendere se non precedute dalla evidenza di ciò che deve succederne dappoi, noi saremmo gli esseri più immobili che la natura abbia riposti sulla terra; tanto ci scostiamo dalla immobilità quanto diamo alla ventura. La indispensabile necessità di agire ci costringe a ricorrere ad un nuovo genere di evidenza pratica, la quale propriamente è una probabilità fortissima di cui le prove non le abbiamo che dalla sperienza della successione d’un fenomeno all’altro. Questa sperienza, in alcuni più vasta e ordinata, in altri più ristretta e confusa, cagiona una diversa disposizione all’errore; e quanto è maggiore il numero dei fenomeni che conosciamo uniti per questa connessione chiamata cagione ed effetto, tanto minore è la probabilità che abbiamo di esporci all’errore.
Provengono gli errori nostri altresì dai limiti ristretti della sensibilità nostra, la quale, o spossata talvolta e mancante d’energia, leggiermente reagisce sugli oggetti che colpiscono i sensi, ovvero, fortemente percossa ed assorbita da un solo fantasma vincitore, gli altri non vede che appannati e con mal definiti contorni; nel primo caso ella trovasi su qualcuno di que’ gradi intermedi che accostano al sonno, nell’altro sulla strada che conduce al delirio.
Finalmente l’imparagonabilità dell’estensione colla intensione delle sensazioni nostre è cagione de’ nostri errori; e su di ciò non ho veduto alcuno che vi abbia fatta osservazione. La vita è una serie di momenti più o meno prolungata quanto sono più o men distanti i due punti dalla prima sensazione all’ultima; ma sebbene questa serie sia non mai spezzata, e si combacino con somma adesione tutti gl’istanti, per modo che non ci venga dato sentirne la divisione, con tutto ciò il momento attuale è talmente diviso dal passato e dal venturo quanto è diversa una cosa che esiste da una cosa che più non è o che abbia soltanto la possibilità di essere. Forse fralle combinazioni fin ora accadute non si son date due foglie perfettamente uguali o due momenti perfettamente uguali. Il senso della nostra esistenza forse manca di quella precisione che ci sarebbe d’uopo per renderci un conto esatto in tal proposito. L’uomo è paragonabile ad un fiume diverso ad ogni istante, sebben conservi l’istesso aspetto. Da ciò ne segue che l’intensione e la durata sia de’ beni, sia de’ mali sono quantità incommensurabili e perfettamente eterogenee nell’animo nostro; e mentre il freddo calcolatore uguaglia una sensazione breve e forte con una più mansueta e prolungata, l’uomo le trova diseguali; poiché tutto lo spazio della durata è nello scritto del geometra una quantità che esiste contemporaneamente alla quantità d’intensione: sono elleno altrettante figure da quattro lati rinchiuse fra paralelle, altre più in lungo prodotte, altre più vicine a se stesse in ogni loro parte, ma tutte comprendenti un’aia eguale. Ma l’uomo che deve scegliere fra due sensazioni vede ammucchiata l’una e da portarsi tutta nel momento che segue, e dell’altra non se gli presenta che il capo assai meno voluminoso e più maneggievole. L’ignoranza comune de’ principii delle cose e delle venture combinazioni somministra sempre qualche grado di probabilità d’ogni parte; e questa tanto più s’accresce quanto lo spazio viene protratto; ed ecco l’uomo, che ingordamente divorando il piacere più intenso e allontanandosi con ribrezzo dal più intenso dolore, si gitta in braccio ai mali che da principio meno l’offendono, qualunque poi esser debba la loro durata.
Da ciò ne segue che il calcolo della durata e intensione de’ beni e mali, sebben giustissimo per definire il grado di felicità di ogni essere, non è però quello che presiede ai giudizi dell’uomo.
P. [Pietro Verri]
IL CAFFÈ )( Fogl. XIII )(
Dei difetti della letteratura e di alcune loro cagioni
Verbera, sed audi
Gl’inglesi pensatori scrivono con non molta cura dell’ordine. I francesi con periodi vibrati e brevi. Si curano gli autori di queste due rispettabili nazioni di seguire nella composizione le traccie de’ lor pensieri; lasciano un libero volo all’intelletto; non temono gl’importanti episodi; non si fanno una legge di costringere le idee a scorrere, dirò così, dentro di un alveo quantunque riboccanti; non sagrificano i concetti alle voci, il genio al metodo, la robustezza dello stile alla languida sua purità. Noi per lo contrario sembra che abbiamo nel nostro scrivere un non so che di legato, di circondotto, di timido, d’impastato. Siamo sincerissimi nel far conoscere al lettore la fatica che abbiamo durato nel comporre: e piuttosto che nascondere l’arte, proccuriamo di farla vedere. Nella armonia, nella vanità di scelti vocaboli, nella penosa trasposizione della sintassi poniamo tutto lo studio, pronti a scieglier di due pensieri il men bello, purché più bella frase potiam dire. Siamo più vani che ambiziosi: vogliamo piuttosto che il lettore conosca sapere noi la grammatica che la logica. Qual degl’italiani che ci vengono proposti per modelli avrebbe scritto collo stile dello Spirito delle leggi? Sconnesso in apparenza, liberissimo, con sovente arbitrarie divisioni di capi, in massa però le idee tutte si aggirano, e cospirano in vari centri o punti di vista che formano un sistema ed una grand’opera. Colla nostra servil cura del metodo, co’ nostri rotondi periodi è impossibile il vibrar l’intelletto nelle cose, profondarle, fuggendo dall’una all’altra rapidamente; il che parmi essere il carattere di quel sublime scrittore. Il nostro stile è troppo manifatturato; non abbiamo il coraggio di andare a capo, ma pretendiamo che tutto sia liscio e legato e fluido, quantunque a spese del vero ordine, che debbe consistere nelle cose, non nelle parole. Che importa avvertire il lettore, col terribile rumore d’un risonante e vuoto conciossiaché, della connessione d’un periodo coll’altro? Non basta forse ch’essa vi sia? Non snerva egli lo stile il non lasciar nulla da supplire al lettore? Non è vero ordine quello che, legando il secondo periodo col primo, il terzo col secondo, fa metodicamente una catena d’episodi e metodicamente non ha metodo; ma quello che generosamente getta sulla carta una serie di pensieri, la di cui somma totale s’aggira su di un oggetto o di più oggetti toccantisi in alcun canto, la qual serie di pensieri li rischiara e loro appartien direttamente od indirettamente. Le grandi idee, le viste sublimi non soffrono l’imbarrazzato e contorto stile del famoso nostro Galateo. I legislatori delle menti umane non cominciano le loro opere immortali così: Conciosiacosaché tu incominci pur ora quel viaggio, del quale io ho la maggior parte, siccome tu vedi, fornito; cioè questa vita mortale, amandoti io assai, come io fo, ho proposto meco medesimo di venirti mostrando quando un luogo e quando un altro, dove io, come colui che gli ho sperimentati, temo che tu camminando per essa possi agevolmente o cadere o come che sia errare ec. Non seguiterò questo periodo, del quale siamo appena alla terza parte: forse me se ne avrà da’ lettori qualche obbligazione. Chi può leggere gli Asolani del Bembo, e ’l Cortigiano del Castiglione, e la maggior parte de’ cotanto celebri nostri cinquecentisti senza tenervi a forza la fuggitiva attenzione, mescolando la lode ai sbadigli?
Non vi vuole gran meditazione per assegnare la cagione di cotal fenomeno. La maggior parte di quella gran turba che bene o male aspira alla gloria delle lettere si conosce capace di fare de’ Galatei e degli Asolani e di farne anco de’ migliori. L’amor proprio distribuisce la lode: lodiamo que’ modelli che ci sentiamo capaci da imitare e di superare, perché vorremmo riporci col tempo a lor luogo. La più gran parte ha interesse che si stimi la mediocrità, perché ella è l’appanaggio della maggior parte. I grandi autori fanno fremere. Quel loro ardimento, que’ lor voli ci fanno troppo piccoli, perché loro perdonare possiamo sì fatta mortificazione. Non v’è nano che sia amico d’un gigante. Perciò nelle opere de’ grandi uomini voi osserverete andarsi comunemente a caccia de’ difetti; e ’n quelle de’ mediocri cercarsi industriosamente le bellezze. La celebrità di alcune opere di quest’ultimo genere, le vicende funeste che le prime tolerar devono, le ingiurie e le discussioni che precedono costantemente la lor gloria sono testimoni certi di queste verità. Quelle opere che hanno l’arte di servire alle opinioni senza apparenza di adularle, quelle in cui trovano gli uomini l’apologia de’ loro errori, quelle che stanno di mezzo fra il pensare di tutti e quello di pochi, contentano il ceto intermedio de’ molti, i quali non son volgo, non filosofi, ed hanno la massima influenza nella società.
Gli uomini di gran merito ancora possono lodare chi loro è inferiore. Un buon poeta loderà Petrarca sino all’adulazione la più decisa, quantunque di Petrarca più buon poeta. Quest’è il ragionamento ch’egli fa, forse senza avvedersene. Petrarca non è più gran poeta di me: se Petrarca sarà venerato, se riesco di ciò fare, la di lui gloria trarrà seco la mia. Chi stima Petrarca, deve stimarmi senza contrasto. Ciò è tanto vero, che questi zelanti lodatori sarebbero puniti se fosser messi al posto del loro eroe. Lo spirito di partito e la passione con cui anche gli uomini di sommo merito si oppongono a chi tenti con libero coraggio di sminuire il culto a cotali modelli e capi d’opera fa comprendere ne’ difensori quel principio finissimo d’amor proprio, sagacissimo come il loro spirito. Non escirebbono dalla tranquillità, e tal volta per fino dalla lor ragionevolezza, se non difendessero più la propria che l’altrui causa. Ed ecco come vi sieno certi utili pregiudizi anche fra i filosofi, i quali per lo quieto vivere è forza rispettare. Sarebbe da spirito forte in letteratura il non piegarsi a sì fatte opinioni. Testimonio ne sia la poco grata accoglienza fatta anche da colti uomini alle due veramente pregievolissime opere, e scritte con una illuminata libertà, il Paralello degli antichi co’ moderni del signor di Perault e le Lettere di P. Virgilio Marone agli Arcadi. Non si è egli fatto in modo che giacessero nella oscurità tai libri, che poco se ne parlasse, benché elegantemente e filosoficamente scritti? Chi parla mai di quanto scrisse su di Omero nella sua Scienza nuova il nostro grande e stranissimo autore Vico? Se non ha provato, non ha egli ridotto per lo meno a gran dubbio che Omero non vi sia stato, e che altro non sieno i suoi poemi che una collezione di antichi canti, come ne abbiamo un esempio in Ossian, poeta celtico ultimamente scoperto? In questo genere non si speri che si renda giustizia al merito, nemmeno da chi lo stima e si fa un dovere di stimarlo. Le opere che si oppongono alle opinioni de’ filosofi cadono nella oscurità, quantunque non la meritino; quelle che si oppongono alle opinioni del volgo sono sempre celebri. Perché i primi sanno adoperare il vantaggio del loro spirito, e con fredda ed illuminata politica fanno insensibilmente cadere un velo sulle cose che lor dispiacciono; laddove gli schiamazzi e gli ululati del volgo fanno celebri i di lui nemici. So che il vero merito stima il merito: ma so ancora che cotali superstizioni ed idolatrie, che fanno un letterario dogma di fede il merito d’un autore, circonscrivono troppo quella libertà dell’intelletto a cui tutte le grandi cose dobbiamo. Chi la teme non la conosce.
Se abbiamo da imitare anzi che creare, al certo conviene pur dire che da’ Francesi e dagl’Inglesi siamo più in istato di farlo con profitto che da’ nostri cinquecentisti. Un Addisson, uno Swift, un Hume, un Montesquieu non possono paragonarsi senza un gran spirito di partito ai Boccaci, ai Fiorenzuola, ai Casa, ai Bembi. Non occorre stenderci di più in questo mortificante paralello. Possono essere per noi quegli autori illustri ciò ch’erano pe’ Romani i Greci. I conquistatori del mondo non disdegnarono d’imparare da’ loro sudditi; ed i più grandi uomini, Lelio e Scipione e Cicerone, più di tutti non temettero i rimproveri di chi gli accusava di corrompere la lingua e di grecizzare. Così poté venire il secolo d’Augusto, che non mai o ben tardi saria venuto, se la voce di chi si opponeva alla imitazion de’ Greci fosse stata ascoltata. La imitazione de’ buoni modelli precede sempre la coltura e ’l fiorimento delle belle arti. Nessuna nazione è divenuta eccellente da sé; come nessuno gran suonatore o musico o pittore può divenirlo senza aver cominciato dal profittare de’ progressi altrui. Dalla ben intesa, dalla non servile ma illuminata imitazione, quand’essa non venga proposta per fine ma per mezzo di perfezione, si passa a superare i modelli. Così i Greci cogli Egizi, i Romani co’ Greci, i Francesi con noi e co’ Spagnuoli fecero.
Io mi rallegro de’ progressi nostri, ascoltando chi c’incolpa di francesizzare. Oh il bel delitto ch’è quello d’avere lo stile de’ gran scrittori del secolo di Luigi XIV! I Francesi, come tutta l’Europa, ebbero da noi le scienze, allorché, conquistato Costantinopoli da Maometto II, i greci letterati rifugiaronsi in Italia. Al tempo massimamente di Catterina de’ Medici, i nostri autori erano in mano delle più colte persone in Parigi. Restituimmo loro con usura ciò che i Provenzali ci aveano dato. Da ciò ne venne che molte maniere francesi s’introdussero da noi, come molte frasi nostre ne’ Francesi. Il che ha fatto che in quegli stessi autori nostri che si chiamano maestri di lingua, molti modi affatto francesi ritrovansi. Non prendiamo che il Boccacio, il più elegante nostro prosatore, e vedremo la verità di tal fatto. Egli usa il verbo avere in vece di essere, il che è proprietà della lingua francese; ed i Provenzali la introdussero nella nostra come riflette il Bembo. Quante miglia ci ha? haccene più di milanta.[41] Ebbevi di quegli che intender vollono alla milanese.[42] Comeché poche ve ne abbiano.[43] Tutti i nostri scrittori riboccano di cotal frase, ella è comunissima. Sono modi francesi i seguenti che aprendo il Bocaccio ognuno può ritrovare ad ogni pagina. Io temo forte ec.[44] A nostra Dama di Parigi.[45] S’avvisò di farli una forza.[46] Buglietto che sai che si conosce così bene di questi panni.[47] Alla fine niente monterebbe.[48] Il mangiare era presto.[49] Montò a cavallo, e come più tosto puoté se ne andò.[50] Amando meglio.[51] Stare il meglio del mondo.[52] Il giudeo s’avvisò troppo bene.[53] Biasimarongli forte.[54] Fare i più nuovi atti del mondo.[55] Nol saprà persona mai.[56] Bel giovane, e grande della persona.[57] Io non mi estenderò più su di quest’articolo; diverrebbe un vocabolario, questo breve discorso. Diasi un’occhiata agli altri primi autori di lingua per essere convinti abbondare eglino di francesismi. È adunque per lo meno una contraddizione il proporci quelli per maestri e l’offenderci di qualche modo francese.
Le belle arti non soffrirebbono tante contraddizioni, se fossero soltanto coltivate da quegli uomini tutti anima, tutti sentimento, che giudicano delle produzioni dell’ingegno in quel modo che degli odori e de’ colori. Come sentendo il tenero odore della viola, vedendo il dolce color ceruleo, bisogna accordar senz’altro essere grata questa sensazione; così senza disputa, senza guardarsene come da ingannevol lusinga, si abbandonano gli uomini sublimi nel sentire a quella dolce languidezza che inspirano le arti del cuore. Sono i freddi esami, le caute discussioni, giudici altrettanto giusti delle opere di ragionamento quanto incompetenti di quelle di sentimento; sono epicurei nelle belle arti i sublimi maestri: non resistono, ma sono strascinati dal sentimento; non eglino si accostano alle passioni, ma esse li tirano a sé quasi irresistibilmente. All’eccellente dramma fatto dal loro nemico essi piangono, che non ha tempo la importuna ragione di ficcarsi tra l’oggetto e la vivissima sensazione. Se gli uomini grandi ritrovano difetti nelle opere grandi, essa è l’ultima scoperta che vi facciano, ed i piccoli la prima. Non sono difetti importanti quelli che nelle opere di cuore non si scoprono che ragionando. Che importa se in una sublime poesia, la quale ti ha rapito in entusiasmo, con freddo esame tu ritrovi alcuni nèi sparsi qua e là? Il sentimento non ha mai torto: l’autore ha ottenuto il suo fine, e levando ancora tutte quelle macchie che ritrovò la fredda ragione e che non poté trovare il sentimento, non sarà sensibilmente migliorata un’opera fatta pel sentimento. Ciò non ostante è stato detto, e bene, che le opere bisogna comporle con ardire e con passione, e ripassarle coll’intelletto. Chi cangia questo metodo faccia una grammatica, ma non pretenda fare di più. Voglio che l’autore al primo moversi de’ suoi pensieri, quando prende la penna in mano, egli sia tutto nella sua testa, ove non veda altro che le proprie idee, e le getti sulla carta com’esse sono. Lingua, ortografia, ordine, periodi, finezze, minutezze all’indomani. Se l’attenzione della mente si dirama in tutti questi oggetti, se l’immaginazione si sottodivide in tutte queste ispezioni, come può ella esser robusta? Dov’è fra cotai ceppi la sua libertà, quella libertà ch’è la dea dell’ingegno! Guardati dallo immaginarti che un grammatico, un pedantuzzo, un caustico motteggiatore, chiamantisi letterati, ti siedano in faccia del tuo tavolino e ti contrastino le parole, ti pesino i sentimenti, ti raffrenino con leggi tiranne l’impeto de’ tuoi pensieri. No: imaginati d’avere in faccia un Newton, un Bacone, un Montesquieu, uomini grandi, e perciò indulgenti uomini, a cui leggendo le cose tue anco informi, anco senza l’ultime finezze dello stile, anco con errori di grammatica, se in esse avrai ragionato, s’esse conteranno idee e lampi di buona filosofia, non li vedresti freddamente accoglierle in udienza letteraria; non cercare di scoraggiarti con molte e minute obbiezioni; non compartirti lodi di protezione peggiori del biasimo; ma bensì vedresti que’ gran dittatori degli umani ingegni discendere alla più urbana e sincera approvazione, animarti, incoraggirti. Corre in ciò quella differenza che passa fra un piccolo gentiluomo ed un gran signore. Questi ha una gentilezza per lo più non sperata; quegli è talvolta grave e sostenuto sino al ridicolo. L’uno è troppo grande per temere di non esserlo creduto; l’altro, perché lo teme, vuol tenersi in alto più che può. Io vorrei mille volte più vivere una vita letteraria co’ grandi geni che co’ mediocri; ed ho l’ardire di persuadermi che il mio amor proprio starebbe meglio con quelli che con questi: perché gli ultimi mi terrebbero da lor lontano, e forse mi farebbero l’onore di temermi; starebbero sulle guardie di non esser conosciuti, superati; loro rincrescerebbe la disputa anco urbana e l’esame che far si potesse del loro avere; ed i primi lascierebbonmi pensare, dire, ragionare, accostare a loro, delirare anco filosoficamente, se così mi piacesse. I piccoli, i miseri geni ti contrastano nella disputa, non con quella urbana discussione che ravviva il dialogo, che agita le idee, che scuote l’intelletto, che fa sfavillare il vero coll’urto di vari veri; ma per abbassarti, se lo potessero, onde li vedrai con insidiose procedure freddamente invilupparti nella disputa; non acconsentire che tu abbia spirito; e con simulata distrazione accogliere i tratti più fini del tuo dire, non rilevarli giammai; contrapporre alla tua passione un tuono languido e strascinato, e pesar le parole ad una ad una nel caldo del tuo ragionare. Fuggi, fuggi, se t’è prezioso il tempo e la ragione, sì fatte conversazioni.
Egli è per lo meno ridicolo il guardare la letteratura come un toson d’oro, il rappresentare il letterato. Oh la sconcia e misera dignità! Qual più chimerico magistrato che il grave, che l’importante letterato! Se la coltura non ci rende amabili, non buoni, non dolci, non semplici, che sarà ella mai? I più grandi uomini sono così umani e di maniere cotanto urbane e naturali, che per lo più chi loro ti presenta bisogna che ti dica: questo è desso e che tu te ne stupisca grandemente. Fu a maraviglia detto d’un tale: Il est simple comme un genie. I ministri, i generali, gli uomini in somma del merito più distinto, si osserva essere stati fuori degli affari sovvente dati a’ giochi fanciulleschi. Soltanto un letterato sempre impacchettato in se stesso, che non vede al mondo in ogni momento altro che sé ed i suoi libri, e che ha il bene di credere che così pensino ancora gli altri, può trovar ridicolo un Newton che, dopo aver lavorato a’ suoi principii matematici, giuochi alla trottola con un fanciullo. Non è uomo grande chi sempre lo rappresenta.
Un falso letterato non è che un piccolo animale, diceva taluno, se ha fatto un libro che nessuno ha letto, che ha fatto fallire lo stampatore. Qual folla di piccole e sempre inquiete passioni non gli agita il cuore! Egli sta sempre sulla vendetta del suo amor proprio offeso; egli non ha avuti gli applausi del pubblico; è inimico di chi gli ottenga. Egli non incontrò il genio del suo secolo; lo biasima continuamente. È eterno declamatore del cattivo gusto; è inimico naturale del vero merito, perché gli sembra che i buoni autori gli usurpino il suo; vorrebbe mettere tutto al suo livello, perché egli non può alzarsi all’altrui. Potrebbe divertire qualcheduno il riscontro di due falsi letterati che sappiano, oh cielo!, tutti due di greco; tutti due vadino a caccia di pergamene, tutti due sappiano anche l’ebraico; tutti due stampino, e non sian letti; tutti due corrano di mal umore dietro alla gloria che li fugge. Io vi sfido, gentili e colte dame, a non annoiarvi in sì fatta conversazione. Era una ciarlataneria il portare che facevano i filosofi al tempo degl’imperadori romani un abito distintivo, una lunga tonaca ed il lasciarsi venire la barba lunga. La vera filosofia non ama sì puerili distinzioni, anzi non ne ama nissuna di tal sorte. Essa è sempre in opposto colle opinioni: le opinioni sono molte, e di molti; convien dunque nascondere questi dispareri, lungi dal farne professione pubblicamente. In oggi non si fa la buffoneria di portare l’abito filosofale; pure un certo contegno, una certa grave urbanità, una gentilezza sostenuta così tra ’l ministro delle Muse e l’uomo di mondo, forma il carattere di taluni. Quanto più di fatica vi vuole per gli uomini grandi in nascondere di esserlo che in mostrarlo! Bisogna saper portare i studi seri del gabinetto alla giocondità della conversazione, ma non comunicare altrui la noia che ci costano; bisogna che ciò che impariamo con fatica, lo imparino gli altri da noi senza fatica; bisogna che acquistino le cognizioni in bocca del filosofo amabile, in bocca de’ Pomponi Attici, e degli Algarotti, e dei Fontenelle, quella venustà la quale fa sembrar tutto facile e bello, e che perdono passando dalle rugose e squallide fauci dei sapienti di mal umore. Bisogna in somma saper farsi perdonare di esser superiore agli altri. Non sono gran citatore, ma Plutarco fa al mio caso:[58] Non solum vincere, sed etiam vinci scire speciosum est, in iis praesertim rebus, in quibus victoria detrimentum parit. I filosofi socievoli conoscono la ragionevolezza di tal precetto e la sua importanza.
La impostura poi o ne’ scritti o nella conversazione non è soltanto un difetto letterario, ma un vizio. Un cattivo libro non è un delitto, il qual meriti che un onest’uomo perda un momento di quiete. Quant’eglino sarebbero infelici se si prendessero tal briga! Ma un autore che stampi fatti falsi in materia di erudizione, che sia apertamente un plagiario, che sia in somma uno di que’ ciarlatani delle lettere descritti nella curiosa ed utile opera di Menchenio,[59] la quale fu in parte, di tal razza d’impostori, il tanto salutare don Chisciotte; un tale uomo dico non solo essere un cattivo autore, ma un cattivo uomo. Mi diffido, e mi diffido assai, della morale di un uomo che ne abbia sì poca nelle lettere. Le passioni si danno troppo di mano per credere che questa cattiva etica sia isolata alle sole materie letterarie.
Fin ora ho accennato qualche difetto della nostra letteratura; mi sia permesso d’indicarne alcune fra le molte cagioni.
Se le accademie di poeti danno superiorità ad una nazione sulle altre, io credo che la italiana sia la prima del mondo. Chi può annoverare gli Accademici Oziosi, Indomiti, Inquieti, Della notte, Del Piacere, Sizienti, Sonnolenti, Torbidi, Addormentati, Della chiave, Umidi, Infocati, Infernali, Lunatici, Caliginosi, Insensati, Della notte vaticana, Ombrosi, Fumosi, Muti ec.? Noi per quella ragione che abbiamo un gran genio per la musica, lo abbiamo ancora per la poesia. Gl’improvisatori ne sono una prova, ed una prova ammirabile. Sensibili e vivaci nelle cose d’immaginazione, siamo anco capaci di contenziosa fatica. Questo è un gran capitale d’ingegno che spendiamo in frivolità, simili ad un gran maestro di musica, che potendo fare delle eccellenti opere, non si dia che a comporre minuetti ed arie per li brindisi.
Il poetico libertinaggio di verseggiare ce lo diffusero in Italia i Provenzali. La nostra lingua italiana sino al secolo decimoterzo non era stata che parlata. Furono dei primi Dante e Petrarca ad usarla ne’ libri. Egli sarebbe un ignorare le leggi di continuità con cui progrediscono le lingue il credere che allora nascesse ad un tratto la nostra. Essa chiamossi volgare, perché era quella del volgo già da molto tempo, e quella de’ letterati era la latina. I Provenzali ci prevennero in tale mutazione. Essi furono i primi che in loro lingua volgare cominciarono a scrivere canzonette amorose, principalmente dopo il secolo millesimo. Gran folla di poeti ebbe quel paese dal mille sino alla metà del secolo decimoterzo; ed allora fu appunto che lasciarono a noi questa eredità. Gl’Italiani accolsero avidamente sì fatte produzioni. Cominciarono i Siciliani, poi i Toscani ad imitarle, onde ne sorsero tanti poeti del secolo decimoterzo, in cui tutto il mondo avea la smania di far versi nella lingua fin allora volgare. La imitazione fu un plagio. Vi sono de’ sonetti del nostro Petrarca tolti a parola per parola dagli autori provenzali. V’è una contraddizione non facile a disciorsi. Benché il popolo parlasse la lingua volgare e che la latina fusse divenuta quella de’ colti, troviamo che in seguito le prediche erano scritte in latino. Testimonio ne sieno quelle de’ santi Francesco, Antonio e Bernardino, e quelle ancora del famoso frate Gabriele Barletta.
Tutti gl’Italiani essendo divenuti perdutamente poeti, e quello ch’è più poeti amorosi, dovettero necessariamente dividersi in vari
IL CAFFÈ )( Fogl. XIV )(
crocchi e per fine far ritornare il secolo della innocenza, divenendo arcadi pastori ed assegnandosi con eccesso di liberalità ciascuno il suo campo alle loro regioni.
Io distinguo due sorta di accademie, e la distinzione mi pare importante: quelle che coltivano la scienza de’ fatti e della memoria da quelle che coltivano le arti le quali principalmente spettano all’intelletto ed al sentimento. Della prima specie sono quelle di fisica sperimentale e di erudizione; della seconda quelle di poesia, di belle lettere, di materie di gusto, di filosofia presa nella sua totalità, nella quale ha gran parte il sentimento ed il genio. Dico adunque che le accademie della prima specie sono utili, ma quelle della seconda hanno tali inconvenienti ch’è difficilissimo che lo sieno. Gli uomini uniti per raccogliere fatti, rischiarare la storia, investigare in dettaglio la natura, cose tutte che dal mecanismo della industria dipendono e dalla fredda sagacità, possono esser utili gli uni agli altri; e la lor opra comune può dar urto alle scienze. Ma non così dov’entra il sentimento, il sublime, il genio. Ognuno in tali arti ha il suo pensare, il suo proprio sentire. Esse non si raffinano, non si sollevano che per un caldo ardire, ed ardire proprio, non acquisito. Nelle cose di sentimento chi ne ha più degli altri lor non lo comunica, ma vivendo con essi lo perde e si raffredda. Chi non ha sentimento non lo può acquistare; e chi lo ha, a forza di non essere applaudito e colla consuetudine di fredde persone, lo scema. La contagione si comunica.
Un ceto d’uomini anche non grandi, purché sagaci e pazienti, può accrescere di molto la scienza de’ fatti: ma quest’istesso ceto d’uomini mediocri se si dà a coltivare in comune quelle arti che non sono fatte pe’ mediocri, cioè quelle di sentimento, non può che ritardarne i progressi o corromperne il buon gusto. Le arti di sentimento e d’immaginazione per intrinseca lor natura non ammettono una società, per alquanto vasta ch’ella sia. Tale società per esser utile dev’esser composta di uomini grandi. Fra molti uomini grandi per sentimento, come non sorgeranno mille passioni figlie dell’immortale e sempre regnante amor proprio, e di quella sensibilità istessa che tali arti richiedono? Per lo contrario questo inconveniente non v’è in quelle adunanze dell’altra specie, nelle quali i mediocri ancora bastano. È utile il solo buon senso; egli non fa tanto rumore: le passioni degli uomini tranquilli e che non pretendono ciascuno ad una fama parziale ed immortale non molto si oppongono le une alle altre. Facilmente ritrovi due uomini che sieno capaci di studiare assieme l’erudizione e la fisica osservatrice; che coltivino l’istesso orto botanico; scavino la stessa miniera; ma due grand’uomini, che facciano assieme il poeta e ’l metafisico, che non sieno gelosi alcun poco della lor gloria, che mettano tutti due in comune le lor grandi idee e che se le donino a vicenda, questo è un raro fenomeno. Che molti il facciano è impossibile. Tutti i grandi uomini hanno composte le loro massime opere con qualche sorta di mistero. Le grandi scoperte in ogni genere, i parti più illustri dell’intelletto sono figli, e figli carissimi, che non si danno in addozione ad alcuno. I più grandi uomini stanno da sé. Hanno bisogno dell’amico fautor laudatorque, ed amico illuminato. Si restringono a piccolo cerchio, e per loro natura istessa non sono fatti per stare in una vasta società, in cui trovar non possono nella maggior parte quella filosofica e dolcissima amicizia che nasce dalla perfetta analogia de’ sentimenti. Acquistano gli uomini del secondo ordine coll’unirsi, e quelli del primo vi perdono.
Per esser adunque utili e durevoli, le accademie ad altro non dovrebbero essere destinate che al mecanismo delle scienze; alle grandi fatiche di sgrossare i fatti; alle vaste opere di erudizione; alla fisica esperimentale, alla astronomia osservatrice, a formare in somma vasti magazeni all’ingegno umano. Se la metafisica delle scienze, se le arti, cui il sublime, il sentimento, la creatrice immaginazione presiedono, vogliansi in tai ceti introdurre, essendo esse facoltà differenti nella maggior parte degli uomini, non può a meno che l’un l’altro non si servino d’inciampo. Per questo vediamo come l’Accademia Cosentina, poi quella del Cimento, ambe benemerite della fisica osservatrice ed investigatrice, ch’era loro scopo, fussero state utili a tale scienza, e come tante accademie di poesia e di belle lettere tenessero anzi indietro ciò che si proponevano di coltivare.
L’instituto delle società investigatrici e raccoglitrici di fatti è quello di accrescerne il loro numero; quello delle società di belle arti è piuttosto di conservarle com’esse sono. Le une progrediscono; le altre stanno ferme. Di fatti elle si considerano come destinate a preservare dalla corruzione il buon gusto.
Non è però che anche queste società non fussero utili nella loro istituzione. Quelle di poesia precedettero il rinascimento delle belle lettere, a cui va dietro la ragionatrice filosofia, che suol distruggere le arti d’onde è nata. Erano dunque utili nel cominciamento della coltura i poeti anche mediocri, perché son qualche cosa i mediocri fra i rozzi. Erano utili perché davano qualche consistenza ad una lingua fino allora abbandonata al volgo. Passato massimamente il metaforico ed ampolloso regno della seicentista letteratura, fu proficuo il restaurare e richiamare a’ suoi principii il buon gusto naufragato fra le puerilità ed i giuochi di parole mediante simili unioni letterarie che si davano alla imitazione degli antichi. Ma succede dappoi che questi corpi pubblici della letteratura, che questi senati delle scienze acquistano di mano in mano uno spirito parziale di corpo che si oppone all’universale libertà della repubblica degl’ingegni. Avvezzi ad essere venerati e a non istimar che se stessi, gelosi del loro credito, vigorosamente s’oppongono a tutto ciò che può scemarlo. Quindi se v’è alcuno che non sia del loro corpo, che faccia qualche straordinario volo nelle arti o nelle scienze, eglino sono sempre gli ultimi ad acconsentirvi, perché di troppo amano la dittatura delle lettere, che hanno ottenuta in tempi meno colti e che sono avvezzi ad esercitare. L’amor proprio d’un uomo è grande; quello di molti uomini non incolti è grandissimo: e la somma di tutti questi amor propri cospiranti alla considerazione del ceto ed alla sua conservazione forma quel massimo amor proprio che diviene geloso spirito di partito. Allora diventano queste società, quantunque rispettabili nella loro istituzione, ceti che vorrebbero tenere il secolo eguale ad essi, non potendo essi essere eguali a lui. Generalmente tutto ciò che fa ammasso e monopolio di letteratura impedisce col tempo la sua libertà. Alcuni pregiudizi, alcune passioni nascono necessariamente dove vi sia società e spirito d’unione. La gloria del corpo diventa la patria comune, ed in piccolo vi sono i vizi politici delle repubbliche. Le maggiori obbiezioni alla restaurazione della filosofia partirono dalle accademie, perché le grandi mutazioni e le vicende delle lettere le distruggono. La cartesiana filosofia, ossia quell’ingegnoso romanzo dell’universo, distrusse le accademie peripatetiche; la newtoniana le cartesiane. Sarebbe dunque ben strano se tai ceti non arenassero i progressi di quelle vicende che li dispergono. In oltre quegli stessi uomini, che ad uno ad uno piegherebbonsi alle nuove verità, uniti assieme più difficilmente il fanno. Egli è principio costante che più facile è il cangiar le idee di un uomo che di una società. In esse lo spirito del corpo non è più quello di ciascheduno, ma bensì è il risultato di tutti, ed è quello della passata generazione più che della presente. L’accademia è immortale; i nuovi candidati non piegano il corpo alle loro opinioni, ma essi conviene che si pieghino a quelle del corpo; e così hanno nelle loro cose questi ceti, come la maggior parte, uno spirito d’immobilità. Il che fa che allora soltanto sarebbero utili quando l’umano ingegno ritornasse indietro, poiché lo impedirebbero; ma che non lo sieno quand’egli è per progredire. E chi dirà che non si debba ancora far viaggio dall’umano intelletto, o chi ne potrà fissare i confini?
Chi si prendesse la briga pericolosa e molesta di opporsi a ciò che questi ceti credono l’ottimo, è sicuro di avere contro di sé un nembo di libretti. Non si può prenderla con un membro senza che tutto il corpo se ne interessi in sua difesa. Anche questo impedisce la letteraria libertà. Sarebbe adunque più utile ai progressi dell’umano intelletto che in materia di scienze corpi non si formassero. Non v’è bisogno di cotali unioni nell’odierno sistema, in cui tutta l’Europa è una sola nazione. La stampa sparge al momento le nuove scoperte; ed i nuovi lumi si diffondono ad un tratto da Londra a Reggio di Calabria. Qual più stretta ed universale società che il poter avere sul suo tavolino tutti i progressi d’ogni uomo che coltivi l’inesauribil verità? A che fare società parziale, quando v’è la generale?
Porrò fralle cagioni dei difetti della letteratura lo spirito grammaticale. La grammatica anch’essa, tale quale è, s’oppone ai progressi delle belle arti. Ella insegna a scrivere come scrivevasi quando appena cominciarono presso di noi a rinascer le lettere. Testimoni ne sieno gli autori che vi si citano e che sono divenuti i legislatori della lingua.
La grammatica è una raccolta di vari precetti nati dalla osservazione fatta su di vari autori. Essa dice: scrivi così, perché così ha scritto Boccaccio. Ella dovrebbe dire: scrivi co’ vocaboli veglianti, colla ortografia della più ricevuta prononciazione, colla lingua delle idee, collo stile de’ tuoi sentimenti. Le nostre grammatiche non hanno altro scopo che di fermare la lingua dov’ella è. La vera grammatica dovrebbe insegnare a perfezionarla. Una buona grammatica deve più insegnare a sfuggire gli errori di lingua che insegnare tutti i modi, le frasi, la sintassi e le pretese grazie di essa. Questo è un affare di sentimento, che colla lettura de’ buoni autori si deve imparare, non cogli inviluppati, molti e secchi precetti, che legano più che non aiutano. Per errori di lingua io non intendo ciò che dissuona dalla autorità di qualche scrittore che viene proposto come modello, ma bensì ciò ch’è difforme dalle ben dedotte analogie di essa. Il buon senso, non l’autorità deve decidere queste controversie. Che importerebbe che la nostra lingua migliorandosi non fusse intesa da qui a cinque o sei secoli? Questo è sempre stato il destino delle lingue. I primi trattati fatti da’ Romani co’ Cartaginesi più non s’intendevano a’ tempi di Polibio, il qual dice che tampoco i più eruditi non li potevano discifrare. Era egli questo un male? Sarebbe egli succeduta questa fortunata mutazione se i grammatici avessero dovuto presiedervi? E Cesare, Cicerone, Orazio, Lucrezio, Virgilio, Seneca scrivevano adunque una lingua corrotta? Non temiamo le mutazioni nella lingua. Se abbiamo da far progressi nella ragione, le dobbiamo necessariamente fare. Non può succedere un cambiamento nelle idee d’una nazione che non lo succeda ancora nel mezzo con cui si esprimono. Forsi l’immobilità della nostra lingua, che da Petrarca sino a noi ha quasi nulla cangiato, ascriver debbesi alla immobilità delle nostre idee. Nissun’altra nazione colta d’Europa scrive presentemente quella lingua che scrivevasi a’ tempi del nostro Petrarca. Tutte hanno moltissimo cangiato. Il pretendere che non si cangi il vocabolario è lo stesso che pretendere che non vi sia moto nell’universo.
Una grammatica che dirigga colla ragione l’autorità noi non l’abbiamo. Una grammatica metafisica ci manca, onde ci manca una vera grammatica. Essa deve consistere in esattamente definire le parti dell’orazione; in ridurre con chiaro metodo il fortuito ammasso di tante voci, nate dai molti e vari bisogni senza disegno alcuno, a certi principii e punti di veduta generali, ed a fare che quella lingua, che fece in dettaglio il disordine ed il caso, divenga come se fosse stata inventata da’ filosofi. Lungi adunque che la vera grammatica consista in ricavare i precetti dell’arte da essa lingua qual è, deve anzi consistere nell’esame di essa lingua qual è, per correggerne le false analogie, le inconseguenze, i capricci e tutti quegli errori che in ogni lingua meritano la mano emendatrice d’un filosofo; errori che il grammatico rivolge in precetti e talvolta in bellezze. Per tal cagione vediamo tanti verbi irregolari nella lingua nostra come in molte altre, e quel mostro che chiamasi sintassi figurata, ed i barbari nomi di elissi, pleonasmo, sillessi, enallage, iperbato e simili, le quali cose altro non sono che inconseguenze e disanalogie, che rendono difficile la lingua inutilmente. Questi sono errori che dal saggio grammatico non dovrebbonsi nobilitare con nomi greci, ma bensì distruggere insensibilmente e con quella discrezione che faccia il meno di cambiamento e di correzione possibile. Certo non vi debbe essere mutazione non necessaria nella lingua; ma la ben regolata corrispondenza delle voci e la loro generazione ben dedotta insegnerebbe a render semplici e pochi i precetti più che a compilarne di molti. Non è possibile chiamar perfetta quella lingua che altro non è che un caos di parole: non è possibile il ridurla a generali dottrine. Ciò manifestamente si osserva nella nostra, in cui le regole si chiaman regole, ma non lo sono. Le eccezioni e le appendici le distruggono. Leggi di lingua mai non vi saranno finché vorrassi ch’esse servano a lei, non ella a loro. I grammatici fin ora sono stati come legislatori i quali, in una nazione che sta nel seno dell’anarchia, non facessero leggi per togliere i disordini, ma di ogni disordine facessero una legge.
Non deve però esser concessa l’istessa libertà al grammatico che all’autore. Il filosofo grammatico ragiona sulla lingua; il filosofo scrittore l’adopera. Quello può far progetti, mostrar delle nuove vedute, il che è impresa della ragione; questo, se vuol essere inteso, deve servir all’uso; se vuol esprimere la tale idea, conviene che adoperi il tale vocabolo. Tutta la libertà è concessa a quello; a questi se non se la più giudiziosa. Ma cospirando a poco a poco entrambi, l’uno a perfezionar la lingua indipendentemente dall’autorità, l’altro a seguirlo, con non turbolenta riforma si distruggerebbe il sempre tirannico regno de’ puri grammatici.
Dirò alcuna cosa della dialettica, il di cui abuso non ha fatto men danni alla filosofia che lo spirito grammaticale. Di tanti trattati di logica onde abbondiamo, nessuno la può ispirare a chi non l’abbia. Le formole sillogistiche sostituiscono al sentimento della ragione il mecanismo de’ suoi ordigni; sono fatti ben più per abusare del linguaggio di lei che per adoperarla; sono il più imponente metodo di metodicamente disragionare. Quando mai si è più puerilmente delirato che al favore della peripatetica filosofia? Vi sono eglino più gran ragionatori in apparenza che gli aristotelici? Non so perché chiamossi sottigliezza cotanto grossolana maniera di tessere soffismi. Egli è un errore, ed un error grande, il credere che cotai forme sillogistiche e dialettiche assottigliano l’ingegno. L’abuso della ragione non fa che scemarla ed intorpidirla. Bisogna guardarci dal cominciare da giovine ad adoperare sconciamente i gracili e delicati ordigni della mente. Sono queste di quelle malattie che si sentono tutta la vita. La maggior parte crede che basti ne’ giovani uno qualunque studio che impieghi l’ingegno; basti l’avvezzargli a quistionare, ad argomentare su di vari soggetti; a guerreggiare nelle dispute; sostenere con sagacità una tesi egualmente che un’altra, per rendere loro maneggievole e facile l’ingegno. Ma questa massima da molti ripetuta e posta generalmente in pratica nella instituzione della gioventù è perniciosissima. Una mente formata può divertirsi con fare qualche paralogismo; un gran ballerino può fare una grottesca e sconcia danza senza pregiudicarsi; non così un tenero principiante. Un giovine non può divenir soffista alcun poco senza perdere il senso comune. È meglio non ragionare che abusar della ragione: è meglio esser ignorante che dotto di errori. Queste sono massime non nuove, ma non mai abbastanza ristampate.
La logica dipende dal sentimento. Chi non ha gli organi per distinguere il vero dal falso, non gli acquisterà giammai coi sussidi pretesi delle sterili e gravemente puerili dottrine degli entimemi, delle formole, de’ subbietti e de’ predicati. Chi ha bisogno d’un sillogismo per sentire il vero, disperi di sentirlo. Non sembreranno strane sì fatte riflessioni dopo di tanti che fecero guerra al Peripato, se non a chi si dimentichi de’ studi che ha fatti in gioventù e di quelli che si fanno. S’è declamato, o meglio ragionato assai contro di cotesto abuso, eppure non è ancora venuto il tempo di tacere.
Il sillogismo involve l’errore, gli fa trinciera e fortificazione, e facendolo espugnare passo a passo allontana talmente la di lui sconfitta che non è mai vinto. È fatto per difender gli errori più che per indagar il vero. Acquistano i giovani il funesto piacere di abusar dello ingegno; ripongono la loro vanità in quistionare, ed escono dalle scuole cavillosi, non dialettici, persuasi essere la ragione ciò ch’è loro paruta, un istromento utile a chi ha la destrezza di usarlo a suo talento. Si avvezzano a non comprendere la verità che nel sillogismo. La consuetudine talmente accoppia e lega strettamente l’idea del vero alla formola sillogistica, che tosto che la mente vuol conoscere se tal cosa è vera, a tal formola si rifugia. Ben presto il senso del vero si trasporta al senso del mecanismo delle formole; molti ed involuti soffismi annonciati come sillogismi arrivano a persuadere; prendendo essi il tuono della ragione, il suo fare, il suo stile, ed imitandola perfettamente, possono facilmente avere i suoi privilegi.
L’aver volute fare arti mecaniche quelle che sono cose di sentimento, è stata cagione che come la logica si degradò nel numero de’ mestieri, così la poesia e l’eloquenza si pretese d’insegnare co’ precetti. Queste sublimi facoltà figlie del sentimento non si acquistano con leggi pedantesche. Tutti que’ libri che imitarono le Istituzioni di Quintiliano, e le imitarono male, sono da riporsi fra gl’inutili. Le passioni non s’ispirano, non si raffinano colla sinecdoche, colla ampliazione, colla enumerazione delle parti o con simili inezie. Datemi un contadino che abbia ingegno; datemelo in una forte passione; fate ch’ei parli, che io dico ch’egli adornerà più di figure il suo discorso che non ne insegnino il Decolonia e l’Eloquentiae Praeludia; e ch’ei sarà più eloquente di chi ripone l’eloquenza in que’ freddi precetti. Non è un affare d’industria, non di mecaniche dottrine il senso squisito del cuore, il linguaggio delle passioni, la robusta, la libera immaginazione.
Se i precetti e la sagace ragione influiscono nelle arti di sentimento, essi sono posteriori a quelle arti istesse che per tal mezzo insegnare vorrebbonsi. Mi spiego: Orazio fece quel suo capo d’opera dell’Arte poetica, ma la sua Arte poetica non avrebbe fatto un Orazio. Egli, divenuto un grand’uomo, poteva vedere le ultime e più delicate finezze dell’arte, avere sviluppati i propri sentimenti, e poteva colla lunga esperienza avere discoperti que’ nascostissimi principii che reggono il cuore umano. I grandi poeti, i grandi oratori, allorché compongono, non hanno presente alcuna regola, precetto alcuno; ma sono agitati dal sentimento vivissimo delle cose, hanno il lor Febo che gl’inspira. L’entusiasmo male s’accoppia colla riflessione e col minuto timore di non trasgredir certe regole. Quando si giugne ad avvedersi che in tali arti vi possono essere precetti ed a fare che perfezionino il sentimento, egli è allora che siamo già maestri. Ora dunque cominciare in queste facoltà dai freddi precetti d’una osservatrice sagacità è appunto cominciare dove si dovrebbe finire; e molto più se tai precetti sieno non giudiziosi, non delicati, non tratti dal cuore umano da un filosofo che lo abbia esaminato: allora sono due mali, l’uno insegnar con precetti il sentimento, l’altro corromperlo co’ cattivi. Gli ammiratori di Cicerone qual arte non ritrovano nelle sue orazioni? Tutto è fatto con mirabil disegno, secondo essi; tutto giusta il più fino conoscimento delle umane passioni. V’è da scommettere con vantaggio che Cicerone sarebbe meravigliatissimo di simili commenti.
I giovani, che non hanno ancora il cuore formato, le di cui passioni sono vive, ma non forti; leggieri, ma non robuste; molte, ma minute, non sono fatti per sentire le bellezze delle arti motrici del cuore, molto meno per capirne le teorie. I libri che trattino filosoficamente queste ultime non sono alla portata che de’ uomini già formati, ed essi soli li possono leggere con profitto; vi ritrovano la storia, dirò così, del cuore umano.
In generale egli è un errore il cominciare ad insegnare ai giovani le arti che appartengono al sentimento. Eglino non ne sono ancora capaci. Un cuore che non ha conosciuta la divina e funesta sensibilità, come potrà gustare le tenere egloghe e tutte le sue silvestri e toccantissime immagini? Chi non ha provata la più dolce e terribile delle passioni, come fremerà a quel capo d’opera della morte di Didone? Chi non ha provata amicizia e paterna benevolenza, intenderà egli li noti squarci di Niso e di Eurialo e del conte Ugolino? Come in somma un cuore che non è ancor cuore potrà esser suscettibile di quelle arti che spettano al cuore? Il buon senso, la ragione, la moral pratica, la memoria sono quelle cose che dovrebbero precedere nella educazione. La eloquenza, la poesia sono fatte per chi ha provate le passioni. Dovrebbero perciò essere degli ultimi studi, e non insegnarsi che colla lettura de’ buoni autori. Più vale la ben regolata imitazione, più sviluppa il cuore la lettura delle arringhe del gran-cancelliere d’Aguesseau e delle poesie d’un Haller che tutti i trattati di eloquenza e di poesia, che non hanno mai fatto né un oratore né un poeta. Io ritorno sempre a quel principio, e vi ritorno con piacere, che bisogna ben distinguere ciò che al sentimento, ciò che all’intelletto appartiene. L’aver confuso le arti del cuore con quelle della mente ha pregiudicato ad entrambe. Il sentimento e la poesia introdotti nella investigazion della natura, che tutta dev’esser l’opra della fredda e diligente ragione, ha formate le tante favole dell’universo chiamate sistemi, che l’una dopo l’altra si rovesciarono. I dettami d’una fredda discussione introdotti nelle belle e liberissime arti e fatti tiranni del sentimento intimidirono gl’ingegni; avvilirono il felice ardimento; screditarono il divino entusiasmo; produssero, in una parola, tutti i mali della servitù.
A. [Alessandro Verri]
IL CAFFÈ )( Fogl. XV )(
Sul ridicolo
Il talento di rendere un oggetto ridicolo è propriamente l’arte d’interessare quella porzione di malignità che sta riposta quasi sempre in qualche angolo del cuore degli uomini contro l’oggetto che cerchiamo di far cadere in discredito. V’è già chi ha fatto vedere che il riso non viene mai sul labbro dell’uomo se non quando ei fa qualche confronto di se stesso con un altro con proprio vantaggio; e che il riso è il segnale del trionfo dell’amor proprio paragonato. Questa proposizione deve sembrare un paradosso a chiunque la legga per la prima volta, e tale sembrò a me pure: ma chi è capace di contenzione e di seguir le traccie de’ movimenti anche dilicati della propria sensibilità, vedrà grado a grado verificarsi questa teoria eziandio ne’ casi ne’ quali sembra il riso la più innocente e disinteressata sensazione di ogni altra. Crescerà il paradosso al bel principio se si rifletta come gli uomini i più umani e benefici sieno per lo più coloro i quali più sovvente e di cuore, come sogliam dire, si lasciano movere al riso; e per lo contrario assai più incalliti, e occulti, e capaci di cabale e raggiri sieno coloro sulla fronte de’ quali o di raro o non mai compare la giocondità e il riso. Ciò avviene cred’io perché l’uomo non è malvaggio giammai gratuitamente, e tanto minore invito ha per esserlo quanto meno è infelice; e come gli uomini quanto a più alta e indipendente autorità sono innalzati tanto più generosi sono e buoni, non restando ad essi più altro a bramare che la lode e l’amore de’ loro simili, così quegli ai quali è stato dato un felice temperamento, e che ne’ continui confronti che fanno di se stessi cogli altri sono beneficati dalla natura a segno di poter sempre decidere favorevolmente per loro stessi, altro più non desiderano che d’ottenere anco l’amore di quelli su i quali ottengono tante vittorie. Moltissima delicatezza d’ingegno e vivacità d’imaginazione richiedesi in chiunque ricerchi di ben maneggiare la sferza del ridicolo; poiché si tratta di solleticar destramente l’amor proprio degli uomini, e risvegliare senza ch’essi pur se ne avveggano le più care e inseparabili loro passioni a combattere con noi. Fra cento che aspirano all’onore di ben riuscirvi, forse due o tre vi riescono, e la maggior parte degenera o in basse e plebee contumelie ovvero in ricercate e fantastiche allusioni, che risvegliano tutt’al più uno imprestato sorriso di convenzione dagli astanti, non mai un sorriso che parta dalla vera compiacenza del cuore. Taluno vuol porre in ridicolo un giovane nobile, ricco, voluttuoso e spensierato; e per ciò fare me lo descrive superbamente vestito e circondato nella persona di tutta la più squisita eleganza che sappia inventare sulle rive della Senna l’ultimo raffinamento del lusso: l’aria ch’ei fende è imbalsamata da’ profumi deliziosi che spirano dal suo corpo, che non sembra mortale; ei discende le scale dopo aver ricevuto i servigi e gli omaggi d’una schiera di salariati adulatori; si gitta entro un dorato cocchio mollemente, e preceduto da riccamente gallonati lacchè rapidamente percorre le strade della città che lo dividono dalla sua bella, dove riceve l’accoglienza la più distinta. Dico che colui che per questa strada prende a maneggiare il ridicolo manca di giudizio per ben maneggiarlo, poiché nessuno facendo il confronto di se medesimo colla pittura di quel Ganimede potrà mai sinceramente sentire la superiorità propria sopra di esso, né ridere di cuore per conseguenza. Il solo sentimento che da pitture sì ben espresse può nascere è il desiderio di poter fare altrettanto. Io a quel tale direi: volete voi porre in ridicolo quello sventato dissipatore de’ suoi beni? Dipingetelo in un dialogo col mercante creditore; dipingetelo occupato di mille bassissimi intrighi e cabale in secreto per raccogliere con che sostenere il fasto apparente; dipingetelo in conversazione con un uomo di spirito, che rileva e sferza le sciocchezze che escono dalla bocca di uno stordito, e non si arrestano nella gola quand’anche avesse un brillante ogni dito, cento libbre di ricamo sull’abito e dieci staffieri nell’anticamera: questa è la strada per cui potrete farne una pittura tale che i circostanti confrontandola a se stessi la trovino posponibile, e ne ridano, e si compiacciano con voi del trionfo che avete dato al loro amor proprio, atterrando un oggetto che con dispiacere vedevano più alto alzarsi del loro livello. Oltre questa malignità ne nascerà anche un utile sentimento, per cui si modererà in altri la voglia d’imitare quel brillante e vuoto originale; e conoscendo che il fasto e la profusione non fanno mai nascere negli uomini quei sentimenti di stima che producono la virtù e l’ingegno, e conoscendo a quai duri passi conducano la spensieratezza e la trascuranza d’una nobile economia, si volgeranno a cercare altrove migliori oggetti d’invidia, e cercheranno di formarsi buoni, virtuosi e illuminati cittadini. Questa è la strada che convien battere, direi a quel tale. Dunque la prima massima per ben usare del ridicolo si è quella di non cercare mai di spargerlo se non su gli oggetti che gli uomini possano trovare posponibili nel nascosto confronto che fanno con essi loro, altrimenti la malignità umana, che non perde mai l’occasione di fare tutt’i confronti consolanti che può, renderà ridicolo l’inesperto maneggiatore del ridicolo istesso. Un’altra osservazione pure è necessario di fare prima di gettare il ridicolo sopra un oggetto, ed è ch’ei non sia per se medesimo presentato in guisa di eccitare in noi qualche forte emozione. Alcuni inesperti, per voglia d’avere il nome assai pericoloso di motteggiatori, disumanamente frizzano i loro sali contro un miserabile che viene frustato per mano del carnefice per la città. Ciò vuol dire propriamente sovvertire i principii della morale umana e pretendere che taccia nel cuore degli uomini il benefico sentimento di compassione verso un infelice esposto al pubblico vilipendio, sentimento che ogni cuore non indurito e non forastiero alla virtù deve provare. Così dicasi di chi cerca di porre in ridicolo la prepotenza, la venalità dei giudici, il tradimento e simili piaghe della società, le quali anzi che dar luogo a quel leggero vantaggio che il confronto di noi con essi fa nascere allorché sorridiamo, eccitano in vece l’abominazione e lo sdegno d’ogni cuore non corrotto. Conviene dunque che l’oggetto che si sceglie per rendere ridicolo sia soltanto capace di eccitare in noi quella emozione che chiamasi invidia, e che destramente ei ci venga rappresentato per modo che conosciamo d’avere indebitamente provato noi per l’addietro il penoso sentimento dell’invidia, che anzi sentiamo noi stessi a lui preferibili; il che non si ottiene sì tosto che l’oggetto per se medesimo ecciti in noi le forti emozioni di compassione o di ribrezzo o simili. Conviene di più che il ridicolo cada sopra oggetti che, come dissi, abbiano offeso il nostro amor proprio in qualche guisa; perciò non riuscirà mai a far ridere davvero i suoi lettori colui che pone loro davanti gli occhi costumi da essi mal conosciuti ovvero ad essi affatto indifferenti. Un errore di calcolo de’ più grossolani fatto da un algebrista non farà mai ridere gli uomini di mondo, ed un nastro anche giallo posto su un abito nero non farà mai ridere un’accademia di scienze. Il vezzo poi del ridicolo, scelto che s’abbia bene il soggetto, si è quello di dipingerlo verisimilmente ed in caricatura, ma con una tranquillità d’animo e con una pace sì calma che non trapelli nel motteggiatore verun fiele che a ciò fare lo spinga. Il ridicolo vuole della malignità bensì, ma di quella che viene per così dire a fior d’acqua, non già di quella viziosa e nera, che resta nel fango, e di cui sono composte le anime atrabiliari e perverse. Ogni onesta persona si sdegna tosto che il ridicolo diventa maldicenza assoluta, ovvero discende in bassezze e scurrilità. Nulla più piace alle genti non affatto grossolane quanto una sorta di decenza e di nobile eleganza in tutto; queste se non sono virtù sono almeno qualità che le accompagnano caramente. Il talento di ben maneggiare il ridicolo è una qualità che se non fa amare un uomo, è però cagione che per timore si finga d’amarlo. Gli uomini sono in una sorte di contraddizione ne’ loro sentimenti verso gl’illustri motteggiatori: sentono la gratitudine verso di essi per tutte le vittorie che il loro amor proprio ha ottenute per mezzo loro, ma nel tempo stesso temendo di non restarne altresì la vittima, ed essendo il timore una disaggradevole sensazione, come ognuno sa, odiano chi in essi la produce. Io però non sono ancora ben persuaso per rispondere a chi mi chiedesse se il talento del motteggio sia utile o no alla società. Conosco che il flagello del ridicolo è una delle più possenti correzioni che si diano per i difetti degli uomini, ma vedo altresì che il medesimo flagello può essere il più crudele supplicio per atterrire l’uomo di genio e costringerlo a restare uomo volgare. Nelle società dove gli uomini siano molto inclinati dalla educazione a slanciare ed a temere il ridicolo, io osservo che molto raffinamento v’è negl’ingegni, ma questa universale coltura non va accompagnata dalla produzione di quegl’ingegni feroci e sublimi che osano carpire le grandi verità ed avventarsi alla folta nebbia entro cui stanno riposte; io non vedo in esse quei felici ardimenti che si slanciano al disopra del livello della mediocrità. Parmi che il ridicolo stuzzichi gli uomini inferiori alla mediocrità a giugnervi, e prema sul capo ai vigorosi acciocché non l’oltrepassino. In fatti la ragione e la sperienza ci provano egualmente che l’uomo allora soltanto è capace di ergersi a qualche grande oggetto, qualora ei abbia di esso la mente e l’anima ripiena e siane come assorbito interamente, cosicché poca o nessuna attenzion ei faccia a tutta la innumerevole folla degli uffici e delle cure che occupano periodicamente il maggior numero. Ora un tal uomo deve per una indispensabile incompatibilità presentare il fianco disarmato al ridicolo: che se da’ primi anni sia già piegato a temerlo, forz’è ch’ei contrapponga questo timore a quel felice entusiasmo che lo porterebbe al grande, e la forza di esso o si estingua o per lo meno si elida, cosicché si pieghi alla condizione degli uomini volgari. Non v’è cosa più facile che il gettare il ridicolo sulle azioni d’un grand’uomo, se a lui si avventi prima che la pubblica estimazione lo abbia cinto di quella sacra nebbia in cui Venere ascose il Troiano per guidarlo sicuro in Cartagine. L’uomo capace di grandi cose forz’è che degli oggetti che gli agitano la mente ne parli con una energia proporzionata al sentimento che ne ha grandissimo, ed ogni idea un po’ gigantesca, per poco che tu la spinga, facilmente la trasporti entro ai confini del ridicolo. Io osservo che le nazioni d’Europa le quali lampeggiano sopra le altre per la gloria degl’ingegni e delle armi sono forse quelle nelle quali il ridicolo ha minor porzione nella vita civile. Osservo pure che dovunque la celia, il motteggio, ossia il ridicolo sono in onore singolarmente, ivi il cuore e i dolci sentimenti d’una reciproca fidanza non possono aver luogo in conto alcuno, e con ciò vien posto un argine insuperabile alle più dolci e virtuose corrispondenze sociali. Convien distinguer bene due cose separatissime, e sono la gioia ed il ridicolo: una nazione che balli, canti, beva e passi il suo tempo festosamente non è perciò una nazione di motteggiatori. Anzi dirò che ogni società in cui si faccia studio di spargere il ridicolo deve per necessità essere fredda, circospetta e triste, né mai può gustare la gioia vera e sincera, la quale esigge la libertà del cuore e la sicurezza d’ognuno. Nella Camera de’ Comuni di Londra un cittadino animato della felicità e della gloria della patria arringava per una deliberazione che stavasi per prendere; nel maggior fervore della sua eloquenza avvenne che gli cadde la parrucca a terra; ognuno sa quanto sia numerosa la Camera de’ Comuni d’Inghilterra: neppure un sorriso svegliò quest’effetto della gravità; il cittadino riprese la parrucca, se la ripose e proseguì il discorso senza che alcuno abbia fatto nemmeno cenno d’accorgersi d’un accidente sì naturale e sì frivolo. Io credo che un filosofo viaggiatore avrebbe da questo solo fatto potuto calcolare qual sia la forza politica dell’Inghilterra. Il riso è una convulsione privativa dell’uomo e che, per quanto sappiamo, la natura non ha concessa a verun altro animale, giacché non basta il ragrinzamento d’alcuni muscoli del volto, per cui sollevisi il labbro superiore e mostrinsi i denti, perché dicasi uno ridere. I viaggiatori ci dipingono i popoli dell’Asia come nazioni presso le quali è sconosciuto il ridere, almeno quel ridere sonoro e smascellato che praticasi da noi; sensazione ch’io non so bene se debbasi anzi riporre fra le piacevoli ovvero fralle dolorose, massimamente per la lassitudine che lascia dopo di sé. Io so che l’uomo, dopo un riso che sia alquanto durato, trovasi tristo ed abbattuto potentemente. So pure che il sublime del diletto che provasi nella società è quello che si manifesta con un sincero sorriso, e che accrescendosi questo movimento al di là, degenera e lascia vuoto il cuore. Troppo mi dilungherei se m’abbandonassi a queste idee; servirann’elleno per un altro foglio; per ora concludo così. I vantaggi che porta alla società il talento di spargere il ridicolo si restringono a correggere non i vizi degli uomini, ma bensì i loro difetti; e questi difetti per la maggior parte sono talmente inseparabili dalle buone qualità essenziali che togliendoli bene spesso si corre pericolo di togliere insieme quelle. I mali che l’uso del ridicolo fa, impedendo i progressi dei talenti e della generosa virtù, sono massimi a parer mio. Per ciò asserisco che questa sorta di spirito è opposta alla pubblica felicità.
P. [Pietro Verri]
Voti sinceri agli onesti letterati
I letterati sono o dovrebbero essere quella razza d’uomini destinati a far l’onore della nostra specie, ad istruirla, rischiararla, perfezionarla: né ad altro fine esser dovrebbero diretti i loro studi e le loro meditazioni. Ma pare appunto che quanto talvolta s’elevano dal volgo alcuni di loro colla forza dell’ingegno, e che gli si rendono superiori, altrettanto manchino (se pur tanto può dirsi) dalla parte della moderazione; poiché certo non avrebbe a chiamarsi gente destinata a esser maestra dell’umanità quella che collo specioso titolo di letterata ribocca di piccole passioncelle, di mordace invidia, di sordo disprezzo pel sapere altrui. Nulla più conviene all’uomo di lettere che la dolcezza de’ costumi, la purità della morale, la venerazione alle sacre cose ed una certa modestia, che non è figlia dell’avvilimento, ma bensì della tranquilla ragione e della persuasione di non esser oggetto dispregievole agli occhi de’ buoni o de’ saggi; onde si riposa sulla propria coscienza, senza mendicare i suffragi altrui colle viltà, colle bassezze, coll’adulazione; pretenderli coll’impostura e ’l pedantismo; o vendicarsi di non averli ottenuti colla satira, colla durezza delle maniere, colla causticità de’ parlari. Pare appunto, per taluni chiamantisi letterati, che l’umano sapere sia un piccolo campo che debba essere del primo occupante, in guisa che abbia diritto di scacciare chi vi si accosta in appresso per coltivarne una benché menoma porzione. V’è chi ha ottenuta la gloria di poeta? Tosto il vedi vestirsi de’ pubblici applausi, e quasi in trionfo d’averli ottenuti divenire in Pindo impertinente, intolerando ancora come uomo che si vendica di quella oscurità in cui giacque. Or non è più colui che si rodeva occultamente l’invidia, o la caustica disistima degli uomini tacitamente divorava: ora egli ha diritto di pedanteggiare gl’ingegni, di nulla lodare o di lodare con svenevole encomio i parti dell’intelletto altrui; di prendere in somma le arti e ’l tuono della politica letteraria freddezza, trascuranza, mistero, riservatezza al di fuori, rabbia, invidia, livore, amarezza al di dentro. V’è chi dalle scienze pensi trarre la sua gloria o l’abbia ottenuta? Quanto gl’incresce ch’altri prima di lui arrivi alla scoperta di qualche verità; quanto più sovente ei loda chi gli è inferiore di chi è più grande di lui, perché il lodare quegli ha l’apparenza della stima del merito, e ’l lodar questi contiene una confessione a cui di rado l’amor proprio bene o male inteso acconsente! In somma, in qualunque facoltà scelga un letterato di distinguersi, lo vedi mirar di mal occhio chi gli è compagno nel cammino; dar degli urti a chi cerca di sopravanzarlo nel corso, e dileggi, villanie, insulti talora fare a chi malgrado i suoi sforzi a gran volo gli corre avanti, sicché sembran barbari che corrono il pallio. O per fare un altro non men vero paragone, si usano da’ falsi letterati le cabale, i raggiri, i modi istessi che hanno talvolta luogo fra coloro che pretendono agl’impieghi pubblici. Ognuno pare che fabbrichi quella gloria a cui agogna sulle rovine altrui con tranquillità apparente, con astio vero. Quindi si guattano tra di loro con vista sospettosa; né modi tralasciano onde con pesante pedantismo, col flagello ferreo di critica mordace, derisione, disprezzo (turpissimi aborti d’animo impotente) frapporre ostacoli e discoraggiare chi aspira alla gloria letteraria. Ma non sono già questi bravi dell’abietta letteratura, sgherri o carnefici d’ogni buon’arte, che più debba temere chi comincia il sempre difficile tirocinio delle lettere. Costoro col loro di troppo abbaiare screditano la propria causa, e per troppo tentare nulla possono. Più sono molesti coloro che in apparenza ostentando modestia, freddezza, moderazione, hanno addattati i precetti dell’uomo di corte all’uomo di lettere. Questi sanno dare all’amara satira, all’odio, all’invidia le sembianze della ragione, freddissimi, pacatissimi, moderatissimi. Fingere di trascurare la gloria, ed avidamente desiarla; non mai lodare, e ricever gli encomi come incensi dovuti, con annoiata grandezza; non mai rilevare lo spirito altrui nel conversare; far mostra di non accorgersi che altri ne abbiano; mettere in foggia tutte le sue merci, avendo l’arte di far credere ch’elleno non sono che una minima porzione della loro sapienza; dir tutto mentre che pare che moltissimo ancor rimane a dirsi; non citare gli autori onde si trasse buona parte dell’opera, ma citare i citati con maestosa comparsa d’erudizione, e poi dire degli altri che tutto imitarono servilmente e con plagio ingiusto usurparono l’altrui; parlar con disprezzo di coloro che più si stimano perché altri non li legga, son le poche fra le moltissime arti de’ falsi letterati. E tali saranno dunque i mezzi onde cerchino essi di rendersi rispettabili; e tali saranno i costumi, tale la morale di chi pretende d’esser depositario dell’umana sapienza? Ognun lo dica, se pur vuol dirsi il vero, nissuna compagnia più di cabale, di noia, di passioncelle, di livore ripiena di quella di tai letterati. Quindi il ragghiare delle impudentissime controversie, quindi il dileggiarsi, contumeliarsi, combattere in faccia del pubblico, come fiere arrabbiate, con libelli ed invettive atroci; quindi le calunnie tolte con audace e sacrilega mano dal tempio; quindi per fine ogni eccesso d’infame morale. Onde è bene che il giovine che allo spinoso cammino delle lettere comincia a rivolgere i suoi passi si prepari a combattere, s’indurisca agli ostacoli, toleri, trascuri, perdoni e ingiurie e villannie, il più sicuro appannaggio de’ veri saggi. Ma prima di pretendere d’entrare ne’ penetrali dell’umano sapere, sia egli uomo dabbene, ch’egli è ancor meglio che l’esser letterato. La religione, la morale il conducano sempre per mano nei laberinti della sapienza; e gli siano inseparabili compagne, anzi venerande maestre. Quanto augusto non saria il tempio della sapienza, se i falsi sacerdoti non ne screditassero il culto, non ne offuscassero lo splendore con frodi, ardimento, bassezza, venalità, se con rabbia, schiamazzo, urli, guerre crudeli, vendette di partito non ne infamassero gli altari, e per fin di sangue umano non gli avessero macchiati! Esempio dell’umana follia che diedesi all’Italia per la celebre canzone d’Annibal Caro. Vorrebbesi dunque non mai bastevolmente persuadere ai letterati l’imitare il fresco esempio del gran lume nostro, il signor prevosto Lodovico Antonio Muratori, uomo che ritrovò quasi incolti li campi della erudizione italiana e che talmente coltivati ce li lasciò che nulla rimane a desiderare. Questo grand’uomo pieno di modestia, di religione e di sapere, e costumi dolcissimi accoppiando ad una mente grandissima, nulla pareva più desiderare che la morale di taluni tra’ letterati si riformasse; che quelli che sono i maestri del sapere lo fossero ancora della virtù. E ben prova quanto a’ tempi suoi di questa mancassero taluni fra di loro, leggendo le ingiurie villane, le infami declamazioni, le atroci invettive che furono scagliate contro quella calva e venerabil fronte.
Non così presto sarebbe finito il funesto catalogo de’ grandi uomini che furono il bersaglio di mille ingiurie contro di loro vomitate da’ falsi letterati; pur troppo egli è numeroso; e sarebbe per avventura una storia assai istruttiva quella delle letterarie battaglie, quanto quella delle sanguinose.
Benché però ogni uomo ragionevole possa essere agevolmente persuaso che fino a che in questo mondo vi sarà amor proprio, vi sarà ancor sempre invidia e gelosia fra coloro che per l’istessa via pretendono alla gloria, ciò non ostante lasciare non si debbe di diminuire i difetti di una professione, benché tutti togliere non si possano. Il che se per me si potesse, che sono poi sì piccola cosa in quest’universo, io mi crederei uno de’ più grandi benefattori dell’umanità. Poiché tolti che fussero questi vizi dalla letteratura, riformata la morale di cert’uni fra’ letterati e sostituita la moderazione, la dolcezza, la buona fede, la purità dell’intenzione all’orgolio, all’amarezza, alla frode, all’impostura, diverebbero i letterati i maestri del genere umano e suoi benefattori, i modelli della virtù; e quella venerazione, e quella ammirazione che per loro si ha comunemente sarebbe ancor più giusta e più utile. Questa uniformità poi d’intenzione e di buona fede infiniti vantaggi produrrebbe per ciascuno di essi. Avvegnacché travagliando unanimemente e pacificamente alla investigazione del vero, del giusto, dell’utile, tre cose che sono inseparabili agli occhi dell’onest’uomo, gran bene ne verrebbe alle scienze ed alle arti, le quali non mai più sogliono crescere ed aumentarsi di perfezione che allorquando molti concorrono allo stesso fine. Ma finché ogni letterato se ne starà trincerato ne’ suoi studi, pronto a discacciare chiunque ardisca abitare colle sue Muse, e che cinto, dirò così, di uno steccato, gelosamente custodirà il suo campo e sarà pronto ad insultare in ogni più indecente maniera colui che seco voglia coltivarlo; sino a tanto, dico, che i beni dell’umano intelletto non saranno comuni, ma rigidamente vorrassi indurre il diritto di proprietà, non mai è sperabile che cresca di molto la massa delle umane cognizioni. Né perciò vorrebbesi togliere l’emulazione (utilissimo incentivo in ogni umana cosa), ma bensì gli eccessi di questa emulazione. E a dir vero qual più scandaloso spettacolo e ridicolo a un tempo che due chiamantisi letterati che s’ingiuriano in faccia de’ cortesi leggitori e del pubblico che si protestano di cotanto venerare nelle loro prefazioni, s’ingiuriano, dissi, per un verso, per una parola, per una misera erudizioncella e per cotali gravissime inezie? E che ci avvanza per disapprovare un assassinio, un parricidio, un enormissimo delitto? E che ha da dire quel volgo che tanto sogliono i letterati aver a vile, quasi mandra di pecore? Queste pecore, dico, cos’hanno a dire di cotal professione, se i di lei seguaci talmente s’assomigliano a’ facchini ed a’ campioni che altro non manchi alla più perfetta parità che il menar di mano? Di cotali pseudoletterati, grazie al cielo, la razza può dirsi spenta da noi: che se pur tentasse di risorgere, sembra che il primo che lo tentasse verrebbe tosto colle sue ingiurie sepolto nella oscurità. Più i costumi e l’educazione s’inciviliscono, meno di cotai mostri infettano la società, e meno di tai mostri l’infettano, più l’impero della virtù e della ragione si va dilatando. Per lo che è da desiderarsi da ogni uomo che l’importante ed onorato mestiere di letterato si spogli di quel restante d’impostura, di frode e di livore che pur ha tuttavia il suo partito, benché d’assai minore di quello che coltiva in pace ed in buona fede i vasti campi dell’umano sapere. Se desidera ogni buon cittadino che le case della sua patria sieno ben fabbricate, i campi ben coltivati, i giudici incorrotti, le leggi santissime, il vero letterato, la di cui patria è l’universo, molto più deve avere fra i suoi voti che i suoi concittadini non vilipendano sì augusta professione; che le leggi ed il sistema di questa gran repubblica sieno giuste e sagrosante, e che non sia riposta al luogo di una onesta libertà, di una ragionevole indipendenza, una licenza enorme ed una scandalosa e dannosissima anarchia.
A. [Alessandro Verri]
IL CAFFÈ )( Fogl. XVI )(
Ragionamento sulle leggi civili
Molti si lagnano della incertezza del diritto; altri si contentano di sparger qualche motto di ridicolo sulla facoltà legale; uomo per fine non v’è, per poco che abbia notizia di tai materie, il quale non accordi esser massimo il disordine della giurisprudenza, e perciò de’ giudizi. Né le querele però, né i motteggi su i dottori, posti per fino da lungo tempo sulle scene, compensano punto i mali antichi e gravi i quali la disordinata legislazione, ossia la mancanza di legislazione produce: e se fosse lo stesso il dolersi de’ mali o ’l porli in ridicolo come il toglierli, io credo che nulla di più perfetto al mondo vi sarebbe quanto la giurisprudenza: tanto essa fu soggetto fin ora ad altri di declamazioni, ad altri di scherno. Giovi perciò dare un’idea compiuta, quanto il comporta la strettezza di un breve ragionamento, in qual guisa sorgesse quella vasta biblioteca di dottori cui le nostre sostanze sono in abbandono; come il legale sistema si riducesse a ciò che è; quai sieno le leggi nostre; chi ce le desse; quale la lor natura; quai sieno state le cagioni del disordine; qual sia il disordine istesso; come crebber così all’immenso le leggi e le opinioni.
Non tesserò una storia legale perciò. Struvio ne ha data una che uguaglia la più grande avidità. Altri pur molti la scrissero e rescrissero, a’ quali ricorra chi ne brami esser informato ne’ minimi dettagli di erudizione. Un brevissimo di lei compendio basta al mio instituto, onde veduta l’origine de’ mali se ne presentino i rimedi, i quali nelle cose politiche come nelle mediche non si riducono tanto in fare quanto in disfare, togliendo gl’inciampi al buono e richiamando le cose alla loro disprezzata e saggia semplicità.
Io suppongo il mio lettore nuovo in queste materie, perciò dalle cose più note a que’ del mestiere io dò principio.
La giurisprudenza con cui si decidono le cause ne’ tribunali di quasi tutta l’Europa, ognun sa essere le leggi romane, per modo che la quasi universale accettazione di esse ha dato loro il titolo di diritto comune. Egli è noto parimenti che l’imperator d’Oriente Giustiniano ne fece compilar nel secolo vi dell’era cristiana quella raccolta, per opra massimamente di Triboniano, della quale ci serviamo oggidì, e di essa ne ho data una se non lunga, non dispregevole idea nel foglio XVI del primo volume di quest’opera. Ognuno ha pure ascoltati i vocaboli di Codice e Digesto, ma non gli ha che ascoltati chi a tai studi non si è consagrato. Tutto adunque quell’ammasso di leggi che chiamiamo diritto comune ha quattro parti. Il Digesto, il Codice, le Novelle e le Instituzioni.
Il Digesto, che anche Pandette vien detto, è la collezione delle risposte di trentasette giureconsulti romani, che vissero nel tempo d’Augusto e de’ seguenti imperatori, a’ casi che lor venivan proposti; ed alcuni squarci di commenti ch’eglino fecero alle antiche leggi romane, massimamente agli editti de’ pretori, i quali ne constituivano la più abbondante porzione. Questi frammenti dell’antichità stanno disposti sotto a titoli per materie compartiti.
Il Codice è la compilazione delle constituzioni degl’imperatori romani, o, diremmo noi, proclami, cominciando da Adriano sino a Giustiniano, cioè di cinquantaquattro legislatori. Queste constituzioni o sono sentenze di casi particolari, com’era costume che gl’imperatori giudicassero le differenze private, o sono lettere imperiali dirette secondo i vari affari a’ presidi delle provincie, ai prefetti del pretorio ed agli altri magistrati.
Le Novelle sono cento sessant’otto proclami che promulgò Giustiniano dopo la raccolta pubblicata: esse mutano, involvono, limitano, estendono, confondono la già fatta compilazione.
Le Instituzioni sono l’unico vero codice che noi abbiamo. Esse sono, come il loro titolo dà bastantemente a divedere, gli elementi del diritto preso per regole generali e senza far casi particolari. Vi si spiegano in massima e vi si danno in istile legislativo i principii onde decidere le questioni. Furono compilate per istruzione della gioventù: sono un breve estratto delle Pandette e del Codice.
Eccovi cos’è quel grosso volume che si chiama la raccolta delle leggi romane. Dal metodo istesso che si è tenuto in quest’opera tosto si comprendono queste verità. Esse leggi esser piene di cose che appartengono alla religione, al governo, ai costumi de’ Romani, pe’ quali furono fatte, laonde o inadattabili od inutili in non poca parte per noi: come ciò che concerne i servi, i liberti, gl’ingenui, le manomissioni, le concubine, le sepolture, i sacri luoghi, i funerali, le nozze, la giurisdizione del prefetto della città, del pretorio, de’ vigili, i decurioni, le provincie, le città, i mancipi, il censo, i vettigali, in somma il sistema di governo e di economia, le azioni e le stipulazioni, le chiamate in giudizio, tutti gli atti legittimi ch’eran propri de’ Romani, che molto stavano nelle formalità, la patria podestà, le successioni intestate dalle leggi municipali quasi dovunque cangiate, ed altre tali materie che formano una considerevol porzione delle leggi del Codice e del Digesto.
Si comprende ancora facilmente che codesto non è un codice, ma un vasto materiale di cui servirsene per farlo: poiché non sarebb’egli strano che la raccolta de’ proclami che fanno i principi, per esempio, in varie materie alla opportunità oggidì, e delle lettere reali che a’ vari magistrati indirizzano, e le decisioni di casi particolari ch’eglino facessero, dovesse chiamarsi un buon codice? Ognun vede quai sarebbero i suoi disordini. Riboccante d’inutilità, di lunghezze, di confusioni, di contraddizioni, e tale appunto è il codice romano. L’istesso dicasi delle Pandette. Sarebb’egli un codice ben regolato l’ammasso delle risposte in iure de’ nostri avvocati, aggiuntovi qualche pezzo delle glosse e comenti che hanno fatti i nostri dottori alle leggi romane? Eppure il paragone conviene, essendo con tal metodo fatto il Digesto. Il codice, prender dovendo le leggi in massima e star su i principii generali e costanti, non può mai esser compilato di vari pezzi di legislazione che in vari tempi e pe’ vari casi si fecero. Il confuso ammasso di questi frammenti, che nacquero ad uno ad uno, non faranno mai un tutto, ed il codice dev’esser fatto per fare un tutto. Sarebbe lo stesso come se uno statuario da un cumulo di rottami e di membri ne pretendesse comporre una statua ben proporzionata. Adunque egli è forza confessare che eccettuatene le Instituzioni, non abbiamo nulla che si assomigli ad un codice. Dico assomigli perché esse per la loro brevità sono appena una idea di codice.
Questa raccolta di Giustiniano cedé il luogo alle leggi franche, longobarde, borgognone e degli altri popoli che invasero l’Europa, com’è noto. Quindi a’ tempi di Lottario II, ritrovatosi, come si pretende, in Amalfi l’anno 1137 un esemplare delle Pandette, che più non si conoscevano, cominciarono ad essere studiate le romane leggi ed insegnate pubblicamente in Bologna. Irnerio fu il primo, che ne promovesse lo studio. Cominciò egli a farvi delle note chiamate glose, e fu tosto seguito da un nembo di glossatori. Giacomo, Martino, Bulgaro, Rogerio, Bossiano, Piacentino, Ugolino, Balduino, Roffredo tante ne fecero che fornirono campo ad Accursio di compilarne una vasta raccolta. Così a poco a poco crescendo il numero de’ scolari e quello de’ maestri, s’introdussero dappertutto queste leggi che lungamente erano state sepolte. Dai comenti si passò ai consigli. Odofredo, Dino Mugellano, Oldrado, poi Bartolo detto lucerna iuris, e Baldo e Saliceto, ed i due Rafaeli, Comano e Fulgoso, ed Immola, e ’l Castrense, e Socino, e Giasone e tanti altri, il di cui catalogo non è breve, empierono il mondo non solo di comenti ma d’infiniti consigli, ad essi tutti ricorrendo in tutti gli affari. Così le allegazioni, che venalmente all’opportunità delle cause si componevano, raccolte in volumi entrarono nelle biblioteche a constituire una considerevol parte di legislatura. Quindi lor venne dietro la turba de’ trattatisti, vale a dire di altri dottori, che raccogliendo quanto s’era scritto su di una materia, e nel testo, e ne’ comenti, e ne’ consigli ne compilarono un trattato. Poi vennero i decisionanti, i quali sono altri dottori che prendendo principalmente di mira le decisioni de’ tribunali sulle diverse materie, in quella occasione entrano a discuterle e trattarle. Poi vennero gli eruditi, i quali vollero distruggere ciò che avea fatto l’ignoranza de’ loro antecessori. Il primo ad aprire questa nuova scuola fu il nostro Andrea Alciato, ed il Cuiacio dopo di lui molto la promosse. Lo scopo di questi eruditi fu di tessere la storia legale; di restituire a’ testi il lor senso; d’apportarle luce colla erudizione romana; di conciliar le contraddizioni; di adoperare una lingua latina meno barbara nelle loro opere. Ma codesti dottori non poteron vincere la torrente degli antichi glossatori e consulenti, onde seguitò ad esser la legislatura principalmente fondata su quelle opere. Eccovi come siano nati ben venti mila grossi volumi legali che noi abbiamo.
Da qui ne venne che la minor parte di nostra giurisprudenza consista nel testo delle leggi romane, poiché esse or non sono che la causa occasionale onde nacque. Coi comenti, colle interpretazioni e con sì sterminato e sciaurato numero di opere legali ne sorsero le tante questioni che c’inondano, ed in queste, non nelle leggi sta la facoltà legale, la quale è tutta questioni, sicché si dica nihil est in iure pacificum, come tante volte ripete il cardinal de Luca; onde le leggi nostre, per quanto si dica, non sono altrimenti le leggi romane; elleno sono come perdute di vista e sepolte nella moltitudine delle opinioni che da esse come da tronchi si diramano in ogni parte senza fine. Del qual disordine fu in parte cagione la oscurità stessa d’esse leggi, che colle loro ambiguità forniscono ampio soggetto di comenti, colle frequenti loro contraddizioni materia di difender due opinioni; ed in parte fu cagione la barbarie del secolo in cui esse cominciarono a comentarsi e lo spirito cavilloso di que’ tempi, come quello in cui la logica male intesa e peggio insegnata di Aristotile avea resi gl’intelletti più fatti per cercar gloria nella disputa che nel vero, sofisti e protervi ponendo tutti gli studi nell’abusar della ragione con qualche sagacità. Al che si aggiunse un vasto sussidio per quistionare e render ogni cosa incerta nel dritto, che dovrebbe esser fatto perché nessuna ve ne sia, cioè l’aver riposte nella massa della legislazione le allegazioni de’ dottori nelle cause, i quali non cercando il vero ma l’opportuno, e facendo pullulare molte e minute ed intricate difficoltà per offuscare se non altro la ragione, sono propriamente ciò da cui dovrebbe aversi cura grandissima non fosse contaminata la legislazione, né esser mai norma de’ giudizi. Egli è lo stesso il fare altrimenti che l’abbandonare la giurisprudenza a que’ i quali hanno interesse ch’ella non sia chiara e certa.
Da tutto ciò ne venne che se nelle sentenze rimonteremo alle ragioni di decidere, ben di rado si troveranno desunte dalle leggi, ma dalla opinione di qualche dottore originalmente, sicché rimontando dall’uno all’altro de’ suoi sostenitori sino alla fonte, si troverà il suo principio in una glossa od in una teorica, cioè o in un antico comento adottato successivamente per buono, e ristampato e riassunto da altri dottori posteriori, od in una massima di questo e di quel dottore, che fu ricevuta non si sa come ed adottata ne’ tribunali non si sa perché. E queste opinioni ebbero fin ora la lor moda fatale, onde ne avvenne con iscorno dell’umana ragione che sovente un consiglio di un oscuro giureconsulto mutasse il modo di decidere ne’ tribunali, e che varie opinioni fosser vere, poi false, poi ancor vere e poi di nuovo false, or vincendo le cause ed or perdendole, e così fluttuassero i giudizi secondo che il caso, le passioni, l’interesse ed altre ignote ma vere cagioni si prendessero giuoco delle vicende umane.
In cotanta ambiguità e licenza di legislatura si cominciò a prender per norma la opinione comune, onde quella per certa si avesse e da seguirsi che più sostenitori contasse. Ma codesto fu un rimedio apparente. Ogni dottore come più gli torna a conto testimonia di certo che comune è la sentenza ch’ei sostiene, e ritrovasi poi in fatti che non la è, se alcuno si dà la briga di verificarla. D’onde ne venne che tante sono le opinioni dette comuni contrarie ad altre opinioni che parimenti si pretendono comuni, che ben due grossi volumi in foglio ne abbia consarcinate il Caevallos di opinioni comuni fra sé opposte. Oltre di che cominciossi a dire come tampoco l’opinione quantosivoglia comune debba seguirsi, ed esser pericolosa tal massima, poiché i dottori sovente ricopiandosi l’un l’altro senza esame o discussione, la opinione di molti è poi quella di un solo, e questa di un solo mal fondata, arbitraria e che sovente ha per base una legge male intesa; e per fine non doversi giudicare del peso d’una opinione col numero, quanto dalla qualità e dottrina de’ giurisperiti che la sostennero. Ed in tal guisa gli uomini sogliono cercar l’ordine negli effetti dopo il disordine delle cagioni, lo che è un accrescer il disordine istesso, aggiungendo a’ mali rimedi cattivi. Onde poiché tanti e sì vari requisiti vi vogliono per fissare l’opinion da seguirsi, anche quel po’ di certo che rimaneva fu distrutto, e men male sarebbe l’andar col numero delle autorità cecamente che l’entrare in tante disquisizioni, le quali da sé forse vere e giuste, sono nocive posto il disordine primitivo.
Più autorità ebbero le decisioni de’ tribunali, ma queste, perché desunte dalle opinioni, sono sovente contradditorie, e poi altre discussioni vennero in campo intorno alla disparità del caso, le ragioni di decidere che non entrano nel caso di cui si tratta, le ragioni e le circostanze che non si sanno e che furono forse i veri motivi della sentenza, e simili inciampi alla autorità delle cose giudicate; onde avviene che si dica comunemente nel foro esser pericoloso il giudicar dagli esempi; difficile il fissare l’opinione comune; e per fino che ogni definizione parimenti è pericolosa: Omnis definitio in iure periculosa. Dopo di che più non si scorge qual norma rimanga di giudicare. E ben comprendono i più versati nel foro che ogni opinione può sostenersi; e nel giudicare, a quai leggi ricorrere non si sa il più delle volte.
Molti convengono che la licenza degl’interpreti, l’ignoranza e venalità loro abbiano prodotto l’attuale disordine. Vi furono fra i giureconsulti taluni che viddero i danni ai quali le leggi erano state in preda e tentarono di apporvi il rimedio.
Antonio Fabro, presidente del Senato di Savoia, fece ben quattro tomi in grosso quarto, cui diede il titolo De erroribus pragmaticorum, ove fece vedere quanti errori contro il buon senso e le leggi fussero nelle opere de’ dottori e perciò ancora nella pratica di decidere, e sembrava a quel per altro commendevole giureconsulto che tutto l’attual disordine nella giurisprudenza venisse da’ forensi dottori, cui sì triste deturpazione delle leggi attribuiva in guisa che altro non v’era che ridursi alla romana giurisprudenza, come quella che in sé è ottima e veneranda, onde credeva che introdotti nel foro studi migliori, ed al testo massimamente rapportandoci, avremmo avuta una perfetta legislazione, locché con declamazioni passionate e robuste ei sostenne nelle prefazioni di quell’opera. Di fatti quali esser non dovettero i commenti degl’interpreti de’ primi secoli, s’eglino nulla affatto sapevano di romana istoria, nulla di erudizione, nulla delle cose di quel popolo le di cui leggi di ben grossi volumi di note aggravavano, per modo che incontrando in quelle il Pontifex Maximus, il sacerdos, locus religiosus, nuptiae e tanti altri vocaboli che significano cose romane, eglino, come tutt’ora è facile vedersi, le intendevano come se del Papa, de’ preti, de’ vescovi, delle chiese e nozze cristiane si parlasse, onde dicevano non far bisogno altra teologia, poiché essa tutta si poteva imparare dalle leggi romane, cioè dalle leggi pagane? E chi di loro scrisse, come Bartolo, che il Tevere era stato così nominato da Tiberio imperatore, chi, come Accursio, che Giustiniano fu anteriore di tempo a Gesù Cristo, benché posteriore di cinque secoli, com’è assai noto, e simili altre vergognose dicerie che furono da vari autori raccolte; donde si vegga esser la nostra giurisprudenza composta originariamente da commenti di simili interpreti, cioè di barbare persone, che in un barbaro tempo eran maestre di quelle leggi che sovente non intendevano punto. Eppure vi fu chi tenesse per costante che l’ammasso di cotali opere e la giurisprudenza quale essa è fosse una scienza perfetta, come sostenne fra gli altri Andrea Gammaro, giureconsulto che scrisse un trattato De veritate ac excellentia legalis scientiae. E vi fu anche in questa facoltà chi avesse la smania, che Raimondo Lullo ebbe, di ridurre le scienze e le cognizioni tutte a metodo tale d’impararle agevolmente in poco tempo: la qual arte, detta perciò lullistica, egli è noto esser non altro che una bella ed orgogliosa pretensione. Non mancarono adunque alla giurisprudenza i suoi lullisti, fra i quali i primi furono i dottori sommisti, cioè che tutte le materie legali sparse in tanti comenti e glose e consigli ridussero sommariamente in un solo trattato universale, fra i quali Azone fu dei più bene accolti. Ma poiché le cose nate a poco a poco dal disordine e l’ammasso d’infinite e contradditorie opinioni non possono mai ridursi al certo ed al vero, quindi altro non provarono quelle summole se non se esser vana, quantunque lodevole impresa il compilarle. Altri vi furono i quali incassando, dirò così, la giurisprudenza nelle formole e ne’ metodi peripatetici, credettero che consociandola colla logica aristotelica ad arte ridur si potesse, lo che era fare un gran mostro di due. Questa idea ebbero Giovanni Corasio, senatore nel Senato di Tolosa, di cui abbiamo un trattato De iure civili in artem redigendo; e Giacomo Opperio, giureconsulto parigino, nel suo trattato De civili arte; e Lodovico Pelleo scrisse una lunga confutazione contro di coloro: Qui ius civile artis, aut scientiae titulo non esse donandum asseruere. Tale è l’idea ch’ebbero taluni della giurisprudenza credendola una scienza, mentre non era che un vasto cumulo di opinioni.
Né se vi furono degli eruditi che tentassero di togliere dalle leggi la feccia de’ tanti comenti lo poterono eglino ottenere, come si è osservato. Avvegnacché già stabilite per lungo tempo le opinioni nel foro e ne’ giudizi, la voce de’ più colti non fu ascoltata: onde malgrado i tanti eruditi, e profondamente eruditi, che formano una buona parte d’una biblioteca legale, le teoriche, le glose ed i consigli di questo o quel dottore antico ripetuti e ristampati dagli altri dottori reggono tuttavia il diritto di proprietà. E questa differenza di studi altro non produsse se non se che anche nella giurisprudenza s’introducesse quella volgar distinzione di teorica e di pratica, di catedratico e di forense, essendosi cominciato a dire che questi eruditi da cattedra non vagliono nulla per attitare le cause nel foro o giudicarle. Lo che è vero, verissimo, perché i cattedratici, attenendosi in brevemente esporre le materie appoggiati principalmente alle leggi ed a quella erudizione che loro apporti lume, se avessero da gettarsi nel foro perderebbono co’ loro studi le cause, le quali ben di rado si vincono colle leggi romane o colla erudizione, ma coll’avere i dottori favorevoli e col sapere quali opinioni sieno addottate ne’ tribunali avanti a cui s’instituisce la causa, ed i statuti municipali, e le anteriori sentenze, ed altre simili notizie che faccian conoscere all’avvocato il paese in cui egli vuol combattere; perché, mutando regioni, si muta anche la giurisprudenza coi cavalli da posta, come taluno ha osservato. Hanno bel dolersi i più colti giureconsulti di esser posposti ai forensi, ma la cosa è così; ed è forza il confessare che studiando alle scuole ed alle università quella che chiamiamo erudita giurisprudenza, e poi andando nel foro, bisogna disimpararla. I principii che ivi sono in vigore, la lingua legale, le questioni sono tutte cose nuove per il puro erudito, e molto più per chi venga dalle Instituzioni; sicché tanto se ne avea a risparmiar tal fatica.
Che se gli sforzi de’ studiosi più colti poteron far qualche riforma nella giurisprudenza, eglino altro non fecero che instituire una nuova setta di dottori. Fra questi il Cuiacio, uomo d’immensa fatica e di fama grandissima a’ suoi tempi, restituendo molte leggi al loro senso, conciliandone, come il poté, le contraddizioni, illustrandole con una sterminata erudizione, e prescindendo dalle opinioni de’ prammatici o loro opponendosi, e riducendo la giurisprudenza alle leggi romane, fu autore di una nuova maniera di studiarla. Ma chi soltanto vegga i molti e grossi suoi volumi, i quali d’altri non men grossi volumi furon padri, poiché altri imitarono il di lui esempio, facilmente comprenderà che se di opere cotanto sterminate fa d’uopo per emendare i testi e toglierli d’intorno e la propria oscurità e quella che loro aggiunsero i tanti comentatori, immensi ancor conviene che fossero i sacchegi che l’ignoranza ed i studi incolti aveano fatti nella giurisprudenza. Ma peggiori furono i rimedi che i mali: perché s’è stato detto che un gran libro è un gran male, ciò non mai tanto fu vero quanto in questa facoltà. Ogni opera che entri nella folla delle altre accresce la massa delle opinioni e non fa una vera riforma; ed o ne introduca di sue, o voglia opporsi alle antiche, forma nuove dispute e nuove disquisizioni, e nulla più. Nella giurisprudenza la quiete è da preferirsi alla verità istessa, poiché è men male che opinioni non conformi alle leggi romane sieno ricevute e costanti, che, conformi ad esse, soggetto di disputare. Bisogna che la ingiustizia di una legge sia ben palese e pregiudiziale, per essere eguale al male che soffre la società dall’esservene nessuna, e quel ch’è peggio dall’esservi questioni in luogo di leggi. Poiché se non vi fossero leggi civili che in certe materie provvedessero, ricorrerebbesi al solo senso comune, e la cavillazione tacerebbe in faccia di lui; laddove, allorché è incerto il diritto e feconde materie di disputazioni forniscono le leggi istesse che le dovrebbero spegnere, allora le leggi sono uno scudo sotto di cui pugna e si difende la cavillazione. Per esempio, avevamo noi altre leggi nelle cavalleresche dispute cotanto frequenti nel secolo passato che gli arbitramenti di qualche grave e venerata persona? Eppure appunto perché non v’è stato un codice di cavalleria, che con leggi contradditorie ed equivoche aprisse il campo alle dispute ed alle opinioni, il diritto in questi affari l’ha fissato il solo buon senso, onde avvenisse ch’erano più costanti le leggi de’ puntigli che quelle del mio e tuo. Poiché la giurisprudenza com’ella è di presente ha ciò di funesto, ch’è fatta più per resistere al diritto che per rinvenirlo. Men male è l’aver leggi, anche con qualche ingiustizia, certe che opinioni giuste, ma incerte: e men male sarebbe mancare d’una cosa che soffrirne l’estremo suo abuso. Altri vi sono i quali danno tutta la colpa del disordine a Triboniano, come
IL CAFFÈ )( Fogl. XVII )(
quello che troncando, confondendo, tralasciando gli antichi frammenti della romana giurisprudenza, tutta la deturpasse. E queste antiche ruine di lei desiderano con gran passione, e lor sembra che se le potessimo disotterrare niente di più perfetto vi sarebbe che la giurisprudenza. Il dolore di tai perdite fu sì grave in Hoffmanno che scrisse un libro contro di Triboniano cui si compiacque di dare il titolo di Antitriboniano. Altri dà la colpa di tanti guai ai giudici, agli avvocati, ai forensi come coloro che male usando una cosa ottima, qual dicono la giurisprudenza, convertono in veleno i remedi più salutari. Chi potrà in somma riferire le varie declamazioni fatte da vari contro il disordine della giurisprudenza? Le tante fatiche fatte dagli eruditi per restituire quella legge, conciliare questa con quella, illustrarne un’altra, compendiarne i titoli, altro non furono che rimedi parziali ad un male generale. Parmi di vedere de’ fabbricatori, i quali ad un vasto e sproporzionato edificio che crolla perché non fu ben fabbricato, van riparando questa e quella parte con piccoli e diligenti lavori, invece che altro non v’è che atterrare tutto il mal costrutto edificio e servirsi in parte de’ stessi materiali per alzarne un nuovo colle dovute regole d’architettura.
Tutti però coloro che di tempo in tempo declamarono contro la giurisprudenza e ne desiderarono qualche riforma, egli è costante ch’ebbero un profondissimo rispetto per le leggi romane e se la presero fortemente contro degli effetti rispettando le cagioni, giusta il solito destino della umanità, o perché il rimontare alle cagioni è una fatica che l’intelletto di rado sostiene, o perché gli effetti son nuovi e le cagioni antiche, perciò venerande; od in fine perché gli effetti toccano immediatamente l’uomo, e sono la cosa che la irritata immaginazione tosto incontra, e sulla quale si ferma e si sfoga.
Il cardinale de Luca, nome assai noto nel foro, avea un sistema tutto suo. È indicibile quant’egli si scagli contra de’ dottori, che ad ogni tratto ne’ tanti suoi discorsi chiama ignoranti, che le leggi non intendono, le regole non sanno, i principii involvono e male applicano al caso, e l’uno e l’altro si corrono dietro more avium et pecudum, com’egli di sovente si querela, onde vorrebbe che la ragione ed il buon senso avessero la massima parte nella facoltà legale, del che veniva incolpato a’ suoi tempi, come che appoggiasse i suoi principii non alla autorità ma al suo raziocinio. Ma tal maniera di decidere le quistioni era buona prima d’instituire la società civile e prima delle leggi; ma queste bene o male fatte ed addottate ne’ magistrati, quantunque sien oscurate da una folla sterminata di controversie, fa pur d’uopo che il giureconsulto non la faccia da legislatore, e che vegga ed esamini quali opinioni siano più ricevute, quai sentenze in simili casi proferite, quai principii sembrino più addottati per quanto in cotante tenebre si può ravvisare, e siano pur questi contrari al buon senso, egli è dovere difendere le cause con essi, che altrimenti si perderebbero immancabilmente. Quel giureconsulto ha voluta render piana e facile una disordinatissima facoltà, qual è la giurisprudenza, col pretendere che le regole sieno certe, onde altro non rimanga che di bene addattarle al caso, nel che egli picca sovente errare grandemente e vergognosamente i dottori; e quando la questione è più ardua perché le regole non si trovano per deciderla, se la passa col dire: verumtamen haec est quaestio potius facti quam iuris dependens a singularibus casus circumstantiis a prudenti iudicis arbitrio pensandis.
Ma per quante volte ei ripeta tal clausula, egli è certo che la questione non è altrimenti di fatto, ma di diritto, quando non vi sono regole certe per deciderla, e le opinioni dei dottori e le decisioni diverse de’ tribunali altro non offrino al giudice che motivi di dubitare ed all’avvocato di disputare. Ed il passarsela allora col dire che tutto dipende dal bene addattar le dottrine e che il giudice col suo prudente arbitrio ciò faccia, è un dare un consiglio del quale chichesia può farne senza. Sarebbe lo stesso se un medico dicesse all’ammalato: tutto sta a guarire, il che vi consiglio di fare. E certo sarebbe una cosa sorprendente se un ammasso di opinioni, che sono il risultato di un ammasso di comenti, e di consigli, e di glose, e frutto per fine di venti mila volumi fatti da vari oscuri ed incolti uomini per privata autorità, in cui ognuno seguì le proprie idee, sorprendente, dico, sarebbe se questo ammasso fosse così ordinato che da lui fossero nati certi principii e regole costanti, sicché non rimanga che di ben adoperarle.
Ed il fatto dimostra tutto il contrario, com’è molto naturale. Poiché quantunque alcune regole sembrino fissate sulla più ricevuta opinione e sulla pratica di decidere, con tutto ciò esse regole, oltre di esser poche, e quelle poche ancora controvertibili senz’esser tacciato di cavillatore, non ne hanno che il nome, bastando una minima circostanza nel fatto a rovesciarle, ossia limitarle, sicché ben sovente le limitazioni distruggono la regola. Ed in queste limitazioni e sottolimitazioni è dove giuoca massimamente la giurisprudenza forense, essendovene molte cavillose e peripatetiche appoggiate alla autorità de’ dottori, le quali tutte si pongono l’una dopo l’altra dagli autori sotto la regola. Così a cagion d’esempio nella tanto controversa e disperata materia della interpretazione delle ultime volontà, essendovi state tante questioni su tutte quasi le possibili clausule de’ testamenti, ne nacque che a forza di contendere e di decidere non vi sia quasi caso affatto nuovo, od almeno che non abbia relazione con uno già stato controverso. Lo che ha fatto che pure alcune questioni sien cessate, avendo insegnato la frequenza de’ giudizi che questa a preferenza di quella opinione era ricevuta; onde a forza di un clamoroso e lungo disputare si è dovuto convenire in qualche principio ossia regola per l’interpretazione de’ testamenti.
Ma si è fissato ancora per regola che queste regole sono elidibili, per parlar la lingua legale, dalle congetture contrarie desunte dalla verisimil mente del testatore. Così è aperto il varco ad una immensa folla di opinioni sulla forza e validità di tali congetture e sulla interpretazione delle clausule che limitano la regola, ed a parola per parola io credo che siansi vagliati e triturati tutti i testamenti possibili ed instituite su tutte le parole tutte le dispute possibili, sicché aprendo i trattatisti di tali materie reca meraviglia come tante e sì varie quistioni e sì minute controversie abbian potuto venire in campo e germogliare da tutte le parti, se non si rifletta esser questa l’opra della cavillazione di molti uomini e di lunghissimo tempo. Cotanto poco si è curato che la giurisprudenza fosse preservata dalla cavillazione, mostro che veglia sempre in suo danno: perché gli uomini più attivi ed inquieti trovano più di sovente le leggi opposte ai loro fini che favorevoli, e perciò vengono ben tosto esse dilacerate e contorte, se il legislatore non veglia a difenderle. Il che, se sarebbe necessario anche qualora fossero chiare e certe, molto più lo è qualora l’intrinseca loro imperfezione inviti l’astuzia e l’interesse ad abusarne. In cotal guisa il diritto di proprietà, in cui è sì facile ch’entri il disordine e ch’è una sì importante parte del sistema sociale, fu dato in preda alle opinioni in quasi tutte le nazioni, essendo ben rado che abbiano un codice fatto da un filosofo in vece di uno nato a poco a poco e figlio del fato a cui pare destinata da lungo tempo la legislatura.
Egli è bene il dare un’idea delle questioni legali con un esempio. Non isdegnino i grandi ingegni di conoscere a fondo i mali della umanità. Egli è importante che sappiano questi dettagli, e qual è la maniera di pensare e di ragionare in tali materie, e qual sorta di logica faccia che i beni di questo mondo passino dall’uno all’altro possessore.
Prenderò una famosa questione agitata con grandissima furia da’ dottori, e questa è se i figli posti in condizione sieno chiamati. Traduciamola in lingua comune: Tizio dice nel suo testamento: Instituisco mio erede Caio, e morendo egli senza figliuoli, gli sostituisco Sempronio. La esistenza de’ figli di Caio, siccome è una condizione verificandosi la quale svanisce la sostituzione di Sempronio, così diconsi posti in condizione. Cercano i dottori se essi figli sieno anche virtualmente chiamati alla eredità del testatore Tizio: vale a dire se morendo Caio con figliuoli sia obbligato a loro lasciare tale eredità, oppure ne possa disporre come gli piace. E questa libertà o vincolo, dipende dal decidere se essi figli sieno chiamati tacitamente, o soltanto posti in condizione. La regola in tal caso la più accettata, secondo l’odierna pratica, sembra essere in favore della libertà de’ beni, cioè che, morendo Caio con figli superstiti svanisca la sostituzione di Sempronio e rimangano liberi i beni: e così ancora premorendo Sempronio, Caio può disporre parimenti a suo arbitrio di quella eredità, né i figli suoi possono pretendere a quella come chiamativi. Mi si perdoni questa disquisizione, e molto più quelle che son per fare. Questo articolo, come chiamasi nel foro, nacque, come molti altri, originariamente dalle leggi istesse; onde ebbe a dire Francesco Mantica, giureconsulto in tali materie di molta autorità e diligenza, nel suo trattato notissimo nel foro De coniecturis ultimarum voluntatum: Qui sane articulus est fere inextricabilis, quoniam nec certa lege (notisi questa ragione) nec concludenti ratione videtur posse terminari, et doctorum authoritates sunt invicem pugnantes, atque iidem sibi ipsis contradixerunt, et utramvis opinionem crebriorem esse magna contentione tum veteres, tum recentiores professi sunt. E dopo avere citata una lunga serie di dottori d’ambe le parti, e citate, il che è più, leggi che fanno per ambe, finisce col dire che ius adhuc incertum est, et utravis sententia non difficulter defendi potest.
Ma tenendo pure per fermo che sia stabilita la regola suddetta, vengono in campo le seguenti di lei limitazioni.
1. Se i figli posti in condizione sieno discendenti dal testatore: perché in tal caso si suppone una gran predilezione per loro.
2. Se i posti in condizione sieno altresì gravati di restituir l’eredità a qualcheduno. Perché se sono incaricati di restituirla, è loro, per necessaria conghiettura, lasciata.
3. Se sieno posti in condizione soltanto i figli maschi, allora s’intendono sostituiti e chiamati al fedecommesso, perché avendo il testatore fatta parola soltanto de’ maschi, si desume la conghiettura che abbia voluto conservare i beni nella famiglia del suo erede; il che non si può fare non proibendone tacitamente a lui l’alienazione; dunque essa si deve presumere.
4. Se alle parole: se morrà senza figli aggiunga il testatore nati da legittimo matrimonio, perché questa restrizione fa scorgere ch’egli ha inteso che succedessero per testamento, non dandosi tal distinzione nelle successioni ab intestato, nelle quali i legittimi egualmente che i legittimati succedono. Il qual ragionamento chiamano potentissimo i dottori; non so poi come il chiameranno i buoni logici.
5. Si limita la regola della non vocazione quando il testatore fa più sostituzioni al suo erede, in caso che muoia senza figli; ripetendo sempre la clausola se morrà senza figli, a cagion d’esempio: Instituisco Caio, e morendo egli senza figli, gli sostituisco Sempronio, e se Sempronio in quel tempo non vivesse, gli sostituisco Seio, purché il mio erede non abbia lasciati figliuoli ec. Perché il ripetere che fece, in quella nuova sostituzione, il testatore la clausola: se il mio erede non abbia lasciati figli, fa conghietturare che gli stavano molto a cuore, e che perciò gli abbia chiamati alla sua eredità.
6. Si limita la regola, se il testatore alla clausola: se il mio erede morrà senza figli gli aggiunga la proibizione di alienare la eredità: e molto più se ne dia la ragione, cioè perché vuole che si conservi essa eredità nella famiglia del suo erede.
7. Si limita la regola quando i figli posti in condizione non possono succedere ab intestato al loro padre. Per esempio, se sieno naturali. In tal caso si supponga che l’erede lor padre muoia senza far testamento e senza figli legittimi, ma soltanto naturali. Questi impediranno che l’eredità passi al sostituito, perché non si è verificata la condizione che l’erede morisse senza figli, essendo figli anche i naturali. Or dunque altro non rimane a dirsi se non che a loro spetti questa eredità. Ma siccome essi figli naturali non possono succedere al loro padre ab intestato, giusta la disposizion delle leggi; dunque succedono per testamento come sostituiti al lor padre, e perciò in ragione di fedecommesso. Non si dimentichi il lettore che questi ragionamenti non sono miei, che anzi v’è qualche fatica in poterglieli rendere quali gli hanno costrutti i giureconsulti. Non mi si incolpi neppure se sono oscuri, io altro non garantisco se non se che sono tali e quali si trovano in più volumi.
8. Si limita la regola della non vocazione se i figli sieno posti in condizione con un ablativo assoluto. Per esempio, dice il testatore: Instituisco il mio figlio Caio erede, e non vivendo i suoi figli (non extantibus eius filiis) gli sostituisco Sempronio. Allora si conghiettura che i figli sono tacitamente sostituiti al lor padre. Bartolo è l’inventore di questa opinione, e ne dà questa ragione. Se uno statuto dice: vivendo gli agnati (extantibus agnatis), la madre non succeda, non solo, dice egli, quell’ablativo assoluto extantibus esclude la madre, ma include anche gli agnati. Dunque i figli posti in condizione coll’ablativo extantibus non solamente escludono il sostituito, ma sono anche inclusi, e perciò chiamati. Notisi che chi ha fatto questo ragionamento ha guadagnato a’ suoi tempi quattordicimila scudi appunto in questa materia delle sostituzioni. Anche allora si pagavan bene i paralogismi.
Queste, ed altre che io tralascio, sono quelle limitazioni della regola che i figli posti in condizione non sono chiamati, perché da contrarie conghietture si ricava esser diversa la volontà del testatore da quella che la regola generale fa presumere.
Ma non si creda tampoco che queste limitazioni sieno certe, anzi ciascuna di esse è soggetto di quistioni, essendo più che mai divisi i pareri s’esse sieno legittime e se in questo od in quel caso debbano aver luogo. Così oltre l’esser tutt’ora controvertibile la regola, s’essa fosse certa, la renderebbero incerta le tante limitazioni che la inviluppano, e queste ancora altro non forniscono che materia perpetua di disputare; al che, quasi che fosse poco, s’aggiunse un’altra regola, ed è che dopo tante limitazioni, e sublimitazioni, e dichiarazioni, e subdichiarazioni, si finisce col dire che dipende dal giudice il considerare le circostanze del caso e decidere con prudente arbitrio quai conghietture possino entrare per bene interpretare la verisimile volontà del testatore, altre in un caso valendo, altre in un altro non valendo nulla, et quae singula non prosunt unita iuvant; e che tutto dipende dal ben addattar le dottrine; onde tanto si poteva risparmiar la fatica di compilar sì grossi volumi per condurci a questo punto. Colla grandissima differenza però, che se il solo natural buon senso avesse da decidere cotali quistioni, vi sarebbe il male di farle decidere dall’arbitrio e non dalle leggi, ma non vi sarebbe quello ancor più grande di potere in simili casi proferire il giudice or l’una or l’altra sentenza opposta, senza potere essere tacciato né d’aver offese le leggi né il buon senso. Egli agevolmente troverà la sua difesa nella folla delle opinioni tirandone fuori quelle che fanno per lui, o prendendo la regola o la limitazione con citar sempre gravi dottori dalla sua parte; giacché la giurisprudenza è uno sterminato magazino di opinioni, ove ognun trova merci che gli convengono.
Ed ecco a che è ridotta la giurisprudenza. Da qui comprenda il lettore qual sia essa tutta, giacché tutta è composta di simili opinioni. Dirò di più, che tal maniera di ragionare, ossia di delirare dottamente, che in tanti volumi è celebrata, produce una logica tutta propria del foro; e tanti che con lunghi studi in cotal guisa formarono l’intelletto fin dalla prima gioventù, compongono poi uno spirito universale forense, ove altre menti, altre idee e logica singolare tu incontri. Sicché oltre il non avere giurisprudenza certa, almeno essa non ci togliesse anche la logica. Che se in questa facoltà e l’una e l’altra mancar devono per il sistema e per gli studi che si fanno, ognun vede a quale infelicità sia ridotta questa importante parte del governo civile.
Eppure, stando a questa sola questione, sarebbe facil cosa il determinarla, senza che più se ne avesse a far materia di controversie. Lascio se si debba permettere l’interpretare per conghietture la verisimil mente de’ testatori, lo che dà campo a dire che si fa parlare a’ morti ciò che non ebbero mai intenzione di dire. Lascio se quando è non certa, ma soltanto verisimile la volontà del testatore, si debba decidere non liquet, in vece di affirmativamente o negativamente, considerando quella parte del testamento il di cui senso è incerto come non scritta, e supplendovi, se faccia bisogno, colle leggi che provedono alle successioni intestate. Lascio per fine che tai mali bisognerebbe distruggerli nella loro sorgente; pure non volendo toccare il sistema generale, e in questa e simili questioni volendo con parziali rimedi togliere di mezzo l’incertezza, basterebbe che il legislatore fissasse per certa la regola e per certe ancora le sue limitazioni; oppure che stabilisse la regola opposta, come s’è fatto in qualche paese, cioè che i figli posti in condizione sono chiamati, che allora sarebbero bandite anche le limitazioni. E per verità fa qualche stupore come si lasciasse disputare dei secoli molti senza rimediarvi con un tratto di penna; ed un tratto di penna può distrugger dei volumi intieri di controversie. Lasciamo i rimedi parziali ed estendiamo a maggiore distanza le viste.
Le principali e massime cagioni del disordine della giurisprudenza sono a mio parere: il gettare nella massa della legislazione le ragioni che le parti addussero in giudizio; il pretendere che sieno immobili le leggi; il rimediare agli effetti lasciando le cagioni; il preferire la privata giustizia alla universale.
Dall’avere gettate nella legislazione le ragioni che le parti addussero in giudizio ne venne la cavillazione; dall’aver pretesa la immobilità delle leggi, esse caddero in disprezzo; dal voler rimediare agli effetti lasciando le cagioni è venuta la moltiplicità delle leggi; dal posporre la giustizia universale alla privata n’è venuto l’arbitrio de’ giudizi. Sviluppiamo queste idee ancor più.
S’egli è un male che le leggi prima di stabilire imperativamente alcuna cosa dieno in via di prefazione le ragioni che inducono il legislatore a promulgarle, perché da quelle ragioni ne nascerebbero infinite dispute, pretendendo ciascuno all’occasione che le ragioni della legge convengono o non convengono al caso, così servendosi dello spirito stesso della legge per distruggere la sua certezza, e da’ motivi espressi, che furono la ragione di lei, cavandone conghietture e verisimiglianze di ciò che in questo e quel caso avrebbe fatto il legislatore; molto più questo male cresce mettendo a canto delle leggi le ragioni delle parti e facendole anzi passare per norma d’interpretarle. Poiché le ragioni che adduce il legislatore di promulgare una legge possono toglierle la sua universalità col circoscriverla a’ casi soltanto espressi nelle ragioni: ma quelle dell’avvocato possono distruggerla, che ad altro non tende sempre una delle parti in giudizio che a togliersi al vigor molesto delle leggi. Di più, le ragioni che dà il legislatore son buone per lo più: quelle delle parti sono sempre la maggior parte fabbricate dalla mala fede, dall’abuso della logica e delle leggi. Poiché ne’ giudizi convien pure che l’una delle parti abbia il torto, e questa non può addurre buone ragioni; ed anche chi ha ragione non lascia di mescolar le buone alle cattive. Il conservare adunque per norma de’ giudizi l’ammasso degli atti è un eternare l’impero della cavillazione e stabilirla per sistema.
Il pretendere la immobilità delle leggi egli è far voti vani alla inesorabil natura. Voti imbecilli! È in moto l’universo, e lo è sempre: perché saranno costanti le circostanze d’una nazione? Cangino esse adunque, e secondino le mutazioni necessarie e promovino le utili. Quanto siamo lontani da questa verità si conosca dal leggersi tutt’ora nel Digesto le leggi che diede Silla a’ Romani, cioè quelle colle quali frenò la licenza del popolo e stabilì l’autorità de’ patrizi. Che più strano come il citarle ora ne’ nostri giudizi e l’averle nel nostro codice? Le leggi non sono un soggetto di erudizione, non di studi profondi: nulla in esse vi deve essere d’inutile. E quando sarà facile l’esser giureconsulto, allora dir si potrà che le leggi saranno certe, cioè poche e chiare. L’antichità delle leggi non è un lor pregio: ciò vuol sempre dire che non sono più addattabili. Il costume alla fine le distrugge se gli sono opposte; ed ecco un altro male, che le leggi periscano non per una rivocazione espressa, ma per disprezzo ed inutilità. Da qui ne venne l’abuso della lunga consuetudine, a cui è dato il diritto di vincere le leggi, come pur di molte ha fatto. La qual lunga consuetudine è per lo più ben lontana dal significare l’universal consenso de’ popoli, lo che proverebbe un interesse comune; ma i popoli non sanno che sieno le leggi, né che sia il governo; e questo consenso è chimerico e impossibile, se non in una perfetta parimenti impossibile democrazia: consenso malamente presunto, che fomenta l’arbitrio de’ giudicanti. E questa lunga consuetudine avuta come un mezzo legittimo di derogar le leggi può servir di pretesto alle passioni private di derogarle. E quand’anche alcune leggi sieno ineseguibili, il lasciarle nel codice è danno: perché la necessaria derogazion delle leggi, che fa la consuetudine, tragge seco l’arbitraria. Quando è costume che le leggi periscano, v’è chi sa farle perire, se gli torni a conto.
Altra origine della confusione della giurisprudenza è il rimediare agli effetti lasciando sussistere le cagioni. Non v’è materia, a cagion d’esempio, che più abbondi di questioni e che constituisca la parte più mostruosa della nostra giurisprudenza quanto quella de’ fedecommessi. Qual n’è la origine? Lasciano le leggi una piena libertà di esser legislatore dopo morte; e, posta questa perniciosa licenza, cercano colla loro moltiplicità e minutezza di rimediare agl’inconvenienti ch’essa produce. Questa licenza produce infinite questioni, opinioni infinite, e ’l voler toglier sì fatti disordini con molte leggi e dettagli è un porger nuovo alimento alle controversie. Oltre di che la moltiplicità stessa delle leggi è un mal grande, quanto lo è il far complicate le cose che devono essere semplicissime: ed essa moltiplicità nasce sempre dall’esser i legislatori in contraddizione con se stessi rispettando le cagioni, e facendo gran strepito nella giurisprudenza per impedirne i necessari effetti. Lo stesso dicasi di tutte le di lei parti: dove basterebbe una legge se ne incontrano cento, perché una che togliesse la cagion del male risparmierebbe esso male e l’altro non men grande, cioè il tumulto che fanno le leggi e le opinioni per toglierlo; e per fine l’ultimo ed
IL CAFFÈ )( Fogl. XVIII )(
estremo male, ch’è di far tante cose inutilmente.
Ho detto che bisogna posporre la giustizia privata alla universale: val a dire, che bisogna che il legislatore abbia il coraggio di soffrire nelle leggi alcuna necessaria ingiustizia privata in favor della pubblica giustizia. E questa verità sembra un paradosso agli uomini volgari; e non resse la mano de’ legislatori, perché sovente non ne ebbe l’umanità che di volgari. Non v’è legge universale che in alcun caso non riesca dura ad eseguirsi e che non sembri discostarsi dalle idee che hanno gli uomini di giustizia. Quindi si è inventato quel fatale ed umano nome di equità, il quale a tutti i giudizi vorrebbesi che presedesse, vale a dire una correzion della legge in quanto ch’ella è aspra per la sua universalità. Il che è aprir la porta agli arbitrii, è un toglier la certezza alle leggi, è in somma il far legislatore il giudice. Un esempio ben chiaro e manifesto ch’è un gran danno l’aver mire ristrette e parziali nella legislazione e ’l voler in ogni sua minima parte il più esatto ordine e le più perfette regole di giustizia, si riconosce nella cotanto inviluppata parte di nostra giurisprudenza forense, i concorsi de’ creditori, della quale il più ampio trattatista, il Salgado, facendone due vasti tomi, lor diede il nome uguale alla materia di Labyrintus creditorum. Il pretendere il giusto in ogni caso indipendentemente dalla giustizia universale ha fatto sì che infinite dispute siensi introdotte in questa materia. Intanto che i creditori disputano fra loro delle ipoteche, e delle anteriorità, e delle prelazioni, e dei privilegi, e di tanti altri articoli, citando e leggi e dottori ciascun dalla sua parte, perisce la sostanza, ch’è il soggetto della disputa. Ora, non sarebb’egli men male il mettere nella stessa classe anche que’ creditori che forse, presi da sé soli, avrebbero un diritto ineguale, ma avuto riguardo al ben pubblico, che vuole che non sieno lunghe le liti, complicate le leggi ed impossibili a praticarsi per la troppo minuta loro chimerica perfezione, diventa necessario il lasciare quest’inconveniente per non averne de’ più grandi? Generalmente la legge non deve piegarsi dalla sua inesorabile universalità, ed essendo inesorabile, uopo è che sia dura talvolta. Ma questo è minor male che il cessare di essere universale, o coll’avere sotto di sé una folla di minute dichiarazioni e complicate ampliazioni e limitazioni per provedere a tutto con una impossibile esattezza, o coll’essere abbandonata alla equità, che vuol sempre dire arbitrio, ed arbitrio vuol dire nessuna legge. Le leggi non devono lasciar nulla alla virtù finch’ella non sia l’appanaggio de’ molti, il qual tempo ancora aspettiamo. Intanto ciò che v’è di più sicuro nella odierna giurisprudenza è che nulla v’è di sicuro. Onde in cotanta anarchia s’è pur dovuto rimettere la maggior parte delle quistioni alla equità ed arbitrio de’ giudicanti, raccomandando loro caldamente la prudenza. E di queste tante ve ne sono che il Menochio ne ha potuto compilare un grosso volume, ed altri se ne potrebbero compilare. Nulla dirò delle opinioni, che invalsero nel foro, le quali sono opposte direttamente alle leggi romane; ed altre fondate sull’autorità di chi si compiacque inventarle, e che poi fu seguitato con veramente prodigiosa rassegnazione, non si sa come, da tutti i tribunali e da’ giurisconsulti. Del che molti esempi potrei addurre, se avessi intenzione di fare un trattato e se cotanto mi si permettesse contare sulla pazienza de’ leggitori. Nulla pure dirò di quelle opinioni le più accettate che sono contrarie alla ragione e che ripugnano al buon senso, del che ne ha dato un saggio il cardinale de Luca nel suo Conflictus legis et rationis.
È giunta a segno la venerazione del sistema presente, che dissero taluni esser necessaria tal moltitudine di dottori perché l’equità possa aver luogo ne’ giudizi, perché altrimenti se le leggi non fossero equamente interpretabili ed inesorabile il giudizio, questo sarebbe un dispotismo ed una tirannia. La qual proposizione altro non prova se non se che quando in una classe di cose sono infiniti gli errori, si giugne per fino a difenderli con quelle ragioni che li distruggono. Poiché appunto fra i gran mali di cotanta licenza di opinare v’è quel massimo che le opinioni sieno in vece di leggi certe, e l’arbitrio divenuto il pretesto d’ogni interpretazione sia in luogo d’un inesorabil giudizio che incurvi gli uomini alle leggi, non le leggi agli uomini; altrimenti non avremo mai leggi per sentenze universali s’esse hanno a piegarsi a’ minuti riguardi di privata equità. Vi vorrebbe non una legge per tutti i casi, ma tante leggi quanti casi, cioè un codice immenso ed ineseguibile.
I disordini de’ quali abbiamo data brevemente un’idea possono farci strada a rinvenire i rimedi. I mali pervenuti al colmo non ne ammettono di mediocri. Non si tratta di un sistema il di cui fondo sia buono, ma che vi siano sovraimposti dei difetti: si tratta di un totale disordine; si tratta di non esservi certezza nelle leggi, nihil in iure pacificum; di non avere un codice, ma venti mila volumi di quistioni. Non v’è a mio parere riforma parziale che basti. Non giova il declamare né contro gli avvocati, né contro i giudici, né contro i vizi del foro, né contro gli studi incolti. Finché il giudice potrà seguir le sue passioni col pretesto del prudente arbitrio e della equità; finché col favore istesso delle leggi il giudice, che dovrebb’essere il loro esecutore, potrà divenir legislatore in ogni sentenza; finché ei sarà padrone anziché servo delle leggi, nessuna declamazione potrà impedire ch’egli non scelga il partito che gli è più comodo, e ciò sarà sempre finché l’umana natura sarà fatta in guisa che ami meglio piegar le leggi alle sue passioni che queste alle leggi. Così ancor gli avvocati finché potranno sostenere con sì versatile giurisprudenza qualunque opinione, le invettive non faranno mai ch’essi non trovino utile tal sistema. Le rendite e l’autorità loro sono sempre proporzionate all’incertezza del diritto.
Adunque i rimedi fin ora suggeriti da taluno provano più il suo zelo che i suoi lumi. Non basta definire le più clamorose e frequenti controversie: bisogna tutte tagliarle al tronco. Non basta che si facciano studi più ragionevoli, com’altri vorrebbe, questo è un piccol rimedio ad un moribondo. Non basta corregger con leggi parziali le forensi insidie; non basta proibire l’interpretazion delle leggi, perché leggi non abbiamo a cui possa risparmiarsi interpretazione; non basta proibire le citazion de’ dottori; non basta tampoco abbrucciar tutti i loro volumi; l’esperienza dimostrerebbe che il codice romano non è fatto per noi. I censi, i livelli, i cambi, tutti i contratti dal commercio introdotti, i concorsi de’ creditori, le doti, i testamenti, i fidecommessi, le formole e procedure giudiziarie sono tutte una nuova giurisprudenza, della quale non vi sono che le prime tracce nelle leggi romane; e tutte sono fabbricate su i loro comenti. L’esperienza farebbe comprendere essere perduti i giudici e gli avvocati tutto in un colpo, né saprebbero come decidere i casi colle sole leggi romane, quas numquam viderunt, come gl’incolpa il cardinal De Luca, e le quali nulla provvedono alla maggior parte delle odierne questioni. Onde ne verrebbe con tal mutazione il male di mancare ad un tratto di giurisprudenza nella più gran parte de’ casi, che dalle opinioni più comuni e dalle decisioni de’ tribunali hanno pure qualche, se non altro, verisimil norma con cui decidersi. E non solo si distruggerebbe la presente qualunque siasi giurisprudenza, senza sostituirvi niente che più vaglia di lei quanto all’ordine ed alla certezza; ma si muterebbe ancora una gran parte di quella che rimanesse. Poiché egli è costante che non poche opinioni dall’uso ne’ giudizi introdotte sono fondate su leggi romane mal intese, ed altre leggi loro sono affatto opposte. Ond’ecco come una folla di liti sorgerebbono con tal cangiamento di giurisprudenza; e mutate dal sì al no le opinioni, altra maniera di giudicare s’introdurrebbe: e que’ che non promoveano una lite, perché la probabilità era di perderla, ora fatto più probabile il vincerla entrerebbono in campo. Né mi si opponga che tale inconveniente proverebbe non doversi mai fare riforma alcuna nella giurisprudenza, perché io dico che un codice nuovo ma ben costruito non dovrebbe mutare opinione per opinione, né sostituire all’incerto l’incerto; ma stando a’ principii generali entrare il meno che potesse in dettaglio e non avere ambiguità, contraddizioni e materie di dubbi feconde, quai sono i difetti delle leggi romane. Il ridurre ad esse sole la giurisprudenza sarebbe lo stesso che il fare uno strepitoso tumulto nel foro, senza aver fatta una riforma, ma una mutazione. Saremmo da capo. Avvegnacché l’origine dell’attuale disordine è nella natura istessa delle leggi, come si è osservato: onde ritorneremmo ai tempi d’Accursio e Baldo, Bartolo, ne’ quali, quantunque non vi fossero che pochi libri di giurisprudenza e s’instituissero le cause appoggiandosi al testo, il disordine era pure grandissimo, potendosi vedere nelle loro opere quanto facile sia il far quistioni molte e cavillose e ’l sostenere diverse sentenze col citar leggi d’ambe le parti non senza probabilità.
Il sostituire alle questioni le leggi, alla interpretazione la ininterpretabil loro chiarezza, ai dubbi gli assiomi, alla moltiplicità la concisione, alle particolarità le universalità, ai dettagli la vastità delle vedute, sono le sole e vere riforme da farsi.
Per la qual cosa sembra degna impresa di questo secolo illuminato che dopo aver conosciute le leggi della gravità e del moto ed aver quasi soggiogata la natura alla umana inquisizione, si pensi ancora, quantunque tardi, a far leggi per noi; né che abbiamo a mendicarle da un popolo il quale nulla ebbe di comune con noi che l’avere abitata la stessa porzione di questo globo. Popolo in questa parte non così saggio o fortunato come nel vincere, perché non ebbe mai codice costante di leggi civili, per modo che a’ tempi di Augusto, in quel secolo cotanto chiaro per le belle arti, le leggi consistevano nei pareri arbitrari di alcuni giureconsulti a ciò destinati e che aveano autorità legislatrice, dovendo i giudici attenersi alle loro opinioni; e lungi che i Romani fossero in questo imitabili e degni d’esser maestri, eglino non ebber mai un filosofo legislatore, sicché i più grandi uomini, Pompeo, Cesare e Cicerone, conoscendo questo male desideravano che si facesse un codice; ed è fama che anche s’intraprendesse questa impresa, che non ebbe poi effetto. Abbiamo esempi illustri in questo secolo che ci potrebbero servir d’incitamento e di norma. Gli estremi disordini hanno soltanto questo tristo bene, che fanno accorto il legislatore a provveder meglio a tutto. Le tante questioni onde ribocca la giurisprudenza indicheranno le vie per cui s’introdussero, faranno scoprire le sorgenti della incertezza. La misura del disordine parendo compiuta, il saggio legislatore potrà aver presenti tutti i mali possibili: ed istruito dalla funesta esperienza conoscerà perfettamente sin dove estender si debbano le sue mire. Dovrà la sua sapienza ai lunghi danni onde fu in preda il diritto di proprietà.
Serviranno, per costruire un codice generale e costante, di guida le leggi romane, principalmente quelle del Digesto, ove si ritrovano delle saggie risposte che sviluppano filosoficamente i principii di giustizia universale. Serviranno gl’innumerevoli volumi dei dottori che si difondono in molte questioni e dettagli ch’è necessario il conoscere. Serviranno i più completi trattati in ciascheduna materia de’ più ragionevoli e colti giureconsulti, perché percorrendo diligentemente tutti i soggetti, i casi, le mire, i dettagli di quella materia, potranno fornir molto di che imparare; ed errino o colgano il giusto, marcheranno sempre i punti di veduta d’onde il legislatore deve con un colpo d’occhio misurare la soggetta materia. Serviranno molto i trattati universali, cioè di quelli che diedero in ristretto e colla maggior chiarezza un trattato di tutte le parti della giurisprudenza quanto si può fare in una disordinata facoltà; tralasciate avendo le questioni, i cavilli e le disquisizioni, anzi tutti intenti a sopirli ed estinguerli per quanto l’hanno potuto. Per ciò, a cagion d’esempio, le Instituzioni e le Pandette dell’Eineccio, e le Leggi civili nel lor ordine naturale del signor Domat, e le opere di altri simili rispettabili giureconsulti saranno utili a vedersi. Ed a dir vero nulla s’è tralasciato da alcuni per dar forma di codice all’ammasso disordinato delle leggi romane, lasciando i titoli inutili, estraendo da vari casi particolari i principii, disponendo ordinatamente l’estratto delle materie e facendo in somma in gran parte ciò che doveasi far da Triboniano. Ma poiché essi non si dipartirono, giusta il loro instituto, dalle leggi giustinianee, può dirsi che tali opere sieno una idea di codice, e non più. I vincoli che si sono posti da loro stessi gli ha fatti eccellenti epilogatori ed espositori di quelle leggi, delle quali la maggior parte è d’uopo rifondere. Con non molte aggiunte e mutazioni però non si può negare che diverrebbero un codice perfetto, e fra le mutazioni massime vi dovrebbe esser quella di cangiare lo stile dogmatico nello stile legislativo: perché il giureconsulto cerca sempre la ragion della legge, e il legislatore deve comandare, non insegnare. Tutti questi sussidi sono necessari, perché anche il più gran legislatore non farà mai una compiuta legislazione senza conoscere i minimi dettagli delle relazioni che hanno i cittadini vicendevolmente fra loro. Non è concesso alla mente più sublime nello stato presente della società il ben comprendere, senza esser disceso in questi dettagli, gli oggetti delle leggi, che il commercio, le arti nuove, i nuovi costumi, i contratti di molte specie hanno infinitamente moltiplicati. Più che cresce la società e la sua coltura, più crescono gli oggetti di legislazione. Il codice de’ selvaggi americani è presto fatto: qualche legge sulla caccia, sulle nozze, sulle prede lo farebbe compiuto; ma quello de’ colti popoli, benché non debba esser immenso, pure si può dire che abbia oggetti infiniti; e la sua brevità è l’opra di una mente che sappia ridurre molti fili ad un nodo. Perciò egli è affatto necessaria cosa il ben conoscere questi fili innumerevoli, cioè i moltiplici diritti e le loro modificazioni intorno alle cose, allo stato delle persone, ai contratti, ai testamenti. Perciò è forse necessario per quest’affare il filosofo giurisconsulto, il quale unisca, ad un vasto e legislatore ingegno, le intime cognizioni dei disordini presenti e di tutti questi moltiplici oggetti. Né il solo giureconsulto, né il solo filosofo basterebbe, all’uno mancando la estensione delle idee, all’altro i fatti.
Ma per dar mano ad un nuovo codice in cui si avesse massimamente di mira la semplicità delle leggi, bisognerebbe in prima non lasciar licenza agli uomini di fare in ogni cosa a modo loro, poiché allora non bastano leggi a provedere agli atti umani. Fa d’uopo ristringere i confini della loro libertà, perché più sicura sia quella porzione che a ciascuno rimane. Così non in tutte le guise che a ciascun piace ha da esser permesso di usar delle cose, ma in quelle maniere soltanto che al bene universale non si oppongono. E quantunque ciò sembri poco equo preso da sé solo, ciò non ostante il legislatore, le di cui mire non debbono fermarsi nelle private massime ma nelle universali, sottoporrà sempre quelle a queste. Così, per esempio, le sostituzioni ed i fedecommessi, che constituiscono sì vasta materia di giurisprudenza e soggetto d’infinite liti e complicati rapporti, dovranno essere o molto limitati o forse affatto esclusi, perché una funesta esperienza ha insegnato che non è possibile, data questa licenza, di andare incontro colle leggi agl’inconvenienti che produce: o leggi innumerevoli vi vorrebbero perciò, e né tampoco esse basterebbono. E se pare ingiusto il circonscrivere questa libertà, egli è più ingiusto il lasciarla, come quella che necessariamente rende incerti molti patrimoni.
L’istesso dicasi de’ contratti, de’ patti e di tutte le differenti maniere di commerciare ed usar delle cose che l’uso introdusse fra gli uomini, perché quelle che sieno troppo complicate, e che perciò esiggano troppa quantità di leggi per esser regolate, non dovranno permettersi, non mancando maniere di sostituirne altre più semplici. Nel che però si guardi il legislatore di ristringer la libertà delle azioni se non quando lo esigga la necessità. Perché nulla di non necessario vi dev’esser nelle leggi.
Molti atti umani dipendono dal consenso: il consenso colla lingua si esprime. Per troncare adunque l’origine delle questioni sulla interpretazione de’ pensieri umani in qualunque atto, è bisogno che il legislatore fissi il senso delle parole e ne circonscriva l’uso. Ciò otterrassi col ridurre simili atti quanto più si possa a formole legali, perché la lingua comune, massimamente nella bocca del volgo, è soggetta a troppa incostanza ed abuso. Questa riforma avrebbe da lungo tempo resi inutili i molti volumi sulle interpretazioni de’ testamenti, degli istromenti dotali e degli altri contratti. Nel sistema presente l’abuso delle opinioni ha fatto che vi sia una gran differenza fra la lingua parlata e la legale, in guisa che un testatore, pensando disporre in una maniera del suo patrimonio, disporrebbe in un’altra; perché la lingua legale non è altro che la lingua comune impastata di vocaboli legali e tirata in diversi sensi, anche dov’è chiara, dalle arbitrarie e cavillose interpretazioni. Il saggio legislatore, lungi dal renderla ambigua, la renda costante: né faccia una nuova e strana lingua con termini particolari dell’arte se la necessità non lo vuole. Chi delle formole non si servisse, s’intenderebbe non aver fatto nissun atto legittimo. I Romani in questa parte sono imitabili, se non che andarono sino alla superstizione di caricar di formole non necessarie gli atti umani.
Ristretta che sia la materia delle leggi, restringendo il numero de’ loro oggetti, e fissato l’uso e la forza di quel mezzo con cui gli uomini si comunicano le idee, sarebbe reso molto più facile il dar norma agli atti umani; e due terzi del codice sarebber già fatti.
Egli è un errore fabbricato da una limitata mediocrità (la quale è la madre della maggior parte, perché l’ignoranza estrema non è tampoco buona d’inventare errori) quello che non si possano formar leggi con principii generali, non credendosi possibile comprendere sotto di esse tutti i casi particolari. Se non è concesso alla mente umana di prevedere sempre tutti i conseguenti di un principio, è però concesso di prevederne molti sovente: e buona ed ottima è quella legge che comprenda la maggior parte de’ casi. I dettagli innumerevoli possono da chi gli sa vedere ridursi a certi punti comuni. Non v’è altra guisa di far leggi certe che col ridurle a viste generali. Gli universali comprendono tutti i singolari, e questi sono infiniti, né possono che con leggi infinite regolarsi.
Quest’errore, se non fusse smentito dalla ragione, lo sarebbe dalla men sicura di lei, ma più persuasiva esperienza. Abbiam veduto quale incertezza ingombri la giurisprudenza, dove i dettagli sono in luogo di principii. Ora vediamone una parte, nella quale i principii stanno in luogo de’ dettagli.
La materia che risguarda il contratto di compra e vendita è l’esempio ch’io scelgo. Questa è quella porzione delle leggi romane in cui le leggi sono chiare, universali; distinti e ben dedotti i principii. Per poco che si mutasse sarebbe perfetta. Eppure per quanto succeda questo contratto nella società civile in ogni momento del giorno, pochissime sono le questioni su di tal materia. Onde disse il cardinal De Luca, venendo a scrivere su tale soggetto: Quamvis omnium humanorum actuum frequentior iste sit emptionis et venditionis, utpote humano usui et commercio magis necessarius, atque inde maioris frequentiae ratione omnium amplior ista materia videatur primo aspectu, contrarium tamen fori praxis docet, cum ob pene (notisi la ragione) certas, ac determinatas regulas, quae habentur, omnium fere brevior, magis que angusta apud forenses videatur. Ecco adunque che dove sonvi certi e determinati principii non vi sono questioni. Che se questo avviene in un così frequente contratto, molto più avverrebbe in altri atti umani meno frequenti di lui. Ora paragonisi ciò che abbiamo detto di sopra intorno ad una fra le tante questioni spettanti alla interpretazion de’ testamenti, e vedrassi chiaro che hanno ragione i trattatisti di dire in quelle materie non esservi leggi certe, anzi esservene di contradditorie. Egli è adunque manifesto che dove vi sieno leggi chiare e ben ordinate, come può vedersi nei titoli delle Instituzioni e del Digesto, l’incertezza è in gran parte sbandita; laddove rimontando all’opposto nelle più controvertibili materie legali alla origine della incertezza, troverassi come o leggi non vi provviddero, o manchino d’universalità e sieno oscure, o le une contradditorie alle altre. D’onde sempre più si scorga che il male è nelle leggi, e non nella umana malizia con cui sempre si difendono i limitati legislatori; e che sanno diriggere i saggi.
E nel contratto di compra e vendita ha dovuto necessariamente accadere che vi fosse certezza di diritto, perché altrimenti i disordini che in questa parte l’incertezza avrebbe prodotti sarebbero stati del tutto intolerabili. Se certezza non vi fosse nel vendere e comperare, se ad ogni tratto avessero dovuto o i venditori o i compratori ricorrere ai giudici ed instituir liti, sarebbe stato ben tosto spopolato quel paese in cui vi fosse sì orribile abuso. Laddove più rari sono i testamenti, i fedecommessi, i concorsi, le dotazioni; né questi sono affari giornalieri, onde i disordini in tali materie, quantunque gravissimi, possono sussistere anche per lungo tempo invendicati. Non riducono gl’inconvenienti a quell’estremo a cui non si possa più resistere: e sarebbe per avventura un bene che non sordi e lenti e mediocri fosser talvolta i danni; ma grandi, manifesti, intolerandi, perché scoppiando con sintomi mortali esigessero necessariamente rimedio. I mali cronici al corpo politico sono i peggiori. Ritorno al mio soggetto.
Fatte adunque leggi chiare ed ordinate e nella lingua volgare per esser intese da tutti, il giudizio in altro non dovrebbe consistere se non se in decidere che il tal caso nella tal legge è compreso. Che se il caso non ha legge in cui possa comprendersi, allora o ad una curia suprema a ciò destinata, o al principe, o a qualunque altro legittimo tribunale cui questa incombenza avrebbe a commettersi, spetterebbe o l’estender la legge, perché provveda al nuovo caso non preveduto, o farne una nuova; e questa metter subito nel codice, perché serva per l’avvenire. Ed in tal guisa la prima decisione darebbe norma a tutte le posteriori. Il tribunale a cui venisse una questione che non può decidersi con leggi altro non dovrebbe fare che decidere appunto che legge non v’è per quel caso. In tal guisa nulla sarebbe lasciato alle opinioni, e ’l giudice farebbe de’ giudizi, non delle leggi, e s’affaccerebbero di mano in mano agli occhi della curia suprema legislatrice i difetti imprescindibili del codice, il quale in un certo periodo di tempo sarebbe stato esposto a tutte quelle riforme che l’esperienza di tutti
IL CAFFÈ )( Fogl. XIX )(
i possibili inconvenienti avrebbe suggerite. E questa riforma con veglianza continova dovrebbe farsi dalla curia suprema senza ritardo.
Dirò qui che un tribunale di tal sorte sarà sempre necessario finché le vicende sociali avranno quel rapido moto e quell’inchinamento al disordine ed al discioglimento che hanno sempre avuto finora e che sempre avranno, come la lor natura comporta. Le passioni umane sempre urtano contro le sociali instituzioni; che se queste non si rinforzano e puntellano, dirò così, cedono al continuo impulso: e come ne’ paesi che temono l’impeto del mare o de’ fiumi sonovi magistrati destinati a vegliare alla conservazione e riparazioni degli argini, così è d’uopo che vi sia chi le leggi e ripari e conservi; poiché infinite e possenti sono le forze e gli interessi a cui denno far ostacolo. Negli Stati non basta la facoltà esecutrice, ma vi vuole ancora la direttrice. Che se nella legislatura a’ tribunali giudiziari tal cura si commettesse, i giudici sarebbon legislatori.
I giudici dovrebbero dare la ragion del giudizio necessariamente. Perché dicendo che il caso controverso è quello che nella tal legge si contiene, darebber sempre così anche la ragion della sentenza. Non farebbe obbiezione il dire, che se si dasse la ragion del giudicato, ciò servirebbe di pretesto nelle ulteriori questioni di mettere in dubbio se le ragioni convengano o non convengano in altri simili casi a cagione di qualche diversità di circostanze, come avviene quando le leggi pongono la ragione delle loro disposizioni. Poiché in questa riforma che si propone le sentenze non dovrebbero formar parte di legislazione giammai, ma soltanto servir di norma e di lume per gli ulteriori giudizi. Né i giudici avrebbero a giudicare, nel tal caso, nel tal modo perché un anno fa hanno parimenti giudicato così; ma perché vi son leggi che così determinano che si giudichi di presente come allora fu giudicato.
Le sentenze possono fare stato nella presente oscurità, perché dove non v’è certezza di leggi, è qualche cosa di certo un giudizio: né ragione si adduce di dar forza di leggi alle decisioni de’ tribunali anche di altre nazioni, se non se quella che non par verisimile che uomini dotti e gravi s’ingannassero. La qual ragione ognun vede quanto vaglia. Di fatti non si adducono le ragioni delle sentenze, le quali son rari i tribunali ch’abbian uso di darle, e perciò indovinando confusamente cercanle gli autori che le raccolsero e commentarono. Che se almeno le ragioni si dessero nette e chiare in tal sistema, non perché quelle ragioni sieno stati i motivi di decidere, ma soltanto le buone e conformi alle leggi si avrebbero di addottare. Ora però si ha cura soltanto di conoscere il caso e la sentenza; e queste sentenze, per esempio, del Senato di Savoia raccolte dal Fabro; del Senato del Delfinato da Francesco Marchio; del Concistoro di Cosenza da D. Garzia Mastrillo; della Rota di Siena da Cristoforo Medici; del Supremo Consiglio di Napoli da Vincenzo de’ Franchi; del Senato di Catalogna dal Ramonio e dal Corziada; della Rota di Bologna dal Barzio; del Supremo Consiglio d’Arragona da Crespo de Valdaura; del Senato di Portogallo da Melchior Febo; del Senato di Lipsia dal Carpzovio, ec. sono messe nel numero delle leggi e decidono le liti ne’ tribunali di altre nazioni e ad altri principi soggetti, e per avventura a diversità rimarcabile di leggi e di consuetudini. Ma fissato che sia un codice preciso di leggi, la ragion di decidere non può mai essere, per esempio in Italia, perché così in quel caso ha deciso il Senato di Lipsia o di Portogallo; né parimenti perché l’istesso tribunale abbia così deciso altra volta. Le leggi sole saranno la ragion de’ giudizi, non i giudizi de’ giudizi; avvegnacché basterebbe un solo ingiusto giudizio a distruggere le leggi per sempre.
Così pure nelle formole d’instituire i giudizi e nella loro tessitura dovrebbe ridursi alla maggior semplicità la tela giudiziaria, mettendovi quell’ordine e quelle cautele che impediscano le sorprese e che rendano il giudizio grave e solenne e costante; ma le quali non ne facciano un intricato labirinto di peripatetiche forme, di sofistiche formalità e d’inutili e tortuosi inciampi, sicché divenga il giudizio, anzicché una legittima solennità, una guerra d’industria, nella quale si pugni coi raggiri, colle cautele, colle eccezioni, colle astuzie, piuttosto che colle leggi. De’ quali stratagemi assai ne inventarono i giurisperiti; onde è voce sovente ripetuta nel foro che tanto vale il buon diritto quanto la condotta nelle cause, ch’è poi dire che tanto si può fare coll’adoperare sagacemente gl’intrighi giudiziari quanto coll’aver ragione. Si provederebbe facilmente a ciò con fissar metodi certi e semplici; giacché rimontando all’origine di questi inconvenienti se ne trova la ragione nella troppo complicata forma de’ giudizi. Ella è una massima delle più ripetute che le leggi devono piegarsi all’indole delle nazioni. Noi, lasciando indecisa questa disputa degna de’ grandi filosofi che la agitarono, cioè se l’indole delle nazioni dalle leggi dipenda o dalla natura, nel che per avventura ambe concorrono, diremo soltanto non esser di grand’uso alcuna di queste verità, dove si tratti di formare un codice di leggi civili. Esse non risguardano il sistema universale di governo o la di lui natura. Queste meglio si possono chiamare le leggi fondamentali e politiche; e con queste si fanno eroi li Romani, stoici i Lacedemoni, conquistatori gli Arabi. Ma codesti non sono gli oggetti delle leggi civili, che equivocando sulle parole non bisogna confondere con quelle. Né i patti, i contratti, le donazioni, i testamenti prender possono norma dal clima e dalla natura della nazione che ben di rado. Con poche mutazioni l’Europa tutta potrebbe avere le stesse leggi civili, quantunque i costumi, le indoli, le nature sieno differenti ogni cento miglia.
Ed ecco come ne’ capi di riforma sommariamente indicati consista a mio credere la norma che seguir dovrebbesi per imprender la grande e necessaria opera di un nuovo codice. Non tanto dovrà il legislatore edificare, quanto distruggere. Che se pure tal riforma sembrasse tumultuosa tutto in un colpo facendola, e camminar si volesse con quel timore illuminato con cui i grandi legislatori lavorano sul corpo politico, potrebbesi incominciare dal riformare, giusta questi principii, una parte della giurisprudenza; a cagion d’esempio quella de’ testamenti, del debito e credito o delle doti, o altra delle più vaste e complicate: onde vedendosene i buoni effetti di questa parzial riforma in paragone e dell’antico disordine e di quello delle altre parti del diritto, si confermasse colla esperienza la meditazione di un oscuro e buon cittadino; e come sua sarà la gloria del zelo, così di chi ha la potenza quella ancor più conspicua d’una riforma così grande e desiderata.
A. [Alessandro Verri]
Sulla fortuna
Ogni nazione, ogni secolo, ogni uomo parla della fortuna, e ne parla quasi come di un essere esistente da sé, a cui attribuisce i femminili difetti di volubilità, di capriccio e talvolta persino di amicizia singolare per la giovinezza e di avversione per l’età matura. L’uomo naturalmente inclinato ad attribuire agli oggetti che son fuori di lui i movimenti che prova in se stesso, e perciò spinto facilmente alla poesia animatrice d’ogni essere, l’uomo che non regge al dilicato esame dei minutissimi fili che uniscono i fenomeni l’uno coll’altro se non per una fattizia organizzazione d’idee, e che perciò tutti gli oggetti che immediatamente non si succedono crede indipendenti l’uno dall’altro, l’uomo fatto in somma quale egli è, deve personalizzare la successione dei fenomeni dell’universo e chiamarla poi con qualche nome, e il nome che le diamo noi è la Fortuna. Le sette antiche di coloro che forse per la distanza in cui sono da noi godono tutt’ora il nome di filosofi, in gran parte applaudirono a questo volgar modo di ravvisare gli oggetti, e gli stoici e li platonici risguardarono Fortuna come un essere o un genio distinto, e sebbene la scuola d’Epicuro sembrasse scostarsi alquanto da questo popolare metodo d’immaginare, pure Lucrezio la risguarda come una potenza, ovvero forza nascosta che calpesta i fasci e le scurri consolari:
Usque adeo res humanas vis abdita quaedam | Obterit, et pulchros fasces saevasque secures | Proculcare et ludibrio sibi habere videtur. | (lib. V).
Se per altro ricerchisi la vera definizione di questa voce Fortuna, non trovasene altra che questa: ignoranza della concatenazione degli oggetti che influiscono immediatamente sugli uomini. Né credasi superfluo il circoscriverla ai soli oggetti che influiscono immediatamente sopra di noi; poiché nessun fenomeno che non abbia una immediata influenza sopra l’uomo viene da esso attribuito alla fortuna, sebbene ne ignori la cagione. Con una mano getto un dado, coll’altra un globo: l’uomo volgare non dirà che il globo siasi posto in quiete al tal determinato sito per opera della fortuna, ed attribuirà alla fortuna che a un tal determinato sito siasi posto in quiete il dado. Nessuno attribuirà alla fortuna che un fiocco di neve cada più alla sua destra che alla sinistra, e attribuirà alla fortuna se cade più alla destra che alla sinistra una carta da giuoco; eppure, come le leggi del moto benché sconosciute paiono sufficienti anche al volgo per cagionare gli uni di questi fenomeni, così potrebbero sembrar buone anche ad appagarlo sugli altri: ma ciò non segue perché gli uni influiscono immediatamente sopra il ben essere dell’uomo e gli altri gli sono indifferenti.
Quello che singolarmente contribuisce a confermare gli uomini nella opinione dell’esistenza di quest’essere chiamato Fortuna è il vedere come spesse volte un felice avvenimento sia seguito da un altro pure felice, e talvolta da una catena di fauste cose le quali accompagnano la vita degli uni; e così all’opposto una sventura sia come foriera di un’altra; onde s’intralciano i tristi come i buoni avvenimenti per modo che pare che una certa quale fatalità regga al bene tutte le azioni dell’uno e spinga e precipiti alla miseria tutti gli sforzi dell’altro. Questa attrazione dei beni e dei mali non è per altro tanto difficile ad intendersi, sicché sia d’uopo di farne una dea e collocarla nel cielo. Acciocché l’uomo faccia le sue azioni bene, cosicché facilmente ottenga il fine per cui le intraprende, fa di mestieri ch’egli abbia singolarmente un certo qual ardire e fidanza di se stesso, per modo che abbia ferma la voce, la mano e il passo, e sembri quasi persuaso di comandar alle cose, anziché implorarne da esse l’aiuto. Su di ciò è senza dubbio fondato l’antichissimo detto che la fortuna è amica degli arditi, e la sperienza giornaliera assai lo comprova. Ora non vi essendo cosa che più contribuisca a dare all’uomo una vantaggiosa opinione del proprio valore quanto l’esito felice delle sue intraprese; e per lo contrario nulla che tanto lo renda di se stesso diffidente quanto l’inutilità de’ suoi tentativi, chiara cosa è come una felicità disponga ad ottenerne un’altra, una sventura produca altre sventure; e così quell’astro, quel destino che gli uomini volgari ripongono tanto lontano dall’uomo, realmente risiede nella opinione che l’uomo ha di se medesimo.
Generalmente parlando la fisonomia d’un uomo lieto di sé e confidente viene chiamata una fisonomia fortunata; e per lo contrario ogni fisonomia che dimostri avvilimento, timore o melanconia si giudica fisonomia da sventure. Né in ciò s’inganna la opinion comune, se non nella cagione che la maggior parte degli uomini, costanti adoratori della maraviglia, vanno a ricercare fra’ spazi per quanto sappiamo sconnessi perfettamente dai piccolissimi affari dei piccolissimi uomini. Le passioni nostre continuate per qualche tempo lasciano sul volto le traccie loro particolari; perciò la fisonomia fortunata è un sicuro indizio d’un uomo che fida nelle proprie forze, e che per conseguenza opera con quel vigore il quale è il più sicuro mezzo per far uscire dalla folla delle combinazioni le più avventurose. Se nella storia non avessimo anche che le vite sole di Maometto e di Cromwell, esse basterebbero a farci intendere quanto sieno facili e gli uomini e le intere nazioni a piegarsi ad un uomo che sia intimamente persuaso di poterle piegare. Forse tal verità richiudevasi nell’antico assioma delle scuole: Fortis imaginatio generat casum. Una forte persuasione, una viva immagine che colpisca robustamente la fantasia d’un uomo produce il caso, ossia forma quello che chiamasi ventura o fortuna.
I Romani ebbero un’opinione fortissima che fintanto che custodivasi presso di loro il dio Termino, i confini dello Stato di Roma non si sarebbero ristretti giammai; e in fatti sinché questa immaginazione restò ben viva nelle menti romane, essi trionfarono di tutte le nazioni colle quali ebbero guerra. Questa immaginazione fu sì forte che trovavansi compratori del terreno che occupava il campo d’Annibale vicino a Roma mentre parevano le cose ridotte alla inevitabile caduta di Roma. Tutta la storia romana sino alla distruzione di Cartagine ci prova e la ostinata immaginazione di sicurezza, appoggiata agli errori della superstizione, e la costanza della fortuna, che va sempre compagna alla persuasione, vigorosa di finir bene. La disfatta del console Pulcro, che disprezzando, non da saggio nel solo silenzio dell’animo, ma da mal accorto in faccia del volgo gli augurii presi dai polli, volle dar la battaglia sotto infausti auspicii, prova abbastanza quanto possa l’opinione sugli avvenimenti e quanto sia pronta la fortuna a seguir un esercito persuaso di averla con sé; e quanto siano sventurate le imprese alle quali s’accingono gli uomini con diffidenza e presentimento di mal riuscirvi. Queste verità erano certamente conosciute da que’ saggi repubblicani, presso i quali era in abbominazione la greca filosofia, che tendeva a togliere la credenza agli augurii, agli oracoli ed a qualunque superstiziosa opinione, per tal modo che ogni nuova maniera di pensare e di ragionare sulle cose riguardavano come una corruzione della Repubblica. Rozzi e illiterati erano costoro agli occhi di chi semplicemente osservava il progresso delle scienze, ma saggi e profondi filosofi dovevano essere riconosciuti da chiunque esaminasse la costituzione di quella società e conoscesse il principio motore delle azioni degli uomini. Nelle cose umane pochissime sono le grandi azioni prodotte dalla verità e moltissime quelle che devono il loro nascimento all’errore: togli l’errore e l’ignoranza a un popolo conquistatore, e lo riduci a livello cogli altri popoli. Tutti gli errori che danno ardire e fidanza delle proprie forze a una nazione, che fanno temere ai cittadini più la viltà che la morte, che ispirano ad essi un amore robusto e feroce per la patria, sono il vero Paladio della gloria d’un popolo.
La persuasione di riuscir bene fa che per lo più si riesca bene, e il buon riuscimento conferma nella persuasione di ben riuscire. Il timore di un cattivo esito fa lo stesso; e così vanno i felici avvenimenti moltiplicandosi, e similmente le sventure, diventando cagioni gli effetti; per lo che disse l’Ariosto:
Non comincia fortuna mai per poco | Quando un mortal si piglia a scherno e a giuoco.
Che se l’uomo potesse agevolmente scancellare dal suo animo la impressione che ha ricevuto da una sventura, e riconfortarsi e rinvigorire se stesso facendo nascere un sentimento di fidanza di sé e ripigliando con fibbra più elastica ancora le azioni della vita, se tal facoltà, dico, fosse pienamente in potere dell’uomo, allora non vedrebbesi quella costante successione di casi aggradevoli, ovvero disaggradevoli, dalla quale principalmente nasce l’idea volgare della fortuna; e direbbesi in vece: sui cuique mores fingunt fortunam.
Io non pretendo con ciò di dire che gli avvenimenti della vita d’un uomo sieno talmente in mano di esso sicché possa ottenere il compimento perfetto de’ suoi desideri, dico soltanto che posti due uomini nelle stesse circostanze, dando ad uno di essi una mente che ragioni e dando all’altro della debolezza d’animo, e della imbecillità; il primo domerà molto più ostacoli che non farà il secondo; e finirà il primo per addattarsi un sistema assai più agiato, e tranquillo di quello che non farà il secondo, al quale converrà passar la vita edificando ordigni che ad ogni tratto crolleranno e l’obbligheranno a ritornare da capo. Che se pure l’imbecille per qualche rara combinazione verrà dalla mano d’un protettore cavato dal labirinto per cui va errando e posto in più luminosa comparsa, io dico che male della fortuna di esso si giudica da chi lo vede di lontano; e che se la fortuna dee misurarsi dal numero de’ beni che ciascun gode, probabilmente colui anche in quello stato deve dirsi abbandonato dalla fortuna, tanto ei stesso si troverà per tutto il corso della vita straniero nella situazione in cui è riposto; e timoroso e ansante incessantemente di perderla. Se v’è bene che godiamo egli è quello che abbiamo noi stessi veduto di lontano, ed a carpire il quale siam camminati noi stessi, sormontando gli ostacoli che ci si frapponevano: la casa che più ci piace d’abitare è quella che abbiamo saggiamente edificata da noi. Un sovrano nato sul soglio ha molto minor piacere ricevendo gli omaggi e i titoli dovuti al suo grado di quello che non ne provi un uomo di mente e di coraggio il quale col merito è giunto al ministero, e che veggendosi superiore agli uomini che gli stanno d’intorno, può lusingarsi con ragione che ciò dinoti una fisica e reale superiorità in suo vantaggio.
Ogni uomo incontra degli ostacoli per giungere ai fini che si propone; l’uomo confidente e robusto ne supera assai più, sieno essi fisici, sieno essi morali, che non ne supera il timido e il troppo circospetto. Il coraggio, purché non giunga sino alla frenesia, diminuisce in effetto i pericoli anche fisici. Chi si batte colla spada tremante, chi timidamente si getta a nuoto in un fiume, chi fugge alla vista di una fiera è più in pericolo di colui che con fermezza di cuore impugna il ferro, nuota o sta fermo. La sperienza e la storia ci provano ancor più quanto l’opinione costante e forte di noi medesimi possa per conciliarci quella degli uomini, e quanto un tratto vigoroso fatto a tempo possa decidere la moltitudine in favore d’un uomo solo. Pochissimi uomini hanno carpito la fortuna senza aver fatto nella lor vita qualche azione che presso gli uomini volgari vien chiamata imprudente; ma somma prudenza, ossia sommo sapere è quello che sa ne’ casi straordinari uscire dalle ordinarie leggi e trovarne di opportune alle circostanze. Questa massima è vera, ma sarà sempre pericolosa, qualora venga addottata da un uomo che abbia la vanità di comparir grande senza esserlo, poiché lo precipita in una turbolenta serie d’imprudenti azioni, contradittorie bene spesso le une colle altre, le quali finalmente lo conducono al discredito ed all’abbandono.
Gli uomini volgari hanno una folla immensa di desideri, poiché desiderano gli oggetti uno ad uno separatamente, né spingono i loro sguardi sino alle cagioni che li producono; gli uomini capaci di ergersi sopra degli altri scoprono nella folla degli avvenimenti civili le poche cagioni motrici, l’autorità, le ricchezze e simili; e verso uno di questi oggetti condensano tutt’il desiderio: quindi ne segue che mentre gli uni cercano ad accostare a sé le foglie d’un albero legate una ad una con moltiplici fragilissimi fili, gli altri pochi con una sola fune bene annodata al tronco dell’albero gli dieno una continua e non interrotta spinta, all’azione della quale costantemente adoperata difficil cosa è che l’albero alla fine non ceda, mentre i minutissimi fili qualche foglia al più avranno staccata, ma rotti per la maggior parte lasciano deluse le speranze del mal avveduto volgare. Un uomo solo è un piccolissimo oggetto; ma un uomo che costantemente dirigga e con vigore le sue azioni ad uno scopo solo per il corso della sua vita, deve considerarsi come un oggetto piccolissimo bensì, ma moltiplicato per tutto quello spazio di tempo per cui ha agito. Le macchine della statica ci fan vedere come una forza, benché piccola, giunga a smovere un peso per grande ch’ei sia, purché sia continuata per un tratto di tempo. Una forza eguale a 1, che duri il tempo 100, smove quello stesso peso per cui sarebbe di bisogno a smoverlo in un sol colpo la forza 100. Questo principio statico è pure adattabile agli avvenimenti umani. L’uomo che condensi la sua anima e la dirigga verso un oggetto solo, se abbia lena e robustezza di perseverare nella stessa direzione per lungo tratto di tempo, giunge per lo più a ottenere quanto s’era proposto. Il carattere più disposto di ogni altro alla fortuna è dunque quello che non ha divisa la sensibilità e sminuzzata intorno vari oggetti; ma bensì che la spinge tutta cospirante verso un oggetto solo e costantemente ve la tiene, d’onde nasce il volgare verissimo avviso: Guardati dall’uomo d’un solo affare.
Le storie ci somministrano copiosamente gli esempi di uomini i quali a forza d’ostinazione, opponendo un animo imperterrito ad ogni ostacolo, giunsero ai fini anche più elevati che s’erano proposti. Il vigore con cui si diriggono gli avvenimenti e la costanza con cui si tengono di mira sono i veri elementi della fortuna; ma osserviamo che negli uomini superiori prevale il vigore, nei secondari prevale la costanza. Io osservo di più che una piccola sventura in un uomo di fibbra forte in vece di essere presaga delle sventure a venire, anzi lo rinvigorisce, lo risveglia e lo sforza a correre alla fortuna con passo più fermo. Quanti hanno fatto imprese grandi e grandi rivoluzioni per ciò solo, che da’ loro cittadini non ottenevano que’ riguardi che sentivano di meritare! Se un uomo si trova nella prima età sua agiato di beni di fortuna ed assistito dalla buona opinione e stima degli altri uomini, difficilmente si pone in moto per cambiar situazione, anzi la inerzia e l’indolenza naturale lo vincono e l’inchiodano nella condizione in cui è nato; ma se o i beni manchino, ovvero il capriccio volgare ricusagli quella porzione di stima che l’uomo valente cerca ed esigge, allora lo vedi riscuotersi e diventare ambizioso, e per quella strada per cui il naturale genio e la constituzione permettono di spingersi, lo vedi correre alla fortuna. Accade negli uomini quello che nelle nazioni, cioè che quelle piantate in terreni fertili e in climi felici facilmente s’abbandonano al letargo ed all’inerte godimento de’ loro naturali vantaggi; laddove le nazioni poste sotto climi più ingrati ed abitatrici di un suolo sterile, costrette per non perire a ricorrere alla industria, tanto con essa si addomesticano e la fanno propria, sicché non riparano soltanto le mancanze della natura, ma giungono in opulenza a superare le altre. A questo principio attribuir si debbono i pochi sforzi che fanno per lo più i nobili per coltivare l’ingegno e distinguersi dalla folla del genere umano, dalla quale per una ereditaria opinione trovansi già, benché senza lor merito, di tanto distinti. Vi vuole una qualunque vessazione non eccessiva, perché quella avvilisse più che non stimola, ma una moderata vessazione, perché l’uomo corra anche alla fortuna delle lettere, curis acuens mortalia corda.
Chiunque siasi esaminato nell’intimo del proprio cuore conosce qual differenza vi sia da un uomo che nelle azioni della vita diffidi di se medesimo e un uomo che perfettamente
IL CAFFÈ )( Fogl. XX )(
confidi. Felice l’uomo che sa diffidare quando esamina e confidare quando opera. La diffidenza guida l’intelletto alla verità, la fidanza guida le operazioni al loro termine. L’ingegno di chi è persuaso di se stesso trovasi nella sua massima vivacità, i termini si presentano opportuni al discorso; le positure della persona, il tuono di voce, le maniere tutte sono eleganti, naturali e piacevoli, tutto va col vento a seconda. Dammi l’uomo medesimo abbattuto e mal contento di se medesimo, e vedrai ch’ei tormenta in vano la sua mente insterilita, da cui nulla gli vien suggerito che vaglia: le parole mancano ad esprimere i suoi pensieri; tutto è imbarazzato e sconcio in lui; la voce, il moto, tutto è spiacevole; e l’avvilimento scorgesi in ogni menoma azione! Sono ben rari gli uomini che non abbiano qualche volta in vita provato l’uno e l’altro di questi due stati, almeno per breve tempo. Non vi sono che gli sciocchi d’instituto, che non credono d’essere giammai stati sciocchi per tutta la vita loro. Questa massima differenza, che trovasi nell’uomo col cambiamento della opinione del valor proprio, fa vedere abbastanza quante sieno diverse le disposizioni nell’uomo medesimo di riuscir bene in qualunque impresa e di correre alla fortuna. Conviene aver moltissimo spirito per conservarne nelle traversie, e pochissimo basta per dimostrarne fra gli avvenimenti piacevoli.
Ho nominata poco fa la fortuna delle lettere, perché nella repubblica capricciosissima delle lettere appunto pare che singolarmente signoreggi la fortuna, e voglio con ciò dire che l’applauso o il discredito di alcune opere viene prodotto da principii sì poco conosciuti e da una influenza tanto oscura e nascosta agli occhi degli uomini che sarebbe impossibile il prevederlo. A noi non è lecito lagnarci della fortuna letteraria, dopo che essa si è apertamente decisa a favorire i nostri fogli; e sarebbe interesse nostro il sostenere che realmente gli applausi del pubblico sieno la giusta misura del merito di un’opera: ma il principale interesse nostro si è di non tradire la verità, la quale è in contrario e ci prova che né tutte le opere applaudite meritano, né tutte le opere non applaudite demeritano di esserlo. Mille esempi mi si affacciano alla mente, ma pericolosa cosa sarebbe nominarli e offendere le passioni di molti. Noi lasceremo che il lettore da se medesimo li ritrovi, e non avrà da tardar molto.
Concludiam dunque queste brevi riflessioni. Fortuna vuol dire ignoranza nostra: più l’uomo è illuminato, e minore è il numero degli avvenimenti che attribuisce alla fortuna. La energia de’ nostri desideri e la costanza nel fidare in noi stessi formano per la massima parte quel cieco essere che ha il nome di Fortuna. Il saggio la riconosce con Seneca: Natura, Providentia, Fatum, Fortuna nomina sunt unius, et eiusdem dei varie agentis in rebus humanis.
P. [Pietro Verri]
Del teatro
E voi avreste il coraggio, amico, di consigliarmi di dare al pubblico le due commedie, che vi trasmisi? Replicovi dunque che queste non son fatte per comparirvi né sul teatro, né colle stampe: ma se vi comparissero, qual successo ne potrei io sperare? Permettetemi, vi prego, che diffidando questa volta del vostro giudizio, che l’amicizia e la prevenzione potrebbero forse aver reso parziale, questo sia il soggetto della presente lettera.
Non v’ha dubbio che s’io dovessi riguardare al luminoso fonte donde son tratte, avrei tutta la ragione di lusingarmi che fosser per esser dal pubblico aggradite e ben accolte.
Il soggetto della prima[60] non può essere a mio dire né più interessante, né più istruttivo. Le regole dell’arte, cioè l’unità di tempo, di luogo, d’azione e d’interesse, se l’amor proprio non mi fa illusione, sembrami che sieno in essa scrupolosamente osservate; ed ha altresì il raro merito di non lasciare giammai il teatro vuoto.[61] Niente fra noi di più ordinario, ma al tempo stesso di più indecente, che di veder partire dalla scena due attori e sottentrarvene due altri, senza che o si aspettino, o sien chiamati, o ve li conduca la necessità. Niente di più comune nelle nostre commedie che di vedervi ad ogni momento trasportati da una casa ad un’altra, dalla casa alla piazza, al caffè ec. Se la pretesa legge della scena stabile par troppo dura ad alcuni, come quella che rinserri l’autore in troppo angusti confini, io non so per questo tollerare, molto meno approvare quei che nel corso dello stesso atto si prendon di queste libertà; e sono di costante parere che almeno ogni atto dovrebbe avere la sua scena stabile. Chi cambia di scena nello stesso atto fa passeggiare i luoghi in vece delle persone e distrugge in un momento il più grande incantesimo teatrale, l’illusione degli spettatori. Il signor di Marmontel nella sua Poetica, e qualch’altro forse prima di lui, hanno a quest’effetto proposto di calare il sipario alla fine d’ogni atto, finché sian fatti sul teatro i necessari cambiamenti e disposizioni, cosa che sembrerà forse ad alcuni troppo minuta e scrupolosa, non però a coloro che conoscono il vero bello teatrale e sanno che in una buona composizione drammatica lo spettatore deve essere assolutamente un testimonio affatto ignoto. Tutto questo però quando non si volesse adottare l’idea del celebre signor Diderot, che vorrebbe che il teatro rappresentasse talvolta al tempo stesso due diverse scene egualmente aperte agli spettatori, ma affatto distinte e separate per gli attori. Cosa, com’egli stesso lo dice, che potrebbe dare una nuova faccia alla poesia drammatica, ed introdurre sul teatro tratti fino a’ dì nostri affatto sconosciuti.
Questa commedia non ha veramente un grand’intreccio, tutto consistendo nel solo innocente artificio d’un’amorosa madre di condurre opportunamente quelle persone e circostanze; di far nascere que’ discorsi che possono mettere nel suo vero aspetto, in tutta la sua luce agli occhi della figlia i due opposti caratteri del Marchese e di Belzons. Vi supplisce però coll’interesse, e colla forza e verità de’ caratteri; e quanto a me so più facilmente perdonare ad un autore questo difetto (se tale si può dire) che d’urtare per aver dell’intreccio nell’inverosimile o nel puerile; estremi che l’esperienza fa pur troppo vedere quanto sia difficile d’ischivare.[62]
Ma a fronte anche di questi supposti vantaggi il nostro teatro, la nostra moltitudine specialmente è troppo avvezza a commedie, che dilettano e che rallegrano, per sperare che commedie d’un genere tutto diverso e quasi fra noi sconosciuto possano avere un favorevole accoglimento, voglio dire di quel genere che il citato signor Diderot chiama serio. Divide egli le composizioni drammatiche in cinque generi, cioè burlesco, comico, serio, tragico e meraviglioso, quantunque confessi che i veri limiti sieno il comico ed il tragico, essendo impossibile, egli dice, alla comedia di chiamare in suo soccorso il burlesco senza degradarsi, alla tragedia il meraviglioso senza perdere della sua verità; e consiglia, a chi si senta dell’inclinazione e del talento pel teatro, di appigliarsi al genere serio, che posto per dir così fra i due estremi, egli è ed il più facile ed il meno soggetto alle vicende del tempo e de’ luoghi. Egli lo distingue affatto dal genere che noi diciamo tragi-comico, che caratterizza di mostruoso, come quello che confonde due generi affatto distinti e separati da una barriera naturale. Nella tragi-comedia non si passa, dic’egli, per gradazioni insensibili, ma si salta dall’un estremo all’altro, quando nel genere intermedio quanto egli prende dei generi collaterali non può arrivare a sfigurarlo, e ne avrete sempre o una commedia nel genere serio o una tragedia domestica, che non sarà certamente meno interessante della tragedia da noi conosciuta. Di fatti, chi è che non abbia tremato in vita sua per i parenti, per gli amici, per se stesso? Una improvvisa rivoluzione di fortuna, il timor dell’infamia, le funeste conseguenze della miseria, una passione che conduca l’uomo alla sua rovina, dalla rovina alla disperazione, dalla disperazione ad una morte violenta, non sono avvenimenti rari e che dovrebbono, a mio dire, scuoterci e toccarci molto più che la morte d’un favoloso tiranno o d’un eroe dell’antichità! Poiché la compassione, che non è altro ch’una sostituzione che noi facciamo di noi stessi all’essere che vediamo soffrire, deve senza dubbio essere proporzionata ai gradi di probabilità che una tal sorte possa un giorno essere anche la nostra. Ma egli è tempo ormai di ritornare all’esame delle ragioni per le quali dubiterei che le mie commedie fosser per riuscire sul nostro teatro.
Dissi di sopra che spero d’avere in esse osservate scrupolosamente le regole dell’arte, ma una soverchia esattezza e regolarità di condotta raffreddano l’azione, e fanno languire l’attenzione degli spettatori, ch’ha di tempo in tempo bisogno per tenerla risvegliata di qualche cosa di piccante, quantunque un po’ irregolare. E finalmente potrebbe avere il destino d’una commedia che portasse sul nostro teatro i costumi delle passate età, tanto a’ dì nostri son diversi e disparati i principii su’ quali si cammina per definire una buona madre, per scegliere un marito; dice pur bene in questo proposito il nostro Orazio:
… Non di ceco amore | Vicendevol desire alterno impulso | Non di costume somiglianza or guida | Gl’incauti sposi al talamo bramato; | Ma la Prudenza co’ canuti padri | Siede librando il molt’oro, e i divini | Antiquissimi sangui; e allor che l’uno | Bene all’altro risponde, ecco Imeneo | Scoter sua face, e unirsi al freddo sposo | Di lui non già, ma delle nozze amante | La freddissima vergine, che in core | Già volge i riti del bel mondo; e lieta | L’indifferenza maritale affronta.
Ma questo appunto è il disordine preso di mira in questa commedia, e se l’esito non sia per corrispondere all’intenzione, sarà un difetto dell’autore, non mai del soggetto. Il costume, i pregiudizi possono talvolta soffocare e far tacere la voce della natura, i sentimenti che portiam scritti nel cuore; ma non distruggerla, ma non scancellarli a segno che al suono guerriero d’una tromba, al balenar d’uno scudo non si risveglino, non si riscotano e non tentino come Achille e Rinaldo di rompere gl’ingiuriosi ornamenti da’ quali sentonsi circondati ed oppressi.
Non è meno interessante e meno istruttivo il soggetto nella seconda commedia.[63] Non v’ha cosa più importante che di preservare la gioventù da quelle illusioni, che presentandole i beni che non possiede maggiori di quel che realmente sono e facendoglieli anticipatamente stimare più di quel che vagliono, le preparano poi un avvenire funesto e pieno d’inutili desideri e di continue inquietudini, di modo che da questo primo calcolo fallato dipende poi bene spesso la felicità o l’infelicità della lor vita. Il quadro che presenta questa commedia non solo può servire per mettere in guardia e far che s’abbia cura di tenerla ben lontana da tutto ciò che possa guastarle la fantasia, e specialmente dalla lettura della maggior parte de’ romanzi; ma per disingannare chi fosse già preso da questa malattia, malattia tanto più perniciosa, quanto che (come dice il signor di Marmontel, e la ragione e l’esperienza l’insegna) essa non attacca che l’anime sensibili e delicate.
Io ho procurato sì nell’una che nell’altra di scostarmi meno che mi sia stato possibile dall’originale che mi son proposto, cioè da’ Racconti morali del celebre signor di Marmontel che ne portano i rispettivi titoli, e credo d’averlo anche fatto esattamente, fin a quel segno però che lo soffre la differenza che passa fra una commedia ed un racconto. Differenza, ch’or che le commedie son fatte, non parrà forse molto grande agli occhi di coloro, che poco avvezzi ad analizzare tal sorta di oggetti, non son fatti per accorgersi delle piccole ed insensibili gradazioni delle cose e non sanno quanto sia penoso l’addattarsi ed il supplire alle altrui idee. Succede in questo caso ad uno scrittore quel che succede ad un architetto, che sia costretto di servire al disegno d’un già formato edificio.
Chi racconta, abbraccia quell’estensione di tempo e di luogo che più gli aggrada, e non è circoscritto da alcuna altra delle tante regole ch’obbligano inesorabilmente nella commedia e che restringono l’azione al più entro le mura d’una città, il corto giro di 24 ore ed un dato numero di persone. Egli è inoltre molto diverso il raccontare ciò che sia seguito dal metterlo in azione,[64] il render ragione del come e del perché ciò sia seguito; l’accennare ciò che dovrebbe dirsi in una data circostanza dal metterlo effettivamente in dialogo. Fa molto al mio assunto quanto leggesi nella prefazione del signor abate Conti nella sua tragedia di Marco Bruto: Il popolo greco, dic’egli, parlando d’un certo gusto e discernimento più fino, certamente lo avea, se al dir d’Aristotile tollerar non puoté in una tragedia che un attore escisse da un tempio in cui non era entrato. Non è difficile immaginar gli accidenti, ma bensì difficile d’assegnar la ragione verosimile e sufficiente, e molto più a legar queste ragioni tra loro, onde nascano dallo stesso soggetto o dal carattere dominante, e non da cose estrinseche ed immaginate dal poeta per l’accidente. L’arte di far entrare in scena e sortire gli attori senza stiracchiatura ed affettazione non è in pratica certamente la più facile.
Altra notabile diversità ella è quella che il racconto può essere accompagnato da circostanze che la commedia non può imitare, e resta per conseguenza priva d’un gran soccorso e d’un grand’ornamento. Caviamone, per fornirne un’idea, un esempio da quanto in altro proposito ne dice il più volte citato signor Diderot nel suo Discorso sulla poesia drammatica. Riterrò i versi francesi, ch’egli cita, per non alterarli colla traduzione. Eccoli:
Entre les deux partis Calcas s’est avancé, | L’oeil farouche, l’air sombre et le poil herissé, | Terrible et plein du dieu qui l’agitoit sans doute.
Dov’è l’attore che mi farà vedere Calcante qual egli è dipinto in questi versi? Egli s’avvanzerà con passo nobile e fiero. Egli avrà l’aria malinconica, l’occhio torvo e feroce; io mi accorgerò al suo portamento, al suo gesto del demone che l’agita e lo tormenta; ma per quanto egli si mostri terribile, i capelli non gli si rizzeranno sul suo capo. L’imitazione drammatica non arriva fin là. Dicasi altrettanto delle successive imagini che animano quel racconto: un’armata in tumulto, la terra bagnata di sangue; una giovine principessa trafitta il seno con un pugnale; lo scatenarsi de’ venti; l’agitarsi ed il muggire del mare; i tuoni, i lampi, tutto si può dipingere da un poeta. L’imaginazione vede tutte queste cose; ma l’arte non può imitarle.[65] E chi volesse d’una tale diversità una maggiore, più pratica e più autentica riprova, sappia che lo stesso signor di Marmontel, che riuscì sì mirabilmente e con tanta gloria ne’ suoi racconti, non ebbe poi presso il pubblico un eguale incontro colle sue opere drammatiche.
Se questo basta per far vedere quanta sia la differenza che passa fra una commedia ed un racconto, non basta meno per farmi comprendere quanto sia ragionevole e fondata la ripugnanza ch’io mostro di dare al pubblico le commedie trasmessevi.
Ma poiché siamo in proposito di teatro risponderò, sebbene un po’ tardi, a quanto mi fu da voi scritto in occasione che aveste costì la compagnia de’ comici francesi, cioè che sia sembrato universalmente che gli attori esaggerassero troppo l’azione col gesto, colle attitudini e colla passione. Compatisco i vostri concittadini se passando di slancio dalla mortal indolenza de’ nostri comici agli animati quadri del teatro francese ne furono a prima vista un po’ sorpresi. Il salto era troppo grande, ed è successo loro quel che succede a chi da un’oscura dimora sorte direttamente alla gran luce; e son sicuro che se la compagnia fusse dimorata più lungamente, si sarebbero ben presto accomodati a questo nuovo gusto di declamazione ed avrebbero finalmente capito che la rappresentazione teatrale è un’azione, non un semplice dialogo od una semplice conversazione.
Convengo però che questi colpi arditi d’espressione devono essere rari e necessari, e che moltiplicati inutilmente moveranno il riso in vece delle lagrime. Ma io vidi altrove, non è gran tempo, gli stessi attori, e se non sonosi guasti, non si poteva loro certamente rimproverare un tale eccesso. Voglio copiarvi qui ciò che ne dice l’autore[66] di cui il signor Diderot, nel citato suo Discorso sulla poesia drammatica, non dubita di proferire che s’egli avesse su questa materia a riconoscere in terra un’autorità infallibile sarebbe la sua. La declamazione, sono le parole del detto autore, che fino a la Couvreur non fu che un recitativo misurato, frapponeva un nuovo ostacolo a que’ trasporti della natura che meglio si dipingono e s’esprimono con una parola, con un gesto e con un grido che sfugge al dolore. Noi non cominciammo a conoscere questi tratti che dopo la Dumesnil, allorché nella Merope cogli occhi stravolti, la voce interrotta, alzando una mano tremante, ella stava per immolare il proprio figlio, quando, trattenuta da Alerbas, lasciando cadere il pugnale fu veduta svenire fra le braccia delle sue donne, e quando passando da quello stato di morte ai trasporti d’una tenera madre, slanciossi agli occhi di Polifonte, e traversando in un batter d’occhio tutto il palco, pallida, singhiozzando e colle braccia alzate, s’udì gridare: Barbaro, egli è mio figlio. Qualche cosa di superiore ancora, s’egli è possibile, fu l’azione della Clairon e dell’attore che rappresentò da Tancredi nel terzo atto ed alla fine del quinto. Giammai gli animi de’ spettatori furono scossi sì vivamente e con maggior forza; giammai sì abbondanti colaron le lagrime. La perfezione degli attori s’è spiegata in questi due incontri con una superiorità di cui fin a quel punto noi non avevamo idea, e la Clairon è divenuta, non v’ha dubbio, la più gran pittrice di tutta la nazione. Senza questo, dice Sant’Evremont, la tenerezza tien luogo di pietà e di compassione, la commozione di sorpresa, la sorpresa d’orrore, e lascia mancare ai nostri sentimenti un grado abbastanza forte e profondo d’intensione. Il signor Diderot porta, a mio dire, molto più lungi non solo l’utilità, ma la necessità dell’azione e della pantomima che accompagni il discorso, e fa vedere come si potrebbe sostituire ad una gran quantità de’ nostri a parte[67] quanto ci potrebbe servire per abbreviare e rendere più espressivo lo stesso discorso, e quanto pregio ed uso ne facessero gli antichi, ed arriva perfino a consigliare di abbandonare quasi intieramente alcune scene agli stessi attori (qualora però siano abbastanza conosciuti). Poiché cos’è, egli dice, che più ci scuote allo spettacolo d’un uomo agitato da una gran passione? I suoi discorsi alcuna volta; ma ciò che sempre ci commove sono i gridi, le parole inarticolate, le voci interrotte, alcuni monosillabi che di tratto in tratto gli sfuggono, un certo fremito ec. La violenza del sentimento interrompendo la respirazione e portando il turbamento nello spirito, si dividono le parole, l’uomo passa da un’idea all’altra. Comincia molti discorsi e non ne termina alcuno, ed eccettuati pochi sentimenti, ch’egli prononcia nel primo impeto ed ai quali ogn’or riviene, il resto non è che un suono debole e confuso, accenti interrotti e soffocati, che l’attore conosce assai meglio dello stesso poeta. La voce, il tuono, il gesto, l’azione appartengono all’attore, ed è ciò che più ci penetra specialmente ne’ spettacoli delle gran passioni. Egli è l’attore che dà al discorso tutto quel ch’egli ha di più energico; egli è che porta all’orrecchio la forza e la verità dell’accento, poiché a che serve al poeta l’imaginare i quadri, se gli attori restano immobili nella simetrica lor disposizione, nei compassati lor movimenti?[68]
Dopo testimoni sì autorevoli e decisivi io non saprei che soggiungere circa l’importanza della pantomima, dell’azione e de’ quadri nelle teatrali rappresentazioni, e finirò col dirvi che la cattiva maniera di recitare e di rappresentare de’ nostri comici non lasciando sperare assolutamente un gran successo, essa non è forse l’ultima delle cagioni che allontanano gli uomini di merito dal teatro italiano e lo tengono nell’attuale vergognosa mediocrità. L’esame, l’analisi di queste cagioni sembrami, amico, ch’esser potrebbe un soggetto molto utile e molto opportuno per uno de’ vostri fogli. Io sono ec.
S. [Pietro Secchi]
IL CAFFÈ )( Fogl. XXI )(
Comentariolo di un galantuomo di mal umore che ha ragione, sulla definizione: L’uomo è un animale ragionevole, in cui si vedrà di che si tratta
Dappoiché sonosi veduti comparire nel mondo sublunare tanti trattati e trattattini e trattattelli di logica, certo che l’uman genere dovrebbe ragionare a meraviglia. Malgrado però tutti questi soccorsi, la vita de’ mortali è un continuo e profondo sonno di errori, dal quale si svegliano di tempo in tempo per fare cogli occhi ancora mezzo addormentati un sillogismo, e poi ricadere nel sonno. Altri stanno desti un momento e fanno un buon madrigale o un buon sonetto, altri vi stanno un po’ più e fanno lo Spirito delle leggi, ma poi subito tornano a dormire nel libro de’ feudi e nel capitolo del cambio, altri stanno desti a spiegare l’attrazione dell’universo, ma poi subito dormono nel comentare l’Apocalisse, ed è grand’uomo chi sta veramente svegliato per un considerevole spazio di tempo.
Se gli animali avessero la tanto meravigliosa e funesta arte di scrivere, e che ritrovassimo negli archivi reali degli elefanti, e de’ castori molti trattati sullo instinto, e che vi trovassimo il loro instinto di Port Roïal, non avremmo noi diritto a sospettare che conviene che ne abbiano ben poco, se fanno tanti libri per insegnare ad averlo?
Se il far entimemi e sillogismi fosse cosa comune all’uomo, non si avrebbe bisogno di tanto apparato di precetti per acquistare codesta facoltà che chiamiamo arte di ragionare. Non vi sarebbero tanti occhiali di Venezia se non vi fossero molti miopi e molti presbiti, non vi sarebbero carozze se le gambe non si stancassero, le arti non avrebbero tanti ordigni se la mano dell’uomo avesse forza, agilità e durezza tale da poter far di meno di questi ordigni. Dove l’arte supplisce alla natura, stiamo male certo di natura. I tanti volumi di logica provano che ne manchiamo, e provano talvolta per isfortuna che anche i loro autori aveano l’istesso bisogno. Dove sono i libri che insegnino la tanto bella facoltà di mangiare e bere? Questa sarebbe una impertinenza; l’uman genere mangia e beve a meraviglia senza che alcuno gli faccia il maestro. Sentiremmo delle dicerie e delle rappresentanze contro gli autori dell’arte di mangiare e di bere. Ma contro chi c’insegna gli atqui e gli ergo ed il barbara celarent Darii ferio, i primi elementi in somma di ridurci a quel gran passo di balbettare alla meglio maggiore, minore e conseguenza, contro di costoro, dissi, non si faranno querele? Prudentissimi mortali, io vi lodo del vostro silenzio, egli vi convince che non vi vergognate di tacitamente confessare aver voi bisogno di chi v’insegni a far gli ergo e gli atqui.
Io non farò torto al gener umano, io gli sono buon amico, ma quale pretensione è questa di esser animale ragionevole? Certamente egli lo è; ma quanti minuti in un secolo lo è egli? Questo è il problema che mi propongo di sciogliere, e che potrò sciogliere passabilmente se m’incontro in uno di que’ minuti. Intanto per ora stia in sospeso l’esimio titolo che si è arrogato l’uomo di re degli animali.
Chi dubitò che il picciolissimo pesce remora non fermasse i più grossi vascelli? Nessuno per molti secoli. Certo saravvi stata una qualche gran bella dimostrazione di cotanto incredibil fenomeno. Ecco, o uomini, qual era quella dimostrazione di cui vi contentaste. Le prime qualità, dissero gravemente i vostri dottori, sono in guerra fra loro. Il vascello è umido, la remora è secca, il secco è più attivo dell’umido, ond’è chiaro che la qualità secca del pesce deve vincere la qualità umida del vascello, e per necessaria conseguenza fermarlo. Si scrissero, si stamparono, si credettero simili ragioni, i dottori le insegnarono, i scolari le impararono a memoria, nessuno ebbe la bontà di farne l’esperienza, ognuno fu contento della bella dimostrazione, e si dica poi che gli uomini sono incontentabili!
L’erba lunaria maggiore ha tal forza di corrodere il ferro, che se un cavallo gli passa sopra egli si sferra; si pesa più digiuno che dopo mangiato; un tamburro di agnello scoppia al suono di un tamburro di lupo; il corrallo è contro al timor panico ed alle grandini; il dolore de’ denti cessa toccandoli colla calamita tenendo la bocca aperta verso il Polo; i galli talvolta partoriscono de’ piccioli uovi senza giallo, e covati nel lettame partoriscono il famoso basilisco, che è poi buono a tante cose; le cavalle s’ingravidano col soffio de’ venti: Varrone, Solino, Columella, Livio ed altri gravissimi autori lo danno per fatto costantissimo; le donne eziandio hanno la stessa prerogativa secondo la opinione di altri egualmente gravissimi autori, di massime un po’ rilasciate; se il lupo vede prima l’uomo ei resta immobile, al contrario se l’uomo vede prima il lupo ei resta parimenti immobile e perde la voce. Dove lascio la fenice che si abbruggia, e ch’è sempre una sola, dove la salamandra che non s’abbrucia nel fuoco, dove lo scorpione che ammazza l’uomo col suo veleno, dove il mettere un enorme pezzo di legno in bocca delle donne morte col figlio nel ventre perché egli respiri in tal foggia, quantunque nell’utero viva il figlio senza respirare, e se respirasse non comunicherebbe per la bocca della madre coll’aria esterna, dove la bacchetta divinatoria che discopre le sorgenti, le miniere ed i tesori, dove tante altre belle cose, credute tanto tempo, e delle quali cominciano appena i saggi a potere farne di meno? Per qual via v’entrarono tante amene cognizioni se non se per la vastissima porta della vostra imbecillità?
Che può fare contro i tamburri di lupo, l’erba lunaria, il basilisco e la salamandra il povero saggio? Quando voi credevate che l’ecclisse della Luna e del Sole fosse una guerra arrabbiatissima che fra di loro facevansi, sicché soccorrevate la povera Luna con uno grandissimo strepito d’istrumenti, come pur ora fate nella Persia e nel Regno di Tonchino, quando credevate che la Luna in tal tempo combatteva con uno sterminato dragone, quando credevate che fosse un terribile demonione colle griffe nere che acchiappasse il Sole e la Luna, onde vi cacciavate, com’ora fate, poverini, nelle Indie Orientali, dentro ne’ fiumi sino alla gola inclusivamente perché avete la docilità di lasciarvi dar ad intendere che in tal guisa fate coraggio al Sole ed alla Luna a difendersi dalle griffe nere di quel terribile demonione, quando i coltissimi Greci, che supponevano di fare una gran bella figura in questo mondo, credevano che la Luna fosse oscurata a forza d’incantesimi in tempo d’ecclissi, ed i maghi aveano la onestà di farla discender dal cielo, com’essi vi assicuravano ingenuamente, e di farle sputare su certe erbe una velenosa schiuma, come volevate che il povero ed oscuro saggio ardisse spiegarvi come veramente si passassero codeste cose? Sapete cosa accadeva? V’era egli un Anassagora che non imbarazzandosi dei sputi neri della Luna avesse conosciute e spiegate le fasi lunari, dal che avreste poi facilmente potuto comprendere anche la cagione degli ecclissi? Lo scritto di questo galantuomo era tenuto segreto, e non se ne lasciava saper nulla a voi altri dilettissimi uomini, che avreste fatto correre al vostro solito colle sassate chi voleva togliervi il sommo piacere di cacciarvi ne’ fiumi sino alla gola, di credere ai dragoni delle griffe nere, alla guerra del Sole, ai demonioni ed a’ sputi velenosi della Luna. Cosa può fare il saggio tutt’al più in tali casi? Quello che fece Agatocle passando in Africa.[69] Sopravenne uno ecclisse solare, che ridusse il suo esercito ad una estrema desolazione. Se vi avesse detto che il Sole si oscurava perché la Luna era in quel momento interposta fra esso e noi, oh, stava fresco Agatocle! Ma egli, uomo di mondo che vi conosceva, interpretò il presagio in suo favore. Se il Sole, diss’egli, si fosse impallidito prima del nostro imbarco, miseri noi! Ma rendiamo grazie agli dei, egli s’impallidì dopo la nostra partenza, onde egli è un presagio contro de’ nostri nemici. La cosa era chiara; l’esercito fu convinto, il timore se ne andò, si credette d’aver propizio il Sole, perciò di vincere, e si vinse di fatti. Tenetevi da conto, o saggi, o legislatori, questo metodo, in tal maniera otterrete tutto quel che volete. Questo è il solo caso in cui sia umanissima cosa l’ingannare gli uomini, quando da errori nocevoli si traggono in errori utili. Non fate come il console Giunio Pulcro, che andando contro Cartagine e prendendosi al solito gli auspicii de’ polli, avendo veduto ch’essi non volevano mangiare: ebbene, diss’egli, se non vogliono mangiare vadino costoro a bere, e gettolli in mare. Tutti i volti s’impallidirono, tutti i cuori palpitarono a questa empietà: si avvilirono i soldati, credettero che fossero irati gli dei per questo disprezzo de’ loro auspicii, e credendolo furono sconfitti perché un’armata tremante non vince. Il console dovea dare la buona mano ai guardatori de’ polli perché lor facessero ben bene patir la fame, così avrebbe vinto. Tenetevi da conto, o saggi, o legislatori, questo metodo, in tal maniera otterrete tutto quello che vorrete.
Secondo la buona astrologia sette essendo i buchi della testa, sette pianeti sono incomodati a presedervi. Quindi l’orecchia destra è consegnata a Saturno, la sinistra a Giove, la destra nare a Marte, la sinistra a Venere, l’occhio destro al Sole, il sinistro alla Luna, la bocca a Mercurio. I segni del zodiaco anch’eglino hanno le loro possessioni sul corpo umano, i naturali differenti hanno il loro pianeta dominante, com’è noto. Chi nasce sotto il dominio del Sole è bello, franco, magnanimo; chi sotto Venere, ricco e voluttuoso; chi sotto a Mercurio, di buona reminiscenza e scaltro; chi sotto la Luna, incostante e valetudinario; chi sotto a Saturno, sfortunato; chi sotto a Giove, equo ed illustre; chi sotto Marte, felice e valoroso. Non dirò nulla delle dodici case in cui dividono gli astrologi il cielo, nulla de’ sei aspetti, delle sei famigliarità, della congiunzione, della opposizione del trino e del quadrato, del sestile, dell’esagono e dell’antisco, nulla dico de’ pronostici che si cavano dalle rughe della fronte e del palmo delle mani, dove i pianeti tutti hanno i lor grandi affari; lascio le quattro semplicità ed i cinque alfeti a lor luogo, e tutta questa preterizione io faccio pel rispetto che professo alla umana prosapia. Eran queste le inezie, uomo misero, uomo imbecille, che dovevi apprendere dall’aspetto d’un cielo immenso, d’una sterminata folla di mondi, e da uno interminabil aggregato di universi? Verme di fango, che nel fango ti strisci, come paragonando, miserabile! questa tua meschina figura, pidocchio dell’universo, colla vastità e magnificenza della natura osasti trarne sì lepida conseguenza ch’ella è tutta occupata di te; e quel Sole animatore del mondo e meraviglia del cielo, un milione di volte più vasto di questa tua palla su cui gli giri d’intorno, hai tu potuto credere che fosse occupato a custodirti il tuo occhio dritto quando un vaiuolo, una cataratta, una gotta serena, una spilla, un pugno ti fanno guercio? Fu, per avventura, la persuasione, che l’universo vegliasse ognora sull’uman genere che diede al Sole ed alla Luna gli occhi, il naso e la bocca, quasiché stasser sempre guatandoci dall’alta volta de’ cieli con que’ loro gran visi benignamente. Eppure tutte le volte che verso d’entrambi si fissasse lo sguardo, era pronto il disinganno. Sì fatte amenissime cognizioni abitarono nella glandola pineale, o nel cerebro, o nel cerebello, o nelle meningi, o nella pia madre, o nella dura madre, o nel sangue, o nel cuore, in sostanza nella sede di ciò che esiste certo, ma che non può né sedere, né giacere in luogo alcuno, cioè nella bella mente della ammiranda umana prosapia con applauso universale del pubblico, il che fa che io mi dichiari divoto e rispettoso servitore della stessa ammiranda prosapia.
Quali gran prede non fece l’astrologia? Un Licurgo, un sì gran legislatore, fece una legge in cui proibiva agli Ateniesi di combattere prima della Luna piena,[70] così in Luna crescente potevano esser battuti comodamente gli Ateniesi. Ipocrate, quel gran maestro della più importante ed incerta facoltà, è pieno nelle sue opere immortali di astrologia, e fonda su di lei buona parte della sua medicina. Il grande Enrico IV diede ordine al medico La Riviere di far seriamente l’oroscopo al Delfino, che fu poi Luigi XIII. Non teneva già La Riviere come un buffone, egli era il suo primo medico di corte. Quanto non fu celebre in Francia l’astrologo Morino? Il cardinale Mazzarini lo consultava spessissimo e lo pensionava. Il cardinale di Richelieu governava una vasta monarchia, disprezzava il gran Cornelio e non si partì per andare a Perpignano prima di aver consultato l’oracolo di Morino. Il conte di Chavignì, segretario di Stato, non prendeva risoluzione senza sentir Morino. Eppure il gran secolo di Luigi XIV era già spontato. Il gran Bacone di Verulamio, padre della fisica, non ha egli nelle sue opere immortali delle buone pennellate di astrologia? Dunque codeste persone avranno creduto ai talismani? Avranno creduto che alcuni pezzi di metallo fusi ed incisi di vari geroglifici sotto favorevoli aspetti di pianeti sieno come cassette, o sponghe che conservino e s’inzuppino delle celesti influenze, onde portati indosso producano gl’istessi benigni effetti come se quel tale fosse veramente sotto quella tale benefica influenza? Certo che sì. Non v’è contagione che più si diffonda di quella degli errori del secolo; gli uomini più grandi durano gran fatica a preservarsene. L’astrologia giudiziaria è stata il delirio di tutte le genti, e di tutti i grandi uomini quand’era il delirio di tutte le genti. Ella è forse la più vecchia chimera del mondo. Non ve n’è forse tuttavia la sua buona dose nei nostri almanacchi, non ne balenano ancora gli estremi lampi anche ne’ gran poeti in quelle loro barbare stelle, ed astri spietati? Ed il dire qual astro splendeva al nascer mio, non è egli un oroscopo fatto in fallo da chi non crede punto agli oroscopi? Ci serviamo tuttavia della lingua astrologica, perché la lingua degli errori ch’ebber vita sì lunga non muore con essi. Non sembrano sconvenevoli queste espressioni, perché appena cominciamo a non esser astrologi.
I Romani, i vincitori del mondo, portavano ne’ loro trionfi un talismano con sé, e credevano esser questo un preservativo contro l’invidia.[71] Dunque i Camilli, i Scipioni, i Marcelli portavano quest’inezia? E perché no? Mario e Silla, que’ due sì celebri mostri, non erano eglino donnicciole in alcune cose, tigri in alcune altre? Mario era estremamente timido de’ cattivi augurii. Avendo una volta veduti due scorpioni che attaccavano zuffa fra di loro sulle rive del mare, avea risolto di andare in Africa, e prendendo la guerra di questi due insetti per un augurio pessimo non vi volle andare. Silla portava al collo una statuina di Appollo, e fu veduto ne’ maggiori pericoli delle battaglie a dirigere le più fervide preghiere al suo Appollinino. L’uomo è un animale capace di qualunque contraddizione, l’uomo grande ha le sue debolezze, e massimamente quelle di moda. Esse sono tanto comuni, assediano tante volte al giorno la ragione, che se non foss’altro per indolenza si lascia ella vincere. Quanti ora parlano dell’attrazione neutoniana come di una verità dimostrata, la quale sarebbe uno scandalo porre in menomo dubbio: ma quanti hanno letti i libri di Neuton e ne parlano con cognizione di causa? A che sono debitori tutti questi pappagalli di non esser in errore se non se al caso che fa che veramente il sistema neutoniano sia dimostrato? Se a suo luogo vi fossero gli atomi di Democrito o l’armonia delle sfere del buon Pittagora, e che fosser di moda gli atomi e l’armonia delle sfere, si darebbe nell’errore. Così fu la sorte dei sistemi di mano in mano. Molti uomini grandi furono passionatissimi per quella ingegnosa favola dell’universo di Cartesio, ch’ei fu il solo per tanto tempo che avesse chiamata fabella mundi. Gli uomini grandi, in quella classe di idee che si sono posti ad analizzare, cercano la verità e ve la ritrovano; se loro avviene di far delle scorrerie in altri studi alieni dai loro, seguono le opinioni de’ tempi, perché se non ne sono convinti prima di esaminarle, non sarebbe decenza il chiamarle false senza dimostrarle tali. Si appigliano al più sicuro partito. Così possono esser creduli anche i grand’uomini, ma lo sono per cautela più spesso che non per imbecillità.
Tutto un tempo fu astrologia. La medicina era piena d’influenze e vuota di fisica. La numerosa scuola di Paracelso fu un seguito di pazzarelli che si trasmettevano da maestro a scolare i loro deliri. Il Sole influiva sul cuore, la Luna sul cervello, Saturno sulla milza, Mercurio sul polmone, Venere sulle reni, Giove sul fegato, Marte sul fiele. Quindi insegnavasi colla consueta gravità della cattedra che il giovine medico deve prima di tutto conoscere nell’uomo la coda del Dragone, l’Ariete, l’Oriente e l’Occidente.[72] Il grand’avo di questi pazzarelli, l’esimio Paracelso, insegnava dottamente la maniera di far gli uomini vivi colla alchimia.[73] Egli era poco tranquillo sul conto di quest’arte, madre di belle e di ridicole cose; così rivolge in un sito il suo discorso a’ medici:[74] Tutto ciò ch’è compreso fra’ due Poli mi sarà di aiuto, perché io affoghi nel lago di Pilato (egli l’avea di spesso con questo lago di Pilato) la vostra astrologia e le effemeridi de’ vostri salassi. Colla mia alchimia ridurrò in sali alcali a forza di fuoco di riverbero i vostri Esculapi e Galleni e tutti i vostri scrittori. Da qui si vede che Paracelso, dopo di aver creduto molto alla astrologia com’ei fece, s’era poi rivolto al serio dell’alchimia. Si disse di lui che sapea tutto lo scibile; ed a ragione, perché i deliri del suo tempo gli sapeva tutti a meraviglia. Si vantava d’aver fatti vivere molti uomini per più secoli e d’aver l’arte di far l’oro: di fatti morì d’anni quarantasette e poverissimo. Chi si disingannò per questo delle sue chimere? Fu dopo di lui generalmente creduto dagli alchimisti che un certo Artefio per virtù di quest’arte visse mille e venticinque anni precisamente. Oh poveri cani barboni, sapientissime bestie, se un giorno avrete dei Titi Livi e degli Erodoti che scrivino le cose vostre, non vi troveremo, io spero, degli Artefi barboni o de’ barboni fatti ne’ fornelli piuttosto che nell’utero delle vostre barbone! Che baronata non è questa, mi par che diranno i vostri Grozi, che baronata non è questa, contraria ad ogni diritto della natura e delle genti, che noi dobbiamo portare di notte la nostra lanterna in bocca avanti dell’animale bipede ed implume, avanti dei Paracelsi che sono propriamente i pazzarelli degli animali, ch’hanno essi soli nelle due dita della orgogliosa lor fronte più errori e più straniezze che non ne abbia tutto il cagnesco nostro genere? Che bricconata non è questa, che i nostri confratelli debbano far girare su di un ferro gl’insanguinati quarti de’ poveri buoi e de’ meschini vitelli, de’ polli miserabili, perché si abbrustoliscano e le divori il carnivoro uomo? Noi adunque dentro di una ruota di legno faremo girare ansando con fuori tanto di lingua l’arrosto d’Abelardo e del padre Bouhours, che insegnarono come tutti gli uomini abbiano uno specchio nella testa in cui l’anima vede le idee, e che gl’ingegni chiari e penetranti hanno pulito e mondo questo specchio, ed appannato e fosco i rozzi? I nostri confratelli dovranno adunque correre abbaiando dietro alle lepri fuggitive ed alle politiche volpi, ed insidiare le quaglie nelle caccie proibite de’ feudi de’ Cardani, ch’era persuaso[75] che la pelle del piè destro dell’avvoltoio guarisce la gotta del piè destro dell’uomo, e così quella del sinistro piè il piè sinistro; che il cordone dell’umbilico del fanciullo appena nato, e tagliato, portato in un anello d’argento guarisce la colica? Dove trovate conforme al diritto di natura e delle genti che naschiamo non liberi, ma servi di un Agrippa che credeva[76] che gli occhi cisposi si guariscono mettendo al collo gli occhi delle rane? Qual dei nostri confratelli animali ha mai cotanto delirato come questi tiranni che ci fanno strascinare le carrette in un paese e ci adorano in un altro? Imbecilli o crudeli, secondo i vari meridiani, sotto ai quali nascono! Uomini, non abbiamo le vostre cognizioni, ma tampoco i vostri vizi. Eppure quale eccesso di acciecamento di chiamarci automi? Quale colmo d’ingiustizia, paragonando i miti nostri costumi colla vostra ferocia, di aver messa fra le ingiurie maggiori il nostro nome chiamandovi cani gli uni gli altri per contumelia? Così voi chiamate i Turchi, così i Francesi vengono chiamati dagli Inglesi, quasiché noi non fossimo i migliori vostri amici, i compagni più dolci ed attenti della vostra vita. Non avremmo noi miglior diritto di chiamare i nostri confratelli, quando per disgrazia arrabbiano, uomini? Il genere umano potrebbe stipendiare cinquanta de’ buoni avvocati a dir le sue ragioni in iure, ma non risponderebbe plausibilmente ad un solo can barbone. Non vi sarebbe che la dotta antichità che farebbe buona figura in tal causa. Filone, Plutarco, Stratone, Enesidemo, Parmenide, Empedocle, Democrito, Anassagora, Pittagora ed il divinamente noioso Platone insegnarono che le bestie aveano anima ragionevole. Oh dotta antichità, esclamerebbe il cagnesco
IL CAFFÈ )( Fogl. XXII )(
amor proprio, maestra del vero, oh corruzione delle menti offuscate de’ perversi tuoi figli! Finché foste vicini allo stato di natura, e che eravate poco dissimili da noi, ci avete resa giustizia, ci avete accordato un intendimento pari al vostro, ma dappoiché siete degenerati da questo stato, e dappoco più di scimiotti ch’eravate avete messa parrucca, borsa e manichetti, non si può più trattare con voi, siete divenuti impertinenti, simili a chi tra di voi fa fortuna, che riguarda i suoi confratelli come animali ai quali appena accorda la facoltà d’intendere. Nascondete adunque, miei fratelli uomini, nascondete per pietà agli elefanti ed ai castori i dieci zefirot, le cinquanta porte d’intelligenza, la virtù del dieci e del numero sferico, li trentadue sentieri della sapienza, la trombetta di Giuda, le scienze della onomanzia, negromanzia, idromanzia, lecanomanzia, aereomanzia, gastromanzia, amnomanzia, catopromanzia, alfitomanzia, coscinomanzia, cefalainomanzia, rabdomanzia, xilomanzia, ceromanzia, piromanzia ed il morso velenoso delle pecore, nascondete, nascondete per pietà alle pecore istesse queste vostre scappate che per distrazione faceste. Che gli elefanti non le sappino, che i castori non le sospettino, vi vuol prudenza, zitto, zitto.
Ci fanno ridere di tutto cuore i Caraibi, i quali credano che la Luna non compare che di notte, perché essendo ella nata prima del suo fratello il Sole, poiché vide la di lui gran bellezza, si nascose per vergogna agli occhi suoi, onde s’appigliò al partito di non lasciarsi vedere che di notte. Ci fanno ridere di tutto cuore gli Uroni,[77] i quali tengano per sicuro che la Terra è forata per mezzo, e di quel buco passa la notte il Sole. Ridete pure, miei fratelli socievoli, uomini di città, uomini addomesticati. Ridete di que’ meschini selvaggi che sono tutt’altra cosa che voi, vendeteli pure una sessantina di pezze o di guinee al paio, ma abbiate almeno la destrezza di nasconder loro che la dotta antichità si vanta di un Xenofane, il qual credeva che le stelle si estinguevano di giorno e si accendevano di notte come candele; si vanta della pittagorica setta, i di cui seguaci credevano che la Via Lattea fosse propriamente un gran fiume di latte, il quale serviva di alimento alle anime che si stavano sulle di lui sponde, aspettando la metemsicosi; si vanta di un Zenone, il quale diceva che la Luna era un foco artificiale; di un Epicuro, nella di cui testa in mezzo degli atomi risiedeva anche questo atomo di bontà filosofica, che il Sole alla sera si estingue nel mare. Ed Epicuro cotanto empio, cotanto ardito contro le volgari credenze se ne stava quieto su di tal conto, né era punto imbarazzato a far estinguere tutte le sere ed accender tutte le mattine una sì piccola torcia. Che più? Nel tempo della maggior coltura de’ Romani, nell’aureo secolo il nostro accreditatissimo Lucio Floro ci porge la vaga notizia che nelle Spagne Decimo Bruto cadentem in maria solem, obrutumque aquis ignem, non sine quodam sacrilegii metu, et horrore deprehendit.[78]
Perché tanto meravigliarci che nel Messico si sagrificassero a Visiliputzi i prigionieri, se nel coltissimo popolo romano dopo il trionfo si ammazzavano i re nel Campidoglio in vittima a Giove Ottimo Massimo e si seppellivano nel foro i prigionieri in sagrificio a’ dei d’Averno? Non s’immolavano forse nella commerciante città di Cartagine i propri figliuoli a Saturno? Non v’erano i gladiatori alle cene de’ Romani? Il grande Augusto in mezzo degli Orazi e de’ Lucrezi, de’ Virgili, de’ Mecenati, degli Agrippa e de’ Ciceroni portava sempre sopra di sé la sua buona pelle di cane marino, perché credeva ch’ella preservasse dal fulmine.[79] Il padrone del mondo temeva ciò che non temono i nostri villani, ed impiegava sì ridicolo mezzo per difendersene. Nel nostro secolo decimottavo, ch’è un altro gran secolo aureo dopo quello di Augusto, non si ritrova egli, nella Storia di un ceto così rispettabile qual è l’Accademia delle Scienze di Parigi, che fu veduto in quella capitale delle belle cose un persiano che tirava fuori dalle gengive quando voleva otto o dieci denti e che li rimetteva colla stessa disinvoltura?[80] Se non giungessero a’ nostri posteri che i denti di questo persiano, ci chiamerebbero Caraibi ed Uroni. L’uomo è sempre imbecille: fa dei sforzi per arrampicarsi allo scoglio della verità, zoppicando vi giugne, e di tempo in tempo anche colà su fanciulleggia. Rispettiamo la nostra coltura, consoliamoci d’esser esciti or ora dalla barbarie civile più funesta ancora della selvaggia, procuriamo di ricadervi più tardi che si può, ma siamo modesti ed abbiam sempre nella nostra mente una celluletta destinata alla gran foriera del vero, la diffidenza. La cabala, l’alchimia, l’astrologia, le più ridicole credenze, gli errori i più mostruosi, il morso velenoso delle pecore ci stanno aspettando. Un momento che taccia la ragione e l’opinione regni, addio umana stirpe, tu ritorni a’ tuoi deliri, ed a rivederci quando ti sveglierai. Simile alle comete, che s’avvicinano al Sole per tosto rapidamente allontanarsi da lui, immergersi negli immensi vuoti dell’universo; e per non ritornare ad infiammarsi della divina sua luce che dopo lunga serie di secoli.
E sai perché? Perché l’origine degli errori la porti sempre teco, ed è uno sforzo, che fai ad esser dotta. I tuoi timori, l’inclinazione al meraviglioso, i sonni or gravi, or tristi della tua immaginazione, l’inganno de’ sensi nelle fisiche cose, sono inesauste sorgenti di tante straniezze che fecero di mano in mano il giro del nostro globo. Egli è contro l’apparenza de’ sensi che la Terra giri d’intorno al Sole e che sia un milione di volte più piccola di lui, egli è conforme alla umana imbecillità di credere stranissime cose quando s’oscura il Sole, e impallidisce la Luna, egli è conforme al sentimento della nostra debolezza il lusingarci che tutte le cose che ci stanno d’intorno ci possino nuocere od esser utili, quindi antipatie e simpatie dappertutto; egli è conforme all’amor proprio non illuminato dell’uomo ancor mezzo selvaggio di rapportar tutto l’universo a se stesso, perciò influenze buone e cattive in tutti gli astri, ch’ei crede non più che lampade che pendono dalla concava volta de’ cieli. Non v’è da meravigliarci dei lunghi nostri deliri; siamo fatti per averne d’ogni sorta, altro non v’è che averli corti, rari e non feroci. A rivederci da qui a mille anni a far di nuovo la guerra, ed a spargere il nostro sangue un’altra volta per i nominali ed i reali.
Fu opinione di Aristotile che ne’ porti di mare non si muore che nel tempo del riflusso.[81] Questa tanto probabile dottrina discese senza contrasto di generazione in generazione fino a’ nostri giorni. Passò al traverso di tutto il secolo aureo di Alessandro Magno, e di quell’altro parimenti aureo d’Augusto, e del nostro similmente aureo secolo mediceo senza il menomo incomodo di un così lungo viaggio. I medici delle città marittime di Francia, di Ollanda e d’Inghilterra la credettero dottamente, finché un certo commissario della marina in Brest s’avvisò di fare negli anni 27, 28, 29 di questo secolo delle sperienze di fatto, e ritrovò che dai registri risultava che n’erano morti più nel tempo del flusso che in quello del riflusso, e seguitandosi a ripetere le esperienze, si ritrovò la veramente gran meraviglia non mai veduta da Aristotile sino al commissario di Brest, che appresso a poco tanto si muore in flusso che in riflusso, ed in uno dei due certamente. Se le verità avessero vita sì lunga quanto gli errori, gran bella razza che sarebbe la nostra; e molto più se le verità dimostrate si lasciasser star quiete per più di due mille anni, come si lasciano tranquilli gli errori di così facile distruzione! Ma pure le cose vanno diversamente in questo mondo. Il vino emetico pugnò un secolo, prima di potere impunemente purgare le umane budella e rispettosamente insinuarsi nell’intestino colon, perché le umane budella e gli intestini colon non volevano purgarsi così per tutto l’oro del mondo. La stampa ebbe i suoi grossi guai ch’io passo sotto silenzio; l’inoculazione è una detestabile invenzione anche dopo la metà del secolo decimottavo ne’ più colti paesi; la fisica nelle bombarde, ne’ cannoni, nelle palle infuocate e nelle mine non trovò difficoltà, le matematiche e la stessa fisica, dirette alla utilità degli uomini, furono accusate di stregonerie e trattate in conseguenza.
Gran quantità di autori, altri in quarto, altri in foglio hanno detto che si ritrovano nelle Indie degli uomini cinocefali, cioè colla testa di cane, i quali abbaiano.[82] Sono ripieni gli antichi scrittori[83] di razze umane stravaganti. I Ciclopi, ossia Arimaspi di un sol occhio, gli Etiopi di quattr’occhi, gli Astromi che si nutrono di soli odori, perché non hanno bocca, gli Sciopedi, che hanno i piè così larghi che lor servono di parasole gettandosi per terra coi piedi in alto, altri coi piedi bovini o rivolti all’indietro, gli Pannoviani nella Scizia colle orecchie così larghe che se ne inviluppano come di un mantello, gli Monosceli che hanno una sola gamba, e che pur corrono come lepri; gl’Ipopodi della stessa Scizia, che sono come i centauri della Tessalia, un corpo d’uomo su quello di un cavallo popoli senza naso, popoli senza testa, cose tutte scritte da gravi autori, che avranno avuto quattro o cinque nasi, ma, per dieci, punto di testa, e credute per la gran bontà de’ sempre cortesi leggitori. Ma quando si trattò di darvi ad intendere che ci sono antipodi, oh allora non se ne volle saper nulla. Non vedete che l’aqua escirebbe da’ pozzi se ci fossero costoro?
Vi sono degli uomini di vista così penetrante che vedono sotterra alla profondità di venti braccia, vedono le sorgenti, vedono le miniere, vedono per conseguenza ne’ vivi corpi lo stomaco, il cuore, le interiora tutte. Questa sì ch’è una bella notizia, e molto più verisimile di quella canaglia che farebbe escir l’aqua da’ pozzi, perciò quel dottissimo uomo del padre Martino del Rio ed il Mercurio francese del 28 di questo secolo ne parlano seriamente come non si può fare di meno, nominando col loro nome di battesimo questi uomini di vista penetrante che con vocabolo universale si chiamavano in Ispagna Zahories. Tanto è vero che le parole s’inventarono dopo le cose. Non m’è noto se si spiegasse fisicamente il fenomeno, ma non si avrà mancato di farlo secondo la consueta pratica in simili casi.
Non so cosa si pensino i galli di noi, se sanno che crediamo ch’essi cantano immancabilmente all’aurora, e secondo altri più eruditi in queste materie anche a mezza notte ed a mezzo dì. Basterebbe avere quel loro pocolino di cervello per essere convinti ch’essi hanno la bontà di cantare in tutte le ore che sieno un po’ quiete. Ma l’esperienza vuole almeno un poco di attenzione, l’attenzione costa un poco di fatica, la fatica dispiace ad ogni onest’uomo; così è meglio lasciar correre le cose come sono, ed in sostanza il gallo canta certo all’aurora. Mi fa una gran breccia la ragione che ne dà Democrito, gran filosofo alla greca, cioè che questa simpatia del gallo coll’aurora proviene dal movimento de’ spiriti animali eccitato dalla digestione della notte, i quali spiriti animali fanno in somma che il gallo si senta in lena di cantare giusto alla mattina.[84] Son pur comode le parole simpatia e spiriti animali, come antipatia, destino, natura. La sempre grande bontà dei popoli è convenuta che nessuno obblighi un galantuomo a definire cosa intenda di dire con queste parole, tutti si contentano di ascoltarle e non intenderle. La discrezione è la regina delle sociali virtù. Così con grandissima comodità si spiegano le cose che altrimenti se si avesse la durezza di non accontentarsi non si spiegherebbero mai. Ed ecco come le scienze resterebbonsi indietro. La calamita tira il ferro, da un polo lo scaccia dall’altro, antipatia da questa parte, simpatia dall’altra. I regni e gli Stati hanno le loro vicende, la politica non ne sa trovar la cagione, egli è il destino de’ regni e degli Stati questa cagione, e li si fa una rispettosa riverenza alla spiegazione, e non si va più avanti. Non s’intende chiaro in qual guisa lo spirito inesteso agisca sulla estensione della materia, eccovi tosto i spiriti animali che portano le ambasciate dall’anima al corpo, ed altri spiriti animali che le portano dal corpo all’anima; se non vi accontentate di questa spiegazione peggio per voi. La natura ci ha fatti nascer liberi, la legge di natura è questa, è quella, il diritto sagrosanto di natura, il codice della natura; natura, natura, gridano ad alta voce i pubblicisti. Si sta aspettando che ne diano la definizione esatta. Ma le cose non si possono fare tutte in una volta. Si è incominciato a dedur conseguenze da principii ipotetici, con un po’ di respiro si rischiareranno anche i principii. Intanto i libri sono fatti, e ciò non sarebbe accaduto se nella prima pagina si fosse cominciato dal pretendere inurbanamente la definizione.
Intanto mi rincresce che non sia più il tempo di Marziano Capella, nel quale egli assicura,[85] come ognuno gli può credere, che si risana dalla febre colla musica, e che Asclepiade risanava dalla sordità col suono delle trombette; mi rincresce che non sia più il tempo di Taletas cretese e di Terpandro, il primo de’ quali col suono della lira sbandì da Sparta la peste, e l’altro sopì in quella stessa città una sedizione anch’egli suonando la lira.[86] Mi rincresce che non si guarisca più la gotta con una arietta di flutta come fa fede Teofrasto,[87] e che non sieno più i bei giorni di Democrito in cui con una suonatina di ciuffolo si faceva andar fuori del sangue il veleno della vipera,[88] mi rincresce che non sieno più que’ buoni tempi di Agamennone,[89] il quale andando all’assedio di Troia lasciò presso la moglie Clitemnestra un musico fidato, al quale ordinò di non suonare che in tono dorico, e finché visse il buon musico e che suonò in tono dorico, Egisto assediò in vano la fedeltà di Clitemnestra, ma morto il musico, non potendo più suonare il poveretto in nessun tono, Clitemnestra, signor mio, la fece brutta, d’onde poi ne vennero i tanti guai che con gran piangistero riferisce la famosa tragedia greca, e ciascuno poi riceva queste erudizioni secondo i suoi comodi; mi rincresce finalmente, e questo sarà l’ultimo di questi miei cinque rincrescimenti, che i tempi di Platone sieno iti in seno della eternità, ne’ quali diceva potersi cangiare i costumi e ’l sistema d’una nazione colla sola musica, che ognun sa quanto fosse potente nella Grecia. Ma non sono più que’ buoni tempi. Ora per discacciar la febbre vi vuole la china-china, e nissun medico, per ricuperare l’udito, ordina le trombette, le quali al dì d’oggi accrescerebbero la sordità; quanto alla peste finisce quand’ella si è consumata tutta, si tien lontana colle diligenze de’ lazaretti e delle quarantene; la gotta si previene col moto e col regime, e si guarisce colla pazienza; la morsicatura della vipera ha i suoi rimedi che ora riescono, ora fanno nulla al solito; i nostri Boeraave, i nostri Redi, i nostri Sauvages, i nostri Tissot, i nostri Haller non sanno nulla di questa medicina musicale: i poverini che sono! I Montesquieu, i Loke e tanti altri politici del secolo nostro furono miserabili autori che non videro ciò ch’essi potevano fare con un’arcata di Tartini e di Wanmaldro. Son perdute le belle cognizioni, son perdute. Le sedizioni ora si prevengono colla dolcezza del governo e si sopiscono colle schioppettate, i governi si mutano con grandissima fatica, i costumi sono ancor più difficili a’ cambiamenti, e non si pongono più a ciuffolare in tono dorico i musici presso alle signore che hanno i lor mariti all’assedio delle piazze, non sono più que’ be’ tempi. Ma vi torneremo, sì, vi torneremo. Basta a lasciar fare ai raccontatori di favole, e vi ritorneremo.
Non siamo noi quel orgoglioso principino della natura ch’è soggetto ad infinite pazzie, alle quali v’è tutta la probabilità che non sieno soggetti i cani delle nostre caccie, i cavalli che strascinano le nostre scatole a vernice di martino da quattro ruote e quelle ocche che gracchiano ne’ nostri cortili? Lascio le pazzie feroci, lascio le manie letterarie, lascio quelle di Democrito e di Eraclito, famosi appunto per esser stati due pazzi solenni, parlando co’ rispetti dovuti a codesti due ridenti e piangenti filosofi ch’io venero assaissimo: ma dove trovate che le bestie abbiano tanti generi di malinconie a quanti n’è soggetto l’orgoglioso principino della natura?
Orgoglioso principino della natura, una gotta di sangue fuor di luogo che ti prema le meningi or ti fa creder d’aver le corna in testa, ora d’esser un gallo onde ti ringalluzzi, canti, batti le ale come lui, or credi d’esser di vetro od una pentola di creta, onde tremi ad ogni momento di non urtar ne’ muri e corpi che ti circondano, ora credi d’aver le gambe di paglia, altre volte di esser lupo e ti metti ad urlare come quell’animale, or sei persuaso d’avere in luogo del solito naso una proposcide di elefante, e su questa credenza quanto non sei cauto nel passar le porte, nel passeggiare per le strade, nel coricarti e nel far tutti i gesti e i moti della vita, perché questa tua gran proposcide non dia incomodo agli altri e non si guasti! Infinite sono sì fatte melanconie che a onore e gloria de’ suoi simili raccolsero i medici, descrivendole con stile purgato, in perfetto latino, ed avendo la consueta modestia di non proporne i rimedi. Con un così vasto capitale di perfettibilità, la sempre gioconda ed ammiranda umana stirpe riemper puoté i molti piissimi luoghi di ospitali de’ pazzarelli, il qual privilegio non l’ha che la stessa gioconda ed ammiranda umana stirpe, composta come si sa, od almeno si dice, di tanti bei principini della natura.
Ora sì che spiegheremo con sodi fondamenti come quella maligna convulsione che chiamasi riso sia una speciale prerogativa dell’umana generazione, della quale non godono gli altri animali. La facoltà di ridere è tutta nostra perché siamo veramente ridicoli. Abbondante materia ci somministriamo vicendevolmente di pagarci fraternalmente il sempre liberalmente pagato tributo di derisione. Ella è composta di due specifici, di disprezzo e di gioia. Quest’ultima vi entra perché il nostro amor proprio fa un ritorno su di noi stessi, e si compiace di ritrovarne esenti da quel diffetto che in altri deride. Il disprezzo poi dipende dalle idee che ciascuno ha di perfezione. D’onde ne viene che l’un dell’altro si deridino di tutto cuore i fratelli uomini, e sovente la ragione sia d’ambe le parti ridenti. E questo ancora sia detto coi riguardi dovuti all’ammiranda stirpe de’ principini dell’universo.
Dopo di usar così bene della esimia facoltà ragionatrice, l’animale razionale negli oggetti presenti e nelle cose le più palpabili, chi può dubitare ch’egli non abbia anche la facoltà di veder le cose avvenire naturalmente? Sì certo, ed Aristotile spiega il fatto a meraviglia[90] attribuendo il profetico dono ad un umore melanconico che rende lo spirito sottilissimo. Il buon Plutarco[91] dice dipender ciò da un vapore terrestre tratto dal Sole, il quale vapore eccita movimento negli spiriti, e che questi spiriti così com’essi sono in movimento producono poi, a dir breve, il conoscimento delle future cose. Pausania[92] dice lo stesso. Plinio[93] dice: di tai cose qual altra ragione si può dare se non se lo spirito della natura diffuso da per tutto, che ora in questa, ora in quella parte scoppia e si sfoga? Altri alla immaginazione che si slancia nell’avvenire,[94] altri per compimento della materia, alle influenze celesti attribuirono questi prodigi.[95] Queste gravissime persone non conoscevano le cose presenti quando spiegavano come si possano conoscere le future.
Su che erano fondati gli oracoli di Delfo e gli altri più famosi della antichità? Sulla opinione che le crepature della terra rispondessero a’ mortali delle cose avvenire. Su che era fondata questa opinione? Dalle caverne esalano vapori che provengono dalle viscere della terra, e questi vapori s’incontrano coi vapori del cielo; ma i vapori del cielo e della terra sono le due estremità della natura, or dunque quale miglior mezzo di conoscere l’avvenire che dove si toccano le due estremità della natura? E così anche questa volta si accontentarono con poco gl’incontentabili uomini, e tutti corsero alle crepature della terra ed alle estremità della natura a chiamare i vapori delle viscere della terra: che sarà de’ miei figliuoli, di mia moglie, del mio amico, della mia patria? La grande benignità della umana spezie si lasciò servire cogli ibis redibis, e tutto per una di quelle rare distrazioni alle quali un così sapiente animale è soggetto, perché sempre occupato di cose sublimi che non li lasciano tempo di pensare a queste minuzie.
L’arte speculatoria, ossia di predir
IL CAFFÈ )( Fogl. XXIII )(
l’avvenire dai lampi e dalle meteore, non fu posta in dubbio dalla dotta antichità. Questo era l’argomento che convinceva i nostri maggiori. Se l’astrologia scopre l’avvenire sino ne’ globi celesti che sono poi tanto lontani, perché non lo scoprirà nelle cose cotanto vicine?[96] Oso far presente anche questa piccola distrazione, ed intanto risparmiovi, fratelli carissimi, i parti mostruosi, le bestie parlanti, le piogge di sangue e di pietre, i combattimenti aerei, i prodigi e le straniezze che formano il principale di quella che chiamate vostra istoria, la quale è un misto delle credulità e delle passioni di chi la scrisse colle cose or ridicole, or feroci che fece l’umana prosapia.
S’egli è vero che alcuni fra gli animali conoscano perfettamente che certe erbe loro sono nocevoli, e se ne guardino, altre che loro sono salutari, e le scelgano fra tutte, nel che lasciamo a lor luogo Eliano, Plinio ed Aristotile, che scrissero di tal materia, se ciò è vero, cosa diranno di noi gli animali se penetreranno che non passa anno in cui non vi sia qualche umana famiglia avvelenata da’ funghi, perché non ancora la facile e disprezzata esperienza ha fatto sospettare che certi fonghi sieno velenosi per loro natural qualità, ma piuttosto si crede che diventino tali perché sono morsicati dalle vipere o dagli aspidi? E noi consegniamo li nostri ventricoli a questa bella fisica de’ nostri guatteri, i quali credono che si conosce se il fungo è avvelenato ponendo nella caldaia in cui bollono un cucchiaio d’argento, il quale s’annerisce se c’è veleno! Tutti gli anni v’è qualche famiglia avvelenata dai funghi, e tutti gli anni si seguita a mettere il cucchiaio d’argento nella caldaia ed a star sodi all’aspide ed alla vipera, ed anche ciò per la gran bontà dell’orgoglioso principino di tutta la vasta natura.
Ma l’uomo non si muta, egli né per l’esperienza, né per li mali, né per le ragioni lascia perciò di seguitare imperturbabilmente il maestoso suo passeggio di verità in verità, di sillogismo in sillogismo, come di ramo in ramo e di fronda in fronda saltellano gli uccelletti.
Chi sa che i più grandi misteri della fisica, l’attrazione, la calamita e la eletricità non sieno verità molto obvie ai nostri cani, e forse più di tutti agli elefanti, che hanno in quel loro gran nasone un tatto squisitissimo ed amplissimo, e chi dice tatto dice il padre di tutti i sensi? Se noi abbiamo da prevedere che tempo farà domani, dovemmo sudare de’ secoli nella fisica, finché un certo Toricelli non ritrovasse il barometro, e gli storni ed i tordi e le quaglie, che non ebbero Toricelli né Reaumur, sono secoli e secoli che conoscono queste mutazioni molti giorni prima di noi, perché più sensibili alle minime mutazioni della atomosfera. Cosa abbiamo noi profittato di questa previsione degli uccelli? Ne abbiamo fatta l’arte degli auspicii cotanto famosa, vale a dire che anche quelle poche verità che le bestie ci somministravano le abbiamo adoperate per formarci degli errori, anzi dei sistemi di errori. E chi comandava veramente al popolo romano, agli Etrusci, agli Egizi? I storni, le quaglie ed i tordi. Rispettiamo il principino dell’universo.
L’uomo è colto, l’uomo è addomesticato? Egli è selvaggio, carnivoro spopolatore della terra per imbandirsi mense stravagantemente squisite che gli accorcino una cortissima vita. Sono costretti i governi a proibir con leggi penali le caccie e le pesche ne’ tempi della generazion degli animali, perché l’uomo addomesticato e colto si mangierebbe il tutto. E che hanno di differente colle tigri e co’ leoni quelle adorabili nazioni che si compiacevano di vedere i loro confratelli uomini alle mani cogli altri loro confratelli orsi e leoni ne’ circhi e negli anfiteatri, e che facevan festa e giubilo e soggetto di lusso l’udire gli urli e le strida degli uomini moribondi, singhiozzanti, squarciati, sbranati? Almeno le tigri, i leoni ed i cocodrilli se non se per bisogno di fame pongon mano a’ viventi, ma voi per mero sfogo di rafinata crudeltà il faceste ed il fate! Che diranno i pacifici buoi, gl’innocenti vitelli ed i tranquilissimi porci se sapranno che l’uomo ha fatta una scienza del modo di sbranargli, confettarli, arrostirli alla kinicsech, impasticciarli, e sì fatte carnificine dottamente trattate ne’ libri che insegnano il cuccinare? Quello che diremmo noi uomini se costoro aprissero gli occhi e facessero pasticci e bodini ed arrosti alla kinicsech dell’animale implume. Il tutto dipende dal ben comprendere ciò ch’è già dimostrato, ch’egli è il principino della natura. Tutto si raffina in questa società coltissima in cui sono felicemente gli uomini dappoiché hanno fatta fortuna e si sono messi a portar parrucca, borse a’ capelli e manichetti di fiandra. Si è inventata l’arte di far morire molti poveri animali a stento perché riescano così più delicate e digeribili le carni loro. I poveri, gli umanissimi porci a forza di bastonate, le anguille arrabbiate, i gambri vivi, i pesci fra le ambascie mortali dell’aqua bollente, altri in altre orrende guise si massacrano e si crucciano, e vanno poi ne’ ventricoli delle gentili dame e de’ gentili signori, ed intanto che se gli divorano parlano della pioggia e del bel tempo, della sensibilità, della filosofia, hanno dello spirito, sbadigliano, sono in distrazione. Il cagnolino di madama anch’egli incivilito divora i quarti di pollo, i rosignoli di madama mangiano il triturato cuore de’ vitelli, il povero cagnolino è accarrezzato, umanissimamente trattenuto, guai chi gli schiacci incautamente il piede, madama non può vedere soffrire una bestiolina per menoma che sia. Ma madama è carnivora quanto le tigri ed i leoni, ed ha fatti diventar carnivori per fino i suoi cagnolini ed i suoi rosignoli. E che diremo noi delle cene de’ Romani in cui si facevano scannare per diletto gli uomini così che cadevano insieme l’ubbriaco conviva e ’l moribondo suo confratello gladiatore? Almeno portassi, o uomo, nella tua ferocia quel non so che di generoso che rende illustri per fino i grandi delitti. Ma quale animale a un tempo più di te crudele ed imbecille? Timido mostro che tremi gir di notte all’oscuro, i tuoni, i lampi ti fanno impallidire, le fantasme, gli spettri, i vampiri e le chimere ti stanno d’intorno per spaventarti. Ogni nazione ha le sue, ogni secolo non mai ne mancò.
Di quanti delitti non siamo capaci, che le bestie non conoscono! Avete voluto introdurre la proprietà dei beni? Eccovi ladri, assassini, perfidie orribili per violarla. Bisogna appiccare, arruotare, massacrare per custodirla. Avete introdotta la moneta? Ecco subito il suo delitto pronto: moneta falsa. Avete proibite le vendette private? Ecco che bisogna che ne facciate ad ogni tratto delle pubbliche, uccider perché non si uccida, toglier la libertà perché non s’introduca l’usanza di togliersela l’un l’altro. Qual razza di animali siamo noi? Qual società è questa? Non abbiamo un momento di tranquillità, ed abbiamo instituita la repubblica per averne. Volete conservarla? Vi vogliono soldati, giudici, sgherri, carnefici, prigioni, manaie, e tutte queste cose sono sempre in moto. Togliete questi ostacoli alla sua dissoluzione, eccovi ancora a mangiar le ghiande dell’aureo secolo. Non v’è mezzo scudo che voi non dobbiate custodire con chiavi e casse ferrate e gran catenacci; non v’è campo che non dobbiate diffender ogni momento dalla usurpazione del vostro vicino; se non vi chiudete in casa di notte siete saccheggiati, se non custodite le vie vi sono delle tigri che si chiamano uomini le quali vi massacrano per togliervi un fiorino. Avete fatti molti miserabili col avere riuniti in pochi i beni e le ricchezze, e poi appiccate qualunque dei molti miserabili voglia toglier a uno de’ pochi cinque o sei gigliati. Vedi, o uomo, quattro cani d’intorno a un pezzo di vivanda che basti a tutti, ed ivi impara il mal inteso tuo diritto di natura. Quei poveretti mangiano ciascuno pacificamente senza contendere! Che bel diritto di natura sarebbe egli se uno di questi cani si usurpasse le tre porzioni degli altri, e che poi si volesse chiamar conte cane, marchese cane, e chiamar gli altri tre suoi simili cani di bassa nascita, o volgo cagnesco! Giocondi e giustissimi uomini, avreste voi per avventura mai fatto così?
Quando mai alcuno fra gli bruti animali fu così carnefice della propria specie come lo siamo noi nelle guerre che chiamiamo vezzosamente purgamenti del mondo? Che sono gli Alessandri, i Gengiscani, i Tamerlani se non se famosi macellai del genere umano celeberrimi dall’uno all’altro Polo per aver fatte spiccar dal busto trenta mila teste, tagliare ottanta mila nasi, centocinquanta mila gambe, ducento milla braccia, ed aver fatte ficcare centomila aste in cento mila ventri, fatte piangere centomila vedove e sospirare cento mila padri, saccheggiate tre mila miglia di paese per ottener la gloria d’aver fatte simili spedizioni? E cos’è questa gloria? Sono i vostri voti, o uomini. Voi li compartite a chi gl’implora con cento mila omicidii, loro alzate statue, monumenti, dedicate poemi e sonetti, e li negate a chi la cerca con un libro ragionevole; siete adunque degni di cattivi libri e di conquistatori.
Questa macellaria del genere umano è divenuta un soggetto di arte e scienza che chiamate tactica. Oh se aveste fatta tanta fatica a raffinare le arti utili quanta ne avete adoperata a raffinare le nocevoli ed orrende, non saremmo ridotti a dimandare umilissima scusa di potervi impunemente far del bene! Sappiate che molti oscuri uomini hanno voglia di farvelo, ma non vi trovano il lor conto.
Cosa è questa pretesa società? Siete, egli è vero, gli uni vicini agli altri, a pian terreno, sotto la soffitta, al secondo, al terzo piano, altri a piedi, altri in carrozza, altri in campagna, altri nelle città, vi fate delle riverenze, vi vestite a un di presso tutti ad un modo, ma qual è quel vincolo che vi tiene uniti? La forza ed il timore. Cosa è questa vostra pretesa fratellanza sociale, cos’è quel detto impertinente che ogni simile ama il suo simile? Ognuno di voi considera l’altrui danno come un fondo del proprio vantaggio. Il mercante desidera che s’affondi un bastimento per vender care le sue merci: sono stato fortunato, dic’egli buonamente, è perito un bastimento di drogherie, ho vendute le mie col guadagno del quaranta per cento. Ma sa egli costui quanti piangono il suo quaranta per cento? Sa egli le famiglie rovinate, sa egli che la novella moglie piange il giovine marito che sta assieme de’ coralli negli abissi del mare, il padre geme sul figlio, l’amico sull’amico, che stanno nel ventre de’ pesci? Il giudice vuole molte liti: e non si guadagna niente in questi tempi calamitosi, ei dice di buona fede: eppure i tempi veramente deliziosi sono quegli che sieno calamitosi per i giudici. Il medico laureato vuol molti ammalati: Come vanno le facende, amico?, chiamansi l’un l’altro, e rispondonsi: Eccellentemente, vi sono molti ammalati, ed anche questo si dice per mera bontà. Il notaro criminale geme che non v’è più prodezza in questo mondo, che non si fanno più infilzamenti che chiamansi duelli, che non si fanno più rispettare i nobili con far assassinare o bastonare qualche impertinente, fra di loro son quieti, non vi sono più le innimicizie da famiglia a famiglia, si farebbero piuttosto ammazzare che diffendersi, tanto sono divenuti codardi gli uomini! Il soldato vuole i disordini della guerra, il padrone de’ fondi la carestia; ecco, o uomini, la vostra società, ecco i vincoli che vi legano dentro que’ recinti di muraglie che mi figuro chiameranno le bestie parchi di bipedi.
La natura vi ha ricusate le griffe, i denti, le corna, e voi avete inventate le bombarde, le pettarde, i canoni, le mine, le spade, le aste, i veleni, i stiletti, che siate pur benedetti! così bisognava perfezionar la natura.
Animali socievoli che siete voi? Uniti col timore, vi chiamate tali essendo continuamente spinti dalle vostre passioni alla insociabilità, e negate la sociabilità ai cani, i quali vanno in America a truppe innumerevoli, alle grue, ai storni, ai merlucci, alle arrenghe, alle quaglie, a tutti gli animali in somma che non sono altrimenti solitari, ma vanno in truppe e fraternalmente si soccorrono per pura animaleschità, senza codice, carnefici, soldati o fideicomessi. Se avete un intelletto più sublime di quello degli animali, voi lo adoperate per riempirvi di miserie, se avete sensi più squisiti di loro, organi più fini e pieghevoli, le passioni più delicate, se avendo più mezzi di sentire avete più materia di combinazioni; da qui appunto esce quella catena d’inesauribili e stoltissimi bisogni d’onde la vostra corruzione e gl’infiniti vizi vostri. Se le bestie non usano della ragione, voi ne abusate; così siete nell’errore in tutti que’ casi ne’ quali le bestie sono nell’ignoranza. Questo è l’unico vantaggio ch’esse ci accordino, ed egli è veramente conspicuo.
Non v’è crudeltà che non abbia commessa la sempre rispettabile ed umanissima stirpe nostra. I sagrifizi umani furono comuni a tutte le nazioni. Le donne indiane si abbruggiano alla morte de’ loro mariti. Si dice che a quest’abbruggiamento vedovile fossero obbligate con una legge, perché l’avvelenare il marito era cotanto venuto di moda che la maggior parte morivano per veneficio. Metteremo anche questi avvelenamenti fra gli fatti del umanissimo nostro genere; e metteremo fra le leggi ben pensate questa che comanda alle vedove di far compagnia a’ lor mariti anche nell’altro mondo, e metteremo per fine fra le belle docilità del femineo sesso quella di eseguirla.
Quanti popoli dell’antichità invece di rispettare la canizie solevano per loro instituto ammazzare i vecchi septuagenari? Fate, padroni miei, un piccolo passeggio mentale sul globo a cui siamo attaccati ed andate nell’isola Java, e vedrete quello che vi ha veduto Luigi Bartemio, cioè ammazzare i poveri vecchi e gli ammalati, ed esporre in vendita i loro corpi tagliati in quarti come qui da noi alle macellarie buoi e vitelli.
Furono della nostra spezie que’ buoni popoli che si mangiavano i loro morti parenti dicendo non vi essere tomba più pietosa che il ventricolo de’ congiunti. Nel Congo le donne mangiano sovente i bambini appena nati.[97]
Nella Caffreria i funerali si facevano con questa edificante cerimonia. Tutti i parenti del morto si tagliavano il piccolo dito della sinistra mano, e lo tagliavano per fino ai bambini, per mettere poi tutti questi parenti piccoli diti nella tomba del morto.[98] A conti fatti era difficile il salvare in quel delizioso paese il suo dito piccolo della mano sinistra; ma che difficoltà che vi sia un popolo senza un dito? Negli Ottentoti, vicini appunto di questi buoni Caffri, non usasi attualmente una certa cerimonia per la quale sono tutti coloro tanti mezzi Cafarielli? Ognun sa con qual cerimonia que’ meschini si lasciano prima della fonzione ugnere tutti di grasso dal loro gran prete, il quale gli onora eziandio di vuotarsi adosso di loro la vescica, ed i poverini si ricevono quest’atto di munificenza sovrana con gran componzione. Egli è pur noto che taluni moiono pe’ gran strazi che fa il gran prete poco esperto di chirurgia in tale occasione. Sono della razza nostra costoro, o socievoli fratelli di città. Quegli fanno la detta fonzione per superstizione, voi, o socievoli fratelli, la fate non per metà, ma per intiero, e per l’importantissimo piacere di sentire a gorgogliare un’arietta da un mezz’uomo in feminea voce.
Alla morte del Gran Kam de’ Tartari i suoi fedelissimi sudditi girano per le strade e si ammazzano l’un l’altro, mandandosi a servire nell’altro mondo il lor principe, e questa sublime pompa funebre costa alle volte il vil prezzo di otto a dieci mila omicidii.[99]
Il popolo della Guinea ha la stessa moda ne’ funerali del suo re. Si va in quella occasione dappertutto ammazzando figli, donne e garzoni, mietendo il fiore della specie umana per servire nell’altro mondo la Maestà Sua, che certamente sarà il più risplendente figlio del Sole e l’odorifero Signore di tutti i Signori, e vi sarà qualche cosa anche per la Luna, si massacrano tutte queste povere creature a tradimento, si sepelliscono colla Maestà Sua, si canta, si balla, e così si vive. Siamo fratelli della stessa stirpe! Veneriamo la adorabile spezie umana.
Era antico costume de’ Sciti[100] di strangolare sulla tomba del re la più cara delle sue donne, il più tenero de’ suoi amici, il più benvoluto de’ suoi ministri. Così si visse nella Scizia. Nell’anniversario della principesca morte di Sua Grandezza sterminatissima, la pompa cresceva di solennità. S’impalavano precisamente fino alla gola cinquanta belli e freschi paggi, e stavano così in gran figura attorno del sepolcro di Sua Maestà. Se un buon uomo si fosse incontrato in quel orrendo spettacolo, se avesse ascoltati i sensi di un altissimo sdegno che simile carnificina commover dovea nel suo cuore, se avesse voluto convertir quegli imbecilli crudeli, sapete cosa ne sarebbe avvenuto di questo buon uomo? In vece di cinquanta impalati sarebbero stati cinquant’uno. E così si vive. Veneriamo l’adorabile umana spezie, i principini dell’universo.
Nella Luigiana v’è una nazione in cui quando taluno muore si fanno morire con lui tutti i suoi domestici. Nel tempo che si fanno le esequie al padrone, si mette divotamente il suo laccio al collo di questi poverelli, ed allora credete voi che urlino, gridino soccorso e che si faccia loro violenza? Non già. Allora appunto cominciano a ballare ed a cantare degli inni. Intanto chi tiene il capo del laccio lo tira di mano in mano; quelli seguono a ballare e cantare, questi a stringer il laccio, e sino all’ultimo fiato ed agli ultimi sforzi cacciano fuori quel po’ di voce moribonda che lor rimane e si dimenano ballando finché possono.[101]
Questi sono alcuni fasti del genere umano, per cui ho la discrezione di non far questa lista più lunga. Né si dica che questa progenie produsse pure un Bacone, un Newton, un Montesquieu, perché io rispondo resolutivamente che questa è una gran temerità di pretendere che fossero di questa razza meschina. La sublimità di quelle grand’anime che ha di comune colla infinita abiezione dell’anime volgari? Se tanto di coda più o meno pelosa, una piccola differenza di muso, una qualunque varietà di struttura nel corpo degli animali basta perché tosto se ne faccia un conto diversissimo e se ne faccia una razza a parte, perché questi scimiotti d’uomini, ne’ quali invano cerchi l’anima e ritrovi tutte le stoltezze ed i vizi, avranno coraggio d’impavonirsi e di farsi confratelli di chi avea cento anime e cento cuori, le une che sempre eran piene di gran pensieri, gli altri di gran sentimenti? Metteremo anche questa lepida pretensione alla partita delle innumerevoli lepidissime pretensioni del principino della natura e dell’universo, a cui faccio un profondissimo inchino.
E questo è il fine del comentariolo del galantuomo di mal umore che ha ragione, e nel quale si sarà potuto intendere di che si tratta, a differenza di tanti altri comentarioli ne’ quali non si può in conto alcuno avere questa poca soddisfazione.
A. [Alessandro Verri]
Degli errori utili
Vantiamo tanto la ragione, e dobbiamo le più grandi cose all’errore. L’entusiasmo, le passioni sublimi sono per lo più figlie di lui, e con queste si fanno le imprese grandi. Dove l’amor della patria, dove il disprezzo stoico della morte e del dolore, dove il valor militare, sorgenti feconde della grandezza delle nazioni immortali, se la logica fosse stata invece delle opinioni? Togliete ai maomettani la persuasione che morendo in guerra vassi in seno del Profeta e nei giardini delle sempre amorose ed immortali Oris, avrete fatto di un esercito di terribili soldati una truppa di freddi logici che si lascieranno battere filosoficamente. Togliete agli antichi Romani la persuasione che dovessero conquistare il mondo, non sarebbero esciti dai confini del Lazio. Togliete ad altre nazioni la opinione della metemsicosi, e ne farete una mandra d’uomini. Qual coraggio non aveano nelle guerre i popoli del Nord? Ciò essi doveano all’antico loro legislatore Odino, che avevali persuasi essere deliziosa cosa il morire in guerra. In un’ode d’un re del Nord, Ledbrog, si vede qual effetto producesse questa persuasione: Qual trasporto di gioia m’inonda il cuore? Io moro. Ascolto la voce d’Odino che mi chiama, le porte del suo palazzo si spalancano, delle ninfe vengono ad incontrarmi, esse mi offrono una deliziosa bevanda nel cranio de’ miei nemici. Venga il buon logico e dica a questo moribondo ch’egli è un pazzo; venga il freddissimo metafisico e faccia un trattato contro di Odino, avrà fatto un bel servizio a quelle nazioni. Quest’errore non produsse meno che la decisa superiorità de’ settentrionali su i meridionali. Questi divennero servi di quelli. Un trattato di filosofia non farà mai sì grandi cose.
Quando mi si dimostrerà che le nazioni non hanno bisogno di certe grandi passioni per esser grandi e felici; quando mi si dimostrerà che in una vasta società d’uomini si possa eccitare l’entusiasmo colla sola ragione e senza opinioni; quando mi si dimostrerà che le sublimi passioni sono ragionamenti, allora dirò che la ragione fa delle grandi cose. Fin ora il solo entusiasmo ed il solo sentimento le ha fatte. Ne’ paesi della sensibilità la fredda logica fa un terribile saccheggio.
Bisogna provarmi che il genere umano possa far senza certi errori; che non ve ne sieno di utili e di necessari, e che loro si possa senza inconvenienti sostituire la verità; prima di convincermi che… Stavo per minacciarvi d’una terribile conclusione, cioè che vi sia un confine da porsi alla filosofia. Ma quand’è che mancheranno errori agli uomini? Gli annali del genere umano mi rendono tranquillo su di ciò.
A. [Alessandro Verri]
IL CAFFÈ )( Fogl. XXIV )(
Osservazioni sulla questione se il commercio corrompa i costumi e la morale
Non v’è, per avventura, disparere più grande fra noi ed i nostri antichi come nel giudicare del commercio. Quanto mai non gli è favorevole il nostro secolo! Infiniti libri lo esaltano, tutt’i fogli pubblici ne parlano: egli serve di agente principale alla politica porta la popolazione e la ricchezza agli Stati ed è il più fedele nunzio della loro felicità. Gli antichi per lo contrario lo risguardavano come la corruzione istessa. Osserva Tacito[102] che bandisce l’ospitalità, e testifica Cesare che indebolisce il coraggio; onde esso attribuì la debolezza dei Galli alla vicinanza dei commercianti marsigliani. Infinite sono le querele fatte contro del commercio; esso occupa i pensieri d’una nazione intorno a piccoli oggetti e non lascia ch’essa prenda di mira i sublimi. È vero che anche il commercio ha la proprietà di rendere dolci questi stessi costumi, ma non lascia di guastarli, poiché in contraccambio ecclissa quei luminosi ed elevati caratteri scortati da un non so che di fiero e di generoso, che lascia in ogni tempo travedere al di dentro la copia di quel fuoco celeste fatto per animare le belle anime, e li trasforma in modo di renderli abietti e vili, simili ad un cadavere, in cui più non si scorge né calore, né moto, né risorgimento alcuno alla vita. Ci acquista, egli è vero, molta copia d’oro e d’argento, ma siccome questi metalli non sono che rappresentazioni delle vere ricchezze, così la loro abbondanza o scarsezza resta indifferente a beneficare uno Stato, come a rappresentare la fisonomia d’un uomo nulla giova o pregiudica la grandezza o piccolezza del ritratto. Ma non sono egualmente indifferenti i vizi morali che da questa copia di metalli ne derivano, copia che genera la mollezza ed il lusso, che esalta la superbia, che indurisce i cuori alla crudeltà e che presta origine a due effetti tra di loro contrari come sono l’avarizia e la prodigalità. L’autore dello Spirito delle leggi[103] e Michele Montagne[104] seguirono in ciò le opinioni degli antichi. Sì grandi autorità meritano delle obbiezioni.
Non credo io già che debbano attribuirsi al commercio le riferite male influenze nella morale. Allontaniamo in primo luogo gli autorevoli detti degli scrittori dalle materie di raziocinio: nel trattarle bisogna usare della ragion nostra, e non di quella degli altri; nulla ha da concedere alla nuda autorità chi non vuole servire alla cieca opinione. La ragione altrui prima d’essere addottata dee passare sotto l’approvazione dell’interno nostro sentimento, ed allora diventa ragione propria. Dell’autorità conviene ricercarne i fondamenti affine di scoprire o una verità che ci consoli o un errore che dia impulso a ricercarla.
Sono talmente distribuite le cose mondane che in tanto numero di soggetti nulla vi è di perfettamente simile. Negli oggetti sensibili, benché d’un genere medesimo, si vede chiaramente la loro diversità, di modo che di tante pietre delle quali è sparsa la terra difficilmente se ne troveranno alcune uniformi. Negli uomini, grandi sono le varietà di forze, di spirito, di corpo e di condizione, varietà tutte che pongono l’uomo sociale in istato di avvedersi della sua debolezza e de’ suoi bisogni, qualora si trova solo, e della sua perfezione, qualora venga dagli altri soccorso ed aiutato. Da questo conoscimento nasce l’amore al commercio, che ne somministra nel cambio delle merci e nell’acquisto del danaro l’opportuna materia. Se dunque alla società umana il commercio è indispensabile, come quello che la sostiene, ed è profittevole, come quello che la perfeziona, con qual fondamento diremo noi ch’egli corrompa la purità dei costumi? Platone, che le ricchezze considera un bene principale dell’uomo,[105] come può giustamente lagnarsi del commercio che le procura, com’ei fa tante volte? Non è il necessario commercio, rispondono i sostenitori della contraria opinione, che si condanna, ma bensì quello delle cose superflue e di lusso. Il male dunque, anche secondo essi, non sta nelle merci, ma bensì nelle passioni umane, le quali sempre precedono alla ricerca delle cose atte ad appagarle. Ma perché mai da un commercio innocente si pretende che derivi il vizioso? Questi due commerci sono d’una spezie diversa: nessun legame gli unisce, nessun necessario rapporto li fa dipendenti l’uno dall’altro; e non hanno essi di comune che la sola denominazione. Mutiamo i termini di parlare, nei quali consiste l’errore, e vi troveremo evidentemente la diversità e l’indipendenza. Diomede vive del prodotto delle sue terre, ed è un giudice avaro ed ingiusto. Che ha di comune il soggetto del suo vitto coll’iniquità delle sue opere, quale unione, quale dipendenza vi troveremo noi? Vi saranno esse, per avventura, perché possiamo dire che Diomede vende i frutti de’ suoi fondi e vende egualmente la giustizia? Perché l’una e l’altra operazione si chiama vendita, le crederemo ambidue necessariamente legate insieme, e supporremo che l’ingiusta sia prodotta dalla giusta? La strage che l’uomo fa per suo sostentamento degli animali irragionevoli non potrà mai dirsi che abbia cagionata l’uccisione degli animali ragionevoli. La prima nasce dal bisogno, la seconda dal vizio fra di loro affatto disgiunti ed indipendenti, quando non volessimo sostenere che l’uomo può essere vizioso per necessità.
Nulla dico della supposta avversione dei trafficanti all’ospitalità attribuita da Tacito al commercio. Essa altro non prova se non se che anche i grandi uomini servono tal volta alle più strane opinioni comuni de’ lor tempi. Egli era grand’uomo di Stato, perché era di una nazione nella quale ragionavasi profondamente sulla politica; egli era mediocre economo, perché visse in una nazione la quale non conobbe mai tal sorta di scienza. Quanto sono grandi i di lei scrittori nelle lettere e nella storia, altrettanto sono fanciulli nel balbettare le scienze economiche. Le più ospitali ed umane nazioni sono le commercianti. La mercatura fa diventar l’uomo cittadino del mondo. Lungi che il commercio indebolisca il coraggio d’una nazione, lo risveglia anzi e lo aumenta. E se l’utile è capace di formare dei grandi uomini, qual cosa fuori del commercio potrà recarne un maggiore ad una nazione? E chi più di lui potrà spingere le belle anime alle grandi opere? Bandisce la povertà, che la confusione impedisce di comparire al pubblico, che il bisogno non permette che stia ritirata in segreto, che se tace per vergogna sente mille necessità; che se chiede mendica, come vile non è creduta; che tanto più sente il peso de’ suoi mali, quanto altri meno la compatisce, e fra di essi n’è forse il maggiore la derisione ed il disprezzo, da cui riceve il colpo mortale il valore ed il coraggio. Tolti d’intorno gl’incomodi d’una vergognosa povertà, non ha lo spirito umano ostacoli ad avere nobili sentimenti della gloria. A questa corre animosamente, e cogli esempi degli uomini illustri che si propone d’imitare si solleva a nobili imprese, quindi va in cerca del nemico, affronta pericoli, trionfa nella tenzone. Si scorrino le storie, e si troverà che i popoli più commercianti hanno fatto fronte più valorosamente ai gran capitani: i cittadini di Tiro ad Alessandro, i Siracusani a Marcello, gli Ateniesi a Silla, i Sagontini ad Annibale. Un popolo afflitto dalla povertà, e con essa da tutt’i mali, non ha tanto impegno d’allontanare da sé la morte, ch’è il fine dei tormenti; ma il ricco, che piacevolmente vive e che dalla copia del danaro coglie le vaghe ghirlande di fiori per distenderle sopra le orride catene di ferro delle quali lo ha gravato l’umana società, è più animato a difendersi da colei, che gli toglie le delizie ed i comodi della vita. Cesare si è ingannato nell’attribuire la debolezza dei Galli al commercio dei Marsigliani. Spesse volte avviene che la viltà della condizione tinge di nera vernice le azioni lodevoli, ed all’incontro non di rado la nobiltà della condizione medesima rende luminose quelle azioni che non meritano elogio. L’una e l’altra cagionano alla mente sensazioni capacissime di alterare l’imaginazione e di mutare i sentimenti al cuore. Per la viltà dell’esecutore dell’alta giustizia, fatta maggiore dalla gravezza de’ suoi precedenti delitti, se ne risguarda con abominio ed orrore l’esecuzione, con tutto che venga essa ordinata dalle leggi, voluta dal buon governo e necessaria alla pubblica felicità. Le battaglie crudeli ed alcune volte ingiuste ordinate da un condottiere d’eserciti sono sempre gloriose ed ammirate, perché procedono da chi è carico d’onori e di ricompense. Il commercio fra’ Romani era commesso agli schiavi, gente vile e disprezzata, ed è credibile che Cesare, soprafatto dal comune nazionale pregiudizio, abbia inconsideratamente attribuita al commercio la viltà de’ suoi commercianti, e che per lo stesso errore abbia imputato al traffico di Marsiglia la mancanza di coraggio dei Galli, con tutto che non vi sia stato popolo che più ostinatamente dei Marsigliani abbia contrastato col suo valore la vittoria ai Romani. Io voglio supporre col signor di Montesquieu che gli oggetti presentati ad una nazione dal commercio siano piccoli e di poca importanza, con tutto che io non sia di tal parere; non posso però concedere ch’egli impedisca l’aspirare ai più grandi. Frattanto che una parte del popolo travaglia alle manifatture, fa conti e contratta, l’altra parte può apprendere la disciplina militare, far piani di campagne, rovesciare argini e battere valorosamente il nemico. Chi mai potrà dimostrarmi che il traffico del cittadino commerciante abbia danneggiato al valore del cittadino guerriero, e che lo spirito quieto del primo abbia rintuzzati i nobili impeti del secondo? Allorché un primogenito toscano siede pacificamente in una manifattura di seta tutt’occupato a farsi ricco, il secondogenito trascorre i mari sulle navi maltesi, ed avido di gloria va a combattere coi barbari dell’Africa. Montesquieu disse[106] che lo spirito di guerra e lo spirito di commercio non possono supporsi in uno stesso individuo; ma non pronunciò giammai che siano incompatibili in un’intera nazione. Non troverassi, se pur si voglia alcun poco esaminare l’umana natura, che la dolcezza dei costumi abbia giammai estinto il nobile calore marziale che risiede in un cuore ben fatto, ed a suo tempo amante della tranquillità e della quiete. Richiamando alla memoria i secoli passati, comprenderassi che la durevole felicità degli Stati è nata nella pace e nella moderazione. La maggiore poi, o la minore copia di danaro sarebbe indifferente ad uno Stato se la di lui circolazione dovesse restringersi all’interno del medesimo; ma siccome mille circostanze esiggono ch’esso venga mandato fuori, così è necessario l’averne in abbondanza per i contratti coi forastieri, e l’averne più di essi per essere ricco. In oltre son ben facili i mezzi per diminuir le ricchezze quanto son difficili quelli per aumentarle. Non temiamo l’abbondanza, ma la povertà.
Io non comprendo come dalle ricchezze derivino la molezza, il lusso, la superbia, la crudeltà, l’avarizia e la prodigalità. Hanno esse un’origine ben diversa da questa. Lo stato d’una torpida indolenza e d’una inopportuna tranquillità, in cui propriamente consiste la mollezza, viene formato da una voluttà raffinata, che di tutto vuol farsene un piacere. Il lusso, che moralmente parlando altro non è che l’amore del fasto e della magnificenza, procede dalla superbia, nata dal sentimento d’una ingiusta preferenza che alcuno fa di se stesso agli altri. La crudeltà è promossa dall’avarizia, che nulla vuol dare perché tutto crede a sé necessario, e l’avarizia viene dall’interminabile bisogno, ch’essa sempre tiene presente. La prodigalità è l’effetto d’un ardente desiderio di procacciarsi o i piaceri o la superiorità, desiderio che ci chiude gli occhi sopra il prezzo ch’esso ci costa. La stessa raffinata voluttà, l’ingiusta preferenza, l’interminabile bisogno, che danno i principii alle sovraccennate viziose inclinazioni dell’animo, traggono anch’essi la loro origine dall’umana società. Questa ci presenta maggiori relazioni e dipendenze che non avevamo in solitudine. La sensibilità, che forma le nostre passioni, si fa maggiore a misura ch’ella parte da maggior numero d’oggetti. L’imaginazione, la quale scorrendo su di questi oggetti ricerca i beni dell’uomo e nei beni la di lui assoluta felicità, senza mai poterla ritrovare, accresce di molto la sensibilità medesima, ne determina la pendenza e ci fa credere falsamente che tale felicità sta fra le cose naturali nella squisitezza dei piaceri, fra le comparazioni nella propria preferenza e fra i bisogni reali o fantastici nella lor piena soddisfazione. La copia del danaro serve di puro istromento alla produzione e conservazione di questi vizi, nella maniera che l’esca non è la cagione del fuoco, ma l’alimento: la voce umana non è la sorgente dell’eloquenza, ma il di lei organo. Le declamazioni degli antichi non sono di molto peso, perché seco portano una manifesta contraddizione che le degrada. Le immense ricchezze accumulate da Seneca, quel gran nemico delle ricchezze ne’ suoi scritti; la deliziosa villeggiatura di Lucretillo acquistata con tanto studio da Orazio, anch’egli gran declamatore contro il lusso; ed il vino prezioso di Lesbo, che tanto saporitamente egli bevea colla sua Tindari, tutti frutti della liberalità di Mecenate, abbastanza ci persuadono qual differenza vi fosse fra i loro sentimenti e le loro espressioni. La vita degli autori quanto per lo più è diversa da’ loro libri!
Concludiamo adunque che il commercio né corrompe i costumi, né genera colle ricchezze la superbia, la crudeltà, l’avarizia, la prodigalità, né per conseguenza si può ragionevolmente dire ch’egli abbia una pessima influenza nella morale.
F. [Sebastiano Franci]
Le antiche querele sul commercio, risguardato come il corrompitor de’ costumi, il padre del lusso, della superbia, della crudeltà, dell’avarizia e de’ vizi più funesti sono espressioni di mal umore alle quali manca la precisione. Questi furono dogmi severi esciti dalle repubbliche antiche, le quali erano nazioni di mezzo fra lo stato selvaggio ed il civile, destinate ad esser sempre coll’armi in mano, destituite di arti e di scienze. Onde il trasportare i lor principii alle vaste e coltivate nazioni è lo stesso che vestire un gigante cogli abiti di un nano. La severità di Sparta trasportata in Persia e la magnificenza di Persia trasportata in Sparta avrebbe fatte perire tutte due queste nazioni. Perché l’una era fondata sulla durezza de’ costumi, e nell’altra la mollezza era una conseguenza necessaria del suo governo e della sua vastità. Lo spirito minuto d’inutili distinzioni, che era nella filosofia aristotelica, sarebbe forse utile introdotto negli oggetti della politica, perché sembrami che prendansi di troppo in massa, e che tutto per lo più ridur si voglia ad un fattizio sistema della mente, piegando loro malgrado gl’inesorabili fatti alle idee nostre. Le verità politiche come le fisiche soffrirono più danni da chi le ha volute generalizare e ridurre a sistema che da chi con idee meno vaste, ma più sicure, le analizò ne’ lor dettagli particolari. Non è forse adunque un paradosso che gli uomini grandi hanno ritardato i progressi di tai scienze ed i mediocri gli hanno di molto accelerati. Bisognerebbe che la natura facesse nascere a tempo li vasti ingegni in tali materie; ed il tempo farebbe dopo molti mediocri, sagaci, studiosi, pazienti indagatori del vero. Allora il vasto ingegno, che tutti i particolari vuol sempre ridurre a’ generali, avrebbe una sterminata materia di grandi verità. Ma se questi uomini non sono preceduti da altri, che gli abbiano preparato il fondo su cui alzare i loro grandi edifizi, eglino li vogliono fabbricare anche senza fondamenti, perché amano troppo d’esser magnifici perfino negli errori.
A. [Alessandro Verri]
La prova del cuore
Nelle guerre fra la casa d’Austria e gli Svizzeri vi fu un giovine soldato di questi che si sacrificò alla patria come un altro Decio. Il fatto è memorabile. Stavano per esser rotti gli Svizzeri dall’urto di un battaglione austriaco che loro piombava addosso. Si trattava di tutto, se si perdeva la battaglia era vinta la patria. Quando il giovine svizzero, spiccatosi dalla sua fila, aperte quanto puoté le braccia, raccolse quante aste erano comprese in quello spazio e se le cacciò nel petto. Non v’è bisogno di dire ch’egli spirasse al momento. Ma con tal mezzo si fecero due voti laterali nel battaglione nemico, ne’ quali puoterono entrare gli Svizzeri e rompere gli Austriaci. Così questa vittima illustre salvò la patria. Raccontò questo fatto Filone nel caffè.
Demetrio all’udirlo io viddi che li brillava sul viso un virtuoso entusiasmo. Veramente quando io ascolto, proruppe il buon uomo con un’aria quasi affannosa, quand’io ascolto di questi tratti, mi sento propriamente tutto a commuovere. Quale erroe! Non gli si è fatta una statua? Sono stati così ingrati i suoi concittaddini? Santo amor della patria! Anime sublimi! Capperi, disse il signor Francesco del bel ventre, il nostro Demetrio si riscalda, ed intanto il caffè si raffredda! Così dissegli perché Demetrio aveva in mano la caffettiera, e sospendeva di versare il caffè, rapito dall’ammirazione di sì generosa virtù.
Per altro, soggiunse il signor Antonio, non saprei se fosse veramente ben provato questo punto d’istoria. Io ho fatto qualche studio di quella di que’ tempi e di quelle rivoluzioni, e non mi ricordo d’aver letto alcuno scrittore che lo rapporti.
Un bel goffo mi pare quello svizzero, ripigliò don Teopompo a grosse guance; chi gli sarà stato obbligato di farsi così bucare il ventre? Oh che matto, oh che matto! Ma ve ne sono di costoro. Mi favorisca una presa del suo rapè, signor Francesco.
Ma, disse un altro tale, mi sembra difficile che colla estensione delle braccia di un uomo si possano abbracciare tante aste da poter fare un sì rimarchevol buco in una schiera di cavalieri armati. Considero la distanza che passa dall’una all’altra asta, vi sono i cavalli di mezzo, vi sarà per verisimile un buon braccio di distanza dall’una all’altra, sicché due, o tre tutt’al più se ne potrebbero prendere. Come dunque fare un cotanto buco? Mi pare inverisimile.
Demetrio fu il solo uomo il di cui cuore fosse colpito dalla bellezza di tale azione e la di cui anima sensibile s’infiammasse di virtù. Il signor Francesco, io conchiusi, è un uomo cattivo che non ha cuore di sorte alcuna, perché preferisce il caffè un po’ più caldo ad un tratto sublime di eroismo, e pone in ridicolo un uomo in entusiasmo, cosa facilissima e funestissima. Di lui non mi fiderei punto. Sarà cattivo padre di famiglia se lo è, cattivo marito se ha moglie, cattivo cittaddino certamente.
Il signor Antonio è un pedante che tira in campo male a proposito la storia ed i suoi studi; anziché sentire la grandezza di tale azione, egli si pone a dubitarne. Forse vorrebbe che la lista degli uomini grandi fosse breve, per l’umiliante paragone che fa il suo amor proprio. Anch’egli non ha cuore. Sarà eruditissimo, ma non lo stimo.
Don Teopompo è un pessimo soggetto, egli è di quegli uomini di fango coi quali la virtù nulla puote.
Quel altro tale è uno di coloro i quali possono avere ingegno e spirito, ma non mai sentimento, che portano negli affari di cuore lo agghiacciato spirito di esatta discussione. Ei ragionava bene; ma guai a coloro che sanno ragionar così bene, quando non si dovrebbe che sentire!
Così da questo piccolo racconto ebbi luogo d’informarmi del carattere di tutte queste persone. Lettori, se volete conoscere i cuori, egli è appunto per questa via che lo potete fare. Un racconto di un atto grande e sublime, di una magnanima impresa mette a prova tutti i caratteri. Osservate i diversi aspetti sotto de’ quali la vedono gli ascoltatori, ed avrete un infallibile criterio per giudicare delle anime di ciascuno.
A. [Alessandro Verri]
Due pensieri
I Francesi si lagnano che la loro lingua è sterile, gl’Italiani vantano la loro come lussureggiante. La doglianza di quelli fa ad essi più onore che a noi il nostro vanto. Bisogna che i Francesi abbiano più idee che parole, e gl’Italiani più parole che idee. Essi vorrebbero dire più cose che non possono, noi diciamo meno di quello che possiamo. I Francesi passarono rapidamente dalla barbarie alla somma coltura, ed il loro vocabolario non poté, per così dire, tener dietro ai tanti lor concetti. Che diremo di noi? Forse che abbiamo un gran lessico di voci ed un piccolo di pensieri, sicché questi largheggino in quelle?
Per condurre gli uomini alla verità, bisogna per lo più non soltanto toglierli dalla nuda ignoranza, ma dall’errore. Onde son due le operazioni da farsi; distruggere ed edificare. Il metodo è forse questo: porre in ridicolo l’errore, poi annunciare la verità seducendo il cuore colle immagini della eloquenza, poi egli è tempo di freddamente ragionare. Perché egli è più facile il far ridere che il commuovere, più il commuovere che il convincere.
A. [Alessandro Verri]
IL CAFFÈ )( Fogl. XXV )(
Pensieri sulla solitudine
La solitudine continuata per lungo tratto di tempo è un male, come un male sono tutti gli altri modi fisici di esistere se non sieno mai interrotti. La gloria, gli onori, le ricchezze, il potere, tutti diventano mali, e mali insopportabili all’uomo, tosto che accompagnino tenacemente ogni momento della sua esistenza. Chi possede questi beni, e da lungo tempo s’è abituato a possederli, ritrova i momenti più deliziosi della vita qualora gli riesca di confondersi col popolo ed essere dimenticato nella folla de’ gregari. Un sovrano avvezzo agli ossequi ed alla ubbidienza si rallegra e voluttuosamente gode dell’incontro in cui taluno non conoscendolo lo tratti da uomo. Un letterato illustre e possessore della stima meritata si consola incontrando un pedagogo imperterrito che senza conoscerlo lo tratti da principiante. Un ricchissimo e accreditato negoziante gode se taluno sconoscendolo gli esibisca un mestiere per campar la vita. L’uomo in somma si consola qualora esce da quello stato che incessantemente lo accompagna, e il villano entrando nella città prova quella gioia che sente il cittadino all’uscirne. I piaceri fisici dell’uomo non tanto dipendono da una tale azione fatta sugli organi, quanto da una mutazione fatta allo stato di essi. Vastissimo sarebbe il campo per dedurne le spiegazioni di moltissimi fenomeni morali; ma io per ora restringere mi voglio all’argomento che mi sono proposto, cioè alla solitudine, la quale è certamente un male se è continuata per lungo spazio, ma disseminata giudiziosamente negl’intervalli della vita, è un bene de’ più dolci e deliziosi che abbia l’uomo in questo mondo. So che la massima parte degli uomini non conosce questo bene, io lo conosco e ne sento tutto il valore, e giacché le circostanze della mia vita mi tolgono il potere di goderne liberamente, come ardentemente vorrei, voglio almeno internarmivi col pensiero e sviluppare a me medesimo i principii di questo disparere fra i pochi e i molti.
La maggior parte degli uomini manca di quel vigore che è indispensabile per conoscere i principii della giustizia, della virtù, e per conoscere gli elementi della felicità; perciò la vita dei più è un tessuto di azioni contradditorie e di pentimenti che si succedono a vicenda; perciò molti naturalmente buoni ricercano il parere altrui ad ogni passo, e in vece di provvedersi d’una bilancia domestica, corrono dai vicini a far pesare ogni merce che occorre ad essi di contrattare; perciò moltissimi, dalla educazione corrotti, sprovveduti d’ogni guida dipendente da principii, ai quali non si giunge che con lena ed uso della facoltà ragionatrice, altra norma non hanno delle azioni loro che l’immaginazione ossia il capriccio. Tutta questa massa di uomini deve necessariamente aborrire la solitudine, poiché sì tosto ch’essi abbiano occasione di riflettere sopra di loro stessi, altro sentimento non possono provare se non se quello della disistima propria e del rimorso, e perciò cadono in braccio alla tristezza e sentonsi avvilire; e perciò impazientemente ricercano lo strepito e la dissipazione continua per cui vivono fuori di loro medesimi sfuggendo la vista o ridicola o vergognosa o abbominevole delle proprie azioni. Non è dunque maraviglia se la maggior parte degli uomini, associando per esperienza l’idea della solitudine coll’idea della noia, dell’avvilimento o del rimorso, la fugga con ogni sforzo e la riguardi come un male potentissimo. Gli uomini spensierati nella solitudine ritrovano le vendicatrici Erinni favoleggiate da’ Greci; e tanto più atroci sono, quanto la solitudine è maggiore, siccome accade fralle tenebre, allorché l’animo non può occuparsi nemmeno della vista degli oggetti esterni.
Da questo principio, cioè dalla mancanza degli elementi della virtù e del sapere, nasce la serie delle azioni mal connesse nell’uomo, e da essa l’abborrimento al riflettere sopra se medesimo, e perciò la fuga della solitudine, la quale quanto è maggiore, tanto s’accresce la tolleranza verso gli oggetti esterni. Da ciò ne viene che l’uomo sensato più facilmente s’annoia nella società che nella solitudine, e l’uomo volgare al contrario più facilmente nella solitudine che fralla società.
Esamina l’uomo di senno. Egli s’è sviluppati i principii che devono guidare tutte le azioni. Domandagli cosa è virtù; egli te ne dà una idea limpida, per cui facilmente distingui quale azione vi sia conforme e quale no. Domandagli cosa è urbanità, ei te ne descrive i veri confini, onde immediatamente conosci sin dove s’estendino le sue leggi. Gli uomini, dic’egli, han ragione di pretendere da me questa somma di azioni, il rimanente è in poter mio di organizzarlo e disporlo come mi pare. Senza chimere ei distingue la strada che s’ha da battere, e senza inquietudine vi passeggia. I suoi studi, le geniali sue occupazioni tutte hanno una abituale tendenza a renderlo migliore. S’ei trascorre la storia, non è già per farsi un magazzeno di nomi e di epoche in mente, ma bensì per esaminare una serie di fatti e di azioni, e conoscendone gli effetti estrarne le generali teorie sulle utili o dannose all’uomo. S’ei volgesi all’esame delle cose naturali, ei non si limita a ripetere destramente le curiose esperienze fatte da altri per far maraviglia agl’indotti; ma dalle poche nozioni che può ritrarne, ne estrae il metodo per accrescere i comodi della vita e conservarsela sana. Così dicasi, a proporzione, delle altre occupazioni dell’uomo di senno. E come vuoi che costui, che ha cercato di diventare una buona compagnia di se medesimo, abbia un bisogno incessante di star lontano da sé e non si sdegni, e rammarichi anzi moltissimo, qualora la combinazione delle cose lo trasporti suo malgrado nel vortice clamoroso ed inquieto degli affari o degli uffici?
Oh beata tranquilla solitudine, in cui l’uomo depone la maschera; in que’ momenti soli egli è perfettamente libero, in que’ soli momenti ei si consacra a se medesimo, e si esamina e si perfeziona ripiegandosi in se stesso. Felici le anime innocenti e buone, che si esaminano senza arossire! Uomini falsi e avvilupati in mille tortuosi raggiri figli dell’ignoranza, uomini avviliti sotto il giogo del vizio, qual distanza fra di voi e l’anima virtuosa, posti che siate entrambi in faccia di voi stessi!
Io provo che è un dolcissimo piacere l’alternare la solitudine e la società; nella prima pongo in ordine le mie idee, nell’altra le acquisto e le stroffino colle idee degli altri; sarei mal contento del mio essere se dovessi consumare tutta la vita a riordinare senza raccogliere o a raccogliere senza aver tempo di riordinare. L’abituazione a poter vivere anche solo una parte del giorno è un valentissimo mezzo a preservarci dai vizi nati dalla debolezza. Chi ha incessante bisogno d’essere dagli uomini distratto deve per necessità rendersi pieghevole alle opinioni degli uomini e diventare una frazione della società anzi che un essere che da se stesso esista. Ne ho osservati alcuni altronde dotati di molta sensibilità e di cuore disposto alla virtù. Si trovano essi fra persone che sparlano d’un uomo di merito, che disapprovano una lodevole riforma, che per passione o ignoranza, in somma ingiustamente distribuiscono le lodi e il biasimo? Piegano al grido, si uniformano alla opinion comune, e sebbene il loro intimo senso diversamente loro suggerirebbe, lo soffocano, lo lasciano inconsultato, e per necessità di rendersi aggradevoli a quel ceto del quale hanno assoluto bisogno per evitare la solitudine, sacrificano con vile condiscendenza l’amicizia, la verità e la virtù medesima ad una mal intesa urbanità. L’uomo in vece che può avvezzarsi alla solitudine ha un bisogno maggiore di conservare puro ed innocente l’intimo sentimento di se stesso di quello che non lo abbia di captivarsi l’accoglimento favorevole di verun uomo o di verun ceto d’uomini; ei saprà dunque non tradire giammai il suo cuore, egli oserà difendere l’amico assente contro la mordacità altrui, egli oserà mostrare rispetto all’uomo di merito reso ridicolo da uomini ridicoli, egli oserà mostrare abbominio per una azione malonesta sebbene applaudita dal volgare consenso. La solitudine dà all’animo un non so qual vigore, senza del quale non v’è virtù. Chi non osa avere una opinione e un sentimento proprio, chi va mendicando le opinioni e i sentimenti altrui per modellarvi i propri discorsi, questi non è, né può essere uomo veramente virtuoso; poiché sì tosto ch’ei troverassi fra i cattivi, sarà loro simile; né sarà buono che per virtù altrui qualora fortunatamente viva fra un ceto di gente che conosca la virtù; probabilità la quale è vinta dall’opposta. Quando è indispensabile il bisogno di vivere cogli uomini ne viene di conseguenza che tutto si sacrifica a quel bisogno; quando sappiamo vivere anche senza la società degli uomini siamo meno schiavi dei loro capricci, siamo più liberi, e conseguentemente più padroni della virtù nostra.
Chiunque esamina i mali della società trova facilmente che la maggior parte di essi trae la sua origine non già dalla ferocia, ma bensì dalla debolezza. Per un delitto feroce, ne trovi mille d’imbecillità. Forse tal verità è stata conosciuta dai nostri padri, i quali stabilirono per massima che l’uomo di coraggio fosse l’uomo virtuoso, e il codardo risguardarono come privo di virtù. La sorda cabala, la simulata amicizia, i riggiri, la maldicenza degli assenti, la perfidia, la simulazione non sono d’ordinario componibili col coraggio e robustezza dell’animo, e sono per l’appunto le sorgenti de’ principali vizi che avviliscono ed inquietano la umana società. Se nella educazione de’ giovani gl’institutori o ragionassero independentemente dagli usi, ovvero preferissero l’utile de’ giovani al comodo proprio in vece di far loro risguardare la cieca ubbidienza come una massima qualità da seguirsi, farebbero loro vedere la sola illuminata docilità e la illuminata fermezza essere la prima base d’ogni onorato carattere. La vanità e la indolenza degl’institutori sono certamente più soddisfatte quando trovino ne’ loro alunni altrettanti automi esecutori; e l’amor proprio di un dispota è sempre di pensar per tutti e far operar tutti per sé; ma un padre, o un maestro benefico, che guarda per primo fine delle sue cure il formare un fanciullo ad esser uomo, che vuol dare alla patria un virtuoso cittadino, al sovrano un utile suddito, non cessa mai di ripetere che è necessario esaminare prima di risolvere, conoscere prima di fidarsi, far tutto per ragione e niente per debolezza, seguire la verità e la virtù piuttosto che l’esempio. Per ciò fare conviene che l’uomo impari a saper vivere con se stesso; poiché altro non è la debolezza dell’animo che l’opinione d’aver bisogno degli uomini, e chi sa esser bene con se stesso non può avere forte opinione di questo bisogno.
Le lettere e le arti sono deliziose compagne della solitudine. Esse occupano delle ore voluttuosamente, per poco che l’animo e l’immaginazione sieno capaci di estasi. Sono queste le più cortesi e grate verso de’ loro amanti, la musica, la pittura, la poesia, la mecanica, la fisica sperimentale e simili possono formare la felicità d’un saggio nella solitudine; ma vogliono essere amate d’un amor puro e senza secondi fini, se non le ami per loro stesse e se le coltivi per servirtene di mezzo ad ottenere altri fini ti puniranno colla noia. Ma se sinceramente le coltivi e le ami, siane sicuro d’una proporzionata ricompensa; soavissime combinazioni d’idee ti si offriranno all’animo e te lo terranno in una incessante attenzione di variati oggetti; e nell’ozio tacito e tranquillo assaporerai le più innocenti e vivaci voluttà che possa provar l’uomo.
Gli uomini dissipati negli uffici della vita non possono nemmeno avere idea di questi beni, come non hanno idea di una forma di governo libera gli schiavi dell’Asia nati e allevati sotto il dispotismo, né presumo io di creare quelle idee nuove col mio discorso, le quali non possono nascere che dal sentimento d’una situazione per cui l’uomo sia passato; gli uomini però che sanno rendere a loro medesimi conto delle sensazioni proprie saranno meco di parere che le ore di solitudine sono necessarie a chi vive in società, come le ore di società a chi vive in solitudine, per non cadere nella noia; che l’amore della solitudine è assai conforme all’amore della virtù; e che in somma la solitudine è un elemento che contribuisce a renderci migliori e più felici, se abbiamo l’industria di ben distribuirla.
P. [Pietro Verri]
Della precauzione contro le opinioni
Chi ama la verità ha da esser indifferente nel ricevere o rigettare una opinione che gli venga proposta, sino a che per mezzo di un accurato esame non venga a conoscere la solidità dei fondamenti sopra de’ quali essa si sostiene. La maggior parte degli uomini addottano i principii a caso sulla fede altrui, ammettono imprudentemente i sistemi con puerile e vergognosa credulità ed amano piuttosto correre pericolo di restare ingannati che di esporsi alla fatica, la quale determinatamente abborriscono, o perché la giudicano inutile, o perché se ne credono incapaci. Egli è vero che si trovano degli uomini la di cui incapacità rende inutile ogni regola atta a condurli alla ricerca del vero, ma il loro numero è piccolo; il gran numero è di quelli i quali la mal’abituazione di non mai esercitare il lor ingegno ha resi inetti: tutte le loro facoltà sono come instupidite, ed hanno perduta quella forza e quella estensione che la natura loro aveva destinata. Vari non osano spingere la vista oltre i confini della opinione comune al secolo, al luogo dov’essi vivono, perché, dicon eglino, la voce del popolo è una voce divina e molti occhi assai più vedono che un solo. Ma io non so che giammai Dio abbia resi i suoi oracoli per mezzo della turba, né che la natura abbia giammai comunicati i suoi segreti alla moltitudine.
La eccessiva credulità e la pigrizia che sono proprie del comune degli uomini gli rendono indifferenti, ma di una indifferenza biasimevole, che gli fa pronti a determinarsi egualmente per la verità e per la menzogna e finalmente gl’induce a credere ciecamente ogni opinione piuttosto che a chiarirsene per mezzo dell’esame. Da ciò deriva che gli uomini generalmente fuggono sempre l’esecuzione de’ modi suggeriti dalla ragione affine di pervenire allo scoprimento della verità, o al più con una stupida aquiescenza non abbracciano che la di lei ombra.
I letterati eziandio non vanno esenti da questi difetti volgari. Dappoiché si diede il nome di studio alla lettura, un uomo che molto legge è creduto di molto sapere. Egli è uopo confessare che i libri sono di un gran soccorso all’ingegno, ch’essi somministrano i modi co’ quali pervenire alla scienza, e sono in somma la materia prima di pensare; ma egli è altresì certo che impediscono molti uomini d’arrivare a pensar da se stessi. Perloché ardisco dire niente esservi in cui l’ingegno debba condursi con più discernimento quanto nell’uso de’ libri, i quali senza questa precauzione se indistintamente si leggono, servono piuttosto di onesto trattenimento che di una utile occupazione, ed aggiungono forse più errori che verità alle nostre cognizioni, ed è preferibile la ignoranza all’errore.
I fatti rapportati dai libri sono di due spezie. O risguardano gli agenti liberi, sopratutte le azioni degli uomini riuniti in società, ciò che forma la storia della vita civile e dei costumi; o risguardono gli agenti naturali e le loro vicendevoli operazioni, sia che si lascino agire nel corso della natura, sia che l’industria umana gli applichi gli uni agli altri per farne delle esperienze. I primi devono essere esaminati colle circostanze dei secoli, dei luoghi, dei costumi; si ha da osservare l’eguaglianza, l’ordine dell’opera e la costanza delle asserzioni. Finalmente conviene assicurarsi della probabilità col sapere se l’autore fu contemporaneo, od almeno vicino al tempo in cui i fatti medesimi avvennero.
I secondi poi meritano d’essere verificati colla esperienza. La natura, che ha presentate le sue ricche produzioni agli occhi altrui, le offre ancora a’ nostri: e perché adunque noi, i quali possiamo consultare a nostro piacimento l’originale, vorremo attenerci al ritratto? Non manca industria a’ viventi per reiterare le sperienze degli antichi. Tutto ciò che si ammette senza queste diligenze è preso sulla fede dell’autore, e non se ne ha una costante certezza. Così non mi stupisco che vi siano molti scrittori che abbondano di citazioni e che non parlino che di autorità, questo è l’unico fondamento sul quale crollano i loro sistemi. Si può dire ch’essi hanno una scienza secondaria ed imprestata, e che parlano bene se il loro autore non s’inganna, lo che non si chiama sapere. Le autorità niente influiscono sulla verità o la fallacia de’ fatti. Siamo molto obbligati agli scrittori di tutt’i secoli d’averci trasmesse le cose passate e le scoperte loro, ma bisogna far di essi un buon uso, il quale consiste a non scorrere frettolosamente le loro opere, a non caricarci la memoria de’ lor detti, ma a seguitare il loro raziocinio, esaminare i loro racconti e le prove di essi, ed a giudicare sulla verità o falsità dalla verisimiglianza o dalla inverisimiglianza di ciò che propongono. Conoscere è lo stesso che vedere. È la più grande delle pazzie l’immaginarsi che si può vedere cogli occhi altrui. Fintanto che noi non vediamo una cosa cogli occhi propri e che il nostro intendimento non la percepisce, caminiamo nelle tenebre e non restiamo veramente instruiti, qualunque sia l’idea vantaggiosa che abbiamo dell’autore che ce la insegna. V’è forse ancor taluno che abbia il delirio che gli antichi sono senza eccezzione? Varie delle loro produzioni sono così lontane dal vero come lo sono di tempo. Ci hanno anch’essi regalati di molte falsità, hanno troppo facilmente addottati incredibili racconti e si sono cecamente ricopiati l’un l’altro, senza esame, senza critica e senza esperienza. Fu sempre carattere specifico de’ Greci il fingere e l’inventar ogni giorno racconti di favole colle quali hanno infettato lo spirito de’ contemporanei, e dei successori per conseguenza. Da quanto ci è rimasto di Palefato, si può conoscere quanto essi abbiano superate le altre nazioni nelle bugie. Erodoto, che da Cicerone fu detto padre della storia, è stato conosciuto falso e maligno da Plutarco. Egli ha veramente raccontate cose incredibili non ad altro fine, come riflette Tucidide, che di piacere al genio romanziere de’ suoi lettori. Ctesia di Gnido, medico d’Artaserse, citato sovente dagli antichi e di cui alcuni frammenti sono pervenuti a noi, è stato ripreso di menzogna per quanto disse intorno agli elefanti. Strabone non gli dà maggior fede che ad Omero ed agli altri poeti. Luciano dice chiaramente ch’egli ha raccontate cose né vedute, né sentite; lo stesso hanno fatto Antigono, Hegone, Appolonio, Galieno e Dioscoride. I successori loro hanno creduto in buona fede ed hanno copiato i loro scritti. S. Clemente Alessandrino osserva che i Greci erano in questa usanza, e lo prova con una infinita serie di esempi. Non inferiori ad essi furono i Latini. Plinio, che ha trascorsi più di due mila volumi e del quale dice Svetonio che non ebbero i Romani più gran compilatore, confessa nella sua prefazione che tutti gli autori da lui esaminati furono plagiari gli uni degli altri seguendo l’ordine de’ tempi. Le fatiche di Ondasio, d’Aezio e di Egineto tutte si riducono ad avere ricopiato Galieno. Eratostene ha trascritta perfino la prefazione di un’opera di Timostene. Simocrate nel suo trattato De Nilo, tradotto da Jungerman, ha fatto lo stesso con Diodoro da Sicilia, e di questo Simocrate al dir di Strabone sono stati plagiari Aristone ed Eudoro, i quali pure hanno parlato del Nilo. Marcello Empirico ha trascritta intieramente l’opera di Scribonio Largo sur la composizione de’ remedi. Ovidio ha prese le Metamorfosi da Partenio Chio. Virgilio le sue Egloghe da Teocrito, le sue Georgiche da Nicandro e da Arato, e se crediamo a Macrobio ha cavato parola per parola da Pisandro ciò che risguarda il cavallo di legno.
Quanto valente naturalista fu riputato quell’Aristotile il quale nelle sue Meteore ha scritto che il sale più facilmente si discioglie nell’aqua fredda, quell’Aristotile il quale ha detto nelle sue Etiche che il bue e la vacca non tossiscono, non ruminano e che unitamente a tutti gli altri animali non imbianchiscono invecchiando come fa l’uomo, e ne domanda meravigliato la ragione? Non ne abbiamo sott’occhi la giornaliera esperienza che ci dimostra il contrario? Come potrassi credere un autore originario colui ch’è stato plagiario d’Ippocrate e di altri scrittori, dai quali si è lasciato dar ad intendere delle cose che oltrepassano i limiti del credibile? Ha creduto con molta semplicità che il castoro abbia il costume di mutilarsi per isfuggire le insidie de’ cacciatori,[107] fatto favoloso ed impossibile a succedere.[108] Gli è bastato d’averlo ritrovato rappresentato nei geroglifici egiziani e scritto fra le favole di Esopo, autore vivente nel tempo di Tiro, per crederlo prontamente.[109] Questa sua eccessiva credulità apparisce ancora dal maltrattare che fece Melisto perché ricusava di credere sulla fede d’Anassagora, d’Anassimandro e di Empedocle. L’uomo, quando non ha interesse particolare da fingere, consiglia ad altri quello che addotta per se stesso. Che dirò poi di Plinio? Fra tutti gli errori popolari ora in voga, non ve n’è quasi alcuno che non sia direttamente o per induzione contenuto ne’ di lui scritti. Ma egli, credulo al pari de’ scrittori da lui consultati, si diffende nella sua lettera indirizzata a Vespasiano col dire che non ha scritto se non se quanto ha letto nelle opere altrui. Infinita
IL CAFFÈ )( Fogl. XXVI )(
perfine è la schiera degli errori che l’umana autorità ha trasmesso alle nazioni.
Chi per esempio dubitò mai che le rotture delle gambe ne’ cavalli sieno incurabili e che lo stesso animale non abbia il fiele, cioè quell’ammasso di bile raunata in una piccola vescica, che discendendo negl’intestini gli ponge ed eccita alla più facile espulsione degli escrementi, ed a questa mancanza si attribuiscono le lunghe e mortali infermità alle quali il cavallo è più degli altri animali soggetto? A chi fra di noi verrebbe in capo di rimarginare un osso rotto di un cavallo? Ognuno gli abbandona. I più celebri ed esperti menascalchi del nostro paese assicurano questi fatti come verità incontrastabili e si riderebbero di chi ne dubitasse. Eglino crederebbono di caricarsi la conscienza se proponessero ad alcuno la dispendiosa ed inutile esperienza di risanare una gamba rotta di un cavallo. In tal guisa una opinione opposta all’immediato interesse di tanti che si servono di questo utilissimo animale con molte spese, la troviamo adottata senza che alcuno da noi si sia preso l’incomodo di ben verificarne il valore ed i fondamenti. Pure ella è falsissima, perché le ossa del cavallo si possono rimarginare e ridurre al pristino stato di sanità come moltissime esperienze insegnano incontrastabilmente, ed io stesso ho veduta ristabilita una gamba di questo animale affatto rotta e disgiunta. La cura si fa col sospenderlo sopra delle cinte e fasciarli diligentemente la gamba, assicurandola ad un sodo travicello, affinché in modo alcuno non la possa muovere. Con tal metodo si risana intieramente a segno di essere abilissimo, dopo quaranta giorni in circa, a sostenere quelle fatiche alle quali era stato in avanti destinato. Parimenti l’opinione che il cavallo non abbia fiele si ritrova anch’ella fra le erronee e false, come tante altre. Com’è probabile che ad un animale così vorace, così soggetto a malatie bigliose abbia la natura voluto ricusare un maggior ricettacolo di bile di quello che non lo sono le vene ed il sangue, e non l’abbia provveduto d’un altro canale per scaricare il superfluo? Questa opinione viene originariamente da Aristotile e da Plinio. Ma Absirto, greco scrittore che viveva nel tempo del gran Costantino, assegna un luogo al fiele nel fegato del cavallo. Carlo da Bologna ne fa una esatta descrizione. Egli è bensì vero che un tale ricettacolo del fiele non è una vessica eminente, come si ritrova nelle altre bestie, ma ella è nascosta nella cavità del fegato sotto forma diversa. Chi voglia chiarirsi sempre più della verità potrà consultare, oltre i suddetti accurati anatomisti, il signor Ruyni ed il signor Bouffon, che lo colloca nella maggior grossezza del canale epatico, e molto meglio ne resterà convinto chi ne faccia la esperienza. Le lunghe e mortali malatie de’ cavalli traggono origine dalla prigionia in cui li constringiamo: dalle impure esalazioni e dalla traspirazione che somministrano maggiore quantità di materie alla corruzzione dell’aria nelle troppo rinchiuse stalle. Egli è costante che la decima terza parte dell’aria stessa, ancorché pura, respirata in un’ora da un animale perde la sua elasticità e diventa inutile per la nuova respirazione; quanto più prestamente la perderà un’aria già infetta ed imputridita? I cavalli, che nell’America spagnola si sono tanto moltiplicati, i quali vivono in libertà senz’altra coperta che il ciel sereno, sono più forti, sono più leggieri e più sani. Si abbia adunque cura di mutar l’ambiente nelle stalle col dar passaggio all’aria e di tenere da esse lontana quant’è più possibile ogni immondezza, e non si creda che i cavalli non abbiano fiele e che non si riuniscono le lor gambe quando son rotte. Sia anche questo un esempio della forza delle opinioni ed un avvertimento della cautela colla quale devono esser ricevute.
F. [Sebastiano Franci]
Digressioni sull’uomo amabile, sulla noia e sull’amor proprio
Qual è l’uomo amabile? Egli è quello che più si piega e s’incurva alle nostre passioni ed a’ nostri difetti, che conosce la natura del nostro amor proprio e che se lo tien sempre presente per non irritarlo. Non mai ci piace chi fa la satira de’ nostri vizi o mortifica il nostro orgoglio. Costui può aver tutte le ragioni del mondo, egli avrà sempre grandissimo torto. La natura umana è inesorabile in queste condanne. Chi parlando coi deboli lumi dell’umana filosofia si vanta di più eroici principii è un ipocrita o un ignorante.
Per esser ciò che chiamiamo generalmente uomo amabile, bisognerebbe esser del carattere di Alcibiade: popolare in Atene, frugale in Isparta, magnifico in Persia, ghiotto ed ubbriaco in Tracia. Ma questa pieghevolezza di carattere è molto sospetta. L’uomo di virtù costante non è capace di tanta versatilità, perché non è capace di smentire i suoi principii ad ogni momento e per piccole cagioni. Le robuste querce muovono tutt’al più le frondi al soffiar de’ venti; le deboli canne li secondano in tutti i versi. Chi sa fingere per sistema ed abitudine i difetti degli uomini per esser grato e far buona compagnia, dirò così, alle debolezze ed opinioni loro, può ancora, anzi deve immancabilmente fingere anche la virtù ed i sentimenti. Non v’è che un passo da fare, ed è impossibile il non farlo. Non ci meravigliamo adunque se gli uomini, che sono virtuosi con robustezza e per principii, non sieno sempre i più amabili presso al comune degli uomini. Non ci meravigliamo tampoco se coloro i quali sembrano onesti e desiderabili in tutti li ceti vengano talvolta inaspettatamente scoperti per caratteri molto equivoci. Quand’è che l’uomo virtuoso sarà comunemente l’uomo di moda? Quando gli uomini virtuosi saranno comuni.
La noia è un sentimento così proprio dell’uomo socievole e colto che sempre lo accompagna, e la più gran fatica del mondo è quella di sapersene schermire. L’uomo socievole si è fabbricata una sì gran folla di fattizi bisogni; ha divisa in tante minutissime porzioni la massa della sua sensibilità; ha accresciuta in tante guise la sua esistenza; si è così moltiplicati i sensi, che di molte ed infinite cose egli ha d’uopo per occupare tutti questi moltiplici organi del suo esistere. L’uomo selvaggio non eccede nelle sue idee la sfera ristretta di que’ pochi oggetti che conosce. La caccia, la pescaggione, la guerra, il cibarsi e poco più sono la materia delle sue sensazioni e gli bastano, perché i desideri non si formano prima della conoscenza. Perciò quand’egli in tai cose non è occupato, o dorme od è tranquillo. Ma l’uomo di colta società, a forza di artificiali bisogni, o reali o di opinione, ha fatta nascere nell’animo suo una continua inquietudine per soddisfarli, d’onde ne viene un incessante bisogno di moto nella sua vita, il qual prurito dell’animo, per così dire, diventa in lui un’abitudine, sicché nulla gli è più disaggradevole che il fissar lungo tempo l’attenzione su di un soggetto, e nulla di più aggradevole che il passeggiare successivamente dall’uno all’altro. Perciò il selvaggio sta de’ giorni intieri contemplando scorrere una fonte ed abbrucciare il fuoco; e l’uomo civile ne soffrirebbe la più dolorosa noia del mondo. Le sensazioni di quello sono ancor semplici ed in massa, ed un oggetto solo basta a tutte riempierle; laddove questo ha una mente composta e sminuzzata in menti infinite, sicché per occuparle per lungo tempo non basti una sola sensazione, ma una massa di sensazioni.
Non v’è che qualche poeta, che ancor si ricordi dello stato che vien detto di natura da’ pubblicisti. Voi gli udite cantare la vaga Filli, che al gorgogliar d’un ruscelletto, allo spirar de’ venti matutini che soavemente scuotono le frondi degli allori, se ne giace sul prato e si lagna de’ suoi ardori; oppur vi sono gli albori dell’aurora, o le querele notturne del patetico rossignolo o delle colombe innocenti, che ispirano una dolce tristezza, o la tacita luna che inargenta i campi, e le tremule onde del mare, ed il pastorello che, le tempia cinte di rose, risponde al tenero canto di Filli col lamentevol flauto onde risuonan le valli. Ma ponete il vostro poeta con questa sua brava corona di rose sul toppè, con questo suo ciuffolo in bocca, e faccia pure eccheggiar le valli, che mi saprà dire qual deliziosa situazione ella sia codesta. Se qualche pecoraro diverrà mai poeta, egli canterà i nostri aurei tetti, i nostri squisiti pranzi, i morbidi letti, i profumati appartamenti, le comode carrozze. Oh egli sì che non sarebbe malcontento di realizzare le sue poesie! Perché adunque crediamo così dolce questo stato, e ci riescono toccantissime le immagini silvestri, quelle che i villani ed i pastori non trovano quasi degne di attenzione? Non è già che sieno semplici queste sensazioni: esse sono composte del paragone che facciamo col nostro lusso, colla mollezza, coi civili costumi; sono il frutto della sazietà de’ piaceri: non sono meno che il risultato di buona parte delle idee sociali.
S’annoia l’uomo di spirito nella conversazione se non può brillare; s’annoia l’ignorante coll’uomo di spirito, s’annoia il timido coll’orgoglioso, ogni carattere per fine ci è molesto se non fa la corte al nostro amor proprio. Queste son tutte idee che la società ci ha acquistate, ed esse sono tante e sì complicate, e l’orgoglio ha tante pretensioni, che non v’è al mondo creditore più molesto di lui. Tutti l’hanno, tutti altamente richiamano i suoi diritti, ecco perché sia così difficile il non offenderlo. Non basta il conoscere queste verità per non esser amanti di noi stessi, bisognerebbe non essere quai siamo. L’uomo però che conosce quel gran fondo di filosofia, il cuore umano, vede altresì quest’istesso suo inestinguibile amor proprio in tutt’altro aspetto di quello che lo vede il comune degli uomini. Essi sono tratti dai primi suoi impulsi, a lui servono senza riflessione; ma l’uomo che più astutamente intende i propri vantaggi si avvezza a piegare la sua forza per quelle direzioni che meglio il conducano a que’ fini d’utilità che si preffigge. Questa triste filosofia è talvolta peggiore dell’ignoranza. L’uomo volgare è irato, brutale, feroce a vendicarsi dalle ingiurie, dalle offese, dal disprezzo; ma l’uomo astuto soffoca le prime voci dello sdegno, e lo fa poi scoppiare nelle sorde cabale, negli indiretti modi di offendere, nelle meditate e fredde vendette.
L’orgoglioso ignorante in questa sublime scienza dell’orgoglio palesa a tutti ne’ suoi moti e ne’ suoi discorsi questo sentimento ch’egli ha. Eccovi l’orgoglioso di buona fede, e perciò sciocco. L’orgoglioso che ragiona non cede alle prime tentazioni del suo amor proprio. Ei vede che ’l suo stesso orgoglio sarebbe esposto a mille insulti se lo manifestasse apertamente. Gli uomini non gliela perdonerebbero, perché essi più o meno hanno l’istessa pretensione, perciò egli è cauto ed anche adulatore; cerca in tutte le occasioni di rendersi benevolo e placare quel sempre irato nume della superbia altrui; offre a lui talvolta per fino voti acciocché non lo offenda e non si opponga alle sue passioni. Eccovi l’uomo orgogliosissimo divenuto pieghevole e compiacente; s’egli rafina più oltre la sua filosofia, diverrà anco modesto.
L’ambizioso, che non conosce altro che la sua ambizione, e non quella degli altri, urta, muove, sconvolge, rovescia ogni cosa per alzarsi due dita dagli uomini. Egli è più vano che ambizioso; perché impaziente di rendersi superiore al comune livello, diffonde questo suo desiderio in tutti gli atti della vita e lo stende a tutti i più minuti oggetti. L’ambizioso ragionatore trattiene i flutti di questo gran fiume, non lo lascia diramare in piccoli ruscelli. Egli sembra freddo, indifferente; tesse in pace le sue reti, cova i suoi desideri, aspetta tempo, occasione, allora si muove con vigore e va dove si era prefisso.
L’uomo di lettere che ha ottenuta la fama se non intende i suoi vantaggi si vendica della oscurità in cui giacque; non nasconde il vivo senso, ond’è vellicato, della gloria; e così offende l’amor proprio di quegli istessi i di cui suffragi egli cotanto agogna. L’uomo di lettere che ragiona su i principii del cuore umano ottiene che gli uomini gli perdonino la sua superiorità colla modestia; e questa modestia non sperata gli acquista il più grande olocausto al suo orgoglio, l’ammirazione.
L’uomo d’un amor proprio ancor rozzo, che voglia brillare nella società, è aspro, caustico e contraddicente; non può soffrire ch’altri abbia spirito, non ammette verità ch’ei non abbia scoperta; tronca a mezzo le sue sconfitte. L’uomo di amor proprio maligno pone insidiosi inciampi all’ingegno altrui; coglie in aguato con fredda distrazione tutte le occasioni di spargere il ridicolo su chi voglia più brillare di lui, ei non s’avvede che alcuno abbia merito, non consente allo spirito, non si accorge de’ talenti; ma aspetta al varco l’amor proprio altrui per ferirlo. Né l’uno, né l’altro ottengono il loro fine di essere i monarchi della conversazione; ambi sono odiati e fuggiti come pessima compagnia. L’uomo che si conosce prepara gli animi ad accordargli il principato dello spirito con interessare l’amor proprio altrui: mischia le sue vittorie con qualche artificiale sconfitta; implora officiosamente i voti con delicatissima adulazione; cerca le occasioni d’incontrarsi colle altrui opinioni; non trascura quelle di lodare, di biasimare a tempo; è attento ad interessare in suo favore tutte le passioni; piega per vincere; seduce per comandare. Qual fatica per farsi perdonare la sua superiorità! Pure, questo è il mezzo per riuscirvi.
L’uomo è complicatissimo nelle sue passioni, e nulla è tanto difficile quanto il non oltraggiarle. Il meno atroce, ma il più intolerabile dei delitti sociali è la seccatura. Oh noia, noia funesta, che ci dipingi i volti di pallore, ci solchi il viso colle tue traccie profonde, e non ci lasci tampoco il piacere della vendetta, perché i più noiosi uomini sono difficilissimi ad annoiarsi! Cos’è questo terribile sentimento che ispirano costoro? Entriamo in qualche analisi di questa sensazione, proccurando di non ispirarla.
Questo sentimento di molestia parmi composto di sdegno e di avvilimento. Si parte ammareggiato, abbattuto, stanco, irato tutt’assieme dalle noiose conversazioni. Sonovi diverse cagioni che producono quest’effetto. Primamente la disanalogia delle idee lo produce. Due uomini che abbiano diversa logica, e che giudicano degli oggetti ambi in conseguenza, s’incontrano sempre di fronte nelle loro conclusioni e devono aver sempre la mortificazione di essere vicendevolmente risguardati come mancanti di raziocinio. Se questi due uomini sono brutali si azzufferanno; se sono educati si annoieranno potentissimamente. Quanto Catone il Censore si sarebbe annoiato con Crasso e Cesare, e così a vicenda! E ciò perché l’amor proprio di entrambi sarebbe stato in una situazione incomodissima, qual è quella di soffrire continui attestati di disistima e di dover stare in estrema penosissima cautela per ismentire i propri sentimenti e per vestire le idee altrui, che altrimenti il dialogo sarebbe presto finito. Questi dispareri di logica, la urbanità e le sociali leggi vogliono che si nascondano; quindi bisogna bere a sorso a sorso il disragionamento altrui, piegarvisi, secondarlo, applaudirlo ancora, ed in questa officiosa condiscendenza l’uomo ch’è sensibile alla ragione, se è costretto a rimaner alcun poco, si riduce a non poter più resistere; l’anima sua si abbassa, perde le parole; l’uomo di spirito diventa anche sciocco; nella incertezza in cui è de’ principii, co’ quali ragionare, nel sospetto che ha sempre presente di non offendere le altrui idee, egli è così incomodamente situato che più non si riconosce. Datemi per lo contrario l’istesso uomo in una compagnia analoga alle sue opinioni, egli si abbandona a se stesso, egli non teme contraddizioni o falsi ridicoli, egli riposa la sua ragione in braccio della ragione altrui; acquista un tuono franco; si sente liberi i pensieri, non ha bisogno di cautela, l’uomo di spirito è nella più brillante situazione in cui possa essere, ed in quella in cui ne ha moltissimo. Come volete che il gran ragionatore non si annoi col brillante ma falso spirito, e che il pedante stia comodamente in conversazione col leggiero uomo di mondo?
La disanalogia delle opinioni produrrebbe ancor più la vicendevol fuga fra gli uomini, se nella società vi fosse tempo di conoscersi a fondo; ma in quella generalmente più si vedono che non si definiscono; più si sfiorano che non si penetrino le persone. Altronde l’educazione dà generalmente, a tutta la massa sociale degli uomini, principii comuni di condotta; e ciascuno nella sua educazione ha imparata quella pieghevolezza ai difetti altrui, quella dissimulazione de’ propri sentimenti e quella decenza di azioni la quale insegna a godere più che a contrastare colla società. Quindi generalmente v’è un certo qual gergo comune a tutti gli enti sociabili, il quale fa che i dispareri intorno alla ragione ed alle opinioni sieno per lo più nascosti, e non si mostri l’anima che in quell’aspetto in cui l’esperienza le ha insegnato che si è generalmente aggradito od almeno tolerato. Che se obbligaste ciascuno a fare in pubblico la sua professione di logica, voi avreste distrutta quella mezza amicizia che lega tanti animi, ossia che li fa star insieme in qualche maniera; forse sospetto che ne potrebbero per fino nascere delle atroci guerre civili. V’è un’altra sorgente della noia, e questa è per avventura la più comune, cioè la monotonia delle idee e ’l pesare su di un solo oggetto per lungo tempo. Niente va esente da questa. Montesquieu poteva annoiare quanto la Sofonisba del Trissino, se avesse preso chicchesia, anche de’ più intimi e cordiali suoi amici, e che lo avesse obbligato ad udire la lettura del suo Spirito delle leggi per tre ore continue. L’animo umano si rivolta a questa pretensione di tenerlo occupato e servo per lungo tempo di una sola sensazione, e la idea soltanto di questa schiavitù lo annoia e lo molesta.
Da questa sorta di noia bisogna che si guardino gli uomini di una sola passione. Newton che sempre parlasse della gravitazione, Fontenelle de’ suoi mondi, Bossuet delle sue controversie, Boileau de’ suoi versi molesterebbero qualunque uomo ragionevole. Il letterato su di quest’articolo dev’esser cautissimo. Egli stima i suoi studi; s’interessa in quelli; dà loro più importanza di qualunque altro uomo. Ora, il pretendere che questa sua passione si ritrovi anche ne’ suoi amici istessi in quel grado in cui egli l’ha, è una pretensione irragionevole. L’uomo che sempre non vede che un solo oggetto, io pronuncio resolutivamente che è un grandissimo seccatore. Egli non prende parte alle passioni altrui, e vuol che tutti prendino parte alla sua. È un terribile dispota. Poiché adunque l’umano intelletto non è generalmente capace di lungo tempo insistere su di un soggetto, e chi ve lo voglia tenere cagiona in esso uno sforzo molestissimo, ne deriva che gli uomini più universalmente aggraditi nelle sociali assemblee sieno quelli che hanno l’arte di leggiermente scorrere e rapidamente volar radendo sopra moltiplici e variati soggetti di ragionare, che molto più hanno d’immaginazione che di esattezza di raziocinio, ed i quali temono estremamente la pertinacia in qualunque argomento. L’ultima finezza giunge ad indicare i punti di conversazione, ma non mai ad esaurirli, perché allora non si lascierebbe all’amor proprio altrui il piacere di aggiugnere alcuna cosa del suo. Chi poi ha l’arte d’indicare a ciascheduno le vie per le quali gli si apra campo a brillare, e le conosce, egli al certo sarà la più cara persona del mondo.
Dirò finalmente che la noia è il flagello delle anime più fine. Esse pretendono, e con ragione, più minuti riguardi, più delicata urbanità, i sensi dell’anima loro sono estremamente squisiti e suscettibili di minime impressioni. Laddove le anime più rozze ed indurite o non conoscono o difficilmente provano questo molestissimo sentimento. Dolce tranquillità della soavissima ignoranza! Giocondissima stupidità, quanto sei tu più felice della patetica sapienza, dello spirito delicato, della ahi troppo facilmente irritabile ragione! Siete puniti, moltissimi uomini di spirito, cento cose vi annoiano, mille vi molestano; avete mille fattizi bisogni, siete voluttuosi ne’ piaceri dell’anima; e vi fa per fino d’uopo di lusso nella sensibilità. Siete vendicati, o pochissimi stupidi, della loro superiorità; poche idee vi riempiono la mente, poche sensazioni vi rendono tranquilli, e beatamente vi godete questo minuto secondo della eternità de’ secoli che respiriamo! Io dovrei qui parlare di que’ sublimi seccatori, infiniti interrogatori, robusti chiaccheroni, gravemente sragionatori, freddi contraddicenti, scempi complimentari, scioccamente spiritosi, sconciamente burleschi, insulsamente lepidi, bestialmente brillanti, pesanti declamatori… Ma non andiamo in collera. Sono discreto; essi sono li più amabili uomini del mondo a quella condizione colla quale volea Cicerone abboccarsi con Catilina: dummodo inter me et te murus intersit.
V’è, per ultima conclusione, la maniera di rendersi noiosissimo per troppo timore di non esserlo. Ciò accade a colui che si fa un dovere di sempre brillare. Penosa e miserabil fatica! Non sono che il sentimento ed il cuore che condiscono la veramente buona società. Chi vi comanda di avere dello spirito vi annoia, anzi ve lo toglie. Se un uomo condenserà in un’ora di conversazione tutto il brillante di Fontenelle e di S. Evremond vedrà molte bocche sbadiglianti intorno di sé. Siate discreto nello spirito, se volete che vi si dia la permissione di averne.
A. [Alessandro Verri]
IL CAFFÈ )( Fogl. XXVII )(
Alcune idee sulla filosofia morale
La maggior parte degli uomini il meno che conosca è se stesso. Quanto pochi sono quelli che sanno render conto de’ principii, co’ quali diriggono le loro azioni! Quanti se fosser obbligati a definirsi non si tirerebbero d’impaccio in conto alcuno! Chiamate a quello che corre dietro alla fortuna ed alle ricchezze: perché tanto ti affanni? Chiamate a quell’altro che cerca gli onori: perché tanti raggiri e cabale? Chiamate a quest’altro: perché sei bugiardo? perché maldicente? perché maligno? qual bene ti viene egli da tutti questi tuoi vizi? Vi è da scommettere che non sa far l’apologia della sua malvagità, e che freddamente esaminando se ciascuno di questi vizi, anche senza farsi carico della virtù de’ doveri e de’ sentimenti, siangli propriamente utili, egli non saprà provare esser tali.
Gli uomini sentono a un di presso all’ingrosso ciò che loro è utile, e da un meccanismo di sensazioni piuttosto che da un’analisi di ragionamento sono dirette le azioni della loro vita. Vi vogliono molti lumi e molta filosofia, anzi né gli uni, né l’altra talvolta bastano per isciogliere i complicatissimi problemi della morale e della nostra felicità: che penseremo poi del comune degli uomini, che giacciono nel sonno degli errori e non si conducono che per esempio e stupore?
Qual definizione è più importante di quella della virtù? Quale nello stesso tempo più vaga e più incerta? Dunque l’uomo misura la distanza, il peso, la velocità de’ pianeti; dunque conosce i miracoli delle matematiche, ha fatto i vascelli, gli orologi, le carrozze, le fontane, i telescopi, ha in somma perfezionate le arti e le scienze in sommo grado, e non ha tuttavia idee chiare, semplici ed esatte della morale?
Cosa mai volean dire gli antichi filosofi con que’ loro illustri deliri intorno alla virtù? Cos’erano quelle entusiastiche declamazioni? Niente. Sarò io divenuto più buon padre di famiglia, più affettuoso marito, amico più cordiale, cittadino più zelante, quando saprò con Esiodo e con Lucillo che la virtù è una dea, la quale sta su di una scoscesa rocca, sulla quale è difficile il giugnere, le di cui falde sono rovinose, scoscese, impraticabili? Avrò io fatto più sensibile il mio cuore, avrò io perfezionato il mio spirito quando saprò con Orazio[110] ed Aristotile che la virtù sta in mezzo delle estremità, d’onde ne venne il detto volgare in medio stat virtus? Sarò io istruito dagli orgogliosi stoici, quando mi dicono che le virtù essendo facoltà dell’anima, esse pure sono esseri spirituali della stessa sostanza di lei; ch’esse sono inseparabili, che chi ne possiede una le ha tutte?[111] Che vogliono dire le superbe espressioni che l’uomo virtuoso non può essere offeso da nessuna ingiuria, perché la sceleraggine non può essere più forte della virtù, e che le calamità, le disgrazie, le sfortune possono tanto contro la virtù quanto può la nebbia contro il sole?[112] Come non è ella odiosa e ributtante la virtù in questa setta, che la ripone nell’astinenza de’ piaceri e nella toleranza de’ dolori? Come si può amare senza uno sforzo la virtù nelle deffinizioni di Platone e di tanti altri, che senza mai deffinire che sia questa virtù pretendono ch’essa non si debba tralasciare quand’anche ci dovessero da lei provenire i più grandi svantaggi?[113] Quanti ripeterono che la virtù deve cercarsi per lei stessa, senza motivi d’interesse, per la sola sua bellezza? Qual senso aveano quelle declamazioni: Oh virtù, degno oggetto delle fatiche degli uomini, esclamava Aristotele in un suo inno,[114] oh virtù, bene il più prezioso che possa acquistarsi. Ella è la tua incomparabile bellezza, che fa disprezzar la morte; tu riempi il cuore di una felicità più risplendente dell’oro e più dolce del sonno. Tu appoggiasti il valor d’Ercole nelle sue disgrazie; tu spingesti i figli di Leda alle più sublimi imprese. Aiace, Achille abbandonarono per te la vita. Le Muse non sono occupate che a cantar le lodi di chi ti ha consagrati i suoi giorni? Vi sentite voi dopo questi tratti di poesia più virtuoso? Vi rendete voi un conto esatto di ciò che si chiama virtù? Se il mio sarto avrà fatto quest’ode, dovrò io esser persuaso ch’egli non mi nasconderà un mezzo braccio di stofa?
Primieramente io domando, è egli necessario, per esser buon cittadino, tenero amico, onest’uomo, benefico, opulente, di gettarsi nel seno della metafisica per ritrovare a tentone nella folta nebbia delle opinioni e delle contraddizioni i nostri doveri ed i principii, con cui regolare la nostra vita? Egli è importante che tutti gli uomini, s’è possibile, sieno virtuosi, ma pure non è ottenibile che tutti gli uomini ragionino. Dunque il fondare la morale su ragionamenti sublimi è lo stesso che il fare una morale di speculazione per poche anime egualmente sublimi, e l’abbandonare l’uman genere alla funesta eredità de’ suoi errori. Cogli uomini illuminati tu puoi ragionare, perché eglino non rimangono a mezzo, ma essendo capaci di una catena di ragionamenti non ricevono le verità tronche e dimezzate. Ma generalmente col comune degli uomini tu non puoi entrare a discutere le materie morali senza gran pericolo che non abusino della ragione. Perciò io credo che il mezzo più atto a comunicar le idee morali all’universale degli uomini sia la strada del sentimento. Molti sentono, pochissimi ragionano. Il sentimento non fa sofismi; l’intelletto ne fa moltissimi.
Vi vuol egli tanto a persuadere agli uomini che sieno buoni? Dipingete l’uomo cattivo con veri e terribili colori. Vedi il bugiardo, che ha perduta la fede e ch’è involto in molti intrichi, che soffrir deve molte mortificazioni. Vedi il maldicente fuggito, odiato, abominevole in ogni ceto. Vedi l’uomo senza cuore, senza sincerità, senza dolcezza di costumi, privo di amici, dei beni più dolci della vita, abbandonato a se stesso, cioè alla peggior compagnia ch’egli possa avere, e compagnia che porta sempre con sé. Sviluppate agli uomini i loro veri interessi, quelli che consistono in una costante e vera felicità, e voi vi troverete sempre sul cammino della virtù. Non crediate pericolosa la massima, se l’intendete bene, che virtù ed interesse nostro sono la stessa cosa; non vi spaventate di Orazio, quando vi dice: Atque ipsa utilitas iusti prope mater, et aequi. Ma intendetelo, cioè non vi maravigliate che la virtù ci renda felici, che la vera strada di esserlo, di procurarci una vera e costante utilità sia quella di esser uomo dabbene. Scorrete di mano in mano su tutte le condizioni della vita, su tutte le umane azioni, voi trovate che esattamente ragionando dovrete sempre predicare la bontà, la beneficenza, la gratitudine, la compassione e l’umanità.
Altro non deve fare, per mio avviso, il filosofo morale che svilluppare i veri interessi degli uomini; giacché come potrete loro persuadere una virtù opposta a’ loro interessi reali e veri? Anzi, ve ne può ella essere di tal sorta? Un trattato di questa moral pratica e, dirò così, sensibile e non speculativa ci manca.
Non ragioniamo tanto: miseri noi se per essere buoni abbiam bisogno di sillogismi! Miseri noi se di lunghi e metodici trattati ci è d’uopo per esser buoni cittadini, uomini sensibili ed onesti! Più ci perfeziona il cuore una tragedia od un romanzo, opere screditate, ma ottime, ed ardirei dire necessarie per formare il cuore e lo spirito: più ci fanno onesti e sociabili le comedie di Moliere che non tutti i libri di metodici, secchi, inconseguenti, non persuadenti precetti di etica. Vogliono essere pitture nella morale, vogliono essere dipinti con vivi colori gl’inconvenienti del vizio ed i vantaggi della virtù. Allora non vi è uomo che non ne possa trar profitto, perché ogni uomo ha un cuore ed ha sentimenti; e quantunque sieno essi dalla educazione e dalle opinioni soffocati, ne porta sempre con se stesso i semi, i quali si schiudono da un abile filosofo che sappia le recondite vie della sensibilità e si ponga ad eccitarla. Anche il raziocinio ci può far buoni in quanto che ci analizza i vantaggi dell’esser tali ed i mali che provengono dal non esserlo: ma se non mischiate la sensibilità col raziocinio, se non profittate di que’ morali sentimenti che più o meno ha ogni uomo, se non ponete per materia prima de’ vostri precetti quei fremiti dell’anima, quei gemiti di compassione che stanno riposti in ogni cuore, voi non moltiplicherete il numero degli uomini dabbene. Levate all’uomo il sentimento di compassione, levategli l’amor proprio; su di che fondarete voi, umanamente parlando, la vostra filosofia morale? Questi sono i due principii, che non devono mai trascurarsi in tali materie. Ogni precetto deve emanare da essi, se ha da esser utile.
Sul sentimento di compassione, sentimento che ha ogni uomo, voi fabbricate la beneficenza, l’umanità, l’amor della giustizia e tutte le più sociali e sublimi virtù; ma con i precetti potete di poco accrescere questo sentimento in chi per sua sfortuna non ne abbia ottenuto molto dalla natura. Potrete servirvi di questo per parlare di tempo in tempo al cuore. Il linguaggio del cuore produce delle vive sensazioni, ma non durevoli; una tragedia fa piangere, ma non persuade, perciò non lasciano profonde traccie queste passaggiere illusioni. Ciò in cui vi fermerete di molto sarà nel far vedere i vantaggi della virtù e gl’inconvenienti del vizio e nell’unire, quanto più potrete, le idee di virtù con quelle di felicità e le idee di vizio con quelle di miseria. Voi potrete far agevolmente vedere, che cominciando dalla più abietta sino alla prima delle sociali condizioni, sono utili ad ognuna di esse la giustizia, la verità e la virtù. Vegga l’artigiano nelle morali instituzioni che i vantaggi del suo piccolo commercio saranno più grandi quanto la buona fede, la diligenza de’ suoi lavori saranno maggiori; e vegga altresì quanto saranno i suoi svantaggi se sulla mala fede e gl’inganni, a’ quali va dietro il discredito, poi la miseria, vorrà fabbricare la sua fortuna. Egli è tanto vero, che parlando della negoziazione, è interesse di chi la professa di avere quelle virtù che sono proprie di tal condizione, le quali tutte poi si riducono alla buona fede, che ne’ paesi dov’ella fiorisce, quelle virtù si ritrovano in grado sublime, e sono così necessarie che senza di esse non susisterebbe una grande negoziazione. Lo stesso appare in tutte le altre condizioni. Non sono mai volgari i soggetti nella morale, se essi in qualunque maniera instruiscono. Non isdegnate di discendere a qualunque classe di persone. E che? Non sono tutti gli uomini oggetto assai importante per meritare le viste del filosofo? Non si faccia tanto il sublime in tali materie: si faccia il catechismo per tutte le condizioni; non si sdegnino i dettagli: s’istruisca e non si brilli. La morale è fatta per tutti gli uomini. Siamo scrittori volgari, non importa, ma accresciamo il numero de’ buoni. Non tanto fa di bene in questo genere chi ne fissa i principii generali, quanto chi sviluppa ne’ casi particolari l’applicazione. Discenda pure il filosofo morale ne’ doveri del padre di famiglia, e facciagli vedere che i suoi veri vantaggi sono l’esser amato, ed insegnili il modo di esserlo. Vegga che i suoi interessi sono di far felice la sua famiglia, ed impari come la debba fare. Da lui impari la moglie la compiacenza verso del marito e l’amorevolezza verso i suoi figli; e imparino questi a piegarsi all’ordine della famiglia, a non esserne inutili membri, ad esser grati ai benefizi, rispettosi alla vecchiezza. Ma non declamate: persuadete, dipingete qual sia la felicità di una famiglia, in cui questi è padre, quella madre, questi figli, quello marito, questa moglie, ma tutti amici, tutti intenti a concorrere all’armonia e felicità comune. Sviluppate quanto ognuno debba contribuire a questa felicità comune, fate vedere li necessari inconvenienti che provengono dalle false idee che si formano gli uomini del posto che occupano in questi domestici regni. Dipingete una famiglia in cui la discordia scuota la sua face infernale, in cui vi sia un continuo commercio di fiele e di sospettosa perfidia, dove mille piccole, ma sciaurate passioni tengan luogo della benevolenza, della bontà, e ponetela a canto di una famiglia di amici, dove i domestici sentimenti e la semplicità affettuosa allignano, e vedrete se a tal confronto vi sarà uomo che non si scuota.
Insegnate al magistrato l’amor della giustizia e la incorruttibilità, ma non lo fulminate col mal definito vocabolo di dovere; persuadetelo. Ei vegga quali pericoli attorniano questi vizi; vegga la perdita della fama e della stima; vegga il discredito che le va dietro, d’onde l’avvilimento, d’onde i rimorsi, d’onde il poco conto di quella dignità a cui ha aspirato per farsi superiore agli uomini, e che in tal guisa non l’ha sollevato in alto che per maggiormente esser loro soggetto ed inferiore. Ei vegga come non v’è coraggio dove vi sono macchie, e che il coraggio onorato è necessario in tal condizione ove gli uomini, che mai non perdonano alcuna sorta di superiorità, cercan sempre di nuocere, ed in molti che hanno questa maligna intenzione cresce la probabilità delle offese.
Poi andate, se volete, alla morale del letterato, ed ei vegga che il fiele e la malignità denigrano qualunque gran fama, e che la modestia e la semplicità, unite a’ vasti talenti, sono ciò che maggiormente li fanno rispettabili e luminosi.
Poi in somma scorrete quante condizioni vi piace, e in ciascheduna seguite questo metodo, e sempre mischiate il linguaggio del cuore a quello dell’analisi, perché in tal guisa avrete tutti i vantaggi possibili per convincere in queste materie. Io parlo di umane virtù; quelle di natura più sublime hanno mezzi più elevati per convincere. Mi sono prefisso in questi miei pensieri di ragionare soltanto della morale virtù, in quanto che di essa sono capaci tutte le nazioni, e di esaminare se ancor senza motivi più augusti possano seguirla gli uomini. Se la sola filosofia umana può inspirarla, di qual forza non sarà ella se abbia più alte cagioni e soccorsi di un genere superiore?
Che se scorrendo per tutti i dettagli delle umane azioni per avventura si trovasse alcuno forse non contingibile caso in cui l’esser uomo dabbene apporti svantaggio, allora il sensibile ed illuminato filosofo faccia cadere un velo su questi mostri, acciocché gli uomini non fondino sistemi su fatti particolari e credano utile il vizio perché in qualche caso forse esser lo puote. Tutta l’umanità esclama: nascondi, nascondi. Tutta l’umanità ha interesse che queste orribili inconseguenze delle contraddizioni, prodotte da’ mal fondati sistemi, sieno sepolte nelle più dense tenebre. Ma non temiamo d’incontrarci con un esatto ragionamento in molti di questi casi. No; la natura non ci ha fatti cotanto infelici. I vizi tutti in fondo sono vermi che corrodono i fondamenti della società; e le virtù tutte in giro recano vantaggio a tutti gli uomini, d’onde ne deriva che ciascun uomo abbia un vero interesse di non dar l’esempio del vizio e di dar quello di seguire la virtù. Dall’omicidio sino alla menzogna si può provare che la nostra costante utilità esigge che non ammazziamo e che non siamo bugiardi. Le leggi puniscono l’omicida, ed esse contrapposero un dolore o più grande od almeno eguale al barbaro piacere che possa produrre la distruzione di un essere a noi eguale. Non v’è bisogno di molta filosofia per esser convinto di ciò. Alla menzogna va dietro il discredito, la derisione, la fuga, il disprezzo, e tutti questi mali compensano di molto il bene che questo vizio possa produrre. Non sarei breve se volessi addattare gli stessi principii a tutte le altre viziose azioni; ma l’applicazione non è difficile a farsi da chichessia.
Di fatti, prendetemi generalmente in ogni classe di persone l’uomo felice, e vi trovate sempre che è l’uomo che si è ben sviluppati i principii del suo vero interesse e che ha tutte le virtù proprie di quel posto ch’egli occupa nella società. Qual è l’uomo felice generalmente? Il maledico, l’ingrato, l’invidioso, il maligno, il perfido, l’ingiusto, il prepotente, l’inurbano, il duro, il feroce, il tristo, l’orgoglioso; oppure il buono, il grato, il semplice, il vero, il giusto, l’urbano, il dolce, l’onesto, l’umano, il modesto? Uomo insensibile, uomo di ghiaccio, uomo di pietra, prendi pure in mano la bilancia, pesa e libra con imperturbabile freddezza il vizio e la virtù, e vedrai cadere la bilancia in favore di questa. Or tu mi chiami cos’è virtù? Io ti rispondo quel metodo di azioni che ti farà costantemente felice. Mi chiami cos’è vizio? Quella serie di azioni che ti farà sicuramente infelice.
Sono più i vizi che produce l’ignoranza, che la perfidia. Le passioni ci presentano ad ogni tratto de’ beni incostanti e de’ vantaggi chimerici. Tutto consiste in calcolare negli ultimi dettagli il vantaggio ed il disavantaggio delle nostre azioni. Ma la mente umana generalmente non ha questa forza di tutti comprendere i dati per isciogliere i problemi morali; d’onde ne proviene che non se gliene presentino che que’ pochi, i quali gli oggetti e le circostanze od il caso le presentano; e perciò il pentimento inutile succede tante volte a questi mal sciolti problemi. Quel filosofo adunque che ci sviluppasse le più remote conseguenze delle umane azioni e che presentasse all’umana mente la genealogia, dirò così, di tutte le azioni della vita, risparmierebbe alla società tanti mali quanti sono quelli prodotti dall’ignoranza, val a dire la più gran parte: ed avvezzandosi con tal metodo gli uomini a ragionare su i principii della morale, forse in breve diverebbe comune questa scienza divina di esser onest’uomo e buon cittadino per ragionamento, lo che vuol dire per convinzione, e per convinzione vuol dire per costanti principii; onde non più sì confuse, ed oscure sarebbero generalmente, qual esse si sono di presente nel comune degli uomini, le idee di virtù e di vizio, ma per avventura un affare di pochi e semplici sillogismi. E tutto ciò farebbe gli uomini virtuosi, quand’anche fossero destituiti di ogni sentimento morale; i quali sentimenti poich’essi hanno, che manca, per far buoni tutti gli uomini, rendere amabile la virtù ed odioso il vizio, se non se che la morale cessi di esser una or tragica, or comica declamazione, e scielga i suoi principii nell’intelletto e nel cuore umano, non nelle vuote e tenebrose regioni di mal definiti vocaboli? Facciamo una morale d’idee, non di parole. Egli è ben vero che le imperfezioni che si ritrovano in tutti i sociali sistemi, imperfezioni or necessarie, perché conseguenze dell’umana piccolezza, ora arbitrarie, ma provenienti da una serie di quasi indistruttibili errori, produr sogliono tal volta delle contraddizioni fra dovere e dovere, dalle quali con gran fatica si può preservare anche il saggio; ma questi casi sono a un di presso così poco frequenti, che non pregiudicano alla formazione di un sistema di morale. Basta ch’egli comprenda all’ingrosso lo sviluppamento de’ più frequenti ed importanti principii di condotta, perché rechi gran vantaggio alla società quel filosofo che lo intraprenda.
Gli antichi fondavano i lor sistemi morali su delle grandi ed ammirande immagini, tutto era entusiasmo, le virtù tutte eran giganti. Di rado ragionavano, quasi sempre erano poeti. In questi ultimi tempi, per lo contrario, la morale tutta sembra che ridur si voglia ad un’esatta analisi. Forse né l’un, né l’altro di questi metodi è il vero. Quello degli antichi era capace di fare degli orgogliosi stoici, degli uomini sublimi, dei mostri, direi quasi, di virtù; ma questo non è che l’effetto di una robustezza di entusiasmo, la quale non può mai essere comune agli uomini, e la morale dev’essere comune. La fredda analisi poi di taluni fra i moderni porta con sé l’inconveniente che avvezza gli uomini a star troppo in guardia contro de’ propri sentimenti ed a calcolare le azioni della vita con quella esatta discussione con cui si scioglie un problema di matematica. Ma con tai mezzi non si distruggerebber eglino, od almeno non si scemerebbero di molto i sentimenti del cuore, sentimenti che fanno, presi in massa, la nostra felicità, ma che ad uno ad uno difficilmente resistono alla fredda discussione? Misero colui che non è mai ingannato dal suo cuore! Egli non sarà mai la vittima della sua sensibilità, non troverà mai un amico ingrato; non si pentirà mai di avere amato, non detesterà mai quel punto in cui si è abbandonato in braccio della illusione, ma non avrà tampoco mai provato i sublimi piaceri dell’amicizia, della benevolenza, e tutti quei gratissimi errori della sensibilità. Freddo ragionatore, chiudi le porte del cuore ai danni che talvolta reca la sensibilità, ma perdi ancora tutti i divini suoi entusiasmi. Che se così infelice tu sei che soltanto con nudo ed analitico raziocinio tu cerchi la virtù, vedi come al risplendere della filosofia l’uomo indiretto, maligno, ingannatore ha perduti tutti i suoi vantaggi, e gli è rimasto il ridicolo e l’abominazione. La vecchia politica è divenuta trasparente. Onde conchiudi: sempre più che gli uomini intenderanno il loro vero interesse, saranno più buoni ed umani; e più che le false idee di utilità e di giustizia staranno in luogo della illuminata morale, essi saranno barbari, pessimi ed anco miseri. Felice quel tempo in cui sieno da tutti conosciute le strade del vizio e la falsa sapienza della mala fede! Allora sarà appunto che non si avrà alcun vantaggio a seguirla; cosicché gli uomini saranno più buoni, più che sapranno come si faccia ad esser viziosi. Felice quel secolo in cui gli uomini cattivi sieno abominevoli; felicissimo quello in cui sieno ridicoli!
A. [Alessandro Verri]
IL CAFFÈ )( Fogl. XXVIII )(
Sulla interpretazione delle leggi
Fralle opinioni delle menti umane alcune ve ne sono le quali per la utilissima loro azione e per la vanità egualmente de’ loro oggetti meritano il nome di benemeriti errori e di famosissime chimere. Tali sono i deliri de’ chimici per la pietra filosofale, gli studi de’ geometri per rettificare o quadrare le curve che racchiudano perfettamente un’aia, i lavori de’ machinisti per inventare artificialmente un ordigno che perpetuamente stia in moto; al che aggiungo le meditazioni de’ politici per organizare una società d’uomini nella quale la felicità e sicurezza da leggi immutabili vengano egualmente divise su tutti gli uomini che la compongono. Queste chimere hanno mirabilmente contribuito ai progressi della fisica, delle matematiche e della grand’arte de’ legislatori, poiché scavando in queste miniere per ricercarvi quello che non v’è, si sono incontrate per via casualmente vene e strati non preveduti e utilissimi. Ognuno facilmente può sapere di quanti rimedi, di quante tinture e curiosità interessantissime siamo debitori alla vanità degli alchimisti; sanno i geometri quanta luce abbia portato alla sublime teoria delle curve la ricerca dell’equazione fra la retta e la circolare dal cavaliere Isacco dimostrata impossibile; così dico delle altre sublimi chimere di tal fatta. La repubblica perfetta è stata lo scopo delle estasi di molti uomini grandi e benefici, i quali da Platone sino al dì d’oggi si sono lasciati assorbire dalla virtuosa immaginazione di vedere gli uomini liberi e sicuri perfettamente. Questi sogni hanno però mirabilmente schiariti i veri interessi del genere umano, e se è vero che l’opinione sia la direttrice e padrona della forza, essa dovrà tanto più rivolgersi al comun bene, quanto meno l’opinione sarà da lui distante.
Gli uomini comuni altra società non conoscono che quella nella quale sono nati e cresciuti: essi non mai rivolsero il pensiero ad analizare i principii che la compongono; perciò credono la loro propria la sola forma perfetta di sociale instituzione, pronti a pagare cordialmente col più sincero disprezzo qualunque proposizione che loro venga fatta per cambiare in meglio. Gli uomini, all’incontrario, i quali dopo essere passati per l’errore nei primi anni della lor vita hanno potuto conoscerlo e riscuotersi e ricercare da loro medesimi la realità degli oggetti, sdegnosi forse dell’inganno passato, quasi avessero una macchia da togliere alla memoria delle loro opinioni, si slanciano nel regno delle riforme, e con avidità mal cauta ad ogni pensiero applaudono per poco che abbia apparenza di novità, e si appropriano facilmente un piano di nuova legislazione sulla più leggera apparenza di utilità. Il saggio trovasi nel mezzo di questi due estremi, e col dubbio e coll’esame va cautamente bilanciando, senza abborrire e senza adorare le cose vecchie o le nuove, per ritrovare e discernere le cose vere, ed utili indiferentemente.
Un’altra fortissima opposizione trovasi nella mente della maggior parte degli uomini qualora vogliasi indurli a qualche riforma d’opinioni ne’ pubblici regolamenti, e questa viene dall’esame negletto dei principii delle cose e dai stretti confini della vista comune, cioè d’escludere ogni buona instituzione sì tosto che se ne affacci un inconveniente, e veder lui solo isolato senza discenderne nel bilancio dei beni e mali, che pur dee farsi in ogni scelta politica. Non v’è legge, sistema, né vi possono essere, dai quali non nascano alcuni inconvenienti; nelle cose umane si tratta sempre di scegliere il men male, non mai di stabilire cosa perfettissima: e questo è lo scoglio appunto de’ politici inesperti, la ricerca del sistema senza difetti, questa è la pietra filosofica loro, questa è la loro quadratura del circolo. La massima che nelle umane cose bisogna scegliere il men male e non cercare la perfezione, che non vi può essere, è una massima che è detta e ripetuta da ognuno; ma rari assai sono coloro che, quando sono nel caso particolare, non operino appunto con viste direttamente opposte a questa massima. Ciò ho dovuto conoscere pochi giorni sono nel nostro caffè coll’occasione di parlare sulla interpretazion delle leggi con un uomo altronde ragionevole, che non mi è mai riuscito di persuadere. Io raccontai quello che trovasi nella dissertazione Sulle ragioni di promulgare o abolire le leggi, scritta da un re che è un membro illustre della reppubblica delle lettere indipendentemente dalla corona. Ivi dunque si legge che nell’Inghilterra v’era una legge che proibiva la bigamia; un uomo fu accusato d’avere cinque mogli, e siccome la legge si osserva letteralmente in Inghilterra, e che il caso delle cinque mogli era ommesso, così l’accusato fu riposto in libertà senza alcuna pena. Io raccontai questo fatto, e il mio avversario cominciò a ridere di tutto cuore sulla stupidità di quei giudici, i quali non avevano nemmeno potuto capire che chi ha cinque mogli ne ha due, e che se la bigamia, ossia le due mogli, ha tre anni di galera, chi ne ha sposate cinque è stato bigamo due volte e mezzo, e in conseguenza deve stare per lo meno in galera sette anni e mezzo. Oh! oh! oh!, schiammazzò fortemente, e tutti gli astanti fecero ecco con esso lui; chi deridendo tutta quanta l’Inghilterra, la quale in fatti poi non è tanto ridicola, massimamente sul mare, chi deridendo l’autore che racconta questo fatto, ed altri quasi sospettando che fosse una favoletta inventata dal mio capriccio quella che aveva esposta. Io lasciai calmare questo tumulto, chiesi frattanto una tazza di caffè; poi, fatto luogo a placidamente ragionare, così presi a discorrere.
Sarebbe mai possibile, signor mio, che l’amor proprio vi concentrasse tanto in voi stesso da credere che tutti i giudici d’Inghilterra non sappiano che cinque è più di due, e che sposar cinque mogli è più che sposarne due? Non voglio crederlo. Non trionfate dunque di questa scoperta, di grazia, e supponiamo pure che i giudici inglesi sappiano che il due è un numero minore del cinque, poiché sin là vi sono certamente arrivati. Il dilegio e la disapprovazione vostra dunque cade su di ciò, che avendo gl’Inglesi una legge che punisce chi ha due mogli e non avendone alcuna che punisca chi ne ha cinque, non abbiano inteso lo spirito della legge, ossia la intenzione del legislatore nella sentenza, e siensi attenuti allo stretto senso letterale. Dunque voi avete trovato assurda cosa che il giudice abbia rigidamente osservata la lettera della legge e non lo spirito. Esaminiamo se veramente sia tale.
Comincio a stabilire un principio secondo ogni ragione chiarissimo, cioè che altra cosa è il legislatore, altra cosa è il giudice. Il legislatore è sempre il sovrano, o sia egli un uomo o uno scelto numero di uomini o la intera nazione radunata, giusta la diversità de’ governi. La legge è un ordine pubblico del sovrano che obbliga le azioni de’ sudditi generalmente. Quest’augusta facoltà di promulgar leggi è inerente alla sovranità istessa, cosicché non può esercitarsi che dal sovrano o da chi è da esso delegato a tal fine, promulgandole però sempre in nome del sovrano. Il giudice per lo contrario non può essere il sovrano, debb’essere o un uomo o un ceto di uomini, ma non ad altro fine fatti giudici che per fare osservar le leggi; il legislatore comanda, il giudice fa eseguire il comando. Se il legislatore farà eseguire o il giudice comanderà, la sicurezza pubblica sarà sconvolta, poiché riunendosi nella stessa persona queste due facoltà, ne nasce il potere di opprimere impunemente e colle solennità della giustizia chiunque, e l’opinione della sicurezza di se medesimo, opinione preziosissima, in cui realmente tutta consiste la civile libertà, ne verrebbe radicalmente distrutta. È dunque conforme alla ragione che il giudice non si erigga mai in legislatore, e come dice il gran Bacone: Si iudex transiret in legislatorem, omnia ex arbitrio penderent (De augm. scient., lib. VIII, aph. 44). Questa cardinale verità è stata luminosamente promulgata dal immortale autore dello Spirito delle leggi (lib. XI, cap. VI), dove si legge: Qualora nella medesima persona o nel medesimo corpo di magistratura la possanza legislatrice è unita alla facoltà esecutrice, non v’è più libertà; poiché si può temere che lo stesso monarca o senato non facciano leggi tiranniche per eseguirle tirannicamente.
M’accorgo che questi principii sono talmente contrari alle idee che l’educazione ha stampate con incessanti precetti nella mente dei più, che nessuna maggior impressione debbon fare di quello che sogliono i paradossi più strani e capricciosi. Per andare al vero gradatamente, abbiate, signori miei, la bontà di riflettere quale sarebbe lo stato d’una società d’uomini in cui non vi fossero leggi di sorte alcuna, né scritte, né per tradizione. In questa società vi sarebbero dei giudici nondimeno, poiché è necessaria una forza qualunque, che prevenga o assorbisca le usurpazioni e l’intestina guerra che è sempre pronta ad accendersi. Quale sarebbe l’autorità di questi giudici? Dispotica perfettamente. Potrebbon essi togliere a chiunque beni, fama, libertà, vita, e i beni, la fama, la vita, la libertà d’ogni cittadino dipendendo dal parere d’un giudice che non ha altra legge che il parer suo, ogni cittadino sarebbe nella schiavitù perfettamente. Forse il caso potrebbe riporre nella giudicatura degli uomini di probità, che ascoltando la voce di quella legge naturale che ha dettate tutte le buone leggi scritte, non usassero del poter loro che per contenere i malvaggi, forse le decisioni di questi giudici sarebbero un modello d’equità e di sapienza; ma forse ancor potrebbon essere questi giudici tutto il contrario, e questa sola possibilità toglie l’opinione della libertà in ogni cittadino, il quale non può essere giammai sicuro di sé o del suo sul testimonio delle proprie azioni. Anco su i troni dell’Asia si veggono sovrani che hanno nel cuore tutte le più benefiche virtù atte a rendere felici i loro popoli; allora la tirannia pratica non v’è, ma vi resta la tirannia di sistema; cioè che l’impero del uomo è maggiore di quello della legge. In libero populo imperia legum potentiora sunt quam hominum, scrive Livio (lib. 2, cap. 2). Dunque cominciamo a stabilire questa verità dimostrata, cioè che dove non vi fossero leggi e vi fossero giudici, ivi l’arbitrio del giudice sarebbe illimitato e dispotico; il che equivale a quest’altra posizione, che tosto che il legislatore e il giudice sono la stessa persona, questa persona è illimitata e dispotica, il che significa che in quella nazione non v’è libertà politica.
Allora uno de’ miei ascoltatori m’interruppe chiedendomi cosa m’intendess’io di dire colle parole libertà politica, se forse m’avessi formata un’idea che si potesse in una nazione far da chiunque tutto quello che il capriccio o le passioni suggeriscono. Signore, gli rispos’io, col nome di libertà politica io intendo l’opinione che ha ogni cittadino di possedere se medesimo e quello che è suo, e di poterne a suo piacere disporre sin tanto ch’ei non trasgredisca le leggi promulgate con legittima autorità. Dico dunque che questa libertà politica sarebbe annientata in una nazione in cui il giudice fosse legislatore. Dico dunque che in quella nazione vi sarebbe la servitù per sistema; la quale è men violenta, ma più durevole assai della servitù per abuso. Queste verità, miei signori, sono appunto quelle che hanno spinto gl’Inglesi, amantissimi, e non a torto, della libertà politica, a stabilire che il giudice sia perfettamente servo della legge e mero esecutore di essa letteralmente. Ecco il ragionamento che essi hanno fatto. Se il giudice diventa legislatore, la libertà politica è annichilata; il giudice diventa legislatore sì tosto che è lecito interpretar la legge; dunque si proibisca al giudice l’interpretar la legge; dunque si riduca ad esser mero esecutore della legge; dunque eseguisca la legge nel puro e stretto significato delle parole e nella materiale disposizione della lettera.
Che il giudice, tosto che la legge è soggetta a interpretarsi più in un senso che in un altro, diventi legislatore, è cosa per sé evidente, basta per esserne convinto il riflettere che interpretare vuol dire sostituire se stesso al luogo di chi ha scritto la legge, e indagare cosa il legislatore avrebbe verisimilmente deciso nel tale o tal altro caso su cui non parla chiaramente la legge. Interpretare significa far dire al legislatore più di quello che ha detto, e quel più è la misura della facoltà legislatrice che si arroga il giudice. Su due casi può aver luogo la interpretazione: il primo caso è quando nella legge non sia preveduto l’affare che si deve decidere, e che sia affare nuovo, sul quale non siavi legge alcuna chiara e manifesta; il secondo caso è quando nel corpo delle leggi vi siano due diversi principii, fra i quali sia dubbio quale dei due debba diriggere la decisione dell’affare. Nella prima supposizione il giudice, col pretesto d’interpretare la mente del legislatore, realmente fabbrica una nuova legge sulla quale appoggia una sentenza, e conseguentemente il legislatore ed il giudice coincidono perfettamente nella stessa persona. Nella seconda supposizione poi il disordine è meno palese, ma non però vi sta meno; poiché il giudicare con leggi fabbricate di propria opinione, ovvero il giudicare sulle leggi legittimamente promulgate bensì, ma moltiplici, varie, opposte, ed avere la scelta libera di prenderne ora l’una ed ora l’altra, sulle quali stabilire sentenze opposte in casi altronde simili, è presso a poco, quanto alla sicurezza e libertà politica, la cosa medesima; e il giudice che abbia facoltà di scegliere più una legge che un’altra per giudicare un caso è realmente legislatore, essendo che ei dà forza di legge più ad un testo che ad un altro della legge istessa. Dunque l’interpretar la legge fa diventare legislatore il giudice e confonde le due persone del legislatore e del giudice, dalla assoluta separazione delle quali dipende essenzialmente la libertà politica d’una nazione. Dunque una nazione che cerchi la libertà politica deve proibire ad ogni giudice ogni qualunque libertà d’interpretare le leggi, altrimenti facendo ne accade quello che il chiarissimo signor Genovesi ha scritto nel suo ragionamento sul commercio, cioè che allora le leggi in mano del potente e dell’astuto sono sempre armi pronte e forti ad offendere ed ingannare; ma non già armi da difesa in mano del debole o dell’ignorante.
Due partiti dunque restano da prendersi nello stabilire il sistema d’una nazione per ciò che risguarda l’officio del giudice, o render il giudice mero e servile esecutore della lettera della legge, ovvero lasciargli l’interpretazione di essa legge. Osservinsi i beni e i mali che contengono queste due disposizioni, e vediamo se abbia avuto veramente torto la nazione inglese. Se il giudice è mero e servile esecutore della lettera della legge, ne nasce il disordine che abbiamo veduto nell’esempio accennato al principio di questo discorso, ed è che molti casi non si possono dal giudice decidere, perché la legge non gli ha preveduti, né è possibile il contenere in un solo codice tutte le azioni che il capriccio dell’uomo può fare. Rispondo: o si tratta di un giudizio criminale, come era l’accennato, e qual male sarà mai che resti impunito un uomo solo, che ha fatta un’azione contraria al buon regolamento della società, la quale azione è stata ommessa dal legislatore? Il male certamente non è grande; tale sarebbe se quest’esempio servisse per altri casi consimili; ma il legislatore d’Inghilterra rimediò immediatamente a quest’unico disordine, promulgando una nuova legge universale in cui vedevasi proibita la poligamia sotto le pene imposte per l’addietro alla bigamia; così restò chiuso l’adito ad altri di sposare più di due mogli per sottrarsi alla pena imposta inavvedutamente a chi sposava due mogli. Il primo caso restò impunito, perché commesso prima che letteralmente fosse vietato dalla legge, la quale non obbliga prima che sia promulgata; gli altri casi consimili generalmente si sottoposero alla pena colla dichiarazione del legislatore istesso, cui solo spetta ampliare o ristringere il numero delle azioni libere de’ cittadini. Vero è che non è possibile descrivere in un codice tutte le azioni che possono commettere gli uomini; ma è vero altresì che tutti si riducono a classi i delitti; e che una serie d’anni suggerisce le giornaliere forme o addizioni che si debbono fare al codice per comprendere con poche leggi generali i casi tutti verisimilmente contingibili.
Che se poi si tratta di causa civile, il prudente legislatore può togliere la metà delle liti col circoscrivere la capricciosa libertà degli uomini nel patteggiare o donarsi fra di loro, ed io dico che circoscrivendo e limitando i testamenti ad alcune formole, fuori delle quali non sia valido il testamento, e stabilendo i gradi delle successioni limitate; così pure proponendo le formole d’altri contratti, la metà delle dispute di privata giurisprudenza verrebbe tolta dal mondo. Ristretti in tal guisa da un sensato codice i limiti delle azioni legittime, facile sarebbe il ridurle anch’esse a classi; e presentandosi un caso che in nessuna classe sia compreso, il legislatore o un corpo da esso delegato lo terminino coi principii della semplice equità, condensando per quel solo caso imprescindibile le due persone del legislatore e del giudice nello stesso corpo; ma ciò immediatamente sia tolto colla promulgazione d’una legge generale che in avvenire comprenda i casi simili. A ciò dunque si riducono gl’inconvenienti di rendere il giudice servo della lettera della legge, cioè che un primo delitto può essere impunito, e che in una disputa civile ommessa dalla legge si dovrà ricorrere al legislatore o al delegato da esso, in vece di aver la sentenza dal giudice. Questi inconvenienti non sono frequenti dovunque vi sia una legislazione ben fatta; né sono mai grandi inconvenienti; laddove la perdita della libertà politica, inseparabile dalla interpretazione della legge, è un male di sistema, un male abituale, che lima e rode ogni principio animatore e motore degli uomini.
Il più dolce, il più benefico impero è quello delle leggi; esse non conoscono parzialità, non hanno affetti; sode, immutabili ordinano lo stesso ad ognuno.
Ma a che riducete voi l’ufficio del giudice?, mi replicò uno dell’adunanza, voi rendete inutile il giudice, se la sola legge provvede a tutto. Signore, gli replicai, la legge deve prescrivere come si provveda a tutto; ed il giudice deve eseguire quanto prescrive la legge. Un codice non basta per tenere una nazione tranquilla e sicura; bisogna che i metodi per la sicurezza e tranquillità pubblica prescritti nel codice sieno posti in esecuzione; e quest’è quello che spetta al giudice. Non è leggiero l’ufficio suo, l’ufficio del giudice è principalmente la verificazione dei fatti; ei deve trovare la verità e cercarvela con sollecitudine, conoscer bene come la cosa sia, e fatto ciò, la legge fa il restante, cioè comanda come debba essere. Il solo dispotismo stabilmente utile, anzi necessario per la prosperità d’una nazione è il dispotismo delle leggi; il vero dispotismo propriamente detto, cioè il volere assoluto e independente d’un solo non è utile che passaggero nelle nazioni corrotte per ricondurle ai loro principii. Da ciò vedrete, signori, che il fatto del poligamo inglese non è realmente né tanto inverisimile, né tanto strano, né tanto ridicolo quanto vi è sembrato.
Così terminai il mio discorso, e ciascuno del caffè si alzò e prese congedo. Un mio amico, che si trovò a caso sulla porta, ascoltò i ragionamenti che facevano fra di loro i miei uditori. Uno disse: Quel uomo è sempre strano nelle sue opinioni. Un altro soggiunse: Belle cose in teorica, ma in pratica, poveri noi! Un terzo brontolava col suo compagno: Sempre quell’Inghilterra, sempre Inghilterra! Un quarto sosteneva che tutto quello che avete udito sono altrettanti soffismi. In somma, anche in questa occasione si conobbe che l’uomo rinunzia ai pregiudizi più tardi che può; che la ragione difficilmente persuade le menti già incallite con una opinione; che dalla ignoranza alla verità la strada è assai più facile che dall’errore alla verità; che l’uomo nel regno dell’immaginazione lascia fabbricare in qualunque maniera, distruggere gli spiace; che finalmente l’amor proprio inerente all’uomo è assaissimo interessato a sostenere le cose che ha giudicate una volta per vere, e il piegarsi imparzialmente alla verità è una sorta d’eroismo.
P. [Pietro Verri]
Agli scrittori del Caffè
È molto tempo dacché voi non inserite ne’ fogli vostri le lettere che vi vengono dirette, non mi curo di saperne la cagione, questa però vi prego di non dimenticarla nel fascio delle altre. Io son un uomo che non ha mai stampato cosa alcuna, e vorrei coll’aiuto vostro passar matricolato autore a diventare un membro della repubblica letteraria. Ve ne sono tanti che non ne sanno più di me e vanno all’onorato torchio! Chi vi porta un sonetto per monaca, chi un epitalamio, chi un almanacco, chi una disquisizione sopra una lampada sepolcrale: oh basta entrare in una vasta biblioteca per conoscere se anch’io possa pretendervi! Fatemi dunque questo piacere, scrittori del Caffè, e per animarvi a compiacermi vi dirò che i vostri fogli sono seri disperatamente, e se non vi fosse stato quel tale Comentariolo in onore e gloria della ragione umana, sarebbero molti e molti fogli senza nulla che rallegri il benigno lettore. Ora, padroni miei, dovete pur sapere che il numero de’ lettori che voglion ridere è maggiore di quelli che vogliono instruirsi. Considero dunque che la vostra maniera di scrivere, se vi proponete di pubblicare un libro che sia letto anche da qui a qualche tempo, tanto tanto può passare; ma se cercate di risvegliare sul giorno i lettori conviene che scherziate, che sfioriate, per dir così, la materia e che lasciate tutti i vostri principii di legislazione, di analisi del cuore e simili. Questo consiglio è buono, è ragionevole e merita che lo stampiate. Seguitelo poi o non seguitelo, ciò non preme; ciascuno ne’ suoi libri deve fare a modo suo, come nella casa propria. Il Cielo vi dia ogni bene.
IL CAFFÈ )( Fogl. XXIX )(
Di Carneade e di Grozio
Non v’è stato fra gli antichi filosofi alcuno, le di cui idee sulla giustizia abbiano recato scandalo maggiore quanto Carneade. Non v’è autore che abbia ottenuta maggior stima od applauso in tal materia come il celebre Ugone Grozio, il di cui trattato del dritto di guerra e di pace è ormai divenuto il codice delle nazioni. Carneade è risguardato come un abbominevole sofista, che abusando del sommo suo ingegno distrusse la virtù ed osava chiamarla stoltezza; Grozio è considerato come il legislatore delle genti, il quale ha il primo sviluppati ed adattati alle nazioni i principii di giustizia universale. Sono ben diversi i posti che occupano queste due illustri persone nella opinion degli uomini: vediamo perciò la ragionevolezza di questa opinione. E perché Grozio fu uno di coloro che singolarmente confutarono Carneade, confronteremo le dottrine di entrambi, donde risulti qual dei due abbia seguita od oltraggiata la virtù.
Io domando ciò che tutti desiderano e pochi ottengono, di esser giudicato dalla ragione, non dalla opinione. Non facciamo un dogma della stima di alcuno autore. Vediamo co’ nostri occhi. Gl’inconvenienti che possono nascere da questo liberissimo metodo non saranno mai tanti quanti son quelli che derivano dal giudicare colla fama e colle prevenzioni.
Le dottrine di Carneade consistevano in ciò: “Gli uomini costituirono le leggi per la loro utilità: queste sono differenti secondo i tempi ed i costumi: però non v’è dritto naturale; tutti gli uomini e gli altri viventi sono spinti dalla natura a cercar le loro utilità; non v’è adunque giustizia, o se ve n’è alcuna differente da questa, ella è una somma stoltezza, perché recherebbe a chi la professa nocumento per fare li vantaggi altrui”. Questi sono que’ dogmi che fecero risguardar quel filosofo come un mostro.
Grozio ne’ prolegomeni della sua opera così lo confuta: “L’uomo è un esimio animale sociabile di sua natura. Non si deve concedere che la natura insegni ad ogni vivente ad appetire l’utile, perché gli animali, sia per amor de’ loro parti, sia risguardo ad altri loro simili, temprano sovente questa inclinazione che li porta a cercare il loro utile. Così lo stesso accade nell’uomo, il quale ancor fanciullo dà dei segni di esser inchinevole alla beneficenza ed alla commiserazione.
La sociabilità dell’uomo è la sorgente del diritto propriamente detto, come l’astenersi e ’l restituire l’altrui, l’obbligazione di mantenere i patti, di riparare il danno colpabile, di subir le pene.
E perché l’uomo non soltanto è sociabile di sua natura, ma eziandio dotato di ragione, per la quale stima l’utile od il nocevole non solo presenti, ma anco futuri; quindi ne deriva che non è conforme alla umana natura di essere strascinato dai primi sconsigliati impeti del piacere e del dolore; e da qui nasce la giustizia distributiva, la quale non cedendo alle prime impressioni dell’utile o del nocevole, preferisce, se così fa d’uopo, l’ignorante al sapiente, l’estraneo al congiunto, il povero al ricco.
Ciò adunque che dice Carneade, esser l’utilità la madre del giusto, parlando con precisione non è vero; perché la madre del natural dritto è la natura istessa, la quale ci spingerebbe alla società, quantunque non avessimo bisogno di alcuna cosa. Che se nel praticare la giustizia non avessimo di mira alcuna utilità, non perciò dovrebb’essa chiamarsi stoltezza, ma sapienza, perché non è tale il seguire i dettami della natura”.
Questi sono gli argomenti che Grozio oppone a Carneade. Si ristringono a ciò. L’uomo è sociabile ed è ragionevole per natura. Come sociabile seguir deve le leggi della società; come ragionevole deve considerare non solo ciò che nuoce o giova al presente, ma anco al futuro. Chi crederebbe che fissando tai principii egli si proponga di confutar Carneade, quando è del suo parere senz’avvedersene? Egli è nostro interesse il non violar le leggi della società; il non considerare soltanto il presente, ma anco il futuro nel calcolo de’ beni e de’ mali. Questo diritto adunque è fondato sulla utilità. Con qual precisione, dopo queste due premesse, conchiude Grozio che l’utilità non è la madre del giusto? Con qual logica, che la natura ci spingerebbe alla società, quantunque non avessimo bisogno di alcuna cosa? Egli stesso poco dopo ci porge la sua confutazione, contraddicendosi. “È falso, egli ripiglia, che il dritto sia fatto per la sola utilità, avvegnaché non v’è nessuna così potente nazione la quale non possa talvolta aver bisogno delle altre, o per il commercio o per le alleanze. Tutto ciò è distrutto da coloro i quali racchiudono la giustizia ne’ confini del lor paese; e siccome”, dic’egli più sopra, “un cittadino il quale viola il dritto civile per un’attuale sua utilità, rovina que’ fondamenti su’ quali si appoggiano le perpetue utilità sue proprie e de’ posteri suoi; così ancora un popolo che viola il diritto delle genti, rompe i ripari della futura sua tranquillità”. Che vale a dire, io conchiudo secondo questi principii, è nostro interesse di osservar le leggi, ed è interesse delle nazioni di osservare il dritto delle genti, perché sciolti questi vincoli ed autorizzando l’ingiustizia col nostro esempio, gli altri farebbero lo stesso con noi, d’onde ben si vede quai danni e qual sovertimento ne verrebbero nel mondo.
Ma Grozio fa entrare ancora ne’ motivi naturali di seguir la giustizia i morali sentimenti di commiserazione che l’uomo ha, i quali fanno ch’egli non di rado pospone il suo utile all’altrui. Non nega adunque che nei motivi di giustizia possa annoverarsi l’utilità, ma nega ch’essa sola debba esser la fonte del giusto: anzi ancor senza utilità dice da seguirsi la giustizia. Bisogna rischiarare i termini.
Sono due le proposizioni di Carneade che irritarono l’animo di Grozio, e di molti altri: il fondare il diritto sulla sola utilità è chiamar stoltezza ogni giustizia che rechi svantaggio. La espressione è giusto ciò ch’è utile ha fatta moltissima paura alla schiera degli scrittori di tali materie, e scandalizza gli animi, perché lor sembra distrutta ogni idea morale, essendo permesso con tal principio qualsivoglia orribile delitto, se torni a conto il commetterlo. Anzi, generalmente da tutt’altri principii desumer suolsi la giustizia, quindi entrano in campo le grandi parole di natura, di dovere, cotanto ripetute, mal intese e peggio definite.
Cesseranno tutte le maraviglie e gli equivoci se si prenda in un senso più esteso la parola utilità, giacché gli errori provennero dal darle un senso troppo stretto, considerando semplicemente l’utile attuale ed immediato. Sarebbe giusto con tal principio che l’uomo irato ammazzi, perché così esige lo sfogo della attual sua collera; che il libertino e l’avaro ed il prodigo rubino, facciano estorsioni per soddisfare i lor bisogni; che l’ambizioso sconvolga l’universo e che per fine ogni uomo, secondando gl’immediati impulsi delle sue passioni, non abbia altra legge che quella dell’immediato piacere. Carneade non ha mai sostenuta questa assurdissima tesi. Quando si parla di utilità bisogna intendere una vera e reale utilità, estesa a tutte le possibili conseguenze di una azione qualunque, una utilità previdente e calcolatrice, la qual veda e conosca gl’inconvenienti lontani quanto i vantaggi presenti. Basta accordare a quel gran filosofo il senso comune, per non fargli la taccia d’aver pensato, e molto più, pubblicamente insegnato diversamente. Entrino in questa espressione utilità anche i rimorsi, che rodono i cuori colpevoli, entrino i sentimenti morali di compassione, ed essi ancora sieno riposti nei motivi utili di seguir la giustizia. Perché utile è il risparmiar i rimorsi, utile, anzi d’una necessaria utilità egli è il sollevare i mali altrui, quand’essi ci recano dolore all’animo, nel che consiste la commiserazione, madre della beneficenza.
Allora quando si dirà che i fondamenti della giustizia sono le utilità, intender devesi che riandando tutte le umane azioni, l’utilità nostra ben intesa e costante vuole che osserviamo le leggi, che non commettiamo delitti, che siamo onesti, perché le vendicatrici leggi, il rimorso dilaceratore, il disprezzo e la diffidenza degli uomini e cento svantaggi, in somma, che ne derivano dalla ingiustizia, non sono paragonabili ai passaggeri vantaggi che ci possono derivar dalla ingiustizia. Non mi pare poi questo un orribil metodo d’insegnarla.
In tutte le nazioni sarà sempre accordato il nome di giusto a ciò che tende alla vera e costante utilità d’esse nazioni, e d’ingiusto a ciò che tende al sovertimento della società ed a renderla infelice. Questo è un fatto che non si può negare; questo è il criterio, umanamente parlando, con cui si stimano le azioni de’ cittadini e la bontà delle leggi. Perché adunque rimproverar Carneade quando dice che le leggi furono composte per l’utilità degli uomini: è ciò falso? Che queste sono differenti secondo i tempi ed i costumi: è ciò ancor falso? Che però non v’è dritto di natura: la conclusione è certissima se per diritto di natura intendiamo principii universali ed impressi nel cuore di ogni uomo ed indipendenti da ogni utilità; perché variando le idee di giustizia nelle nazioni, come possono elleno essere universali? E poi che importa il disputar dei naturali dritti? Basta che fissiamo i principii che ci conducano ad insegnar la giustizia agli uomini. Tutti gli uomini, prosegue Carneade, sono spinti dalla natura a cercare le loro utilità. Ecco in che egli riponga i principii del dritto naturale. Questa inclinazione è ella un assurdo o un fatto? Che però, conchiude, o non v’è giustizia, o ella nasce da questa inclinazione all’utile; che se d’altra sorta se ne vuol porre in campo, ella è stoltezza, perché nuocerebbe a chi la professa, per far gli vantaggi altrui. Chi è fra i confutatori di Carneade che avrà la speranza di persuadere una giustizia utile agli altri, nocevole a chi la segue? Quanto misero sarebbe l’uomo giusto, quanto felice il vizioso! Quanto abbominevoli i dritti di natura, se così punisse i suoi seguaci, quanto mostruosa è la giustizia s’ella è d’ascriversi fra i nostri sommi mali!
Non bisogna prendere ad una ad una le espressioni di Carneade. Esse sembrano troppo esagerate, perché chiamerebbesi stoltezza una grande e virtuosa azione, una somma beneficenza, la quale facesse il comodo altrui col nostro svantaggio. No. Se questa morale può esser utile considerando ciascuna azione e ciascun uomo in particolare, ella non è punto utile considerando tutti gli uomini e tutte le loro azioni in generale. Questo è il punto di vista sotto del quale bisogna considerarle. Ogni nazione ed ogni uomo ha bisogno che la giustizia non abbia sì angusti confini. Non è stolto chi benefica un ingrato, non è stolto chi muore per la patria. E pure entrambi pospongono i propri a’ vantaggi altrui. Ma non è che queste alte virtudi si fondino in declamazioni od in chimere. Prendasi, io il ripeto, questa parola utilità in un senso esteso ed universale. Sono utili agli uomini queste virtù, anzi loro sono sovente necessarie. Laonde il renderle dispregevoli e ’l riporle nella classe delle stolte azioni è opporsi al bene della società, discreditando quegli eroi che in ogni secolo ed in ogni nazione furono la difesa e la maraviglia degli uomini. Se Carneade fosse caduto in un fosso o ridotto alla mendicità, avrebb’egli sostenuto filosoficamente ch’era stolto chi con suo pericolo lo tirasse dal fosso o s’impoverisse di un fiorino? Se ammettiamo tai principii, se facciamo l’utilità della giustizia cotanto ristretta, la distruggiamo, cioè distruggiamo le maggiori utilità del genere umano.
Non erano però questi i sentimenti di Carneade, quantunque sembrino a prima vista conseguenze che derivano da’ suoi precetti. Egli avea a combattere coll’orgoglioso stoicismo, della qual setta ei fu un terribile nemico. Si sa quanto gigantesche idee di virtù e di giustizia si formasse quella illustre e delirante filosofia. Dovendo pugnare con lei, Carneade cadeva di soverchio ne’ principii opposti. Gli stoici fondavano la giustizia sul diritto naturale e dicevano dovere ella seguirsi per se stessa, senza nessun motivo di utilità ed anche co’ propri svantaggi, in ogni caso, e come dice Cicerone nell’orazione Pro Murena: estendevano i confini del dovere più oltre che la natura esige. Carneade, per discreditare queste alte e vuote idee, si compiaceva di confonderli con argomenti distruttori. Di fatti i suoi ragionamenti sulla giustizia erano più temuti che confutati. Venne questo filosofo a Roma, a’ tempi di Catone il Censore, come uno degli ambasciatori di Atene, la quale era stata condannata da’ Romani ad una grossa multa per avere diroccata la città di Oropo. La eloquenza seduttrice e la precisione colla quale ragionava in tali materie gli avea fatta venir d’intorno tutta la romana gioventù. Ciò parve pericoloso in una nazione di stoici. Il Senato lo fece immantinenti ritornare. Catone il Censore risguardò con iscandalo le dottrine di Carneade e fu quello che indusse il Senato a farlo partire. Catone trovò più facile esiliarlo che convincerlo. Cicerone nel libro Delle leggi, dopo di avere stabilita la giustizia co’ principii stoici, ch’ei seguiva in tale affare, non si pone a confutar Carneade, perché soggiunge: se quel filosofo si porrà a contrastare questi principii, che ci sembrano ragionevoli e conseguenti, ei ne farà una gran rovina, ond’io desidero di placarlo; e non ardisco di prendermela con lui. Lattanzio per combatterlo ricorre alla divina giustizia, e posto tal fondamento, presto lo sconfigge; ma co’ soli lumi della umana filosofia, della qual sola ora parliamo, avrebbe sentita la stessa debolezza che provava Cicerone.
Carneade era ben lontano da credere una stoltezza la virtù. Ei la professava, ma voleva abbattere e chiamar stoltezza la gigantesca virtù degli stoici. Benché combattesse la virtù, non iniustus ipse vir fuit, dice Quintiliano. Non vi fu per avventura filosofo che ragionasse con maggior precisione nelle materie morali di lui. Questi erano i suoi studi profondi. Non crederò per altro ch’egli, come si disse, essendo a tavola fosse talvolta così estasiato nelle sue contemplazioni morali che si dimenticasse di mangiare, per modo che la sua serva Melissa dovesse scuoterlo, acciocché si svegliasse; e che si purgasse il cervello coll’eleboro per disputare contro di Zenone. Ho un benedetto naturale di non credere niente che ripugni al senso comune.
Questo filosofo, come Grozio istesso attesta, diceva che il cittadino deve osservare le leggi del suo paese, quantunque per ciò fare debba lasciare alcune sue utilità. Grozio, invece di adoperare questo principio per intendere sanamente le dottrine di quel filosofo, lo adopera per trovarlo in contraddizione. Vedi se Carneade distruggeva la virtù. Questa era una sua dottrina: Se saprai che un aspide è nascosto in qualche sito e che alcuno, la di cui morte ti possa esser di vantaggio, voglia sedersi imprudentemente su di lui, tu fai sceleratamente se non avvisi che non seda, quantunque tacer tu possa impunemente, perché qual persona può riprendertene? La riferisce Cicerone nel lib. 2 De finibus, cap. 18. Ecco l’uomo abbominevole! Era meglio intenderlo che calunniarlo. Se la giustizia sarà spogliata degli apparati ammirabili ma chimerici della orgogliosa filosofia, s’ella sarà ridotta ad essere eguale agli uomini, non più grande di essi, si potrà sperare che la professino comunemente e che i filosofi che la insegnano sieno conseguenti a’ lor principii. Ma finché ella consiste in colossi che hanno i piè di creta, non regnerà altro che ne’ trattati. Carneade fu buon cittadino, fu gran filosofo, fu uomo virtuoso nella sua vita, professò la giustizia, fu temuto e non confutato da chi si scandalizzava delle mal intese sue dottrine. Seneca era missionario del dolore e della morte e della squallida povertà; scriveva cento volte al suo Lucillo che un giorno alla settimana si vestisse con cenci, soffrisse l’inedia per avvezzarsi a non temere la povertà ed il dolore, ed era uno de’ più ricchi, de’ più opulenti Romani; fece la sua corte a Caligola, non parlando mai in pubblico, perché sapeva che quell’imperadore pretendeva di essere un grande oratore, dimorò alla corte di Nerone, suo scolaro e tiranno.
Le sette degli antichi filosofi trovarono molto ingiusta la posterità. Quale oggetto d’ingiurie non è stato Epicuro, i di cui scolari si chiamarono porci del gregge di Epicuro? Quali erano le sue dottrine? “Il saggio comanda alle sue passioni, egli è giusto, sincero, grato, moderato e costante”.[115] Seneca[116] fa vedere come le dottrine di Epicuro coincidessero colle sue, in quanto alla astinenza de’ piaceri ed alla austerità de’ costumi. Dicesi che l’inscrizione che avea posta Epicuro al suo giardino fosse Qui avrai acqua e polenta. S. Girolamo ricolma di lodi la frugalità di quel filosofo. In somma i suoi precetti, quanto alla durezza della vita, erano conformi agli stoici. Perché adunque fu accusato di predicar la voluttà e di riporre il sommo bene in essa sola? Egli diceva che la felicità consiste nel piacere. Ma qual definizione dava del piacere? La virtù. Nega, dice Cicerone nel libro quarto delle Tusculane, nega Epicuro che si possa vivere felicemente senza virtù. Esclama, dice lo stesso Cicerone, lib. I De finibus, Epicuro, quell’Epicuro che voi credete dato in preda a tutte le voluttà, che non si può felicemente vivere senza sapienza, ed onestà. L’equivoco venne dalle parole. Si confuse la dottrina di Aristippo con quella di Epicuro. Ambi ponevano la felicità nel piacere. Ma Aristippo s’intendeva il piacere de’ sensi, ed Epicuro il piacere che reca nell’animo la tranquillità della coscienza, la qual nasce dall’esercizio della virtù. Tai furono i giudizi su queste sette. Non finirei questo argomento. Quanto non furono stimati i gimnosofisti, filosofi indiani, scolari de’ sapientissimi magi d’Egitto? Figuratevi di vedere queste sublimi persone come le descrive Plinio:[117] Que’ filosofi che chiamiamo gimnosofisti se ne stanno dal levare sino al tramontare del sole or su un piede, or sull’altro a vicenda, fra le infocate arene a risguardare quell’astro con immobili occhi. La setta de’ cinici ebbe per fondatore Antistene. Diogene fu suo scolaro. Consistevano i dogmi di tal setta in una estrema libertà di riprendere i vizi, ed in credere che tutto ciò ch’è naturale sia l’ottimo, e potersi fare in pubblico. Lascieremo le conseguenze di questi gran principii. Si noti che Diogene cominciò il suo corso di filosofia dopo esser stato monetario falso in Sinope sua patria. Fuggì da lei, che naturalmente avrà detta ingrata, come si suol fare. Venne in Atene a vivere filosoficamente nella botte. Bisognerebbe riporlo in mezzo di Democrito, che sempre rideva vedendo le pazzie degli uomini, e del patetico Eraclito, che si prendeva l’incomodo di sempre piangere le nostre gran miserie. Sarebbe una bella raccolta. Ho un terribile coraggio in queste materie. Il demone familiare del più saggio degli uomini non gli farebbe torto per avventura? Ma non perturbiamo l’antica filosofia. Cerchiamo piuttosto di non far la guerra a quella del secolo in cui viviamo. Ella certo non ci conduce a stare su di un piede a mirare il sole dei giorni intieri, né ad aver demonii familiari, né a far moneta falsa, né a ridere o piangere tutta la vita, tutt’al più un poco dell’uno ed un poco dell’altro, né a vivere in una botte come il vino, né ad insegnare a’ nostri giovani scolari di vestirsi di cenci o di mangiar pane ed acqua una volta la settimana. Non si chiamano più filosofi i buffoni. Non portano più i filosofi un abito distintivo, come usavasi, non fanno più sussurri e comunità; vi sono, ma si nascondono, poiché, come dice Cicerone, la filosofia è contenta di pochi giudici, si sottrae alla moltitudine, come quella che è sempre al volgo ingrata ed odiosa.
Ritorno al mio soggetto. Abbiamo vedute le dottrine di Carneade, vediamo quelle di Grozio. Quest’autore, dopo di avere fatti altamente risuonare i diritti sacrosanti di natura, dopo di avere fatte molte doglianze perché questa parte così interessante delle scienze sia stata cotanto negletta o maltrattata, dopo di essersi prefisso di dettar leggi alla umanità e di porre in sistema i purissimi principii del giusto, sorprende alcun poco con questo suo principio, che s’incontra al capo terzo del libro primo. Ivi egli tratta in che consista la sovranità, e se ve ne sia di affatto indipendente ed assoluta. “A tal proposito, dic’egli, io debbo primamente confutare l’opinion di coloro i quali vogliono che in ogni luogo e senza eccezione la somma podestà sia presso il popolo, per modo che i principi, qualora abusino dell’autorità loro, possino dal popolo istesso essere raffrenati e puniti. La qual sentenza, se venga accettata, di quanti mali possa esser cagione non v’è alcun saggio che non comprenda. Noi la combattiamo in tal guisa. È lecito a qualunque uomo il darsi in ischiavitù a chi esso voglia. Perché adunque non sarà lecito ad un popolo libero il darsi ad uno o più uomini in modo che trasferisca in essi od in lui ogni diritto di sovranità, non riserbandosene parte alcuna? Né si dica che ciò non si può presumere, perché non cerco che debba presumersi in dubbio, ma che a buon diritto far si possa. In vano ancora si produrrebbero gl’inconvenienti che seguir possono da tal patto, perché qualunque forma di governo immaginare si possa, non ne andrà mai esente.
Siccome adunque sono molti i modi di vivere, gli uni migliori degli altri, ed è libero a ciascuno lo scegliere fra di essi quello che più gli piaccia; così un popolo può scegliere qualunque forma di governo; né dalla prestanza di essa forma, nel che variano le opinioni
IL CAFFÈ )( Fogl. XXX )(
degli uomini, ma dal consenso si desume il diritto. Non mancano poi cagioni per le quali una nazione abdichi da sé ogni sorta di sovranità e la trasferisca altrui; per esempio se, ridotta agli estremi pericoli della vita, non trovi chi la difenda se non a tal patto, o se, oppressa dalla mendicità, non possa in altra guisa ritrovare sostentamento. Aggiungi ciò che dice Aristotile, che alcuni uomini sono destinati dalla natura alla servitù, cosicché non sieno fatti per governare, ma per essere governati. Per queste adunque ed altre cagioni avvenir puote e suole che un popolo si sottometta alla illimitata podestà altrui”.
Eccovi i ragionamenti di questo grande autore. La logica sarà ella destinata al tristo officio di confutarli? Grozio è tiranno ed inconseguente a un tempo. Egli fa uno stato di questione molto pericoloso, e poi lo confuta con inconseguenti principii. Egli vuol distruggere la sediziosa opinion di coloro i quali sostennero che possa la nazione giudicare il suo sovrano e condannarlo a morte. Per confutarla ci dice che vi sono dei popoli schiavi, i quali hanno abdicata ogni sorta di sovranità. Che prova questo? Prova che in que’ popoli di servi tal diritto non competerebbe. Quale ipotesi inumana di ammettere e di provare in buon latino e con fiorita erudizione greco-latina? Grozio favorendo il dispotismo ha offeso i principi e l’umanità, i di cui veri interessi sempre coincidono. Grozio prova che vi sono delle nazioni serve, che tal patto è lecito, che perciò è falso che indistintamente la sovranità sia presso il popolo, laonde che generalmente non procede la massima perniciosa che sia lecito alla nazione di giudicare il suo principe e ’l punirlo di mal governo. Dunque tacitamente ammette che in quelle nazioni nelle quali tal patto di servitù non vi sia, possa il popolo condannare il suo principe: e siccome nazioni che si sieno regalate ad un uomo con tal patto non vi sono, così, io conchiudo, tutte le nazioni potrebbero giudicare il loro sovrano. Grozio favorisce in tal guisa la tirannia e la sedizione. Qual bamboleggio!
Perché mai Grozio per confutare una sì perniciosa dottrina, qual è quella di far il popolo giudice del suo sovrano, ha chiamata in soccorso la tirannia, ha stabilita un’assurda, anzi vergognosa ipotesi? V’è egli bisogno di dottamente scrivere che può un popolo darsi in servitù, che può legittimamente esservi un affatto dispotico ed arbitrario principe che guidi milioni d’uomini come pecore, che questo sia un diritto, che tal patto è giusto, è valido, che alcune genti son nate alla servitù?
Ricorriamo a quel temuto e costantissimo principio, che le società si unirono per la felicità comune. Sotto tal punto di veduta diventa facile ogni soluzione de’ problemi politici.
La mia penna non è destinata a freddamente discutere una tal questione. No, il mio cuore abborrisce questa ipotesi. Mi fa orrore un tiranno, mi fa orrore una nazione che pon mano al suo principe, mi fa orrore l’abuso che si può fare di tali opinioni. Lasciamo all’Asia, alle infelici nazioni che gemono sotto il dispotismo, tali controversie. Noi Europei, noi nati in forme di governo moderate, noi giudicati e protetti dalle leggi, noi nel seno della dolcezza della società, noi che sentiamo tutti i beni della dipendenza e nessuno de’ suoi mali, o quegli imprescindibili dalle umane instituzioni, ardiremo ancor di disputare se sia lecito perturbar lo Stato e condannare i nostri padri? Quella istessa libertà con cui mandiamo alle pubbliche stampe simili questioni prova la nostra ingiustizia. Non ci sarebbe permessa tal libertà se non vivessimo in moderati governi, ne’ quali ciò che dobbiamo abborrire e temere sono le sole rivoluzioni. Basta leggere la storia per essere convinti di tal verità. Non v’è memoria che la dolcezza del governo e le idee di giustizia sieno state più universali e rispettate in Europa. Se alcun effetto produr possono simili controversie, egli è di render anche i buoni principi diffidenti.
Dico adunque che nello stato attuale delle cose si oppone alla felicità delle nazioni chi non soltanto sostiene, ma pone in campo tali questioni; dico che i buoni cittadini osservano le leggi del lor paese, rispettano la sua forma di governo, abborriscono ogni idea di sedizione; dico che non conosce la storia chi non sa quanti danni seco traggono le rivoluzioni; dico che non conosce l’abuso che generalmente fanno gli uomini anche della verità chi avventura al pubblico giudizio massime di tal sorte; dico ch’è un pessimo cittadino chi tranquillamente insegna che ogni privato è giudice del suo sovrano; dico che tai dogmi non hanno mai tolto un tiranno dal mondo, ma fecero il tristo sacrificio di ottimi sovrani. Ecco ciò che poteva dir Grozio, e che non disse. Vediamo ciò che dovea tacere.
È lecito a qualunque uomo il darsi in servitù, dice il nostro autore, dunque anche ad una nazione. Che intese per lecito? Il fatto od il diritto? Se il fatto, non v’è difficoltà. Si può dare un pazzo al mondo. Ma il fatto non è il diritto. Se intese il diritto, quale assurdo! Chi può esser sano di mente e darsi per divertimento in servitù ad un suo simile? Tal contratto si ridurrebbe a ciò. Tutti i comodi sarebbero da una parte, tutti gl’incomodi dall’altra; eppur sarebbe giusto. Chi per delirio e fatuità consegnasse le sue membra ad un tale, il quale lo potesse bastonare ed uccidere impunemente, fargli strascinare un carro, sepellirlo, in una prigione in virtù di tal contratto, secondo i dettami del gius di natura, sarebbe reo di lesa natura e di leso contratto, se tenta di sottrarsi a tale servitù, perché ha trasferito con una sua pazzia in altrui il diritto della propria esistenza, e non v’è più azion delle proprie sue membra che sia sua. Egli di persona è divenuto cosa, perché un gonfiamento di vene, avendogli premute le meningi, gli ha offuscata la ragione, e chi, profittando generosamente di così bella congiuntura, ha accettata la sua servitù, è divenuto giustissimo signore delle di lui due gambe e delle di lui due braccia, che potrà in appresso a suo beneplacito rompere e fracassare. Tutte queste conseguenze derivano immancabilmente, posto il principio che una nazione di servi diventi il patrimonio del principe e che ad essa mai non competa nessuna resistenza; e questo è il principio di Grozio. La stampa ha servito di veicolo a trattati ben diversi; è stampato Epitetto, M. Aurelio, ed Ugone Grozio; ed il suo libro si chiama Del diritto di guerra e di pace.
Il nostro autore non ha per buona la difficoltà che un patto così stolto non si può presumere, laonde per mancanza di consenso sia nullo; perché ei risponde: non cerco che debba presumersi, ma che si possa giustamente fare. Ognun vede la petizion di principio. Così la distruggo: tal patto è assurdo, dunque non è presumibile; perché non è presumibile è nullo. Non v’è bisogno di provare che non è presumibile. Non sarà mai ragionevole chi lo faccia. Terranno i patti fatti da chi non ha ragione? È strano che nessuno contrasti esser nulli i contratti de’ minori, dei prodighi, dei mentecatti, e le universali donazioni, perché suppongono imbecillità e follia, anziché consenso, e non lo sia la donazione di se stesso. È questa per lo meno una contraddizione.
Grozio parimenti non fa verun caso della obbiezione che nasce dagl’inconvenienti orribili che seco trarrebbe questa forma di governo, perché, ei dice, nessun governo ne va esente. Recano maraviglia tai paralogismi. Non ha veduto che l’assurdità di un patto ed i mostruosi inconvenienti che da lui derivano possono renderlo nullo, e non così i piccoli ed imprescindibili a un di presso. Non ha veduto che quantunque in ogni governo vi sieno degl’inconvenienti, non per questo ogni assurda e tirannica costituzione che si possa immaginare è giusta.
Finalmente Grozio fa vedere che vi possono essere varie cagioni per le quali una nazione possa legittimamente darsi in servitù; come l’estremo pericolo, l’estrema fame che l’obblighino a darsi ad un popolo, o ad un re, che a questo solo patto voglia soccorrerla. Figuratevi un miserabile che muore di fame. V’è al mondo un uomo, che ha un cuore così ben fatto, che non gli vuol dare un superfluo tozzo di pane se non si obbliga tutta la vita ad esser suo servo. Il miserabile è costretto ad acconsentirvi. Chi gli ha dato questo tozzo di pane, in conseguenza de’ principii di giustizia stabiliti da Grozio, è fatto suo legittimo signore. Ecco il suo gius di natura.
Non dirò nulla della straniezza della massima di quest’autore, che alcune nazioni sono destinate dalla benigna ed universal madre degli esseri, la natura, alla schiavitù: sarei stato o così imbecille o così umano che mi sarebbe tremata la penna nelle mani nello scrivere sì funesta sentenza. Ciò ch’è certo, alcuni scrittori hanno questo destino, e Grozio, quando sostiene tal principio, ne fornisce una prova non equivoca.
Grozio si fa un’obbiezione e così la scioglie: “Ciò che dicono i filosofi, che ogni governo non è stato costrutto per l’utilità di chi governa, ma dei governati, non è vero universalmente parlando, perché alcuni governi sono propriamente fatti per la utilità de’ reggenti, come la servitù. Così ancor gl’imperi possono essere destinati alla utilità de’ principi, come le conquiste”. Non si potevano aspettare altre conseguenze da’ suoi principii. Da essi ancora ne deriva lo stesso autore un’altra conseguenza, che quel principe il quale possieda gli Stati con tal diritto può a sua voglia alienarli come ciascuno può vendere parte del suo patrimonio.[118] Conseguenze di tristi antecedenti.
Dal gius delle genti Grozio deriva vari diritti della guerra. Questo gius, secondo lui, permette di uccidere le donne, i bambini, i vecchi[119] e senz’altro per necessaria conseguenza di diroccare città, di desolarle, saccheggiar le campagne, abbruciare, devastare ogni cosa.[120] Ei non sospetta tampoco che si cerchi il meno male dei possibili in così tristi avvenimenti. Si contenta di raccomandar però vagamente la moderazione. I prigionieri, poi, di guerra, secondo lui, non soltanto diventano cose dei vincitori, ma gli effetti di questa acquisizione ei dice sono quasi infiniti;[121] cosicché niente v’è di non lecito al padrone contro di loro; nessuno maltrattamento che loro non si possa fare impunemente, nessuna azione che da essi possa non solo pretendersi con un comando, ma estorquersi colla forza. Cosicché, secondo il gius delle genti, ogni sevizia in tal sorta di persone è impunita.
Questo diritto è così sacrosanto, secondo Grozio, che il servo non può mai difendersi dal suo padrone: perché altrimenti sarebbe una contraddizione che il padrone avesse tal diritto, come lo ha, e che nello stesso tempo avesse il servo il diritto di resistenza.[122] Non si può ragionar meglio. Quanto egli è comodo, essendo ambasciatore di Svezia a Parigi, nella tranquillità de’ suoi studi, nella solitudine del suo gabinetto, fra gli agi e gli onori, il dettare queste leggi alla umanità! Avranno bisogno di confutazione tai dottrine? Ella è nel cuore d’ogni uomo. Quell’orrore che vi destano sono la lor condanna. La voce della natura grida contro questi scritti di sangue. Il diritto delle genti è una parola mal definita, ma certo se il consenso comune delle nazioni può formare questo dritto, non è mai presumibile che le genti sieno convenute in questi dogmi distruttori, che ogni uomo in particolare trova abbominevoli. Sieno talvolta anche necessarie queste crudeltà, devono esse entrar ne’ trattati del gius delle genti, devono essere insegnate gravemente, oppure devonsi per l’interesse della umana società deplorare, combattere, dimenticare, nascondere?
Quale adunque, di Carneade e di Grozio, ha offesa la giustizia? Chi ha vantati i diritti di natura per non conoscerli e violarli, o chi meno ippocrita, ma più umano, sembrando, a chi non lo intese, di distruggerli, gli ha professati, e non mise in fuga che le chimere?
Non si scusa Grozio col dire che le circostanze de’ tempi non gli permettevano di scrivere altrimenti. Ei dunque dovea tacere. Altronde non è vero che le sue massime fossero così comuni da non potersi impunemente confutare. Esse non furono mai comuni; non mai lo saranno. Il suo secolo non era quello di Caligola.
A. [Alessandro Verri]
Esame d’alcune cagioni che tengono nell’attual mediocrità il teatro italiano
Per quanto io sia dichiarato ammiratore della commedia francese, non posso però non convenire che la di lei introduzione in Italia non sia stata una delle più forti cagioni che ritardarono l’avvanzamento del nostro teatro. I principi italiani, vedendone il cattivo stato, invece di cercar di trarnelo, come non sarebbe loro stato difficile, si sono rivolti al più pronto partito di cercar nel francese quel piacere che non li prometteva il nazionale, quando non doveva servirci che di modello e di stimolo per avvanzare il nostro e renderlo degno di gareggiar con quello, come fu il primo a risorgere al tempo di Leone X, dei Trissini e dei Bibiena.
Venezia sola, non addottando la commedia francese, ha fatti i primi passi verso un teatro ragionevole. Il benemerito signor dottor Goldoni, che si può con ragione chiamare il riformatore del nostro teatro comico, l’ha reso ben diverso da quel ch’egli era venti anni fa; ma la quantità delle commedie ch’egli ha dovuto precipitare, il gusto del paese, al quale ha dovuto forse troppo servilmente obbedire, l’interesse de’ suoi comici, i pregiudizi troppo inveterati non gli hanno permesso di portare la riforma fin dove il suo genio regolare e fecondo l’avrebbe estesa in tempi migliori. È vero che gli è finalmente riuscito di proscrivere le maschere dalle sue commedie. Ma che perciò? Il poco numero delle buone commedie ed il cattivo gusto che tuttora sussiste nel popolo, costringendo i comici a ricorrere bene spesso alle commedie dell’arte, le rende loro necessarie e fa che nella scelta de’ soggetti che compongono una compagnia di comici il punto principale sia quello di scegliere un buon Arlechino, un buon Brighella, un buon Dottore ec., poco poi loro importando che i soggetti sieno capaci a coprire i personaggi di carattere che seco porta la vera commedia. Anzi io direi che un vero e buon comico mascherato, assuefatto alle caricature necessariamente attaccate al grottesco del suo ridicolo personaggio, non può se non per una rara combinazione vestire colla debita dignità e naturalezza i caratteri più interessanti: Un petit bout d’oreille echappé par malheur, decouvre la fourbe et l’erreur, si può dire a ragione con la Fontaine. Aggiungasi che il dover discendere a questi caratteri indecenti contribuisce moltissimo ad avvilire la professione ed allontanar dalle nostre compagnie quelle colte ed oneste persone che potrebbono avere questo talento sì dilettevole e sì poco universale; oltrediché, assuefatti questi comici a lavorare, per dir così, del proprio il dialogo, non sanno poi sottoporsi alla faticosa necessità di mettersi a memoria le buone commedie, e sono per conseguenza costretti ad abbandonarsi servilmente al molte volte non troppo esperto suggeritore, cosa che sola basta per sfigurare qualunque capo d’opera, poiché, e come mai dare il tuono e le inflessioni necessarie a’ sentimenti che non conoscete e che vi vengon posti in bocca pezzo a pezzo dal suggeritore? Come pensare all’azione in tempo che si è interamente occupato delle parole?
Un altro non minore inconveniente egli è quello che le compagnie de’ nostri comici sono costrette per sussistere a star più che possono ristrette in numero, ond’è che non abbiano poi d’ordinario i soggetti adattati per ogni sorta di personaggio e sieno costretti a far agire Nestore da Telemaco, da Venere una Sfinge e Zanni da Catone. Niente di più ridicolo, niente che più comprometta una composizione drammatica. Ma abbandonati a se stessi ed intieramente occupati della propria sussistenza, come pensare alla perfezione ed alla gloria?
Gli accennati difetti degli attori, di effetti diventando cagioni, mantengono poi il cattivo gusto e la disattenzione de’ spettatori, poiché qual cosa più inutile che di prestarsi con attenzione a delle cattive commedie e mal rappresentate, e qual cosa che più umilii al tempo stesso e scoraggisca che il vedersi trascurati e soffocati dallo strepito? Il teatro diventa allora un luogo di ridotto, di conversazione, di gioco, di visite, la turba gli dà il tuono, ed i comici, vedendo l’indifferenza per una banda e gli applausi per l’altra, sono e per proprio interesse e per propria inclinazione strascinati a continuare nel cattivo cammino incominciato; ed allora si è che i Scaramuccia osano stare a fronte dei Molières. E qual è quella persona di merito, che vedendo il pubblico giudice sì incompetente, sì ingiusto e sì indifferente sulle produzioni che le costano tanta fatica, voglia coltivare la scienza drammatica? Due sono i mobili che decidono gli uomini, la gloria e l’interesse; ma dove vedano molto rischio, quando le sue produzioni non riescano, e nessun compenso dall’altra banda, chi è quel che in pura perdita voglia arrischiarvisi? Datemi in Italia un solo esempio (anzi dirò la sola speranza) ch’eguagli il successo e le conseguenze ch’ebbe in Francia pel suo autore il famoso Assedio di Calais, e vi prometto e de’ buoni autori tragici e delle buone commedie. Credete voi che se Cornelio e Molière fossero restati in Francia nell’oscurità e nella miseria, avrebbe poi quella nazione avuti i Racine, i Voltaire, i Crebillion, i De-Touches, i Regniard e tant’altri ch’hanno portato il teatro francese ad un punto di perfezione sconosciuto per fino agli antichi? Di fatti, qual cosa più disgustosa per un povero autore che il veder, dopo molti sudori e molte vigilie, sfigurate poi in un momento le sue produzioni da’ nostri istrioni, il veder maltrattate le situazioni più interessanti, perduti i più bei quadri delle sue composizioni ed eccitate le fischiate da quelle cose appunto da cui sperava i maggiori applausi ed il maggiore successo? Suol dirsi che gli estremi si toccano, ed una bellezza portata appunto fin dove poteva arrivare diventa un difetto, una caricatura, diventa gigantesco e sproporzionato ciò che non era che ardito e grande, per pochissimo che si alteri e si porti al di là de’ rigorosi confini ideati e stabiliti dall’autore. Il partito che prese il gran Molière di farsi egli stesso attore (alcuni altri fra i Francesi seguirono un tale esempio) fu da grand’uomo, specialmente allor che si trattava di riformare il teatro, ed a questa coraggiosa risoluzione egli deve, a mio dire, in gran parte il successo delle sue commedie e l’aver alfine disingannati i Francesi dai Scaramuccia e dai buffoni; partito reso omai inutile in Francia per la conosciuta bravura e capacità de’ suoi attori, ma che sarebbe necessarissimo in Italia, che trovasi appunto nelle stesse circostanze in cui trovavasi allora il teatro francese. Ma lo spereremo noi, finché proseguiremo a riguardare con quanto altre volte giusto disprezzo per i nostri istrioni, altrettanto ingiusto per chi coltivi il talento sì utile e sì poco comune del teatro, e che arriveremo perfino a gittar il ridicolo su que’ che si volgano a coltivarlo con private rappresentazioni? Trattenimento che non isdegnarono in altri tempi i più grandi principi, e che sebben forse con poco successo da principio potrebbe, se non altro, far aspirare a cose più grandi persone meno imbevute delle cose sue e capaci di fare di meglio.
Al buon successo delle nostre produzioni teatrali, oltre gli attori ed i spettatori s’oppone ancora generalmente la costruzione de’ nostri teatri, che sono fatti più per lo spettacolo, la musica e le decorazioni che per la semplice declamazione, e per conseguenza troppo vasti per potervi recitare d’un tuono di voce naturale. Lo sforzo che convien che faccia la voce basta per distruggere l’illusione, cardine principale su cui s’aggira il successo delle rappresentazioni teatrali, o volendola conservare ne viene che pochissimi arrivano ad intendere, ed il teatro resti poi malcontento e spopolato.
Queste sono in breve, a mio dire, le principali cagioni che tengono il nostro teatro nell’attuale vergognosa mediocrità, dalla quale non sortirà certamente finché non ne vengano affatto proscritte le maschere, e che invece di chiamare compagnie francesi non ci volgiamo ad animare e sostenere il nostro teatro. Non sarà punto difficile di trovare e buoni attori e buoni autori, quando entrando in questa carriera possano sperare di fare una fortuna o di formarsi un nome.
Fatti i primi passi, quai rapidi progressi sarà per fare quest’arte fra noi, animata dall’esempio e dall’emulazione! Le circostanze dell’Italia, che conta nel suo seno omai principi che può chiamare italiani e che vien di far un nuovo fortunato acquisto, pare che lo facciano sperare con tutto il fondamento, e parmi già vedere, là dove rinacquero le scienze e dove ebbero la loro origine tanti grand’uomini, risorgere più glorioso il nostro teatro e riprendere l’antica sua dignità.
S. [Pietro Secchi]
IL CAFFÈ )( Fogl. XXXI )(
Di alcuni sistemi del pubblico diritto[123]
Finché le nazioni fra di esse ebbero poca o nessuna comunicazione, e che in quasi non altra guisa si conoscevano se non se in quella funestissima di guerreggiare, non si parlò di diritto di natura e delle genti; ma poiché le rivoluzioni delle vicende, l’invenzioni delle arti, il commercio, le stampe, le poste, l’ago magnetico fecero di gran parte del globo una sola e vasta nazione, fu bisogno che si accettassero alcuni principii co’ quali regolare i moltiplici rapporti che nacquero fra gente e gente. Non v’è società che possa susistere senza una giustizia conforme alla sua instituzione. L’hanno perfino gli assassini ed i sicari fra di loro, come è vecchia osservazione di Aristotile. Senza fede, senza moralità non stanno uniti gli uomini un momento.
Le prime idee di civil giustizia nacquero dalla necessità. Esse chiamar si possono primitivo ed universal diritto, in quanto che concorrendo a un di presso gl’istessi bisogni nelle prime società, avranno in quelle gli uomini fatti gli stessi ragionamenti partendo da’ medesimi dati. Perciò questa civil giustizia può esser stata comune a quasi tutte le nazioni, quantunque segregate ed incomunicanti. Ma poiché gli uomini furono tranquilli ed esenti dai mali dell’anarchia e da’ suoi timori liberati colla civile giustizia, passarono a cercare le utilità, e da qui nacque la politica. Non sono opposte queste due scienze. L’una tolse i danni che l’esempio e la funesta libertà delle tristi azioni avrebbero recato in giro a ciascuno; l’altra nello stato di coltura, e cresciute le moltiplici relazioni fra le nazioni, va in traccia delle vere e perpetue utilità, le quali, intrecciate od anco nascoste e tralucenti nella folla degli atti umani, han bisogno di ragionamenti e di inquisizione per essere sviluppate e poste in chiaro.
Non è già che alcuna espressa ed universal convenzione abbiano fra di loro celebrata le genti, patteggiando con quai principii dovessero decidersi le controversie vicendevoli e qual norma di giustizia dovessero abbracciare. Egli fu il bisogno, padre de’ vizi e delle virtù, che impose tal legge alle nazioni: siate giuste, non crudeli, non mancate alle promesse. E poiché tal bisogno fu comune a tutte le nazioni, più meno tutte dovettero seguire li medesimi morali principii. Nacquero le pubbliche leggi, come le civili. Senza di queste ben videro gli uomini uniti in società che non potevan sussistere, senza di quelle videro medesimamente le nazioni che gravi danni ed insopportabili inconvenienti ne sarebbero nati e ne nascevano, perciò le adottarono. Vorrei che nel cuore umano fossero impressi profondi vestigi di un’alta virtù, disinteressata, pura, indipendente dalla opinione e dai bisogni. Ma così dolce desiderio è vano se vibri dentro all’animo umano il tuo pensiero e ne analizzi i suoi principii. Parlo dell’uomo abbandonato a se stesso e delle sue sole forze. D’onde nacque la giustizia se non dalla necessità, d’onde le leggi se non dal pericolo, d’onde il diritto se non dall’inconveniente, se tu ragioni di pure umane instituzioni? Furono parimenti la necessità, il pericolo, l’inconveniente che produssero quella scienza che chiamiamo diritto pubblico, diritto delle genti.
Cos’è il diritto delle genti, dice il gran Montesquieu? Egli è che le nazioni si facciano il men male che possono nella guerra e ’l maggior bene che possono nella pace senza nuocere a’ loro veri interessi. Quella gran mente risguardò come voto ciò che sta oltre tai confini.
Furono lodevoli, perché umani, gli sforzi di que’ molti i quali pretesero di dimostrare con geometrica precisione i precetti della natura ed i diritti suoi. Essi esclamano che sono chiari e palesi a qualunque uomo che non ricusi la ragione, e che sono alla intelligenza di qualunque ingegno; pur nello stesso tempo declamano contro l’umana perfidia perché abbia offuscati i chiari diritti della umana natura, sicché essi sieno quasi sepolti nella immensa congerie de’ vizi. Sono eglino facili ad impararsi ed a conoscersi, i precetti di questa gran madre? Perché adunque vi vogliono tanti volumi per apprenderli? E se l’uomo generalmente o non li conosce o li trasgredisce, sicché di grandi invettive esso sia fatto meritevole, come saranno precetti di natura quegli che quasi tutti gli uomini non sanno o non seguono secondo essi? Si sono dispensati gli scrittori di tali materie dal ben definire cosa intendevano con queste lor voci, diritto e natura, onde empierono i trattati. Che vorremo noi dire per natura? L’essere eterno? Allora parleremo de’ suoi augusti precetti e si ridurremo alla teologia, non all’umano diritto. Tutte le cose create? Allora parleremo delle leggi universali della materia. Saremo fisici, non pubblicisti. L’uomo? Allora adunque per ben definire che intendiamo di dire per natura dell’uomo converrà analizarlo e conoscere quai sieno quegli attributi che appartengono alla sua organizazione ed alla totale sua costituzione. In questo solo senso sembra che usurpino tal voce i pubblicisti, ma confusamente parlando ammucchiano sovente tutte e tre queste definizioni.
Quand’io chiamo al fisico: la natura della materia qual è? Egli mi risponde di essere estesa, solida, impenetrabile, gravitante; e per natura della materia altro non vuol significare che il complesso di tutti quegli attributi suoi che in lei conosciamo. Ed io intendo il fisico. Quando io chiamo al pubblicista: qual è la natura dell’uomo in quanto alla morale? Ei mi risponde: d’esser giusto, fedele, benefico, saggio, virtuoso; questo esige la natura da lui, questi sono i di lei precetti, ma egli per la gran sua miseria ed imbecillità ha confuse queste nozioni e quasi non le conosce. Ed io non intendo il pubblicista. Dunque, secondo questi principii, gli attributi dell’uomo generalmente non sono la giustizia, la virtù, ma il vizio e la perfidia. Come dunque chiamar natura sua quello stato nel quale egli non è, e definire che natura umana è quella che non esiste che ne’ trattati? Per definire la natura di un essere altro non de’ farsi che descriverlo qual egli è. Questa è la sua natura, cioè il suo modo di esistere. Ma chiamare natura umana quella idea di perfezione che un solitario metafisico si è formata, e chiamare umana perfidia quella che di fatto è generalmente e non corrisponde a quelle idee di perfezione, egli è pretender molto dall’uomo e riprenderlo perché non sia quale il pretendiamo. Umanissimo, ma irragionevol desiderio.
Scorriamo il globo. Tutte le nazioni furono un tempo barbare, poi si ripulirono; molte sono ancor barbare. Il modo naturale di esistere all’uomo è egli in Parigi alloggiato in un magnifico appartamento, strascinato da una carrozza al teatro, vestito di stoffa, ornato di merletti, sapendo il calcolo differenziale, parlando molte lingue, scrivendo dei trattati del diritto di natura e delle genti; oppure in una caverna, in una capanna, mezzo ignudo, mangiando frutti, cacciando selvaggiumi e pesci, contando tutt’al più sino al cento, non sapendo tampoco quanti anni egli abbia, limitando la sua sapienza alle semplici senzazioni? Sono sortiti dallo stato di natura i Parigini o gli Americani, i settentrionali, gli antichi Galli, gli antichi Greci e cento altre nazioni? Vediamo ciò che alcuni hanno pensato in queste materie.
Ugone Grozio fu il primo che trattasse con estensione del diritto delle genti e di natura. Non è già che prima di lui non si fosse toccata questa scienza. In Cicerone, in Platone, in Aristotile ed in altri fra gli antichi se ne trovano tanti semi da poterne fare un trattato così voluminoso come quello di Grozio. La scienza dell’uomo è vecchia. Egli è stato debitore del grandissimo successo ch’ebbe questa sua opera alla novità di cui la seppe rivestire, alla somma erudizione, alla immensità delle cognizioni e fors’anco allo stile. Se non v’è sempre precisione nelle sue idee, le porge però sempre con molto nervo di stile, che ha un non so che di grave e di legislativo congiunto ad un’ottima lingua latina. Questo non era un piccol merito a’ suoi tempi.
Grozio è ora moralista, ora teologo, or giurisconsulto, or filosofo, ora erudito: vi trovate citato Omero ed Euripide accanto di Molina e di Vasquez; Orazio e Cicerone accanto di Baldo e di Bartolo.
Anche questa fu una delle cagioni dell’applauso dell’opera. V’è un non so che di enciclopedico nelle sue cognizioni. Ma questa mescolanza di persone ch’ei sostiene fa sovente che quando tu aspetti la soluzione d’una questione coi principii della umana filosofia, essa la sia con quelli della teologia, e che quando ti aspetti qualche gran prova de’ principii di natura incontri un paio di versi della Odissea o di Euripide.
Per quanto però sia ben lontana quest’opera dal costituire un tutto, come chiunque l’abbia letta dovrà meco convenire, ciò nonostante si può conoscere che il principal fine dell’autore fu quello di provare i principii del diritto delle genti colla tradizione universale. Le nazioni, secondo Grozio, per una tacita convenzione o per li dettami della natura istessa dovettero abbracciare de’ principii di giustizia universale con cui regolare i patti, i trattati, le legazioni, le cose di guerra e di pace fra di esse. Per ben conoscere adunque quali sieno queste convenzioni e questi principii, da una lunga ed universal consuetudine introdotti, non v’è miglior mezzo che consultare le storie de’ colti e più rispettabili popoli e le opinioni de’ più sensati e classici scrittori. Questa è la mira a cui dirigge la profusa erudizione della quale ha da pertutto sparsa l’opera sua. Questi principii poi autenticati dagli esempi e dalle autorità formano, secondo lui, un diritto come proveniente o dalle tradizioni naturali o dalle convenzioni.
Non è difficile l’intendere al primo colpo d’occhio l’incertezza e gl’inconvenienti di questo metodo. La storia e l’erudizione sono uno sterminato magazzino ove ognuno ritrova merce a suo proposito. Si può fare un sistema di sublimissima tirannia tutto autenticato con esempi anche di colte nazioni, si può fare nello stesso modo un eruditissimo trattato di perfidia. Per far ciò non si ha che a scegliere in tutte le nazioni le guerre ingiuste, i trattati violati, la mala fede, le crudeltà. E ne mancan forse in quella compita raccolta degli orrori umani, la storia?
Se Grozio avesse estese le sue mire a tutto il globo, poiché trattava de’ principii di giustizia emananti dalla natura umana, la quale abita tutto il globo, avrebbe diminuiti di molto gl’inconvenienti di questo sistema. Ma l’universale tradizione delle genti si riduce per lo più ai Greci ed ai Romani, i quali due mucchi d’uomini sono già da gran tempo in diritto di formare l’universo. Questi sono due popoli le di cui storie ci sono notissime, e furono cotanto rischiarate che la maggior parte degli eruditi sarebbe meno forastiera in Roma antica ed in Atene che nella propria sua patria. Per tal cagione, quando si tratta di parlare del genere umano si limitano per lo più le viste a questi due popoli. Basta prendere in mano un globo per arrossire di sì fatta conclusione.
Se i mezzi co’ quali si era fissato quest’autore di dare un sistema del diritto delle genti l’avessero sempre condotto ad umane conseguenze, egli sarebbe apprezzabile, quantunque fosse stato cattivo logico. Ma poiché, come altri ha osservato, egli stabilisce sempre il diritto sul fatto, non ha mancato talvolta di declinare da quello spirito di umanità da cui devono esser dirette tali opere, destinate a scemare, non ad accrescere i mali degli uomini.
Egli è spesse volte filosofo umano, ma è ancor talvolta tiranno. Non gli si può risparmiare né questa lode, né questo biasimo.
Non dirò nulla della precisione delle idee, della chiarezza delle definizioni. Il solo primo capitolo ne può dare un saggio. Quante specie di diritto non istabilisce? Altro è il diritto rettorio, altro l’equatorio, altro di facoltà, altro di attitudine; altra è giustizia espletrice, altra attributrice, altro è il diritto volontario, altro naturale, civile, delle genti, universale, particolare. Sono belle cognizioni per il generale degli uomini, i quali pur dovrebbero conoscere il diritto e la giustizia. Ciò ch’è strano, Grozio non ha mai definito cosa s’intendeva per diritto. Egli ha creduto che bastasse dividere dove faceva bisogno di provare.
Puffendorfio dopo di Grozio rimontò più in alto. Grozio avea appena toccati i principii dell’ius di natura e della giustizia assolutamente considerata, ma piuttosto partendo dai fatti e facendo successivamente delle particolari questioni, le avea di mano in mano decise anziché ridurle a principii generali. Quando si tratta in Grozio di decider una questione del gius delle genti, ricorre alla storia ed a fatti simili. Puffendorfio ricorre alla ragione. Il suo metodo è a priori; si rifugia sempre in seno della natura.
È incredibile con quanta fatica egli travagli nel primo libro della sua opera per istabilire l’origine e la definizione del dovere e della imputazione delle umane azioni. Ei considera gli atti umani come enti morali paragonabili fra di loro, aventi un certo valore riducibile a calcolo, dotati di quantità, qualità e modi come gli enti fisici, perciò suscettibili di geometrica dimostrazione. In conseguenza Puffendorfio confuta coloro che asserirono non darsi certezza in queste materie ed essere una sterminata provincia del regno delle opinioni. Loke era ancora del parere di Puffendorfio nel suo Saggio sull’umano intendimento, in cui vuol provare che la norma del giusto e dell’ingiusto è di egual certezza che le matematiche. Ma questa sua importante proposizione si riduce ad esser nulla più che una proposizione, non altro provando se non se che tal cosa non è impossibile. Non entrò nella materia, ha lasciata tal parte della metafisica dove la ritrovò.
Ecco a un di presso le idee di Puffendorfio quanto al dritto naturale. L’uomo, in quanto ch’è ragionevole nell’intelletto, libero nella volontà e sociabile, è capace di giustizia e di ingiustizia. La cognizione d’entrambe proviene da due sorgenti perciò che spettano alle umane cose: dal retto lume della ragione e dalle leggi civili. Da quello derivano i comuni doveri di umanità e l’attitudine alla società; dalle altre i doveri d’ogni uomo in quanto che unito in società si è sottomesso a certe leggi. Da qui nascono due scienze, quella del diritto naturale e quella del dritto civile. Ognuna di esse scienze ha i suoi principii, co’ quali prova i dogmi suoi. I doveri del gius di natura si provano colla retta ragione e coll’attitudine dell’uomo alla società, che li rende necessari. I doveri del gius civile non si provano con altra ragione se non colla autorità del legislatore. Basta provare ch’egli ha così stabilito. Tal scienza non va più oltre. Quest’è il suo fine. Ma quanto alla giustizia intrinseca di esse leggi, ella dipende dal gius di natura, madre delle leggi civili, la onde quando si tratti di guardarle sotto quest’aspetto l’ius civile si confonde coll’ius di natura ed ambi si regolano colla stessa norma.
Ogni obbligazione adunque, ogni dovere, ogni uficio umano si riduce al gius di natura. Per lo che dal dritto naturale dobbiamo apprendere la norma delle nostre azioni. Una norma è necessaria, è conforme alla ragionevolezza ed alla sociabilità dell’uomo. Senza di essa sarebbe misero e simile ai bruti.
Ogni uomo, secondo lo stesso autore, ha bastevolmente di raziocinio per conoscere questi dettami universali della natura, cioè quella norma di giustizia che lo può condurre ad onesta e tranquilla vita sociale. Essendo facili a conoscersi tai precetti, ne deriva l’obbligazion di conoscerli e quella di osservarli. Non d’altro che da negligente colpa o da reità potrebbe provenire tale ignoranza, la quale non iscusa punto, perché lungi dall’esser invincibile è molto da rimproverarsi. Non è adunque innocente chi o ignora o non conosce i dettami della natura. Da qui ne deriva la imputazion delle umane azioni, ossia il dovere che ogni uomo ha di seguir tal norma, la reità di trasgredirla, il diritto che hanno gli altri di pretendere che la segua.
Che se, giusta quest’autore, i doveri di natura fossero difficili, reconditi ed oscuri, ogni uomo potrebbe allegare ignoranza, né pretender perciò da lui si potrebbe che li seguitasse. Non è reo chi trasgredisce una legge che non conosce. Tai sono i fondamenti del sistema di Puffendorfio. Quai sieno poi o non sieno questi dettami della natura, ivi è dove comincia a diventar sublime la materia in quest’autore, perché sovente non s’intende. Se sieno facili a conoscersi questi dettami della natura, bastevolmente lo provano i molti libri che si sono fatti per provarli tali e le immani crudeltà degli uomini ed i lor vizi e le querele de’ giusti in ogni tempo ed in ogni nazione. Dirò una sola cosa a tal soggetto, e questa è che non mi sembra esatto Puffendorfio quando asserisce che l’imputazion delle azioni nasce dalla obbligazione che si ha di conoscere le leggi naturali, e che non vi sarebbe tale imputazione se si potesse allegare ignoranza. Il fatto è che la più gran parte degli uomini non sa quello che sapea quell’autore, e che sono in tal guisa confuse ed alterate generalmente nell’animo umano queste nozioni, che da taluno non se ne sospetta tampoco l’esistenza. Tali uomini che non le conoscono sono innegabili e molti. Questi non potrebbero adunque, secondo i principii di Puffendorfio, punirsi dalla società. I più gran scellerati non ebbero mai conoscenza di quelle massime che chiamiamo principii di natura, non sanno che la natura gli ha destinati alla società, non sanno com’esse nascessero, non hanno alcuna idea di tai dogmi; eppure la società deve potere metterli fuori di stato di nuocerle, qual è l’oggetto delle pene. Se abbracciamo questi principii, gli uomini più scellerati sarebbero impuniti.
Trovo di rado in queste materie quella precisione dalla qual sola nasce la convinzione. Ella è necessaria in ogni classe di ragionamenti, ma in quelli precipuamente che avendo per oggetto non cose sensibili, ma intellettuali, la mente è come senza appoggio ed ha bisogno della maggior chiarezza e connessione per comprenderle. Nella fisica, nelle arti, in ogni scienza che consista in cose, difficilmente si troveranno equivoci di parole. L’abuso di esse sarebbe presto smentito e scoperto, paragonandosi facilmente le parole agli oggetti esistenti, visibili e palpabili. Ma nelle disquisizioni che si staccano, per dir così, dagli oggetti sensibili e che si fondano su pure idee, l’animo umano cambia facilmente le voci rapportandole ad altre idee differenti, e l’inganno di questa sostituzione di una diversa idea ad una istessa voce non è così facile a smentirsi ed a conoscersi. Perciò non mai trasporterassi la parola barometro ad una casa, perché sono comuni e palpabili gli oggetti che queste voci esprimono, ed ognuno può riconoscere questo cambiamento di vocaboli; là dove le parole virtù e giustizia e tutte le altre intellettuali voci facilmente possono come cadere e sdrucciolare dall’una all’altra idea senza che questa sostituzione di espressioni si manifesti, perché né la virtù, né la giustizia sono due esseri reali e due oggetti immediati de’ sensi. Questa è forse la ragione per cui nelle arti non vi sieno questioni di parole, e tante nella morale e nella metafisica.
Non v’è materia sulla quale si sieno fatti tanti romanzi quanto su queste tre, l’amore, la forma dell’universo e la origine della società. Le prime non fanno al mio soggetto; quanto all’ultima, chi pone negli uomini la sociabilità come una loro peculiar dote negata dalla natura ai bruti animali; chi alla necessità, chi alla forza, chi al timore, chi all’amore ascrive i primi vincoli che associarono gli uomini. Gravina, fra gli altri, fonda i principii della società nel coniugio che approssimò i due sessi. La prole cominciò (sono le idee di quest’autore) a star vicina a’ genitori: prima per necessità, poi per consuetudine. Quindi vennero le unioni delle famiglie, d’onde gl’imperi famigliari. Poiché in tale stato di cose l’uomo, come più potente della donna nella robustezza del corpo e nel raziocinio, occuppò la donna istessa per questo duplice natural diritto della mente e del corpo; e molto più giustamente occupò i feti e li fé suoi, come cose addette alle materne viscere, già fatte sue. D’onde ne viene che la natura consegnò i figli alla podestà del padre. Obesio opinò a tal proposito che per essere i figli porzion dell’utero della madre e come parti del suo corpo, sieno in di lei podestà. Lo confuta Gravina dicendo che malgrado l’acutezza del suo ingegno, non vide Obesio che essendo la donna anteriormente alla generazione passata in podestà dell’uomo per la già detta prestanza di animo e di corpo, tutto ciò che ad essa donna è inerente, è parimenti passato in podestà dell’uomo istesso, perché ciò che forma porzion della cosa occupata per natural diritto si risolve in podestà dell’occupante. Oltrediché siccome l’uomo (segue Gravina) supera la donna nel consiglio, ed abbisognando alla inferma età chi la guidi, ne deriva che la prole debba soggiacere alla più eccellente prudenza, qual è la virile.
Vi sono delle curiose ipotesi in questo sistema. Che la donna sia superata dall’uomo nel raziocinio. Siamo ben orgogliosi se lo crediamo. Non ne dà una gran prova Gravina col asserirlo. Esse non hanno fatti, la Dio mercé, tanti trattati di gius di natura, ma generalmente nella società dove ritrovi meno abuso della ragione si è fra di esse. Elleno avranno de’ capricci, noi degli errori e delle opinioni che dovrebbero farci arrossire. Seguirò io questa lepida confutazione? Gravina avea una fisonomia piuttosto defforme. Ciò rende sospetti i suoi principii a tal proposito.
Gravina confonde apertamente in questo luogo il dritto colla forza. Perché l’uomo è robusto, ha
IL CAFFÈ )( Fogl. XXXII )(
dritto di comandare, occupa il corpo della donna, fa sue per fino le di lei viscere, i feti, i parti sono suoi come frutti di un suo fondo. La difficoltà di ben definire il dritto destituito di forza è stata sentita da molti. Perciò comunemente si ammette un dritto perfetto, cioè quello che è unito colla podestà di ridurlo all’atto, ed un dritto imperfetto, cioè quello ch’è destituito di questa podestà. Un giuoco di parole ha tolto l’impaccio. La superiorità di mente, secondo Gravina, dà ancora diritto di comandare. Il sapiente, secondo lui, deve comandare all’ignorante, perciò furono giuste le guerre de’ Romani, avvegnaché non ad altri le fecero che a quelle genti che mancavano di fede, né riposero in servitù che quelle nazioni le quali trasgredivano le leggi della retta ragione ed anteponevano i feroci costumi ad un genere di vita sociale ed umano. Si servirono della loro forza per estendere i diritti delle genti, propagar quelli di natura e per l’emendazione del genere umano. Nel che la storia non è punto del parere di Gravina, come non è difficile di comprendere. Ciò ch’è certo, i popoli della Magna Grecia, gli Etrusci, i Sanniti, i Campani, i Tarentini e cento altri erano molto colti, e conquistati da’ Romani divennero barbari, parlando della sola Italia. E quanto ai costumi di quel popolo conquistatore, il diritto di uccidere i figli ed i servi, i sagrifizi umani, i gladiatori ch’essi usavano fanno qualche difficoltà.
Anche Grozio e Puffendorfio hanno sostenuta questa opinione, che si possa far guerra ad una nazione la quale professi feroci costumi e violi le prime leggi della umanità, fondati sul rendersi tai popoli meritevoli di pena e da chicchessia punibili, come nello stato insociabile lo sarebbe senza previa alcuna convenzione un uomo che offendesse i primi doveri della natura. In oltre Grozio dà un’altra ragione, ed ella è che le nazioni non solo consegnarono a’ lor sovrani la cura della particolar loro società, ma ancor della universale, che però possono punire quelle genti che violano i primitivi diritti come nemici dell’umano genere, co’ quali vi sia perpetua ed universal guerra. La quale opinione ha comodamente servito alle conquiste di America e può servire in altre occasioni. Si conquista, e si paga un giurisconsulto. Tal dottrina può esser dettata dalla compassione ma non dal dritto. Ella fa una nazione giudice e sovrana di un’altra senza nessuna convenzione e senza nessun bisogno. Non vedo su che possa fondarsi questo diritto quando i feroci costumi de’ barbari non ci recano nessun svantaggio, né col fatto, né coll’esempio.
Fra la gran schiera de’ pubblicisti mi sembra che il signor Vattel abbia colta la verità e sia quello che abbia spogliata questa scienza dalle chimere e dagli equivoci riducendola a sistema d’idee, non di parole. Egli pone per principio che le nazioni devono cercare la loro felicità e la loro perfettibilità in quanto che le conduce alla felicità istessa. Egli impone de’ bei doveri. Nessuno glieli può contrastare. Il suo principio è fondato sul cuore umano quale egli è, non qual vorrebbesi che fosse. Sviluppa quindi le innumerevoli conseguenze che ne derivano e determina con molta precisione i mezzi co’ quali può la nazione ottenere questo fine. Consiste adunque questa scienza nello sviluppare i veri interessi delle nazioni. Ecco a mio credere in che ella debba aggirarsi. Chi porrà altri fondamenti fabbricherà sul voto.
Prendiamo le nazioni come sono presentemente e cerchiamo quai sieno i loro veri interessi. Non temiamo le conseguenze di tal principio, esso ci condurrà sempre ad umanissime conclusioni. La perfidia ne’ trattati, l’ambizione delle conquiste, la gravezza de’ tributi, il dispotismo arbitrario, ogni crudeltà si può evidentemente provare che non è mezzo atto a condurre alla costante felicità nessuna potenza nelle presenti circostanze. Quel governo che faccia felici i suoi sudditi sarà sempre terribile a quello che li faccia infelici. La felicità di chi regge non è disgiunta da quella de’ governati. Non è ricco il sovrano se sono poveri i sudditi, non è forte s’essi sono deboli; ciò è manifesto.
Queste grandi dottrine son giunte ai troni, ne fanno la sicurezza e la felicità. Le guerre istesse non sono più una orribil serie di atrocità. La pubblica fede è somma. Non v’è perpetua guerra di nazione a nazione. Non tanto si fonda la grandezza sull’armi, quanto sulla opulenza e sulla industria. Perché disputeremo ora quai sieno i dritti di natura, quai gli enti morali, quale l’origine della umana società? Sono troppo indeterminate queste nozioni per condurci a certe ed inconcusse conseguenze.
Avremo bisogno di stabilire che gli uomini si unirono in società per il timore, per l’amor de’ loro simili, per la comune difesa, che ognuno ha originalmente rinunciato alla natural sua libertà con certi patti, per certe ragioni? Desumeremo noi il diritto di natura e delle genti da queste antiche convenzioni? In quali memorie le ritroviamo? Questi sono sistemi arbitrari fondati su ciò che dovea o potea essere, non su ciò che è stato. Non poniamo ipotetici principii in materie nelle quali abbiamo bisogno di principii sicuri e costanti. Quand’anche con una ipotesi potessimo spiegare, per dir così, tutti i fenomeni morali ed i casi politici, egualmente che con una ipotesi fisica tutti i naturali effetti, non avremmo ancora ridotta la norma del giusto e dell’ingiusto che a probabili principii. Non siamo cartesiani in morale, non abbiamo dei vortici anche in queste materie; non sostituiamo de’ grandi e semplici errori alla meno sfoggiante ma più sicura verità. Partiamo dall’uomo e da’ suoi principii, profittiamo di essi, fabbrichiamo su di essi. Non v’è altro fondamento.
Egli è certo che l’uomo cerca sempre il suo utile. Fondiamo adunque su questo il sistema. Le relazioni d’utilità non le vede che l’uomo che ragiona su di esse: ognuno cerca la felicità, la desidera, ne ha una confusa nozione. Spetta all’umano filosofo lo svilupparla ne’ suoi elementi e nella sua universalità. Se si trattasse di render felice un uomo, io crederei per lo meno inutile il fare il romanzo della sua nascita, puerizia ed adolescenza. Così parmi che si faccia da coloro i quali, cercando le idee di giustizia che convengano alle nazioni nello stato in cui si ritrovano presentemente, ricorrono alla infanzia del mondo, agl’imperi famigliari, allo stato di natura, ad arbitrarie convenzioni. Se questi principii fossero anche la storia, piuttosto che il romanzo della umanità, non ci condurebbero a convincere il più delle volte. Di qual forza sono queste ipotesi? Basta negarle per distruggerle; e con esse cadrebbero le conseguenze. Tai fondamenti avrebbe la somma e necessaria scienza della giustizia.
Un sistema in cui si proccurino i veri ed eterni vantaggi delle nazioni, un sistema che sempre più stringa quella cognazione che pose la natura fra gli uomini, come disse il giurisconsulto florentino, un sistema che distrugga le massime opposte al bene universale, che faccia svanire le false opinioni di giustizia, che non faccia i beni presenti e chimerici a spese di lunghi e reali futuri danni, un sistema per fine utile a tutti od alla maggior parte, io dico ch’è il solo vero trattato di tal scienza, perché quel solo che sarà abbracciato, il solo che sarà eterno e giusto in ogni tempo ed in ogni nazione.
Grande e tristo autor del Principe, stendi con penna tinta nel sangue atroci leggi di meditata tirannia, sciogli con agghiacciata discussione i problemi delle fraudi, degli assassinii, e delle stilettate, tu t’inganni, quantunque sembri che cerchi con gran metodo e con tranquillità ciò ch’è utile, ciò ch’è dannoso. Tu dimentichi che gli uomini hanno un cuore e che sono capaci di orribili rimorsi; tu fondi i principii del giusto come se gli uomini non sentissero, come se negli animi, egualmente che nelle membra umane, non vi fossero delle dolorose sensazioni. Vedi se t’inganni! Sono pochi coloro a’ quali non rechino orrore i tuoi dogmi.
Quando le grandi nazioni adotteranno questi principii, quando essi condurranno anche un uomo solo alla felicità, io non temerò i tuoi dogmi e le più remote conseguenze di essi; ma poiché sono altrettanto orribili quanto falsi, egli è ragionando che li distruggo.
Di fatti, se quelle massime fossero in vigore generalmente, qual sarebbe il gius delle genti? E quanti non sarebbero i mali che in giro ne soffrirebbero le nazioni? Egli è tanto vero che l’interesse della umanità detta sempre ottima morale, che non mai si è trattato dei diritti della giustizia, non mai vi sono stati tanti ingegni che ragionassero su queste materie quanto in questi ultimi tempi, poiché l’Europa tutta è divenuta una sola nazione. Se i loro sforzi non furono ognor felici, furono però sempre utili. La cabala, i rigiri, la mala fede divennero la vecchia e screditata politica, ed altro mezzo non si ritrovò di fare costantemente i suoi vantaggi che col rispettar l’umanità e la buona fede.
A. [Alessandro Verri]
La virtù sociale. Lettera di un institutore a Lucillo suo alunno
Tu sai, Lucillo, ch’io non ti oppressi con mal definiti precetti, non ti sobissai con vaghe massime, non ti feci tremare con irate declamazioni. Ho sempre creduta la giovinezza la più innocente e preziosa porzione del genere umano. Censori ingiusti e tiranni! Perché nei teneri cuori cercate materia di severe riprensioni ed incensate gli annosi e potenti vizi? L’adolescenza è più suscettibile di difetti che di malvagità. Queste sono riservate agli anni più maturi. Allora è che l’uomo buono diventa ottimo, e pessimo il cattivo. Si sviluppa e si converge, per dir così, in se stesso tanto il giusto come il tristo, cogli anni; forma e sistemizza ciascuno la sua virtù, la sua malvagità. Fa il tempo robusti i cuori, sia nel bene, sia nel male. Perciò generalmente se ritrovai ne’ giovani leggierezza, sventatezza e capricci, non ritrovai in loro perversità riflettuta e dissimulazione profonda, animo freddamente vendicativo. Queste, ed altre molte per isfortuna, sono contagioni che si attaccano col lungo uso della umana società. Il giovine è ancora come forastiero a questo mondo, egli non ha ancora soffocate nel suo petto le querele della natura, ascolta e segue le sue voci, non conosce quelle illustri maschere del vizio, la falsa prudenza, la dissimulazione, la obliquità delle azioni, la destrezza della condotta. Gli affari, la esperienza, gl’interessi moltiplici e contrari della società piegano finalmente l’uomo agli uomini, ed ei diventa un essere del tutto artificiale il di cui cuore è sepolto nella cautela, concentrato, occulto, guardingo, bieco, mendace, freddo, operante a secondi fini, occupato di mille oggetti, astuto, incerto, trasformato.
Se gli uomini fossero generalmente virtuosi, non temi di dubitarlo, o Lucillo, vi sarebbe nessun svantaggio ad esser sempre bambini. Ma non sono il sì ed il no che reggano gli affari umani. Se l’uomo volesse conservare la primigenia sua semplicità e la dolcezza de’ costumi giovanili anche in anni più maturi, a quai pentimenti non sarebbe in preda?
Le virtù sociali, nello stato in cui siamo, non sono più semplicissime. L’aureo secolo è riposto nella mitologia. Un uomo ognor sincero, un uomo che ognora rendesse altrui esatto conto di ciò che sta nell’animo suo, non potrebbe vivere fra gli uomini. È necessario fare il gran passo di diventar prudente, cioè dissimulatore.
Un buon giovine che credesse tutti gli uomini semplici e virtuosi sarebbe ad ogni momento vittima di questo suo umanissimo inganno. Bisogna che gli uomini si accostino con gran cautela fra di essi. Non si può che con mano tremante alzar il velo sotto del quale è nascosto il lor cuore. È melanconia esser misantropo. È dabbennaggine il non guardarti dalle sorprese della malvagità. Ond’ecco necessaria l’accortezza. Convien pur dunque che tu diventi, o mio Lucillo, dissimulatore ed accorto, da semplice, buono, sincero, dolcissimo che tu sei. Parmi di vederti impallidire a questo mio fatal precetto, e fors’anco ti si desta nel cuore una sorte di scandalo. Tu già mi riguardi come un uomo corrotto, tu mi condanni di malvagità. Te beato, se lungamente le tue guancie conosceranno questi pallori ed il tuo cuore questi gemiti di virtù! Ma non credi ch’io venga a spegnere nell’animo tua questa sacra fiamma, fiamma divina ch’io sempre in te venerai e riscossi. Non si tratta di distrugger la tua virtù. Me misero, se questo fosse il mio fato! Si tratta di piegarla ai necessari difetti degli uomini, alle invincibili combinazioni della società; si tratta di umanizzarla, e da incolta e come selvaggia ch’ella è, renderla urbana e profittevole nell’attual sistema delle cose. Quanto crudel spettacolo non è agli occhi del sensibile filosofo la virtù sacrificata al vizio, la bontà all’astuzia, la semplicità alla menzogna, l’innocenza alla derisione? E pure a ciò tu sei condannato, se non muti le direzioni della tua virtù. Non sperare di vincere il vizio. Egli è fatto invincibil tiranno. Bisogna schivarlo. Quest’è ciò che si può ottenere.
Io feci quanto ho potuto per rendere immortale nel tuo cuore la virtù, e tu hai fatto assai per convincermi ch’ella lo sarà. Or io, siccome sino a questo tempo d’altro non fui occupato che di coltivare questo campo fecondo e di accrescere in te la massa della tua sensibilità, or vengo a dirigerla e diramarla per quelle vie che ti conducono alla felicità. È un gran fiume che bisogna dividere in molti e piccoli ruscelli. Io ti ho fatta una gran scorta di virtù, ti ho fatto semplice, magnanimo, modesto, amante della verità, detestatore della menzogna, or che dirai se voglio correger l’opra mia istessa? Dirai che sono in contraddizione, dirai che ti ho ingannato, dirai che questo pentimento prova la ignoranza dell’artefice? No, Lucillo. Per correger l’opra mia io non intendo il distruggerla, ma il modificarla. Largheggian sempre nelle lor manifatture gli artisti. Lasciano materia per le ultime limature. Fin ora fu la natura che ti educò per mia mano, or sia ella mista coll’arte, senza che l’arte la contamini. Io lasciai crescere e fecondai quanto ho potuto nel tuo cuore i germi della sensibilità, ho veduto vegetare e diramarsi quest’albero immortale sotto gli occhi miei, ne fui io stesso il fortunato e diligente coltivatore. Lasciai che quasi lussureggiasse nella sua fecondità e che la vegetal sua forza divenisse quasi inesauribile. Così io ti ho preparato a non temere la sterilità; così io ti ho preparata una gran massa di virtù la qual non ceda né alle corrosioni delle sociali instituzioni, né agli urti frequenti del vizio dominatore. Or io posso francamente limare e ripulire questa scabrosa e feroce tua virtù senza temere che mi si rompa e sfracelli l’opera nelle mani.
Tu fin ora fosti sincero, il tuo labbro non conosce la menzogna, i tuoi sentimenti non trovano niente di mezzo fra il cuore e la bocca, tu biasimi liberamente il vizio, detesti la malvagità. Lucillo, trema in ascoltarmi. Gli uomini si condannano a mentire. Tu dovrai soffocare gl’impeti d’un troppo robusto amor del vero. Dissimulerai i difetti e molto più i vizi degli uomini, perché avendone più meno tutti, li avresti tutti inimici e non convertiresti alcuno.
Lucillo, il tuo cuore non conosce altro che se stesso, ora dovrà conoscere anche l’altrui. Tu misuri gli uomini da te, credi gli altri a te simili; quale inganno! Credi tu generalmente gli uomini così sensibili al vero, così commossi dai pianti e dai gemiti del dolore, così lieti allo splendore delle grandi azioni come lo sei? Sappi che ben sovente è necessario imporre silenzio alle voci del cuore per non esser punito dall’inesorabil nemico de’ sentimenti, il motteggio.
L’uomo sociale più non conosce la natura. La ha ridotta nel più riposto ed angusto angolo dell’anima sua. Tu le consacrasti te stesso. Vedi che sono gli uomini! Sei ridicolo agli occhi loro. L’avresti mai sospettato? Tu tenero e delicato nella commiserazione, tu robusto e magnanimo contro l’ingiustizia, tu vero e franco nelle tue opinioni, tu entusiasta ammiratore delle sublimi azioni, come non saresti ridicolo e sconcio agli occhi del cauto, freddo, minuto, leggiero, dissimulatore, indiretto, adulatore uomo di società? Di quai motteggi non gli forniresti materia! Saresti per lui imprudente, sventato, indecente e per fin pazzo. Tu sei per lui un selvaggio. Egli per te è un essere perverso, ridicolo ne’ suoi vizi istessi.
Converrà adunque, Lucillo mio, che tu riservi alla solitudine ed alla amicizia i trasporti dell’animo tuo. Nascondi, nascondi agli occhi degli uomini profani li sacri entusiasmi della virtù. Non son degni di tai misteri. Ogni grandezza è così vicina al ridicolo che facilmente vi cade. Non vedrai un uomo che parli con gran passione, che brilli del fuoco della virtù, il di cui animo bolla di qualche gran febbre, il quale non sia accolto almeno con sorriso. Conviene disingannarci. L’uomo sociale non è più capace delle grandi passioni. La coltura le ha ridotte in zolle. Sono le sue ire risentimenti, i suoi amori benevolenze, le sue amicizie consuetudini, il suo coraggio timor dell’infamia. Le sue passioni tanto perderono nella energia, quanto si accrebbero in numero. Ora, tu che hai l’anima ancor selvaggia, guardati di non esser strascinato dal suo vigore.
Tu conosci la meraviglia. Quale ammirazione non impressero nel tuo volto i prodigi della natura? Gli oggetti nuovi vivamente percuotono il sensibile animo tuo, e non ascondi la profonda impressione che vi recano.
S’inarcò il tuo ciglio, si alzarono le tue palpebre, rimaser immobili gli occhi tuoi, si stese lo stupore sul tuo volto allorché ti appresi che il Sole è un milione di volte più grande del nostro globo, che nello interminabil spazio de’ cieli son sparsi altri innumerevoli Soli, che con mutue forze si attraggono, da noi così lontani che ci sembrano immobili facelle. Mi ricordo della tua sorpresa. L’ammirazione è madre della sapienza. Quanto non ti sentisti impiccolire in faccia dell’universo? Ma fu allora che diventasti grande. Siamo formiche e ci crediamo giganti. La sapienza è modesta, l’ignoranza è orgogliosa. Le idee dell’uomo superbo son quelle di un insetto sepolto nella crisalide formata dal suo sputo.
Lucillo, nasconderai in avvenire le prime scosse della meraviglia. Cento cose ti saranno nuove. Tu dovrai dissimulare i sentimenti che ti desteranno nel cuore. Altrimenti sarebbe risguardata la tua sorpresa come l’effetto di una limitata educazione. Niente ti de’ sembrar nuovo. Niente ti de’ recar meraviglia. Disprezzano gli uomini chi si mostra novello ospite di questo mondo: lo risguardano come un forastiero mal informato. Misurano da ciò la scarsezza delle sue cognizioni. Onde vedrai come generalmente la comune educazione ha resi gli uomini cauti su di tal punto e freddissimi, sicché con grande attenzione cercano di nascondere agli occhi altrui i primi impulsi della meraviglia. Non operano gli uomini che per riflessione. Avresti con loro un gran svantaggio operando per sentimento.
Tu fin ora non hai avuta altra misura nel mostrar la tua stima che l’interno giudizio che sul merito proferivi da te stesso, libero, franco, indipendente nel compartirla o negarla. Segui questo metodo, ma cela l’interior tuo giudizio. Fatti una abituazione di questa cautela. Cento relazioni, cento invincibili bisogni, cento giusti motivi di utilità t’impongono di soffocare queste sentenze nel tuo cuore. Tu palpiti, Lucillo, l’anima tua si sdegna e si cordoglia! Non è avvezza a queste catene. Il so, ma se vuoi vivere cogli uomini, non li irritare. E chi ti soffrirebbe, se con cinica libertà riprendessi i lor vizi? Gli offenderesti senza corregerli. E vorrai tu esser punito dalla tua istessa virtù? Non può vivere la sincerità fra le menzogne, la verità fra opinioni, la libertà fra la cauta prudenza.
Tu sai quanto è dolce l’amicizia. Tu la riponi fra i pochi beni disseminati fra i molti mali ond’è sparso questo lampo di vita mortale. Lucillo, seguila, coltivala, sia questa una sacra ed inestinguibil fiamma nel tuo cuore. Ma non sperar che tale divenga se non farai precedere al sentimento il freddo e tranquillo esame. Tu non conosci la seduzione, ti è ignota la malvagità; perciò non sai che vi sono degli uomini seducenti e malvagi. Non sai, Lucillo, quanti commedianti abbiano tutte le passioni, quanti pantomimi tutt’i sentimenti. Se tu conosci, come lo conosci, il pregio del cuore, sia cauto ad offrirlo. Questo è un gran dono, è un prezioso dono del quale son degni pochi uomini, credilo, Lucillo, è un dono in cui la liberalità è troppo funesta. È incredibile quanto sia apparente la dolcezza e l’umanità de’ costumi nelle colte nazioni e quanto sia reale in quelle che chiamiamo barbare. Il leggiadro, il colto, l’amabile ateniese t’abbraccia, ti adula, fa il sensibile, sempre parla della virtù, ha il suo gergo a memoria. Amabile ateniese! Non sperare che ti sia amico vent’anni dopo più di quello che lo è stato il primo giorno. Il rozzo spartano è di poche parole, di modi franchi, poco amabile, niente giocondo, non ha spirito, è difficile nella conversazione. Accostati a lui, renditi degno della sua amicizia, vedrai ch’è vero ciò dice Esiodo, che la virtù siede su di un erto scoglio le di cui falde sono aspre e ricoperte di spine.
Ma poiché avrai conosciuto alcuno meritevole del tuo cuore, succeda la confidenza alla cautela, ai dubbi la maggior fede. Quale amicizia è quella suggerita da chi non ne è capace che di sospettar sempre nell’amico un perfido ingrato? Quale insopportabile stato per un libero cuore l’aver sempre il verme del sospetto che lo laceri e lo corroda! Chi non ha il coraggio di far degl’ingrati, non entri nel tempio della sacra amicizia, non sacrifichi a’ suoi altari. Siede la confidenza alle sue porte, dorme presso di lei tranquillamente la fede. Ma non credi che sia un delitto il sospetto. Non temerlo, non arrossire della difidenza se è fondata anche sulle sole apparenze. Guadagnano i buoni ad essere
IL CAFFÈ )( Fogl. XXXIII )(
esaminati, vi perdono i cattivi. Si stringono adunque così le eterne, si rompono le false benevolenze. Questo solo metodo può far nascere le amicizie immortali. Finché non ritrovi in altrui un te stesso, non profanare i sentimenti del tuo cuore. Credi che ti voglia far misantropo? No, Lucillo, ti voglio risparmiar l’alto dolore d’aver degl’ingrati, benché te misero, se non fossi degno d’averne! Quanti non ne fa la beneficenza! Dovrai perciò fuggirla? Non v’è ingratitudine che possa eguagliare i dolcissimi trasporti della beneficenza. Anime caute, nascoste, tranquille calcolatrici delle passioni, voi non sarete giammai ingannate, non vi sedurranno finti gemiti, non false querele, non ipocrite lagrime, ma, quanto io vi compiango! vi sarà ancor sempre negato il sublime piacere di far dei felici, di ascoltare gl’inni che offre la miseria alla beneficenza e le sante voci della tenera gratitudine. Sfortunato chi non le udì; sfortunato chi con arte infelice, troppo temendo l’ingrata seduzione, ha indurito il suo cuore, sfortunato ancor più chi nacque incapace di sentirle! Egli è un verme tutto avolto nel suo fango, che non appartiene a nulla, che è isolato nella immensità dell’universo, rigettato dalla natura nel più abietto canto delle sue opere, destinato a non esistere che in se stesso, a languire più che a vivere, ad essere abitatore dimenticato, non mai cittadino illustre del globo. Ma dove mi strascina una troppo cara serie di pensieri! E chi può parlar della virtù senza disordine! Egli è un santo fuoco che divampa in ogni parte. Spetta alle fredde, caute, investigatrici scienze il caminar con passo lento e timido alla natura; noi, sacerdoti di più alta sapienza, voliamo nel suo grembo.
A questo linguaggio tu mi riconosci. Perdona alla mia contraddizione. Mentre che mi propongo di spegnere in te i pericolosi entusiasmi del tuo cuore troppo grande, troppo virtuoso per vivere fra la corruttela, io non posso abbandonare il mio vecchio stile, ossia me stesso. Ti reco ingiuria col insegnarti la virtù. Ti offendo col apprenderti la sensibilità. Questa grand’opera è già perfetta. Qual bisogno ha di esca un incendio? Ma poiché ti vedo destinato ai vortici della società, o non sia maggiore degli uomini o li fuggi. Io t’abbandono. Questa è l’ultima dottrina che ti ho riserbata. Ho proccurato di farti così virtuoso che non temessi di ascoltarla.
A. [Alessandro Verri]
Alcuni pensieri
I. Coloro i quali dicono che i moderni altro non fanno che ripetere gli antichi, giudicano come i fanciulli. Di due quadri che loro si presentino, l’uno di Tiziano, l’altro del Pianca, non ne sanno conoscere la differenza. Nell’uno e nell’altro vedono occhi, teste, gambe, gesti, persone, colori, perciò lor sembrano lo stesso. Nelle opere di Leucippo, di Platone e di Epicuro v’è qualche oscuro cenno del sistema di Cartesio, in altri antichi si parla di forze occulte, di attomi, di monadi; dunque Neuton e Cartesio hanno tolta da essi l’attrazione ed i vortici. È egli tanto inventore chi ha un sospetto dell’attrazione come chi coglie al varco la natura, verifica il sospetto e ne fa un sistema? Il primo può esser debitore al puro caso delle informi sue idee, talvolta può esser un mero ardimento d’ingegno, una mera poesia che lo ha mosso a gracchiare degl’inni alla natura senza conoscerla. Seneca sospettava moltissimo che le comete fossero pianeti. Non ne adduce nessuna convincente ragione, anzi molte frivolissime. È un pregiudizio il credere una verità per mezzo degli errori. Ma Neuton che calcola il periodo delle comete, avrà egli lo stesso merito di Seneca? Se per cose nuove e grandi s’intendono quelle che non furon mai in nessun conto accennate da un altro uomo prima di noi, credo che nulla di nuovo e grande vi sia. I primi parti delle verità son sempre aborti. Le cose grandi non le fa un uomo solo. Lo spirito umano progredisce per vari gradi. Una verità proviene dall’altra. L’uomo grande, se riduce molti errori in uno solo, fa un semplice e mirabil delirio. Se non ha ritrovata la verità, gli ha aperta una gran strada. Una gran folla di errori condensata in un solo annuncia la vicina loro distruzione. È più difficile vincere in dettaglio dei piccoli aspidi che un solo gran mostro. L’uomo grande, se riduce molte verità ad un nodo comune, fa un sistema immortale. Tutti due però questi uomini hanno il gran pregio di esser stati architteti quando i loro antenati furono muratori. Gli uomini mediocri vedono poche differenze nelle cose: i grandi moltissime. V’è un segreto odio del merito nel proferire tai giudizi.
II. È stato tante volte ripetuto che le arti e le scienze tutte si danno la mano. Non dubito che formino una catena. Si toccano in alcuni lati, ma non in tutti. Si danno la mano, ma alle volte un sol dito: hanno fra di esse delle unioni, ma non sempre totali. Non sono unite le rive di un fiume perché si congiungono con un ponte. Sono fiorite in tali nazioni delle arti e delle scienze in sommo grado, ed altre nello stesso tempo e per sempre sono state ignorate ed affatto incolte. È vero che lo spirito umano giunto a un certo grado di perfezione la spande in tutto ciò che gli appartiene, dalle infime arti sino al calcolo. Ma i costumi, la natura, il genio, il governo, le circostanze delle nazioni fanno che necessariamente alcuni oggetti o non le interessino o le sieno ignoti. Questi oggetti saranno sempre trascurati in tal caso. Saranno nella barbarie le arti che ad essi appartengono anche in una coltissima nazione. Dopo l’attrazione di Neuton, dopo i prodigi del calcolo e della fisica, dopo le profonde meditazioni della politica e della metafisica europea, non si fanno statue come le greche. Vi vogliono uomini così ben fatti com’essi, vi vogliono giuochi olimpici ove non sia indecente la nudità, vi vogliono i greci costumi per far nascere dei Prasiteli. L’architettura ha bisogno di una funesta ineguaglianza di fortune e della vanità di un dispota. Allora sorgono i Colossei. Ecco come certe arti sieno dipendenti non tanto dalla coltura, quanto dalle circostanze. Tutte le nazioni barbare sono sapientissime, tutte le sapientissime barbare in qualche altra cosa. L’istesso paralogismo facevano gli stoici, dicendo che le virtù tutte erano inseparabili, che chi ne possedeva una le possedeva tutte. L’uomo è un misto, così le nazioni.
III. Quando disputavasi cotanto se i corpi esistessero, perché non vi fu uno che dicesse così, a chi ne difendeva la non esistenza: il vostro avversario è egli un corpo? Se dubitate, e sostenete che i corpi non esistono, perché combattete con una chimera? Il filosofo Diodoro diceva al medico Erofilo che non v’era moto con questo argomento: se alcun corpo si move, o egli si move nel luogo dov’è o nel luogo dove non è. Non si move dov’è, perché nel tempo che ivi è, riposa, e ciò che riposa non si move. Non si move poi dove non è, perché dove non esiste non può esercitare nessuna azione. Dunque niente è in moto. Il nostro filosofo si slogò un braccio. Chiamò Erofilo perché glielo rimettesse. O il vostro osso, disseli il medico, s’è mosso nel luogo dov’era, o nel luogo dove non era. Nel luogo dov’era non poteva moversi, perché ivi era in riposo; nel luogo dove non era non poteva aver moto, com’è chiaro; dunque il vostro osso non si è né punto né poco mosso, la onde né meno dislogato. Diodoro allora disse: lasciamo i soffismi, e toglietemi questo dolore.
Il nostro famoso Pirrone avea giudizio, per quanto poco comunemente se gliene conceda. Faceva una gran distinzione fra i principii della filosofia e quelli della condotta; erano diversi quelli delle sue dispute da quelli de’ suoi affari. Diceva, come filosofo, che non v’era certezza, non affermava nulla. Ma come uomo, come cittadino, come magistrato era di parere che si dovesse stare alla probabilità, e fece bene le parti di tutte e tre queste rappresentanze. Così Pirrone si burlava di tante sette di filosofia, le vessava co’ soffismi e le derideva nel suo cuore. La distinzione fra certezza e probabilità mi sembra necessaria. Altro è ragionare, altro è operare. La più gran precisione e cautela è ottima nel primo caso; nel secondo sarebbe ridicolo ed infelice chi non si decidesse sulle probabilità.
IV. Allorquando gli uomini ammucchiarono de’ vasti sistemi di errori e di capricciose opinioni, temettero non tanto chi si aventava contro de’ principii, quanto chi si poneva a cavarne le conseguenze. Poiché hanno ciò di eguale le vere e le false cose: che le conseguenze da esse diramantisi van sempre crescendo a moltiplico. Posto adunque un assurdo per base di ragionamenti, crescono, germogliano e si generano altri assurdi ognor più mostruosi. Allora più non puote la copia degli errori e la deformità loro sostenere neppure un debol raggio di luce. Tanto più vacillano i primitivi errori, padri di una lunga serie di altri errori, quanto è più esatto il raziocinio che fa la mente umana partendo da un falso principio. Chi ha preso un falso cammino, più direttamente lo corre, più dalla vera strada si allontana. Se per avventura si faccia qualche diversione, puossi talvolta ritornare nella giusta via. Posto un errore, si avrà la massima somma de’ falsi conseguenti che racchiude col non far mai un errore dopo il primo in tutto il corso del successivo ragionare. In tal guisa viene presto distrutto l’errore fondamentale. Di un mostro ne nascono cento. Più non sorprendono anche l’uomo volgare. Sono tanti che li vede. Sussistono invendicati lungo tempo quegli errori de’ quali non si schiudono le conseguenze, o li conseguenti de’ quali sono sparsi e misti industriosamente di lampi di luce. Così chi li difende si tiene lontano il discredito che accompagna le estreme assurdità e si serve delle spoglie del vero per combatterlo. Tempra, nasconde, addolcisce, inviluppa e tortuosamente deduce gli assurdi, insinua fra di loro furtivamente le verità, contenta gli uomini ognor difficili ad intraprendere la contenziosa investigazione di una complicata serie d’idee. Come un viaggiatore il quale, camminando fra le tenebre, se vede al balenar di qualche lampo una amena spiaggia crede di esser in un delizioso paese, quantunque il rimanente sia alpestre ed arenoso.
Se la forza ha inventati gli errori o ritrova utili i veglianti, si oppone al loro corso istesso perché ben vede le rovine che seco trarrebbero giuste conseguenze di crollanti principii. Quindi le querele degli audaci, il silenzio de’ prudenti, la tirannia di chi può. Finché, dopo atroci guerre e qualche vittima, non cada il vasto ed incantato edifizio; nella qual impresa sembra che la ragione urti col potere, il ridicolo colle opinioni.
Ma per non rendere dispregievole agli occhi degli uomini così utile intrapresa, non si portino l’armi con gran tumulto e sediziosi ululati contro de’ mostri. Giovi il vincere colla industria, col tempo, colla paziente costanza d’indiretti stratagemmi. Si facciano delle mine, non delle batterie.
Chi poi guerreggia cogli errori e vincendo loro ne sostituisce degli altri, discredita la buona causa, estingue negli animi il sentimento del vero, lo fa risguardare come un industrioso giuoco della mente, sparge la diffidenza della filosofia in tutt’i cuori. I maggiori rei di questo delitto furono i Greci.
A. [Alessandro Verri]
A Demetrio
Tu ci scrivi che siamo troppo seri e che bisognerebbe esser più giocosi. Generalmente i lettori, tu soggiungi, sono persone che prendono in mano un libro perché lor è grave quella preziosissima cosa, il tempo, lo aprono, sbadigliano e gli dicono: divertimi. Pochi per lo contrario sono quegli che leggono per instruirsi. Dove massimamente si tratta di fogli periodici, i quali sono velocissimi enti che devono passare un momento per dire alla sfuggita una parola all’orecchio de’ leggitori, questa vostra gravità di materie non è conforme alla natura della cosa. Siate ragionatori di rado, giocondi sempre. Siate, scrivendo, di buona società al pubblico, non vi vestite coll’abito lugubre della pallida filosofia. Così tu scrivi, o Demetrio. Ma credi tu che i nostri lettori preferiscano ancora il ridere al ragionare, e che bisogni loro tuttavia spargere
di soave liquor gli orli del vaso
perché si bevano le utili verità? Dunque avrem noi pubblicati ben sessantanove fogli colla buona intenzione di conquistar paese alla ragione, ed essa ancor quasi vergognosa e tremante non dovrà comparire che involta nelle nubi e furtivamente profferire qualche tronca parola? Ti confessiam per altro che quando scriviamo questi nostri fogli abbiamo sempre quella salutar paura che dovrebbero avere tutti gli scrittori, d’annoiare il benigno leggitore, e paura che alcuni imperteriti autori di grossi volumi non hanno punto. Altronde la verità brillante di letizia e di giocondità sorprende l’attenzione; si comincia ad udire, poi a pensare, poi ad instruirsi, e si fa pace con quella gran nemica della ignoranza, la ragione. In tal guisa si può esser serissimo ridendo. Basta in questa guerra aver costanza che alla fine si vince, m’intendo nella guerra umanissima che fanno i pacifici seguaci del vero agli errori ed alle opinioni. Sono mostri che alle prime ferite fanno orribili strepiti, urlano, gettano fuoco, ma poi cedono, s’illanguidiscono, cadono, spirano, ed appena rimane la memoria delle loro sconfitte e del trionfo di chi gli ha abbattuti. Per altro stiamo preparando delle composizioni ridicole per chi tuttavia trovasse incomoda la serietà. Dì adunque, Demetrio, a chi le desidera che fra poco manderemo alla pubblica luce un trattato di metafisica aristotelica che sarà cotanto profondo e sublime che nessuno lo potrà intendere, e che per ciò appunto lo dovranno stimare. Vi verrà dietro una tragedia sul gusto greco e varie dissertazioni su importantissimi soggetti dell’antichità, su i vasi etrusci, sul papiro de’ Romani ed altre cose nelle quali non mancherà il suo buon greco ed il suo buon ebraico; dopo vi cacceremo con franchezza da erudito una diatriba sulla etimologia di alcune parole della nostra lingua che saranno cose da far crepare delle risa, al solito; poi gli minacciamo ancora di alcune note alle Disquisizioni magiche del padre Martino del Rio, le quali occuperanno, giusta il costume, quasi tutta la pagina, spiegheranno le cose chiare, passeranno sulle oscure, impasteranno ed imbottiranno molta erudizione, ed ancor questa sarà cosa da smascellar veramente delle risa, come si suol fare. Per fine stiamo manipolando una certa cosuccia, ma che cara cosuccia! cioè certe letterucce sul gusto del Caro, nelle quali anderemo in isvenimento con tante belle e scelte frasuccie e vocabolucci, ed i vuoti e rarefatti pensieri nuotanti in un lago di parole saranno impinguati ogni tanto tempo di sali illepidi e di lepiddezze insipide, e questo ancor per far crepare delle risa, al solito. Che se ciò non basterà agli amatori del ridicolo, dì loro, o Demetrio, che siamo poi anche capaci di regalarli di una raccolta di poesie per nozze e per dottoramenti e per monacazioni, e questo ancora per far smascellare al solito dalle risa ogni onest’uomo.
Se poi taluni bramassero qualche cosa da piagnere, per la gran scarsezza che ve n’è in questo mondo, siam pronti a servirli sia con delle commedie sul gusto delle tante nostre italiane, le quali se non fanno ridere la colpa certo non è loro, perché sono sicuramente ridicole; sia con qualche berniesco capitolo od altra tal cosa come più loro aggradirrà, perché nostra intenzione è e sarà sempre di contentarli tutti per quanto il possiam fare. Capperi, i scrittori politici devono tener da conto i loro associati!
A. [Alessandro Verri]
Intorno la malizia dell’uomo
Io vedo ed approvo il bene, ma sieguo il male. Io vedo il bene, dunque il bene sovra di me fa impressione; io l’approvo, dunque lo sento e lo conosco: e mi sarà possibile volere altrimenti e determinarmi al male? Basta dare un’occhiata sulla maggior parte degli uomini per non dubitare di questa sconsolante verità. E per qual ragione dunque sono cattivi? Tal questione ne suppone un’altra, ed è se sieno veramente cattivi.
Gli uomini, rivolte le spalle al passato, appoggiati appena sul presente, tentano continuamente slanciarsi nell’avvenire. Si vive disponendo e preparando; si muore in preparare e disporre sull’infinita successione de’ secoli venturi. Ma loro malgrado sono le impressioni presenti che determinano le azioni degli uomini. È necessaria una forte passione o una molto riscaldata fantasia perché l’azione di una non presente impressione prevalga in energia e forza sulla presente e sulla nuova, altrimenti gl’interessi presenti hanno tutta la forza e tutta l’energia possibile; i non presenti tanto più sono divergenti quanto più lontani, fintantoché su non trascorrendovi, il tempo li rendi successivamente presenti, e riunisca la loro azione in un sol punto o li dimostri vani.
Fate che il bene o il male abbia attualmente lo stesso vantaggio, non è possibile che alcuno, in tale supposizione, non scelga a preferenza il primo. Gli uomini sono adunque cattivi allorquando è loro interesse di esserlo. Bisogna guardare con occhio ben livido ed iterico tutto l’uman genere per vedere gli uomini, sortiti dal seno della natura, impervertiti e cattivi. Strappate dalle mani dell’ingiusta proprietà l’ineguale distribuzione de’ beni e soffocate quel vano e fattizio sentimento della propria relativa debolezza che chiamasi amor proprio, e allora vedrete se è giammai interesse per gli uomini essere cattivi; allora vedrete perché i selvaggi trucidino alcuna volta con lenta e tormentosa morte i loro nemici; allora vedrete perché, in mezzo alle nazioni che diconsi le più colte e incivilite, non sapete se sotto quel volto ridente e in mezzo a quelle espressioni e maniere le più amichevoli non si celi un nemico, se tra quelle lodi non si nascondi un detrattore, se tra quelle proteste, tra que’ giuramenti non si trova una menzogna, una nera calunnia; vedrete in somma tutta la serie de’ mali morali.
Relativamente alle azioni loro morali, io distinguo gli uomini in tre classi. I pochissimi buoni formano l’una; l’altra più numerosa quelli che diconsi cattivi e che non sanno di esserlo; e quelli che lo sono per sistema compongono l’ultima. La maggior parte de’ buoni lo sono o per debolezza o per temperamento, alcuni pochissimi per sentimento e per elezione. I cattivi che non sanno di esserlo sono tali o per ignoranza o per forza di passioni o per inerzia. I cattivi per sistema lo sono o per esperienza o per intimo conoscimento del cuore umano. La maggior parte degli uomini, e che ho annoverati nella seconda classe, sono li più pericolosi perché sono cattivi e non sanno di esserlo; quelli che ho indicati in terzo luogo lo sono meno, perché essendo cattivi per principii, allorché non vi hanno interesse di esserlo bisogna necessariamente che sieno buoni.
Che ne siegue da ciò? Dovrannosi forse come le tigri, gli orsi e le serpi fuggire gli uomini, o nascondersi ne’ deserti e nelle grotte per evitare il loro commercio? Dovrassi con cinica mordacità ed amaro motteggio insultare, maledire e beffeggiare l’uman genere? No. Tali sono state le false conseguenze, o dirò piuttosto l’impostura di chi ha profanato e prostituito il rispettabil nome di filosofo. Tali sono oggi giorno le grida di chi non ha saputo o non ha riuscito o non può più essere abbastanza cattivo, o di chi finalmente sentendo di esser tale teme di comparirlo.
A chi vorrà oppormi esser io così ragionando il difensore della malizia degli uomini, risponderò: che naturalmente gli uomini sono buoni, che se sono altrimenti alcuna volta lo sono o per educazione o per esempio, e finalmente che lo diventano a proporzione che i bisogni loro fattizi aumentano e superano in numero li pochi e semplici primitivi della natura.
Egli è necessario che gli uomini passino per la trafila di gran porzione de’ beni e de’ mali morali, perché restino convinti per sentimento che li maggiori vantaggi stanno dalla parte della bontà e li più forti svantaggi dalla parte della malizia. Dunque acciocché in tutta la massa degli uomini non si trovi più malizia, bisognerà che tutto l’uman genere abbia provato tutte le combinazioni possibili de’ mali e de’ beni morali; ma temo che tutti gli uomini insieme, in quasi cinque cento settanta sette secoli, che da generazione in generazione si succedono su questo pianeta, non ne abbiano ancora passato che le prime combinazioni. Qual prodigiosa successione di secoli sarà conseguentemente necessaria perché tutto l’uman genere abbia esaurite tutte le combinazioni possibili de’ mali e de’ beni morali? Felici que’ viventi che vedranno la fortunata epoca della fine di questo periodo grandissimo! Queste verità sono poco consolanti per l’uman genere; ciò non ostante un’anima sensibile non può evitare di sentire una patetica e dolce compassione nel vedere che colui che tenta fare agli uomini del male, trasportato da un altro vortice di circostanze sarebbe benefico e gli amerebbe come amici, come fratelli, come altr’uomini a lui simili. E quale sarà poi il giubilo e l’entusiasmo generoso di un cuore pieno d’amore per l’umanità nel trasportarsi coll’immaginazione in un tempo futuro, nel quale tutti gli uomini non saranno che fratelli, li di cui interessi propri diveranno quegli stessi di tutti gli altri?
È un error fatale il credere che li buoni sono il ludibrio de’ cattivi; analizate il cuore umano, e troverete che non già i veramente buoni, ma coloro che non hanno il coraggio di essere virtuosi e quelli che non hanno bastante industria per essere veramente accorti, quegli essere l’istromento e ’l giuoco de’ cattivi. La virtù ha un’ampia sfera di attività intorno di sé, e la bontà vera è un potente talismano contro i malvaggi. Siate voi buoni, e scemerassi intorno di voi il numero de’ cattivi. Allora gli uomini avranno meno interesse a nuocervi. Cessate di gridare ch’essi sono malvaggi; studiate invece di non esserlo.
G. [Giuseppe Visconti]
IL CAFFÈ )( Fogl. XXXIV )(
Sull’innesto del vaiuolo
La questione sull’innesto del vaiuolo non è già del genere di quelle che interessano appena la curiosità degli uomini di lettere, nelle quali entra il saggio rare volte colla speranza di scoprire la natura delle cose disputate, e bene spesso altro non vi ritrova che nuovi argomenti per confermarsi in un cauto sistema di dubitazione. La questione dell’innesto è tale, che vuole l’interesse della intera umanità che venga quanto più si può rischiarata e che con ogni imparzialità e candore resti pacificamente decisa. Se l’innesto è pernicioso alla specie nostra, come taluni asseriscono, conviene screditarlo e proscriverlo il più presto che si può; se l’innesto è quale da alcuni ci vien proposto, di somma utilità a tutta la generazione de’ nostri simili, conviene promoverlo e farlo conoscere colla maggiore sollecitudine. Sarà dunque una virtuosa occupazione e degna d’un buon cittadino quella di concorrere allo schiarimento di questa disputa, né io altro oggetto mi propongo od altra gloria scrivendone che quella che mi darà l’intimo sentimento d’aver contribuito per quanto m’era possibile a calmare quell’incertezza e quelle oscillazioni che dividono su un oggetto sì importante la opinione degli uomini. Dopo tanti uomini illustri e benemeriti che hanno posta in piena luce la questione dell’innesto, a me non resta da sperare altra gloria; né io in queste mie considerazioni altro mi propongo se non di presentare i fatti e le osservazioni che ho raccolte nella lettura di que’ grand’uomini e di guidare chi vorrà leggerle per quella strada medesima per cui è passata la mia mente a veder chiaro in questa materia.
Lo spirito di partito è sempre una macchia anche nelle più indifferenti controversie; la verità è sempre più bella e più augusta di qualunque vittoria riportata con capziosi e soffistici ragionamenti. Nelle materie poi dove lo spirito di partito può cagionar la perdita della vita a qualche incauto, converrebbe essere un vero mostro della specie umana per averlo; sarebbe questo uno de’ più enormi abusi della ragione e della scrittura se s’impiegasse ad innalzare una opinione su i cadaveri delle innocenti vittime umane sacrificatevi. Spero che i lettori troveranno in me quelle disposizioni di cuore capaci di preservarmi da un sì obbrobrioso sospetto, e che se le mie ragioni non persuaderanno taluno, vedrassi almen chiaramente la ingenuità e l’indifferenza colla quale ho cercato di ritrovar le vere. Potrebbe presso alcuni scemar la forza delle ragioni che io andrò ricercando il riflettere come io abbia preso a trattare una materia dipendente dalla medicina senza essere io medico; ma si rifletta primieramente che il soggetto ch’io tratto è piuttosto una questione storica e di fatto anzi che di medicina; secondariamente poi si esaminino le ragioni che sono per addurre, e quando esse si trovino concludenti, sarà conveniente il dire ch’io non medico ragioni non male d’una materia medica.
L’economia della macchina del corpo nostro è sì poco conosciuta dagli uomini e sono talmente profonde e riposte le cagioni e del moto e del disordine di essa, che dopo le più costanti osservazioni, dopo le più industriose ricerche, i più illuminati scrittori delle cose mediche si trovano giunti a quella dotta e filosofica ignoranza che avvicina gli uomini grandi al volgo assai più che non ai mediocri professori. Un’attenta osservazione sulla condotta dei più rischiarati medici dell’Europa ci convince di questa verità, che la miglior teoria medica si è quella che venga appoggiata su fatti costanti, e che ragionare un poco in medicina sia bene, purché sia un poco, giacché la libidine del ragionare e fabbricar capricciosi sistemi su principii che sfuggono i sensi e l’osservazione egli è un voler avventurarsi all’errore, anziché accostarsi alla cognizione intima delle strade che tiene la invisibile natura. Sono quasi sempre ignote agli uomini le vere cagioni de’ morbi, sconosciuto è il meccanismo con cui operano i rimedi. Non v’è chi sappia veramente qual sia la cagion della febbre intermittente, non v’è chi conosca per quai principii venga scomposta la nostra macchina per quel veleno contagioso che dicesi venuto all’Europa dal Nuovo Mondo; oscurissima è pure l’indole della corteccia che chiamiamo china china; ignotissima parimenti l’azione di quell’unico metallo fluvido che chiamiamo mercurio per una immaginaria corrispondenza con un pianeta: ma noto è per una costante sequela di fatti come la china china risani dalla febbre intermittente e il mercurio da quel veleno che tende a spopolar la terra. Gli Afforismi d’Ippocrate, che sono forse il più utile monumento tramandato a noi dalla più remota antichità, altro non sono che alcune regole pratiche dedotte da una lunga serie di osservazioni e di fatti. Il canone dunque più classico che vantar possa la buona medicina è quello che si deduce da una lunga serie di sperienze, per cui dal passato prendesi norma per l’avvenire; e il filosofo medico sopporta in pace l’ignoranza delle vere elementari cagioni delle malattie e de’ rimedi; ignoranza inerente alla umana natura circoscritta dal potere de’ sensi, da’ quali tosto che ci dipartiamo restiamo assorti nel fallace chimerico regno della immaginazione a scapito dell’arte istessa.[124]
Ciò posto, io non perderò il mio tempo nell’indagare quello che nessun medico saprà mai, la natura primordiale in somma di quel veleno vaiuoloso, il quale per contagione si comunica, e difondendosi per quanto pare per tutte le interne ed esterne parti del corpo umano, lo corrompe e lo diforma con una quasi pestilenziale malattia, che miete buona parte dell’uman genere ed altra ne diforma e sfigura spietatamente. Di sì fatte nozioni non si credono in possesso se non coloro i quali si contentano di alcune definizioni più conformi alla poesia che non alla fisica, né rendonsi un esatto conto a loro medesimi delle proprie idee. La vera natura del vaiuolo m’è ignota; non intendo come la maggior parte degli uomini lo soffrano una volta nel corso della lor vita; non intendo come sofferto ch’egli si abbia più non ritorni, e so che i medici, maestri e guida degli altri, sono nella stessa ignoranza in cui son io. Lasciam dunque da parte tutt’i chimerici sistemi sulle cagioni e sulla natura del vaiuolo; e atteniamoci ai fatti, ne’ quali se troveremo autorità, numero e costanza, avremo un filo per uscire dal labirinto dell’incertezza, in cui ci lascerebbe per sempre l’oscurità invincibile in cui siamo condannati di vivere per rapporto alle cagioni.[125]
Della malattia del vaiuolo non se ne trova menzione presso i medici antichi, né presso alcuno scrittore antico. Pare improbabile dunque che tal malattia fosse anticamente conosciuta in Europa, poiché né i medici ci avrebbero lasciate memorie di tant’altri malori meno importanti trascurandone uno sì feroce, né gli storici avrebbero potuto lasciarci le memorie di tanti fatti senza frapporvi la morte di qualche principe o grand’uomo perito per questa malattia, né i poeti, che tanto s’occupavano a descrivere le bellezze che gli accendevano, avrebbero forse dimenticato di accennare quella terribile malattia, che tant’oltraggio può fare ai tratti del volto più gentili. Per quanto potiamo raccogliere dalla storia, il vaiuolo dal fondo dell’Etiopia si comunicò nell’Arabia circa l’anno 571, e nelle spedizioni che gli Europei nostri antenati fecero in Palestina, contrassero questa fatal pestilenza, e nel ritorno la trapiantarono in Europa verso l’anno 1090.[126] Non molta fu la strage che menò al bel principio sì fatta pestilenza che chiamiamo vaiuolo: circa tre secoli e mezzo andò serpeggiando in diverse parti bensì, ma non si manifestò coi crudeli e violenti effetti che circa l’anno 1572,[127] e da quel tempo a questa parte va scorrendo le varie parti d’Europa, per modo che si calcola per adequato che da una epidemia all’altra di vaiuolo non corra che l’intervallo di cinque anni.[128]
Antico assai debb’essere il vaiuolo nel vasto Impero della China, per quanto ne vediamo dalle migliori relazioni, e antico pure l’uso di comunicarlo per innesto.[129] Contuttociò sembra che in Europa il metodo d’innestare sia venuto dai Circassi, presso i quali la bellezza delle fanciulle facendo il principal ramo del commercio, da quell’interesse, che è sempre la parte più filosofica dell’uomo, fu o scoperta o dai Chinesi anticamente ricevuta l’usanza di prevenire il vaiuolo naturale, fatale alla vita e alla bellezza, coll’innesto che la sperienza presso loro ha fatto ritrovare sì utile:[130] perciò l’innesto o sia l’inoculazione viene chiamato dal chiarissimo Haller modus circassicus. Chi mai avrebbe potuto pronosticare che da quelle barbare e inospite contrade riposte fra l’Eusino e il Caspio, d’onde gli Argonauti carpirono il misterioso vello d’oro al re Frisso, dovesse venire nella colta Europa una interessantissima scoperta che somministrasse materia, a tanti uomini chiari in medicina e benemeriti per le lettere, di ragionare! Eppure così avvenne, poiché da una donna circassa appunto l’innesto fu portato in Costantinopoli nello scorso secolo, circa l’anno 1670,[131] dove da principio l’uso se ne dilatò bensì presso i cristiani greci o armeni, ma presso i maomettani non già; per la pregiudicata opinione de’ loro dottori sul punto di una rigida fatalità reggitrice dell’universo, alla quale credevano empietà il cercar di sottrarvisi.[132] Col tempo poi anche i pregiudizi maomettani si tacquero.[133] Da Costantinopoli qualche notizia ne trapellò in Europa prima del 1713, e se ne trovano le vestigia negli Atti di Lipsia, nelle Transazioni filosofiche inglesi e nell’appendice del Viaggio del signor de la Montraye; finalmente nell’anno 1713 due medici greci pubblicarono all’Europa l’innesto che avevan veduto praticato generalmente a Costantinopoli, e furono il signor Giacomo Pilarini[134] ed il signor Emanuello Timoni.[135]
Poco o nessun effetto produssero i libri di que’ due medici. Le scoperte anche più grandi non si difondono giammai nel popolo se non col favore del tempo e degli urti ripetuti a molte riprese: qualche discorso cominciossene soltanto a fare tra i medici e alcuni curiosi; e un solo sperimento d’innesto si fece a Parigi dal celebre medico Eller.[136] Frattanto nel 1718 il signor Wortlay, marito della illustre Milady Montagute, ambasciatore per l’Inghilterra presso la Porta Ottomana, convinto dalle giornaliere sperienze che aveva sott’occhio, fece innestare dal signor Maitland, chirurgo celebre, l’unico suo figlio a Costantinopoli con ottimo successo. Ritornati poscia nella Gran-Brettagna, e il signor Wortlay e Milady ed il signor Maitland cominciarono in Londra a promulgare i vantaggi dell’innesto, e diedero il primo esempio col sottoporre all’innesto una lor figlia d’anni cinque,[137] il qual testimonio dell’intima persuasione loro, accompagnato da un felice avvenimento, accrebbe il numero de’ curiosi, acciocché con una più vasta serie di sperimenti si verificasse se quello che sì bene riusciva nell’Asia e in Costantinopoli potesse essere d’egual beneficio alla specie umana anche ne’ climi nostri. Il Collegio medico di Londra fece a tal fine le sue istanze, e il governo d’Inghilterra concesse sette condannati a morte per servire di prova. Ciò fu nel 1721. Fra questi condannati v’era una fanciulla di 18 anni, sulla quale il signor Mead, celebre medico, il quale si meritò la gloria di vedere confidata la vita del grande Isacco Newton al suo sapere, volle sperimentare l’innesto alla chinese. Il metodo chinese in ciò diferisce dal circasso, che i Chinesi non fanno veruna incisione per comunicare il vaiuolo artificiale, ma soltanto ne inzuppano un turacciolo di bambaggia nella materia vaiuolosa e lo intrudono per le nari; laddove i Circassi fanno alcune superficiali incisioni nelle braccia e nelle coscie, dove la stessa materia insinuano.[138] De’ sette condannati, uno ebbe anticipatamente il vaiuolo naturale in prigione, e i sei che rimanevano contrassero il vaiuolo per innesto e risanarono, ma la fanciulla del signor Mead ne ebbe de’ sintomi assai più gravi, massimamente al capo.[139] Da ciò ne nacque che alcuno, ch’io sappia, non ha più tentato dappoi il metodo de’ Chinesi; ma l’innesto colle incisioni per questi sei nuovi esempi prese qualche credito e voga. Comparvero l’anno seguente due opere, oltre le accennate de’ due medici greci Pilarini e Timoni, e furono del signor Maitland, che aveva fatti già privatamente molti innesti in Londra dopo l’esperimento de’ condannati,[140] e del signor le Duc.[141] Infiniti sperimenti si andavano proseguendo nell’Inghilterra, i quali confermavano sempre più i fautori del nuovo metodo d’innestare il vaiuolo e dilatavano il numero de’ partigiani di esso. Ma come dove più, dove meno in ogni nazione però trovasi una certa persuasione della eccellenza della usanze ricevute per tradizione, la quale è una forza, dirò così, d’inerzia politica che ricusa di ricevere una novità perciò solo che è nuova; così un partito pure vi fu in Inghilterra di oppositori alla inoculazione, i quali fecero ogni sforzo per atterrarla. In una sì grave materia il ribrezzo volgare era in molta parte, convien pur dire, ragionevole.
Trattavasi di persuadere alle tenere madri, ai padri amorosi, di consegnare i figli volontariamente in preda ad un malore naturalmente mortale, colla speranza soltanto di vederli risanati e senza sicurezza che con ciò fossero preservati; di far subire una malattia naturalmente mortale, la quale forse non avrebbe il fanciullo avuta mai in sua vita. Trattavasi perfine di offendere i precetti della religione, la quale non lascia in arbitrio nostro l’esporci a volontari pericoli della vita. Queste ragioni esamineremo separatamente in seguito; ma riprendiamo in breve il proseguimento della storia dell’innesto.
Crebbe nell’Inghilterra sì fattamente il numero degl’innestati da ogni parte, tutti ristabiliti senza correre verun pericolo della vita, e tanto celeri furono i progressi di questo nuovo metodo che nel 1723 la principessa Carolina di Galles, che fu poi regina, sottomise all’innesto l’augusta sua famiglia,[142] e lo stesso signor Maitland ne fece l’operazione. Questa classica approvazione data all’innesto in Inghilterra riscosse alcuni nella Francia a pensarvi; a ciò contribuì pure la lettera stampata del signor la Coste diretta al signor Dodard, medico del Re Cristianissimo nel 1723: in essa facevasi teoreticamente conoscere il metodo dell’innesto. Dicesi che il Duca Reggente fosse disposto a ordinarne delle sperienze, ma la morte lo prevenne, e il consenso de’ medici francesi allora s’oppose a tal novità, e fu chiamata da molti nefanda.[143] Per venti anni ancora seguitossi, nell’Inghilterra principalmente, a disputare e praticare l’innesto del vaiuolo, mentre i migliori medici d’Europa e nell’Ollanda e nella Germania, colpiti dalla costanza de’ felici eventi che ogni giorno più venivano annunziati dall’Inghilterra, ne andavano comendando l’introduzione;[144] ma tale avantaggio avevano gl’Inglesi sul restante dell’Europa che nell’isola la disputa era già nelle mani del popolo, e corredata da continue ripetute sperienze; laddove nel nostro continente appena era trattata da alcuni pensatori, i quali o non osavano o non potevano ridurla al fatto. Quindi prima che fosse generalmente sperimentato l’innesto nel restante dell’Europa, nel 1746 si fondò in Londra uno spedale particolarmente per questa operazione a pubblico comodo,[145] e tanto importante si credette quest’erezione per il ben pubblico, che il re medesimo vi si pose alla testa come protettore, e la carica di presidente di esso volle illustrarla il duca di Marlborough assistito dai conti di Litchfield e di Northumberland.[146] L’esempio della real famiglia e lo spedale fondato provano abbastanza quanto fosse nell’Inghilterra ormai costantemente decisa l’opinione favorevole all’innesto del vaiuolo; da quel punto cessò ogni opposizione nell’isola; i tre principi reali, Enrico, Federico e Gulielmo, si innestarono nel 1754,[147] e l’anno seguente per unanime consentimento di tutta la Società medica di Londra venne dichiarata l’inoculazione importante ed esenziale al genere umano.[148] Nulla di più ci somministra la storia inglese per ciò che spetta al vaiuolo, se non che i due vescovi inglesi di Worchester e di Norwich[149] e il signor Some[150] persuasero alle coscienze timorate lecito l’innesto, e la folla de’ casi giornalieri tutti felici lo persuase importante ed essenziale a tutta la nazione, quale appunto l’avea definito uno de’ più onorandi consessi di medicina che sia in Europa. Così restò stabilito l’uso universale nell’isola d’innestare il vaiuolo, né d’allora sino al dì d’oggi un solo scritto è comparso dall’Inghilterra in cui si faccia opposizione a questo universale metodo, il quale da dodici anni a questa parte è naturalizzato perfettamente in quel regno.[151]
Il celebre signor Tronchin, che due anni sono ebbe l’onore d’innestare il Principe di Parma, ora Infante Duca, fu de’ primi che osasse tentare questa operazione di qua dal mare, e ne diede il felice esempio in Amsterdam sopra un suo figlio sino dall’anno 1748, mentre ivi aveva la carica d’inspettore del Collegio de’ medici.[152] Poco a poco si dilatò la curiosità di esperimentare e nell’Ollanda e negli Svizzeri, e particolarmente in Genevra, dove circa il 1751 s’introdusse l’innesto, e sempre più andò accrescendo il numero de’ suoi partigiani[153] e si dilatò l’usanza nelle Fiandre, nel Brandemburghese e nella Norvegia e in tutto il Nord, per tal modo che nella Svezia e nella Danimarca vi si sono sull’esempio di Londra eretti
IL CAFFÈ )( Fogl. XXXV )(
spedali per l’innesto nel 1754;[154] e tale è il credito e la sicurezza con cui ivi l’operazione si pratica, che la figlia del barone di Bernstorff, secretario di Stato del re di Danimarca, ricchissima erede, vi si sottopose, e perfino il principe reale stesso di Danimarca, ora re.[155] In Gottemburg s’è pure eretto uno spedale a tal fine, e celebre è la medaglia coniata a Stockolm in onore dell’innesto, dove vedesi da una parte l’ara d’Esculapio con un serpe in aspetto d’offendere, col quale si figura il vaiuolo, e la leggenda Sublato iure nocendi, avendo nel rovescio l’altra Oh infantes civium felici ausu servatos![156]
La parte meridionale d’Europa fu più tarda ad esaminare questa interessante scoperta, e forse avrebbe differito degli anni ancora, se il signore de la Condamine, che aveva già tanto ben meritato e della navigazione e delle scienze colla immortale sua spedizione alla linea equinoziale, ritornato dal suo filosofico pellegrinaggio d’America non si fosse indotto a leggere nell’adunanza della Reale Accademia delle Scienze di Parigi la sua prima Memoria,[157] il che avvenne nell’anno 1754. Cagionò negli animi de’ Francesi un fermento non piccolo quella memoria, né la chiarezza, il metodo o l’evidenza de’ fatti poterono impedire che un nembo d’oppositori non insorgesse contro questa nuova dottrina tosto che fu pubblicata. Fece il signor de la Condamine il viaggio d’Italia, e andò invitando dappertutto a fare sperimenti sull’innesto. I Toscani furono i più docili ad ascoltarlo, quindi vediamo che ivi nel 1755 più di ducento innesti s’erano già fatti con prospero evento.[158] Questi felici tentativi mossero il governo della Toscana a ordinarne la sperienza pubblica in Firenze, ed ivi si fece sopra sei fanciulli nel Regio Spedale di Santa Maria degl’Innocenti nel 1756.[159] In que’ contorni, cioè in Montecchi, Città di Castello e Citerna, s’andò dilatando la nuova maniera di prevenire il vaiuolo naturale.[160] Due anni dopo il signor dottore Francesco Berzi introdusse l’inoculazione a Padova,[161] e sempre più andossi propagando il nuovo metodo per l’Italia coll’opera de’ signori medici Guarnieri, Battini, Tani, Fantini, Pierotti, Turacchi, Cei, e pe’ scritti de’ signori Peverini, Lunadei, Targioni, Pauli, Caluri, Berzi, Pizorno, Gandini, Manetti e Centenari. In Milano il signor dottor Tadini diede il primo esempio nel 1761, sopra i suoi figli; sinora due soli innesti si sono fatti dappoi. Il benemerito signor dottor Bicetti de’ Buttinoni lo ha felicemente introdotto in Treviglio, ed ha stampate le storie de’ suoi innestati: la felicità di questi primi tentativi sinora non ha fatto riforma nella generale opinione, la quale né si oppone, né si cangia.
In nessuna parte d’Europa trovò l’innesto tante opposizioni quante gliene furono fatte nella Francia. Abbiamo dissopra accennato come al tempo della Reggenza qualche discorso vi si facesse per l’innesto, ma la morte del Duca Reggente e la contraddizione de’ medici francesi fecero perdere ogni pensiero di provarne gli effetti. Appena nel 1756 alcuni pochi sperimenti si cominciarono a fare nella Francia sotto la direzione del signor Geoffroi;[162] qualch’altra sperienza se ne fece dappoi in Lione,[163] e di ciò trovansi le notizie nelle Memorie dell’Accademia Reale delle Scienze.[164] Verso quel tempo il duca d’Orleans, figlio del Reggente, persuaso dei vantaggi dell’innesto, volle sottoporvi i due suoi figli, il duca di Chartres e madamigella di Montpensier, chiamò a tal fine il signor Tronchin e terminò felicemente l’operazione in Parigi. A quest’esempio s’aggiunse quello del conte di Gisors, figlio del maresciallo di Bellisle, per innestare il quale venne da Londra il chiarissimo signor Kirkpatrick.[165] L’autorità di queste illustri prove eccitò la curiosità de’ Francesi da una parte a non trascurare que’ vantaggi che già godeva la maggior parte dell’Europa, ed animò dall’altro lo zelo e l’impegno d’alcuni teologi e di molti medici a farvi quelle stesse opposizioni che più di trent’anni prima v’erano state fatte nell’Inghilterra. Più si dilatava in Parigi l’uso d’innestare e cresceva il numero delle sperienze che provavano l’utilità dell’innesto, e più sembrava accendersi il partito contrario. Due principesse della casa di Lorena, figlie della contessa di Briosne, furono innestate felicemente dal signor dottor Gatti, nostro italiano e professore di medicina nell’Università di Pisa; la figlia del duca d’Aiguillon fu parimenti sottoposta all’innesto, e tutte senza il menomo pericolo con leggerissima febbre ebbero il vaiuolo artificiale. Quattrocento persone furono innestate a Parigi, ebbero tutte il vaiuolo di ottima qualità, senza verun pericolo risanarono, senza veruna cicatrice e deformità rimasta sul volto, o come dicono i Toscani, senza butteri di sorta alcuna, trattine una donzella, la quale ne morì, incautamente esposta all’innesto mentre da sei mesi era priva de’ suoi corsi.[166] Pochi sono i medici che abbiano scritto contro l’innesto e reso il pubblico giudice delle loro ragioni, moltissimi cercarono di screditarlo con domestici e clandestini ragionamenti; nella Francia io non so che altri sianvisi co’ loro scritti opposti al nuovo metodo, trattine quattro, cioè: il signor Rast, medico di Lione, il signor Dorigny, il signor Beer e il signor Hoc. Stamparono nella Francia in favore dell’innesto i signori Boyer, la Coste, Noguez, Gelée, Macquart, Hosty, Morisot, Lavirotte, Vandermonde, e Montucla, la Condamine, Camus, Joachim, De Beaux, Roux, David, Vernage, Robert, Bordeaux, Razoux e altri. Nel 1760 crebbe lo spirito della disputa in Parigi, e il benemerito signor de la Condamine si trovò sempre alla testa dei difensori dell’innesto.[167] Finalmente nel 1762 venne l’epidemia del vaiuolo in Parigi, e gli avversari dell’inoculazione la incolparono di aver cagionato una maggior mortalità col trasportare la contagione anco in que’ quartieri della città dove naturalmente forse non avrebbe penetrata.[168] Sotto quest’aspetto non potendo più far comparire l’innesto pernicioso a chi lo riceve, riuscirono gli oppositori a farlo passare per dannoso al vicinato di chi vi si sottopose, e con questa vista della salute pubblica sparsero il timore nel popolo e giunsero a muovere il Parlamento di Parigi a pubblicare un decreto, nel giugno del 1763, che sospendeva i progressi del vaiuolo artificiale sin tanto che la Facoltà medica di Parigi adunata non decidesse su gli avantaggi e i danni di questo nuovo metodo e sulle precauzioni da usarsi caso che debbasi adottare.[169] Finalmente l’anno scorso a madama di Boufflers, stata in prima innestata a Parigi, comparve il vaiuolo naturale. Gran trionfo fu questo per gli antinoculisti, i quali non tardarono a pubblicare questo fatto in prova che il vaiuolo innestato non preserva dal naturale. Il signor Gatti, che aveva fatto l’innesto, con ingenuità degna d’un filosofo rischiarò questo fatto, e si conobbe che il vaiuolo le era bensì stato innestato, ma senza effetto, non essendo comparsa che una sola bolla, senza veruna inquietudine della innestata, la quale bolla per errore del signor Gatti fu creduta una espulsione vaiuolosa. Si vide dunque non già che il vaiuolo innestato ritorni, ma bensì che qualora l’innesto non prende, si può avere il vaiuolo naturale in seguito, il che nessuno ha mai negato.
Tale è l’attuale situazione adunque dell’Europa sul proposito dell’innesto del vaiuolo, che nell’Inghilterra, nella Svezia, nella Danimarca, nella Norvegia, in Ginevra e nella Toscana è adottato con pubblica autorità, né v’è veruna opposizione; nella Germania e nel restante dell’Italia non trova né forti ostacoli, né forte premura generalmente per promoverlo; nella Francia soffre le più forti opposizioni, e nella Spagna e nel Portogallo è forse generalmente ancora sconosciuto. Nessun medico di grido in Europa ha preso a combattere l’innesto, trattone il signor Haen, il quale anche con una opera ultimamente pubblicata vi si oppone. In Italia due soli medici, ch’io sappia, vi si sono opposti co’ loro scritti: uno si è il signor conte Roncalli con una lettera stampata nel 1759,[170] l’altro il signor dottor Giovanni Bianchi da Rimino, in una sua lettera al signor conte Roncalli, 1759,[171] i quali hanno dalla parte opposta i medici sostenitori dell’innesto Targioni, Peverini, Lunadei, Pauli, Berzi, Pizorno, Gandini, Centenari, Manetti, Guarnieri, Battini, Tani, Fantini, Pierotti, Turacchi, Cei, Gatti ed altri; per tal modo che se la causa dovesse essere decisa colla pluralità de’ medici capaci di scrivere in medicina, l’innesto verrebbe stabilito e da tutta l’Europa e dalla sola Italia.
Ma, per formarci una più chiara idea dello stato della questione conviene primieramente farci carico delle obbiezioni che vengon fatte all’innesto. Io le riferirò imparzialmente, e con eguale indifferenza cercherò di pesarne il valore una ad una separatamente: nulla vi sarà del mio, né altro merito può darmisi che quello d’aver messo in ordine quanto ho raccolto dall’attenta lettura di alcuni autori che ne trattano.[172]
La prima obbiezione è se sia lecita avanti Dio l’inoculazione. A me non spetta l’entrare ne’ sacri penetrali teologici per fondarvi una opinione; ma soltanto di stare al liminare del santuario, e dire che poiché ne’ Stati d’Italia non è proscritta, poiché nel dominio stesso del romano Pontefice si pratica, poiché sino dal 1758 senza ostacolo il signor dottor Guarnieri ha usato l’innesto in Roma, poiché finalmente uno de’ più rinomati teologi, il padre maestro Lorenzo Berti, agostiniano professore nell’Università di Pisa e teologo delle Maestà Imperiali e Apostoliche, ha in un consulto dichiarato lecita la pratica dell’innesto,[173] v’è ogni ragione per non dubitarne e interpretare il consenso della Chiesa favorevole all’innesto.
Dicono in secondo luogo gli oppositori all’innesto che la malattia del vaiuolo naturale non sia mortale che ben di rado di sua natura, onde sia meglio aspettarla che accellerarne l’attacco coll’innesto. Questa è una della più forti ragioni che adduce il signor Haen. Pare strano veramente come un medico del credito e della dottrina del signor Haen asserisca una proposizione a cui contrasta la giornaliera sperienza del popolo istesso e l’autorità de’ più rinomati scrittori di medicina antichi e moderni.[174] Nella raccolta medica del signor Haller vien chiamato il vaiuolo una malattia, la quale gli uomini di qualunque età per un fatal destino sorprende, e uccide la decima parte dell’uman genere.[175] Le più esatte osservazioni sul vaiuolo naturale c’insegnano che nell’Inghilterra, dove quella malattia non è tanto pericolosa quanto in alcune altre regioni, ne moiono di vaiuolo il 12, il 16, e talvolta il 20 per cento.[176] Nell’America, dove più feroce è la malattia del vaiuolo naturale, ne moiono 20, 30 e persino talvolta 40 per cento.[177] Nella Nuova Inghilterra ne moiono circa 14 ogni cento.[178] In altre contrade d’America ne soccombe il 15 per ogni cento.[179] Facendo poi un adequato generale di tutte le osservazioni fatte in diverse parti del mondo, troviamo che la mortalità per il vaiuolo naturale è di 10 per cento circa,[180] il che risulta e dalle esatte ricerche fatte dal signor Jurin[181] e da quelle del signor Schultz, medico svedese,[182] e dalle liste pubblicate da diciassett’anni a questa parte dagli spedali di Londra, e dalle osservazioni fatte in Genevra sotto la direzione de’ magistrati.[183] La malattia del vaiuolo dunque realmente uccide la decima parte del genere umano. Il signor Haen crede che ciò avenga per colpa de’ medici: io non oserò deciderlo, se ciò sia; dico bensì che sin tanto che l’Europa non fia popolata di medici che non lascino perire la decima parte de’ malati del vaiuolo come ora accade, il vaiuolo sarà un malore mortale. L’arciduchessa Isabella, perita di vaiuolo nella corte imperiale di Vienna sotto gli occhi forse del signor Haen, e assistita da uno de’ più celebri medici d’Europa, il signor barone Wan Svieten, è un forte argomento contro il signor Haen. Da cinquant’anni a questa parte l’imperator Giuseppe, il Delfino, il principe d’Este, l’arciduchessa Isabella, ai quali certamente non potevano mancare tutt’i più zelanti soccorsi della medicina più rischiarata, sono miseramente caduti vittime del vaiuolo; né alcun privato oserà promettersi migliore assistenza o maggiore celebrità di medico. Concludiam dunque che il vaiuolo è veramente per sé una malattia mortale, e che qualora ci colga questa contagione naturalmente, rischiamo d’essere almeno quell’uno fra i dieci che deve morire.
In terzo luogo si oppone così. Molti passano la loro vita senza aver mai il vaiuolo, dunque l’innesto ci darebbe una malattia certa per liberarci da una malattia incerta a venire. A ciò parmi che si risponda assai concludentemente. Se crediamo all’autorità di tutt’i più accreditati medici che hanno scritto, pochissimi sono gli uomini, che avendo un corso naturale di vita, vadino esenti del vaiuolo. Isaac crede il vaiuolo generale a tutti gli uomini. Rhases positivamente afferma che alcuno non ne va esente, così asseriscono pure Averroe ed Avicenna. Fracastoro crede che ogni uomo l’abbia una volta, altrettanto dice Mercurial. Avenzoar risguarda come un miracolo della medicina se alcuno ne va esente. Foresto dice che a ragione gli Arabi ed altri grandi medici hanno stabilito che il vaiuolo fosse un tributo universale all’uman genere. Dedoneo lo crede un malore inevitabile, così Sennert, così Primeroso. Borelli afferma che è una rara eccezione della regola universale colui che non ha sofferto il vaiuolo in un corso ordinario di vita; lo stesso assicurano Ranchin, Diemerbroek e Sebisius. Appena uno in mille lo sfugge, al parere di Riviere; lo stesso attesta presso poco Tulp. Sorbait crede il vaiuolo una ereditaria contagione, e perciò generalmente imprescindibile; universale la crede Low. Riedlin è più liberale di speranza, e accorda che ogni cento, due ne vadano esenti; Juncker non accorda esenzione a veruno. Il signor Hahn, dopo cinquant’anni di pratica, ci avverte che in mille, uno o due al più lo sfuggono; il signor Scardona crede uno ogni mille sia privilegiato; il signor Ludwig dubita se alcuno ne possa essere esente. La maggiore consolazione di tutte trovasi nella raccolta del signor Haller, dove così: Sebbene il vaiuolo non la perdoni a nessuno, l’osservazione però c’insegna che tre o quattro uomini fra cento ne vanno immuni per tutta la vita.[184] Aggiungasi al testimonio de’ citati medici quello degli occhi nostri, i quali ci attestano che poche e facilmente numerevoli sono le persone a noi note le quali sieno morte senza aver avuto il vaiuolo, e concludiamo facilmente che la probabilità di scansarlo è piccola, e forse non giunge al quattro per cento. Dunque non è vero che molti passino la loro vita senza pagar tributo a questa malattia funestissima, ma bensì rari e rimarchevoli sono coloro i quali la scansino. Ma coll’innesto è egli ben provato che si comunichi la malattia a chi non l’avrebbe naturalmente? Io osservo che non tutti gl’innestati contraggono il vaiuolo. Dalle tavole d’innesti fatti nell’Inghilterra nel 1721 e 1728, vedo che a Boxbury ed a Cambridge alcuni dopo l’operazione non ebbero il vaiuolo, e furono fra quegli innestati dai signori Roby, Thompson e Boylston.[185] In Siena e in altri luoghi della Toscana pure ad alcuni innestati non s’è schiuso il vaiuolo;[186] di altri sì fatti esempi ne racconta il signor de la Condamine, ed il signor dottore Niccolò Battini da Lerice, scrivendo al signor Manetti, così dice: La mia figlia ha resistito sino alla terza operazione d’innesto senza effetto veruno.[187] Se è vero che il vaiuolo sia una malattia che si contrae per comunicazione, come sembra; se è vero che questa comunicazione si partecipi anche colle particelle morbose frammiste all’aria, anche per gli abiti d’una terza persona, anche per una lettera sola venuta da dove regni il vaiuolo,[188] convien dire che coloro, i quali nella lor vita sfuggono da questa malattia, per ciò la sfuggono, perché non sianvi nel loro corpo quelle disposizioni che sono necessarie per contraerla; giacché non è possibile nel corso d’una vita ordinaria d’isolarsi talmente, sicché non abbiasi più volte ancora quel contatto o mediato o immediato che basti a farci schiudere il vaiuolo; e ciò somministra un motivo ragionevole per credere che la maggior parte di quegli appunto ai quali non doveva naturalmente accadere tal malattia siano coloro su i quali l’innesto non produce effetto veruno. Dunque il ragionamento in vece deve farsi così: pochi son coloro che in loro vita scansino la mortal malattia del vaiuolo; dunque è meglio esporci a una malattia non affatto certa, ma sicuramente di esito felice, come vedremo poi, anzi che aspettare quella.
La quarta opposizione è quella sulla quale comunemente il volgo de’ medici sparge il maggior numero di fatti supposti e non provati giammai, cioè che il vaiuolo non sia bastantemente prevenuto coll’innesto, cosicché ei torni un’altra volta dappoi. Vediamo in prima che ne dicano i più accreditati medici sul ritorno del vaiuolo. Il signor Tralles si spiega così: Non porrò io in dubbio la testimonianza degli autori che sostengono due volte poter venire il vaiuolo: pure nella mia pratica un sol esempio non ne ho veduto mai, né da veruno de’ miei colleghi udito. So bene che il vaiuolo selvatico talvolta vien preso in iscambio del vero vaiuolo da alcune matrone che han voglia di saperne assai, alle quali con mala loro voglia ho talvolta contraddetto; so bene che alcun medico ancora può ingannarsi
IL CAFFÈ )( Fogl. XXXVI )(
e prender una malattia per l’altra.[189] Il signor Rosen così dice: Quasi tutt’i medici stabiliscono che avuta che s’abbia una volta questa malattia, se n’è esente per sempre; contuttociò vi sono alcuni esempi contrari, sebbene in piccolissimo numero.[190] Il signor Millin così scrive: Oppongono che il vaiuolo naturale venga anche a coloro che l’ebbero per innesto. Ma convien confessare che se ciò è vero, i casi son rari talmente, che appena uno in mille ne troverai, né una osservazione o due formano giammai una regola generale.[191] Il chiarissimo signor Mead s’esprime così: L’esperienza ci prova che il vaiuolo non torna la seconda volta, e che appena uno in mille vive senza soffrirlo… Quanto poi a quelli, che avendo avuto una volta il vaiuolo innestato, dicesi che l’abbiano avuto di nuovo, io stesso, sebbene ne abbia con somma diligenza fatte ricerche, neppur un solo fatto ben avverato ho potuto rinvenirne.[192] Troppo lunga cosa sarebbe il riferire in questo luogo le stesse assicurazioni che leggonsi presso Boerhaave, Molin e Chirac e altri.[193] Tutt’i migliori medici che hanno scritto sull’innesto sono dello stesso parere nell’attestare che il vaiuolo più non ritorna. Leggesi nel signor Manetti: Da sessanta e più anni in qua, che si sono scoperti e osservati i successi e gli effetti dell’inoculazione, non vi è un esempio autentico e verificato di persona alcuna alla quale sia tornato per la seconda volta il vero vaiuolo, dopo di esser quella già stata inoculata.[194] Il consenso e l’autorità di questi illuminati scrittori dovrebbe bastare a confondere le dicerie di coloro i quali vanno, da quaranta e più anni a questa parte, inventando i sogni di vaiuolo sopravenuto agl’innestati, senza che un fatto solo abbiano potuto provare.[195] Pure, oltre l’autorità citata, abbiano di più fatti positivi, i quali, a parer mio, dimostrano che il vaiuolo innestato impedisce che il vaiuolo non torni più. Eccone alcuni de’ più qualificati e notori. Il dottor Maty, che sì bene ha scritto sull’innesto, dopo aver avuto il vaiuolo naturale all’età d’anni 22, volle sperimentare all’età di anni 35 se l’innesto potesse dargli questa malattia di nuovo: s’inoculò da sé medesimo, ma il vaiuolo non comparve.[196] Il dottore Kirkpatrick vide non pochi fanciulli, che avevano avuto il vaiuolo per mezzo dell’inoculazione, i quali coabitarono dappoi famigliarmente co’ vaiuolanti, senza contrarne giammai nuovo vaiuolo. Riccardo Evans, uno de’ sette malfattori destinati in Londra ai primi sperimenti dell’innesto, ebbe in prigione il vaiuolo naturale, e benché gli venissero poi fatte due incisioni molto grandi e in esse infusa una copiosa dose di materia vaiuolosa, non ne ebbe né vaiuolo, né male alcuno, neppure dolore o infiammazione alle incisioni, le quali il sesto giorno si trovarono interamente cicatrizzate. Elisabetta Harris, anch’essa condannata ai primi sperimenti dell’innesto, ebbe il vaiuolo artificiale comunicatole alla chinese dal signor Mead, come abbiam detto, e dappoi fu posta a servire a più di venti vaiuolanti senza che più vi contraesse il vaiuolo. Madamigella Baker ebbe in età d’anni dodici il vaiuolo per innesto, e risanatane, volle sperimentare d’innestarsi di nuovo: si fece da se stessa le incisioni e v’intruse copia di materia vaiuolosa per tre consecutivi giorni, senza che il vaiuolo le tornasse. Un fratello del colonnello York, figlio del Gran-Cancelliere d’Inghilterra, avendo avuto il vaiuolo per innesto e temendo di averlo una seconda volta, si sottopose sino a quattro inoculazioni, senza mai riaverne vaiuolo.[197] Tutti questi fatti non contestati, e resi pubblici da molti autori non bastarono per imporre silenzio a chi minacciava il ritorno del vaiuolo agl’innestati; pochi anni sono, il cavaliere Henry, il quale nell’Inghilterra aveva avuto il vaiuolo per innesto, volle nella Toscana convincere gl’increduli, e fecesi di bel nuovo innestare con copiosa materia vaiuolosa: né vaiuolo o malore di sorta alcuna ne contrasse.[198] L’autorità de’ più chiari scrittori medici, i fatti notori riferiti, la sperienza di più di 40 anni nell’Inghilterra, ancora non bastano. Vi sono de’ medici, i quali senza aver mai letti gli autori che hanno scritto dell’innesto, né vedute le sperienze, si ostinano a spacciare delle vaghe dicerie sul ritorno del vaiuolo, e fra i creduli loro clienti spargono la diffidanza e l’orrore per questa pratica. Ne so di alcuni, i quali forse non conoscono che appena il nome degli autori che possono schiarirci su questo punto, i quali vanno spargendo nella città nostra che nella Toscana il vaiuolo torni agl’innestati; ad essi io vuo’ dire che se altri libri non leggono, si addomestichino almeno coi fogli pubblici, e impareranno che tanto è difficile il trovare un solo esempio giustificato di un innestato, a cui sia venuto la seconda volta il vaiuolo, che presso il signor de Frances, general ricettore delle finanze della Generalità di Soissons in Parigi, è stata depositata l’anno scorso la somma di dodici mila franchi in premio a chiunque possa nel termine di sei anni provare con attestati concludenti che sia sopravenuto il vaiuolo naturale ad uno che l’abbia avuto per innesto:[199] in vece dunque di comunicare le loro notizie del vaiuolo ritornato alla debole sequela de’ loro adoratori, si facciano cuore e la comunichino in Parigi, che avranno la gloria d’avere il premio e l’utile non indifferente di quasi tremila scudi milanesi. Frattanto che questo premio non sia riportato da nessuno, vuole ogni ragione che ci determiniamo a credere che il vaiuolo innestato ci assicuri contro il vaiuolo naturale.
L’ultima obbiezione finalmente consiste in ciò, che poche essendo le bolle che compaiono sul corpo degl’innestati in proporzione di quelle che compaiono quando il vaiuolo viene da sé, pare che la natura non abbia avuto uno sfogo sufficiente, e conseguentemente questa materia venefica possa fare qualche altro danno alla sanità. Questa obbiezione suppone che il vaiuolo sia uno spurgo, una secrezione che fassi dal sangue, e questa supposizione vien fatta dalla maggior parte de’ medici che cercano più di far piegare i fatti ai loro sistemi che di fondar i sistemi su i fatti. Se il vaiuolo fosse uno spurgo, una depurazione del sangue, converrebbe dire che gli uomini sieno più sani e robusti presentemente di quello che non lo fossero gli antichi prima che conoscessesi in Europa il vaiuolo, poiché essi non avevano per conseguenza questo spurgo, né questa secrezione. Se il vaiuolo fosse uno spurgo del sangue, vivrebbero mal sani coloro che non lo hanno avuto e sanissimi coloro che l’hanno sofferto con maggiore violenza, il che non si vede. Qual differenza v’è mai fra il sangue di chi abbia avuto il vaiuolo e di chi non l’abbia avuto? Nessuna certamente sensibile. Quanti ebbero il vaiuolo bambini, e perché dopo trenta, dopo quarant’anni non avrebbero di nuovo il vaiuolo per purgare la nuova massa del sangue, il quale s’è talmente rinnovato, che secondo tutte le probabilità fisiche neppure la menoma particella ve n’è rimasta? Ciò però non accade. Dunque il vaiuolo non è uno spurgo o una fermentazione o secrezione del sangue né d’altri umori, come viene generalmente supposto. Mi si dirà: cos’è dunque il vaiuolo? Rispondo: è una funestissima malattia di cui vedo gli effetti, ma ne ignoro le cagioni; una malattia che si comunica per contatto; di cui l’indole intrinseca m’è perfettamente sconosciuta, come lo era al Sydenham ed al Boerhaave. Ma come dovremo dunque condurci per ben trattarla? Rispondo: co’ fatti, con una serie copiosa di osservazioni tratta dai più classici osservatori, usando quel metodo che ha risanato, scansando que’ rimedi che hanno portato nocumento e confessando l’oscurità e l’ignoranza nostra sulla natura di essa. Ascoltisi il signor Manetti: Da molti si crede che l’innesto non produca uno sfogo adequato di vaiuolo, e perciò temono che i soggetti inoculati più facilmente siano sottoposti a certi incomodi ed a certe malattie; ma l’esperienza, in tutt’i casi maestra, dilegua anche questi timori… fra tanti ormai da molti anni in qua stati inoculati in Firenze ed in tutta la Toscana non esiste neppure un esempio di tali accidenti o conseguenze. Il tempo sopra tutto è quello che alcuni instruisce, altri disinganna.[200] Veggansi le opere de’ migliori medici inoculatori, e troverassi che il più felice innesto è quello in cui compaia minor numero di bolle, ciò lo prova colla propria sperienza il valoroso medico toscano signor Gatti, il quale da vero filosofo ha scritto in Parigi un’opera che fa onore al suo nome ed alla sua patria;[201] né da lui discorda un solo degli autori che dell’innesto trattano, nel confermare che la malattia è tanto più mite quanto minore è il numero delle pustole, o bolle vaiolose, che compaiono.[202]
Abbiam sinora data una idea storica dell’inoculazione e abbiamo sciolte, a quel ch’io credo, concludentemente le difficoltà che le si vanno opponendo da quaranta e più anni a questa parte; ma per conoscere s’ella sia da adottarsi ciò ancora non basta, convien conoscere che l’inoculazione sia utile, e d’una patente utilità, conviene esaminare come si faccia e presentare al giudizio nostro una serie di fatti classica, sincera e numerosa capace di determinarci per una parte o per l’altra.
L’inoculazione è un soggetto di disputa. Io sceglierò quei fatti i quali non sono né posti in dubbio, né contraddetti dai nemici medesimi dell’innesto. Io sceglierò quei fatti i quali sono pubblicati colla maggiore autorità. Io sceglierò quei fatti per fine che non sono stati posti in dubbio né dal signor Haen, né dal signor Rast, né da verun altro oppositore al nuovo metodo. Eccoli.
Il dottore Hadow ha innestate 1200 persone, fralle quali ve n’erano 62 malsane, altre per lo scorbuto, altre per reumatismo, altre per asma ec., e ne morì una sola, imputandosi la di lei morte alla trascuranza che s’è avuto nell’assisterla.[203]
Dai registri pubblicati de’ morti nello Spedale di Londra dal 26 settembre 1746 sino al 24 marzo 1763, consta che in esso spedale vi sono stati ammalati di vaiuolo naturale 6456, de’ quali ne sono morti 1634; innestati 3434, de’ quali ne sono morti 10. Cioè la quarta parte degli ammalati di vaiuolo naturale è perita, e degl’innestati ne è perito uno ogni 347;[204] e qui è da notarsi come negli spedali la mortalità d’ogni malattia è sempre maggiore, e se generalmente abbiam fissata la mortalità del vaiuolo naturale al dieci per cento, non al venticinque come qui appare, l’innesto a proporzione dovrebbe ridurre il pericolo fuori degli spedali a uno ogni ottocento circa.
Di 2000 innesti fatti dal signor Browne, due sole donne gravide ne sono perite.[205]
Da una lista presentata al vescovo di Worcester si vede che di 1500 persone innestate tre soli casi sono andati infelicemente.[206]
Il signor Frewin of Rye nella contea di Sussex ha innestato 300, e ne è perito uno di febbre putrida sopragiuntagli dopo il declinare del vaiuolo.[207]
Il signor dottore Middleton ne inoculò 300, ed uno ne perì.
A Genevra, per testimonianza del signor Tronchin, di 200 innestati è morta una fanciulla molto dilicata, la quale con disapprovazione de’ medici fu sottoposta all’operazione.
Il signor Hosty nel 1757 si portò a Londra per essere testimonio degli effetti dell’innesto, e di 252 innestati che vide, neppur uno ne morì.[208]
Nell’isola di S. Cristoforo 300 schiavi di ogni età furono innestati, e tutti felicemente si riebbero dal vaiuolo.[209]
Nelle colonie inglesi d’America nel 1760 furono innestate 2000 persone, e tutte con fausto evento.[210]
Il signor Ramby, chirurgo di S. M. Britanica, ha innestato 1000 persone senza la perdita d’un solo.[211]
Il signor Morand nel 1755 aveva innestato 903 persone, non solo senza la morte di alcuno, ma senza che ad essi fosse sopraggiunto neppure un accidente grave, nel corso del male, che avesse fatto temere della loro vita.[212]
Il signor dottore Domenico Peverini, un tempo medico di Citerna nello Stato Pontificio, poi nella Città di Castello, nel 1755 aveva inoculati più di dugento soggetti tutti felicemente, e senza che veruno di essi sia restato neppur segnato.[213]
Seguito a prevalermi delle parole del signor Manetti: Il signor Pier Matteo Pierotti, successore del nominato signor Peverini nella condotta di Citerna, vi ha inoculato più di cento fanciulli tutti quanti a bene, e per quanto egli medesimo espone in una lettera in data dei 7 settembre 1756, scritta al signor Peverini, tutti hanno avuto un vaiuolo di specie benigna, e se in alcuni si affacciarono degli accidenti come sarebbe febbre risentita, delirio, dolori, convulsioni ec., questi tutti si dileguarono alla prima comparsa o eruzione del vaiuolo, né veruno è restato segnato, neppur di quelli nei quali le bolle furono in qualche quantità. Per ragione unicamente di sì vantaggiosi effetti ed esempi, non poche madri, in detto paese, elleno stesse hanno innestati i loro figliuoli, e non lasciano continuamente di lodare e ringraziare la divina beneficenza che abbia voluto apprestare un metodo così facile ed utile per un male di cui il mondo sin ora si è cotanto doluto.[214]
I fatti d’Italia è bene riferirli colle parole stesse di chi gli attesta. In Pirano, città dell’Istria, nel 1758, da giugno a ottobre, il signor dottor Giovanni Paolo Centenari innestò più di 300 persone, e fra tutti questi che furono da me inoculati neppur uno morì, e quello che forse è più, neppur uno restò in alcuna parte offeso della persona, mentre per lo contrario morirono quasi altrettanti fanciulli a’ quali non si fece l’innesto, e rimasero molti altri che sopravissero ciechi e attratti ne’ membri e nella faccia deformi.[215]
Il signor dottor Gatti ha fatto felicemente più di 100 innesti a Parigi.[216]
A Nimes sono stati fatti 78 innesti, tutti felici.[217]
Io trascuro qui di accrescere il numero di simili fatti. Molti innesti felicissimi ha fatto il signor Cei ne’ contorni di Livorno; in Lerice, nella Toscana, molti innesti vi ha pure faustamente fatti il signor dottore Niccolò Battini, il quale scrivendo al signor Manetti, gli dice che in Lerice ognuno smania e desidera di fare inoculare i suoi figli; ma essendo io solo, è necessario che aspettino il mio comodo.[218] In Pistoia il signor Tani, a S. Pietro in Bagno il signor Fantini, a Prato il signor dottor Turacchi, in somma per la Toscana tutta son tanto ripetute e popolari le esperienze favorevoli, che una gentildonna persino, la signora marchesa Bufalini, da per se stessa ha inoculati con esito intieramente felice non solo molti figliuoli dei suoi contadini e dipendenti, ma dei terrazzani ancora di quei contorni,[219] tanto i fatti provano che non v’è pericolo in questa operazione.
Concludo la serie de’ fatti da me raccolti con quello insigne di Costantinopoli, dove in un solo anno furono innestate diecimila persone, e tutte, nessuna eccettuata, se ne liberarono.[220]
Ricapitolazione de’ fatti sull’innesto
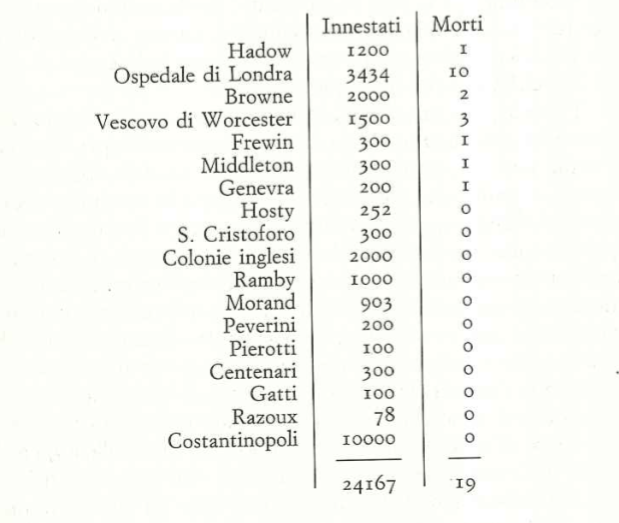
IL CAFFÈ )( Fogl. XXXVII )(
Dai fatti che abbiamo dunque potuto raccogliere da’ più classici autori appare che in ventiquattro mila e più innestati, diciannove ne sono periti, il che importa che ogni 1200 innestati ne muore uno. Della legalità di questi fatti non credo che si possa muovere verun dubbio, giacché quegl’Inglesi tanto dell’isola che delle colonie hanno la pubblica attestazione del Lord Vescovo di Worcester, del secretario della Società Reale di Londra dottore Jurin e del signor Ramby, primo cerusico della corte britannica; gli altri o sono attestati dal signor de la Condamine, di cui il credito è bastantemente stabilito in Europa, o da quegli onorati medici d’Italia attualmente viventi i quali gli hanno pubblicati essi medesimi colle stampe, apponendovi il loro nome; né è credibile che in fatti di tal natura, che hanno tutto un paese per testimonio, si possa impunemente abusare della credulità del pubblico. Chiunque sia stato in Toscana può servire di testimonio della ingenuità di que’ fatti.
Tutte le più esatte ricerche che da vari autori si sono fatte finora intorno la vita umana fanno conoscere che per adequato l’uomo vive trentatré anni e alcuni mesi. Questa notizia è talmente ricevuta, che dal numero de’ morti in un anno in ogni paese moltiplicato per trentatré se ne viene a dedurre l’attuale popolazione di esso; cosicché laddove muoiano, per esempio, mille uomini all’anno, ivi presso poco la popolazione sarà di trentatré mila anime.[221] Ciò posto, di ventiquattro mila ne morranno verisimilmente in un anno più di seicento. Dunque la probabilità sarà che ogni mese di questi ventiquattro mila ne muoiano 50; l’innesto dura circa un mese: dunque, se dei 24000 innestati ne fossero anche morti 50, non dovrebbesi ciò altrimenti attribuire all’innesto, ma anzi dovrebbe attribuirsi alle leggi ordinarie della natura, e dovrebbe credersi che ancora non innestati sarebbero morti. L’innesto non rende gli uomini immortali per il tempo ch’ei dura, né può ciò da veruno pretendersi. Ma di 24000 e più innestati, appena 19 ne sono morti, dunque per l’innesto non ne muore veruno. Quest’argomento mi pare senza replica.
Un’altra riflessione pure convien fare, ed è che sia nel vaiuolo naturale, sia nel vaiuolo innestato, noi troviamo che passa sempre l’intervallo di alcuni giorni dal contraersi la malattia al manifestarsi; ora, chi mi assicura che a taluni non sia stato fatto anche l’innesto dopo che avevano già contratto il veleno vaiuoloso naturalmente? Ciò tanto più è probabile, quanto che il maggior numero d’innesti s’è sempre fatto ne’ tempi ne’ quali la epidemia del vaiuolo regnava più. Dal che sempre più ci confermiamo nell’asserire che la questione dell’innesto del vaiuolo ha in questi ultimi tempi mutato aspetto. Sin tanto che pochi erano i casi e le sperienze, e che s’andavano facendo semplici tentativi per lo più negli spedali, dove l’assistenza non può mai essere tanto esatta, si trattò di cambiare un pericolo maggiore in un minore: ma al dì d’oggi, che negli Stati soli della corona britannica abbiamo più di dugento mila innestati,[222] al dì d’oggi, che in tutte le parti d’Europa, trattane la Spagna e il Portogallo, si sono moltiplicati prodigiosamente i fatti che pongono in chiara luce questa materia, la questione si riduce a sapere semplicemente se debbasi prevenire una malattia mortale quasi inevitabile, la quale ammazza la decima parte per lo meno dell’uman genere, con una operazione niente pericolosa e poco incomoda.
L’operazione dell’innesto consiste in due superficialissime incisioni che si fanno per lo più nella parte media ed esterna delle braccia al disotto del tendine del muscolo deltoide, una per braccio; alcuni le fanno alle coscie, e queste incisioni lunghe circa un pollice appena devono passar la pelle. A queste incisioni si applica un filo inzuppato nel veleno vaiuoloso, poi si fascia. Quest’apparecchio si toglie dopo quarant’ore, e si medicano le incisioni una volta il giorno. Sino al sesto o al settimo giorno il paziente sta bene; pure è lodevol cosa ch’ei non esca di casa ed abbia cura di non disordinare nel vitto. Il giorno ottavo, d’ordinario compare una legger febbre, e il nono o il decimo si vede l’eruzion del vaiuolo, e ciò consiste in 30, 40 o al più 50 pustole che compaiono in tutt’il corpo, tutte discrete e d’ottima qualità.[223] Talvolta accade che tutto il veleno si scarichi dalle sole incisioni e che l’ammalato non abbia che una o due pustole, e talvolta nessuna, ed anche in questo caso se le incisioni avrano tramandata molta materia, l’esperienza di più di 40 anni fa vedere che s’è pagato il tributo al vaiuolo, e che più non ritorna. La febbre di supurazione rarissime volte viene agl’innestati, e quella che viene al comparir delle pustole non è più grave di quella che può dare un rafreddore, e consiste in una febbretta che dura alcune volte 24 ore, e d’ordinario due o tre, o tutt’al più quattro giorni. Le ferite nel giorno decimottavo cominciano a cicatrizzarsi, e nel vigesimo da loro medesime ordinariamente si chiudono. Non v’è esempio che alcuno resti segnato dal vaiuolo innestato;[224] per ciò ebbe ragione di dire il chiarissimo signor dottor Manetti che le sperienze e le storie sino a quest’ora pubblicate sono più che sufficienti a persuader chicchesia, e qualora si trovassero dei non capaci e non persuasi, non altro vi può esser necessario per rendergli parziali, che il ridurgli a vederne i successi ocularmente.[225]
Pare impossibile come un metodo sì utile, sì necessario, sì poco penoso, dopo la serie di più di quarant’anni, confermato nell’Inghilterra da innumerabili fatti, dopo il consenso universale di tutt’i medici inglesi, i quali sono i maestri della medicina d’Europa, dopo l’adozione fattane e nell’Inghilterra e nella Svezia e nella Danimarca e in buona parte degli Svizzeri e nella Toscana; un metodo contro il quale nessuno v’è che si opponga ne’ paesi che lo esercitano, un metodo in somma sì importante e benefico per l’umanità, sia presso di noi un puro soggetto di conversazione, e che vogliamo riserbare alla generazione ventura la fortuna di profittarne e il diritto di cercar le ragioni della nostra indolenza. Pare strano altresì come il grido di questi fatti classici, e che sono anunziati all’Europa da cento autori, non oscuri certamente nella republica delle lettere, riscuota sì poco generalmente gli animi e ci lasci nella indifferenza; e laddove in vece una sola diceria si sparga contro l’innesto, mille lingue siano pronte a ripeterla e a stamparla negli animi volgari. Appena morì in Parigi nel 1759 il figlio del fermier generale de Gaze, il quale era stato innestato, che dappertutto se ne sparse la novella e ne trionfarono i nemici del nuovo metodo; si vide poi che egli era morto per una caduta trentanove giorni dopo l’eruzione del vaiuolo, dopo che perfettamente ne era risanato, e con prove giuridiche e con attestato de’ medici che assistettero alla incisione del cadavero, in cui si trovò una gran copia d’acqua raccolta nel cervello, venne in chiaro che in nessun conto poteva egli dirsi morto di vaiuolo.[226] Caduto che fu il credito di questo fatto, un altro se ne inventò, cioè che il signor dottor Liger, di Clermont in Avergna, avesse innestato suo figlio, e che essendo questi morto per l’innesto, il padre pure ne fosse morto di rammarico; e questo fatto si pubblicò e si sparse in mille guise, e presso molti discreditò il metodo d’innestare; ma fatte le ricerche sul luogo, si vide poi che i signori Liger, padre e figlio, erano già morti quindici anni prima, che il figlio non era mai stato inoculato e che sino a quel giorno nella città di Clermont non era mai stato fatto verun esperimento per l’innesto.[227] Un altro fatto fu pubblicato della morte del figlio di Lord Hillsborough, il quale veramente morì dopo l’innesto, ma ogni ragion vuole che non per ciò se ne incolpi l’innesto. Il figlio del Lord Hillsborough cadde malato il terzo giorno dopo l’innesto, ed ebbe la intera eruzione delle pustole del vaiuolo il giorno quinto:[228] ora tutte le quasi infinite sperienze d’innesto ci assicurano che l’eruzion del vaiuolo non accade mai prima del nono o al più dell’ottavo giorno dopo l’innesto; perciò la ragion ci persuade che il figlio del Lord aveva già contratto il vaiuolo naturale prima che s’innestasse, e ch’egli è morto non già di vaiuolo inoculato, ma di vaiuolo comune. Deve certamente far maraviglia come alcuni uomini siano sì pronti e attivi nel combattere la causa della umanità, e sì indolenti generalmente gli spettatori per i quali si fa la causa da alcuni coraggiosi filosofi, che hanno virtù e costanza tale di voler far del bene agli uomini, togliendo loro dalla mente un importantissimo errore senz’altra speranza che quella, deliziosa per le anime sensibili di esser conscie a loro medesime d’aver promosso il bene.
Credo che quanto abbiam sin ora avuto sott’occhio basti a determinare il giudizio nostro in favore dell’innesto; ma alcune altre brevi osservazioni ci restano a fare per rendere queste nostre considerazioni più complete.
Il vaiuolo può egli comunicarsi con egual indifferenza in ogni età? Quai sono le circostanze nelle quali conviene astenersene? Quali le preparazioni utili per ben disporvisi? Conviene trattare queste tre questioni.
Di que’ trecento innestati nell’isola di S. Cristoforo, che dissopra abbiam registrati e de’ quali neppur uno è perito, vediam che ne dica l’insigne medico signor Mead: Furono essi d’ogni età dai cinque anni sino ai trenta, e l’esito fu sì felice, che sebben fossero mori per la maggior parte, neppur uno ne perì; poiché quantunque la pestilenza del vaiuolo sia gravissima sempre nell’America, con tutto ciò la sperienza ci ha insegnato che gli Affricani la soffrono più mortale ancora.[229] Il signor Schultz attesta di aver fatto l’innesto a persone d’ogni età, ed in particolare a un uomo persino di 70 anni, e tutti felicemente risanarono dal vaiuolo.[230] Il dotto signor Targioni ci assicura che gli adulti s’innestano senza pericolo alcuno della vita.[231] L’innesto riuscir suole più facilmente ne’ bambini e ne’ fanciulli, benché negli adulti eziandio sicuramente si possa amministrare:[232] così ci attesta una rispettabile società di uomini dotti, che ha destinato il primo volume de’ suoi lavori a rischiarare l’importantissima questione dell’innesto. Di trecento e più innesti di vaiuolo fatti dal signor Giovanni Paolo Centenari nell’Istria l’anno 1758, così ne dice egli stesso: Varie e distantissime furono le età degl’innestati; imperciocché ho praticato in quel tempo l’innesto a teneri bambini persino di otto o dieci mesi, e l’ho praticato altresì in giovani uomini e donne d’anni diciotto, e in tutte queste operazioni, alle quali sempre successe il vaiuolo di benigna natura, non m’accadde mai il menomo sinistro accidente.[233] La marchesa di Voyer, d’una complessione molto dilicata, è stata innestata a Parigi dal signor dottor Gatti dopo quindici anni di matrimonio; così la duchessa di Choiseul.[234] Il cavagliere di Chastellux, colonello del Reggimento di Guienne, s’è fatto felicemente innestare d’anni 21, e questa felice riuscita lo fece diventare sostenitore del nuovo metodo, in favor del quale ha scritto.[235] Questi pochi fatti e queste autorità bastano, cred’io, a toglierci il ribrezzo che taluni cercano di far nascere nelle persone che hanno già passata la fanciullezza e l’adolescenza. Il testimonio de’ fatti più autentici d’Europa ci prova che in ogni età riesce felicemente l’innesto.
Le persone d’una età già adulta devono temer dal vaiuolo naturale più assai che non ne debbano i fanciulli. La sperienza generale ci ha fatto stabilire che per lo meno ne muoiano il 10 per cento di vaiuolo naturale; ma questo alla maggior parte viene nella fanciullezza. Se il calcolo si facesse sulle persone adulte, troveremmo che forse ne muoiono cinquanta per cento. Chi è nel caso, rifletta dunque che tanto debb’essere maggiore la sollecitudine a ricorrere all’innesto, quanto è maggiore il pericolo che incontrano colla dilazione. Il signor principe di Darmstadt, stando alle sole case sovrane, è stato la vittima dell’epidemia di due anni sono.
La sperienza ci ha insegnato che l’innesto è riuscito infelicemente sopra alcune donne gravide, e sopra altre che non lo essendo, mancavano di que’ contrassegni che dinotano uno stato regolare di sanità. La ragione dunque c’insinua di non esporre a quest’operazione chi si trovi in questi casi. Coloro altresì che sono soggetti a epilepsia, tabe scrofulare, scorbuto, lue celtica ec., in una parola, coloro che hanno sicuro indizio di non esser sani, s’astenghino dal tentare l’innesto; non già perché assolutamente si debba credere pericoloso nemmeno per essi, che mille fatti ne abbiamo in contrario, ma perché per essi non v’è tutta quella morale e palpabile sicurezza nell’operazione che v’è per i corpi sani; ed io scrivendo liberamente il parer mio, non voglio che mi rimanga l’inquietudine d’aver contribuito a porre in rischio un uomo anche solo su un articolo sì importante.
Quanto poi alle preparazioni colle quali devesi disporre chi vuole innestarsi, io dirò che l’uso ordinario de’ medici si è di prescrivere per dieta, alcuni giorni prima dell’innesto, cibi facili a digerirsi e lontani dal formare sughi corrotti. Erbaggi, farine, legumi, carni di pollo ec. sono i cibi che si sogliono permettere a chi si dispone all’inoculazione. Ciò pare conforme ad ogni ragione il farlo, purché non si ecceda, né si estenuino le forze. Sogliono pure i medici purgare una o due volte, e per poco che il temperamento sembri sanguigno aprir la vena. A questi purganti e a questa emissione di sangue si oppone con ragioni talmente convincenti il signor Gatti, ch’io son convinto che ciò sia cosa per lo meno superflua, se non dannosa. Abbiamo un fatto riferito dal gran conoscitore del vaiuolo, dal Sydenham, d’una fanciulla, la quale risanata appena da una malattia per cui le furono fatte copiose emissioni di sangue, fu sorpresa dal vaiuolo: si consolò il signor Sydenham, colla speranza, che trovando il vaiuolo un sangue sciolto e libero al moto, dovesse spiegarsi felicemente più che in ogni altro caso; ma il fatto non corrispose, e fu il vaiuolo mortale, e gravissimi i sintomi tutti che l’accompagnarono. In questa perplessità, qual dunque sarà la scorta per definire come dobbiamo prepararci? I fatti, i soli maestri d’una scienza conghietturale quale è la medicina. Ecco quai sieno i fatti. Emanuele Timoni c’insegna che in Costantinopoli, al suo tempo, s’eseguiva l’innesto senza tante cautele, anche nelle peggiori constituzioni d’aria e di contagio, e che l’eseguirlo così era una conseguenza del pronto e prospero esito che quegli abitanti e quegl’inoculatori avevano osservato derivare dalla natura propria o efficacia dell’operazione stessa in tutt’i sessi, in tutte le età, in tutt’i temperamenti. Il veder poi che degl’inoculati non ne moriva alcuno, e che tal pratica metteva anche tutti al coperto d’ogni cattiva conseguenza, nel tempo medesimo che degli attaccati di vaiuolo naturale ne moriva sino la metà era la massima ragione perché in dette parti non si trovassero oppositori.[236] Il signor Manetti su tal proposito si spiega così: Molti innestando il vaiuolo non hanno avuto riguardo a purgare i soggetti che volevano inoculare, ed hanno inserito loro il vaiuolo mediante la marcia presa da’ malati di vaiuolo confluente, e non ostante sempre ad essi è sopravvenuto un vaiuolo assai mite e benigno.[237] E quanto alla natura del vaiuolo da cui si prende il veleno, le sperienze ci provano che è indifferente ch’ei sia di buona o cattiva qualità, nel che consultisi il signor Frewin[238] ed il signor Burges[239] ed il signor Kirkpatrick.[240] Neppure i benefici dell’innesto sono limitati ad una stagione; vediamo per testimonianza del signor Archer, il quale in Londra ha inoculato moltissimi, che l’innesto riesce felicemente in ogni stagione;[241] così nel 1758, in dicembre, sebben paia uno de’ mesi meno opportuni, in Siena si sono fatti gl’innesti con ottimo successo.[242] Ma per non riferire inutilmente una più lunga serie d’autorità su questo proposito, io credo bene di qui inserire una lettera scritta da un fattore di villa al nobile signor Antonio Palmieri suo padrone: essa trovasi nel primo tomo degli Atti dell’Accademia delle Scienze di Siena, ed a me pare tanto ingenua e semplice, che debba non esser discara a chi legge queste mie osservazioni. Ecco la lettera:
Casenovole, 7 marzo 1756.
Sono tre anni che circa al 10 d’aprile mandai a prendere il mio ragazzo a Civitella, e arrivato qua la mia moglie stiede quattro giorni per vedere se veniva il vaiuolo senza fare preparazione alcuna, e vedendo che non li veniva andò ad un podere qui vicino ove vi erano tre ragazzi vaiuolosi, due de’ quali avevano il vaiuolo di quello cattivo, ed uno ne aveva pochissimo, e bolle grosse; con uno spillo punse una di quelle bolle putrefatte, e venendo a casa punse col detto spillo il ragazzo in un braccio, ed il detto ragazzo stiede sempre vispo, e la pungitura a poco a poco sempre più gli cresceva. Arrivato al fine di giorni nove, li venne la prima febbre, e fino a tre, ma grandi, che lo tenevano dissentato e non mangiava; e gli arrivò a scappare il vaiuolo, ma pochissimo, e di quello grosso come li s’era annestato, ma li posso dire che dove s’era punto gli aveva fatto un boccio come una grossa nocciola, ed a torno a torno di molte bolle; basta, alla fine di giorni dodici andiede fuori. Due altri contadini delli nostri venivano a vedere il detto mio ragazzo, e quando l’ebbe putrefatto punsero altri due ragazzi de’ suoi, ed a questi alla fine de’ quattro giorni li vennero le solite febbri tre e grandi, li escì pochissimo vaiuolo, meno assai che non ne aveva il mio, e guarirono prima. A questi li lascio considerare li preparamenti potevano farli, al più saranno andati col bestiame. La mia ragazza poi, che fummo sciocchi, si stiede assai piùgiorni dopo l’innestatura del ragazzo, alla fine li s’innestò, e subito li vennero le febbri, e li venne il vaiuolo piccolino, nero, con pochissime bolle d’altro vaiuolo grosso, e qui compresi che quando li s’annestò, era già internato, e li venne l’uno e l’altro, cioè l’innestato e il naturale. Basta, stiede da venti giorni che si credeva che volesse morire, ed è al presente sana e prospera. Queste sono le relazioni che li posso dare, ma io avendo altri figliuoli sempre glielo annesterei, perché ne ho vista l’esperienza.[243]
Da quella rustica naturalezza che trovasi in questo documento, facile è lo scorgere quale opinione faccia nascere di sé l’innesto dovunque se ne faccia la sperienza. Da qui si scorge qual necessità vi sia di purgare o cavar sangue prima d’innestare. Due errori credo che siano trascorsi a quel buon fattore, uno si è d’aver chiamate
IL CAFFÈ )( Fogl. XXXVIII )(
le febbri grandi, perché la sperienza di tutta la terra ci prova ch’elleno non sono tali; saranno bensì state capaci di cagionar della sete al fanciullo e fargli perdere la voglia di mangiare, ma questi non sono sintomi che da loro soli provino una gran febbre. L’altro errore è quello della febbre comparsa quattro giorni dopo l’innesto, cosa contrarissima pure alla più costante sperienza, la quale c’insegna che la febbre non compare che circa l’ottavo giorno dopo l’innesto: né v’è da maravigliarsi, se lo spirito d’un fattore di villa o non abbia fatta una esatta osservazione su i giorni o l’abbia dimenticata, scrivendo la relazione alla sua foggia.
Ma ritorniamo un momento alle qualità necessarie per subire con sicurezza l’innesto; esse ci vengono additate dal chiarissimo signor dottor Gatti nell’aurea sua opera pubblicata a Parigi l’anno scorso su questa materia. Tre condizioni egli esige, e sono: un fiato naturalmente dolce e sano; le carni morbide generalmente in tutto il corpo; e facilità di cicatrizzarsi, il che senza dolore si prova con una cutanea incisione. Queste tre cautele esso le ha imparate ne’ suoi viaggi della Turchia, e la sperienza sua e in Italia e nella Francia gli ha fatto vedere che quei tre segni che osservano gli orientali sono quelli appunto, e non altri, che dobbiamo osservar noi, e che quando si trovino è un colpo sicuro.[244]
E qui terminar potrei le mie riflessioni coll’autore delle Novelle letterarie di Firenze, cioè col dire: A me pare che non metta conto di quistionare più sopra una pratica vantaggiosissima a noi mortali com’è l’inoculazione:[245] ma pare che in vece di lasciar l’ingegno di chi vorrà leggere oppresso sotto la pesante autorità de’ fatti e degli autori, quasi sdegnosamente costretto a persuadersi in favor dell’innesto, non sia male ragionare anche un poco in medicina e ricercar fra questo buio qualche barlume di ragione che appaghi. Quest’inoculazione par quasi una operazione magica. La malattia del vaiuolo si acquista per contatto. Io preparo un fanciullo colla più esatta forma del vitto, lo scelgo della miglior complessione e nella più dolce stagione, lo faccio coabitare con un ammalato di vaiuolo d’ottima qualità. Pare che questo dovrebbe essere il più prudente modo di assicurarsi dagl’insulti del vaiuolo, eppure ciò a nulla giova. Il signor conte Roncalli medesimo, lo stesso impugnatore dell’innesto, c’insegna che con ciò molte volte s’acquistano vaiuoli di pessima qualità, e che se ne muore,[246] e la sperienza lo fa vedere ad ognuno. Prendo in vece un fanciullo non preparato, in una stagione non favorevole, gl’insinuo per una superficiale ferita in un braccio del veleno vaiuoloso di non buona qualità, e il fanciullo ha un leggerissimo vaiuolo benigno e risana. Pare che siavi qualche cosa di misterioso e di magico che non appaga la ragione: quel veleno, tanto attivo che si comunica per l’aria istessa e cagiona una mortal malattia, introdotto nel corpo per una incisione, perde la sua attività e fa cessare ogni pericolo.
Nella lettera del signor Tissot al signor Haen ho trovato il primo lampo di quel sistema che sì bene ha sviluppato il signor Gatti, sistema ch’io da me stesso m’era già formato in mente, e in cui mi son veduto prevenuto da un sì gran maestro con un secreto sentimento di piacere frammischiato a un po’ di pena, poiché ciò mi ha tolta la speranza di produrre qualche cosa di nuovo, come mi era lusingato. Ecco dunque come può concepirsi l’idea del vantaggio dell’innesto. Il vaiuolo naturale cagiona un male tanto più pericoloso e mortale, quanto che la sede di esso si stabilisce in una parte più nobile del corpo nostro. Le cure de’ più valenti medici tendono ad allontanare il vaiuolo più che si può dalle parti vitali. La nostra indicazione è stata costantemente, come si dice, di allontanare più che fosse possibile il veleno vaiuoloso dalle parti vitali, ed anche dalla faccia, dice il celebre signor dottor Targioni:[247] il vaiuolo è micidiale quando fa qualche deposizione, o decubito che chiamiamo, in qualche viscera contenuta nelle tre cavità del corpo; cosa che più d’una volta è avvenuto di vedere, avendo ritrovati degli ascessi nei polmoni e nel fegato in alcuni morti in tempo di vaiuolo: oltreché non sono per avventura pochi quegli che per una deposizione fattasi nella gola, cioè per un’angina, in cert’ epidemie micidiali, specialmente di vaiuolo, morir si veggono: così ci attestano gli Atti dell’Accademia di Siena.[248] Quando il vaiuolo principalmente fissa la sua sede nel capo, come abbiam veduto nella giovane innestata alla chinese dal signor Mead, cagiona fortissimi dolori di capo e talvolta frenesia.[249] Il principal pericolo dunque di questa malattia pare che non consista tanto nella natura stessa del veleno vaiuoloso, quanto nel luogo ove vi pianta la principale impressione e stabilisce la sede. Ciò posto, il che è conforme alle osservazioni mediche, chi contrae il vaiuolo per fortuito contatto o per coabitazione si espone all’azardo che la sede del veleno si determini in una parte nobile o ignobile; indi contraendosi per le parti venefiche frammiste all’aria, pare verisimile che il polmone sia il più disposto a divenir il centro e il punto massimo del male; laddove l’innesto determina la sede di esso male in una parte lontana dalle vitali. L’utilità dunque dell’innesto in ciò consiste, di scegliere e stabilire il sito dove il vaiuolo, deve esercitare la massima azione; e questo sito è quello appunto dove si soffrono durante la malattia le maggiori irritazioni, e ne’ contorni di esso compaiono in numero assai maggiore le bolle, e punture e dolori soffronsi e vedesi scarico di maggior copia di veleno.[250]
Io non pretendo perciò di spiegare esattamente l’indole del vaiuolo, di cui, come da principio ho detto, ognuno ne ignora la natura, trattine i cattivi medici, ai quali soli è permesso di saper tutto: pretendo soltanto d’aver data una spiegazione la migliore che si può, la migliore che sia stata ritrovata sinora in questa materia e la sola che può in qualche maniera dar ragione de’ vari e complicati fenomeni che risultano dalle sperienze dell’innesto. Vorrei che gl’inoculatori tentassero di rendere ancora più dolce e benigno questo metodo, se pure è possibile; vorrei che si esaminasse se convenga, in vece d’innestar nelle braccia, stabilir la sede del vaiuolo nelle coscie, ovvero nelle gambe, ovvero anche ne’ piedi, per allontanarlo sempre più dai visceri più dilicati. Col tempo ciò si farà, ma la benevolezza verso gli uomini deve estendersi sino alle generazioni venture bensì, ma non devono esse preferirsi giammai alla generazione vivente. Mi compiaccio prevedendo i vantaggi de’ nostri successori, i quali per molti capi saranno meno infelici di noi, se qualche improvviso rovesciamento non viene a discomporre quell’organizzazione che va sempre più aumentandosi in Europa; ma vorrei che, giacché siamo incamminati al bene, s’accellerassero i progressi, e che moltiplicandosi le coraggiose grida di quegli uomini sublimi che reggono le opinioni de’ posteri e soffrono le dicerie de’ contemporanei, tutto si ponesse in un moto ordinato per accrescere le cognizioni nostre, e singolarmente le più utili alla vita ed alla sicurezza degli uomini viventi. È da desiderarsi che cautamente e con industria si estendino i beneficii dell’inoculazione, a segno che quelle viste che al dì d’oggi si hanno, vengano bene schiarite quanto è possibile.
Abbiamo alcune notizie come l’innesto si usi prosperamente non solamente nel vaiuolo, ma persino nella peste. Alcuni giornali de’ più accreditati d’Europa ci assicurano che in Costantinopoli s’innesta la peste, che coll’innesto s’acquistano gli stessi vantaggi che col vaiuolo, giacché anche la peste, avuta una volta, più non ritorna. Dicesi che il medico del sultano Muly Mustapha Aga l’abbia felicemente inoculata a quest’ora a molti.[251] Il Magazzino inglese ci assicura altresì che il contagio pestilenziale negli animali perde ogni pericolo coll’innesto. L’esperimento si fece su otto vitelli coll’introdurvi per un taglio fatto nella gola la materia morbosa delle nari e degli occhi d’un bue contagioso.[252] Una lettera del dottor Schwenke, professore di chirurgia e d’anatomia all’Haia, ci conferma simili sperimenti. Sarebbe bene che la curiosità si risvegliasse anche nella Italia e non si lasciassero oziose sì grandi e utili viste, ma bensì sottoponendosi alla sperienza, o venissero riposte fra i sogni, ovvero venissero confermate e rese di pubblico beneficio. La medicina che previene le malattie, ossia, per chiamarla col termine dell’arte, la medicina profilattica, per cui v’è tradizione che Prospero Alpino abbia scritto un trattato il quale ora più non esiste, questa benefica medicina che non aspetta il male per risanarlo, ma invigila e anticipa perché non venga, è troppo generalmente negletta per disavventura dell’umanità.
Terminerò le mie osservazioni col riferire quello che Milady Montagute, di cui abbiamo fatta già menzione, scriveva da Adrianopoli a madama S. C. quasi mezzo secolo fa, cioè nel 1717. Così diceva dunque quella leggiadra e amabile Milady: Vi dirò un fatto che faravvi desiderare d’essere ov’io sono. Il vaiuolo, sì generale e sì crudele da noi, è divenuto un’inezia in questo paese col favore dell’innesto che vi si è introdotto. V’è una schiera di vecchiarelle, le quali innestano per professione; il tempo opportuno si è nell’autunno, scemati che sono i grandi calori; allora i padri di famiglia s’accordano e adunano 15 o 16 de’ loro figli, che ancora non abbiano avuto il vaiuolo; si chiama una delle vecchiarelle, la quale in un guscio di noce porta la materia vaiuolosa della miglior qualità, fa una leggiera incisione, la quale non è più dolorosa di quello che lo sarebbe una graffiatura, e coll’ago v’introduce una stilla di essa materia… I fanciulli innestati giuocano e stanno bene per otto giorni ancora dopo l’innesto, passati gli otto giorni vien la febbre, e allora stanno a letto due giorni, e di rado tre; essi non hanno ordinariamente che venti o trenta bolle sul viso, le quali non v’è esempio che lascino veruna impressione. Finalmente otto giorni dopo sono essi sani e vegeti come se nemmeno avessero avuta malattia. Le incisioni purgano molto durante il vaiuolo, il che serve di sfogo al veleno vaiuoloso, acciocché non si spanda violentemente altrove. Ogni anno questa operazione fassi a miliaia di fanciulli, e l’ambasciator di Francia dice che qui si prende il vaiuolo per solazzo come altrove si prendon le acque. Non s’è veduto perir alcuno in queste parti per l’innesto, ed io sono talmente convinta della bontà di quest’operazione che son risoluta di sottomettervi il mio caro bambolo. Amo la mia cara patria a segno che desidero d’introdurvi questa usanza, e non tarderei a scriverne a’ nostri medici se gli credessi zelanti a segno di preferire il bene del genere umano al lor privato interesse e capaci di sacrificare un ramo sì importante della loro entrata; ma temerei di espormi alle teribili loro vendette se cercassi di far loro uno scapito sì grande. Chi sa che al mio ritorno in Inghilterra io non abbia coraggio tale da muover loro guerra! Ammirate l’eroico zelo della vostra amica ec.[253]
Ma tempo è omai di por fine a questo argomento. Si tratta o di lasciar perire o di conservar la vita alla decima parte del genere umano. S’è interrogata la natura colle sperienze in ogni parte d’Europa da un mezzo secolo in qua, e più di cento mila innestati risanati, liberati dal flagello del vaiuolo, provano in favore dell’innesto. La voce e gli scritti de’ più cospicui medici raccomandano questo nuovo metodo; l’Inghilterra, la Svezia, la Danimarca, la Norvegia, Berna, Genevra, la Toscana, l’Istria profittano di questo prezioso dono del cielo. A questa operazione l’Europa ha veduto sottoporsi i principi reali d’Inghilterra, i principi reali di Danimarca, la casa d’Orleans, il real principe di Parma; un po’ di buon senso basta per farci conoscere che vite sì preziose agli Stati non si avventurano. Se v’è chi in vista di sì chiari argomenti vi si opponga, forza è il dire ch’ei sia di quella parte inferma della specie nostra che s’oppone ai progressi del bene. Gli antipodi e il moto della terra ora dimostrati furono da questa sorta di uomini acremente impugnati. La circolazione del sangue, l’uso dell’antimonio, del mercurio e della china-china ebbero fortissime opposizioni dai medici. Ora sono stabili e uniformi le comuni opinioni su di ciò, né quasi si ricordano le passate dispute che come un anecdoto della storia medica. Oso predire che fra pochi anni ciò accaderà all’innesto pure e che le saggie e ragionevoli persone, prima che il volgo ancora della patria nostra sia istrutto, sapranno profittare in una sì importante e premurosa occasione de’ lumi propri. Resta a desiderarsi che quest’oggetto sia ben noto ai medici, che leggano alcuno de’ molti eccellenti autori capaci di somministrarne idea e che prima di esserne perfettamente instrutti non pronunzino il giudizio loro sopra un punto sì dilicato. Io son contento d’avere imparzialmente cercata la verità, di averla trovata e d’aver proccurato, scrivendola, di presentarla acciocché si acquisti con minor fatica e tempo di quello che ho io dovuto impiegarvi.
P. [Pietro Verri]
Gli autori di questi fogli avvisano che qui termina il loro lavoro, e che se qualche stampatore pubblicherà in avvenire altri fogli del Caffè, saranno opera d’altra mano.
NOTE
[1] Foglio ultimo del tom. I.
[2] Saremo noi sempre gli ultimi ad abbracciare le sane opinioni dell’altre nazioni? Elleno si son corrette; quando ci correggeremo noi? Vi fu bisogno di sessant’anni per farci addottare ciò che Newton avea dimostrato. Noi cominciamo appena ad osar salvare la vita a’ nostri figliuoli per mezzo dell’inoculazione; noi non pratichiamo che da poco tempo i veri principii dell’agricoltura; quando comincieremo noi a praticare i veri principii della umanità ec.? Si potrebbe aggiugnere ch’ebbero lo stesso destino anche la circolazione del sangue dimostrata da Harveo, l’uso della china china e del mercurio, ec.
* Tuttociò che si contiene in questo paragrafo e in tutto questo scritto è diretto contro le false religioni e i legislatori d’esse, e non mai contra la vera religione e il nostro Divino Legislatore.
[3] S’agitò fra i mussulmani se l’ Alcorano fosse eterno, o se creato per dettarlo a Maometto: i dottori decisero che egli era eterno. Essi avevan ragione: questa eternità è molto più bella dell’altra opinione. Col popolo bisogna sempre appigliarsi al partito più incredibile. Volt., Mel., tom. 5, p. 229
[4] Quanto è da preferirsi un Confucio, il primo legislatore fra’ mortali che non usò d’impostura! Egli impiega la ragione, e non la spada e la bugia. Viceré d’una gran provincia, egli vi fa fiorire la morale e le leggi; disgraziato e povero, le insegna. Egli le pratica nella grandezza e nella depressione, rende la virtù amabile, ed ha per discepolo il più antico ed il più saggio de’ popoli. Volt., ibid., p. 232.
[5] Nimirum et hic, et alibi, ut Cicero, Galenus, atque alii notarunt, magna pars stoicarum quaestionum, circa voces consumitur, quod philosopho apprime cavendum est, nam ut verissime dixit scriptor ad Herennium, vitiosum est controversiam intendere propter nominum mutationem. Grot., De iur. bel. et pac., lib. 2, cap. 23. Ubi etiam refert divi Augustini dictum contra Academicos: Turpe disputationibus in verborum quaestione immorari, cum certamen nullum de rebus remanserit.
[6] Per verità egli è un bel viaggio. Ma non è da paragonarsi con quello ch’egli (Maometto) fece quella stessa notte di pianeta in pianeta, e colle belle cose che vide ivi. Pretendeva che vi fossero cent’anni di cammino da un pianeta all’altro, e che egli dividesse la Luna in due. I suoi discepoli, che unirono solennemente dopo la sua morte i versetti dell’Alcorano, stimarono di troncarne questo viaggio del cielo; si lasciarono spaventare, si vede, da’ moteggiatori e da’ filosofi. Quest’era aver troppa delicatezza, e potevan ben fidarsene ai commentatori, ch’avrebbono saputo spiegare l’itinerario… Ma troncando l’itinerario de’ pianeti, lasciarono alcune parole sull’avventura della Luna; non è possibile badare a tutto. Volt
[7] L’autore, che si spiega bastantemente nel progresso, vuole che si sappia ch’egli, in questo suo scritto, intende di parlare de’ soli onesti piaceri.
[8] Tutti i discreti lettori avranno già inteso che qui non si parla d’altra perfezione che della terrena: cioè d’un uomo che volesse essere perfettamente grazioso, perfettamente eloquente, perfettamente dotto ec.
[9] Desaguliers nel suo corso di fisica sperimentale ha dimostrato che l’uomo respira in ogni ora 48000 pollici cubici d’aria, e ne consuma, ossia rende inutile alla respirazione, 1/13 incirca. Gli animali posti sotto ad un recipiente senza che l’aria si muti e ve ne possa entrare della nuova, si muoiono.
[10] Secondo le più esatte osservazioni fatte in molte parti d’Europa, nelle grandi e popolate città tutti gli anni di 28 abitanti ne muore uno; nelle piccole città di 34 abitanti uno; alla campagna di 38 abitanti uno. Bielfeld, Inst. polit., part. 4 chap. 4, § 44.
[11] Derham, Teol. fis., lib. 4, c. 10, not. 9.
[12] Dacché si sono scoperte delle vene lattee intorno agl’intestini, è fuor d’ogni dubbio che la digestione non solo si operi nello stomaco, ma si continui anche in essi.
[13] L’acquavita e lo spirito di vino introdotti nelle vene coagulano il sangue, ma il vino puro naturale non fa questo effetto, rendendo solamente ebrio l’animale e cagionandogli vertigini. Vedi Transact. anglic. Il vino naturale misto con sangue appena sortito dalle vene lo rende più fluido e rubicondo, impedendo che raffreddandosi si ragruppi in una sola massa, come ordinariamente succede. Vid. Puiati.
L’esperienze del Redi hanno dimostrato che quelle cose che mescolate immediatamente col sangue nelle vene sono veleno, come sarebbe il veleno di vipera, non lo sono allorché vi passano colla digestione. Vedansi le Opere di questo autore. Dunque le accennate esperienze del vino e dell’acquavite mescolati col sangue non sono decisive perché li suddetti liquori digeriti nello stomaco cagionino gli accennati effetti nel sangue.
[14] L’esperienza fa vedere che l’aceto o ’l succo de’ limoni misti col latte lo dividono in piccole porzioni coagulate, diversamente di quello faccia quel liquore fatto con lo stomaco di vitella (volgarmente chiamato coagulo) il quale, come ognuno sa, coagula il latte in una sola massa. È parimenti a tutti noto che le carni e le frutta anch’esse in aceto son quelle che meno si putrefanno; e ben lo sanno coloro che manipolano la più gran parte delle malattie dell’uomo nelle cucine, che quelle vivande che già rendono putrido odore, diventano con poca salsa di aceto e limone gustosi cibi de’ più ghiotti o meno delicati palati.
[15] Di cinque parti di cibo che si prendono in un giorno, tre se ne perdono per via di traspirazione, e ciò di estate in un clima poco dissimile dal nostro e in un corpo sano. Vedi Medicina statica del Santorio. La traspirazione di estate è circa il doppio di quella d’inverno, e le urine di estate sono circa la metà della traspirazione, ed in maggior quantità di una quarta o di una terza parte sono quelle rese in inverno di quello sia in estate. Vedi Santor., Gorter, Keill, etc.
[16] Tom. I, fogl. 9, 10, pag. 73 e segu.
[17] Caffè, tomo I, fogl. 8, pag. 64.
[18] Li forastieri che vengono in Italia dicono che gl’Italiani fabbricano le loro case per la sola estate, e che esse altro non sono che di una continua serie di lesenne, non di pareti composte, tante sono le spaziose aperture che trovansi in una sola camera.
[19] La nostra pelle si estende colla forza senza sentir dolore fino ad occupare uno spazio maggiore di una vigesima quinta parte di quello occupi naturalmente. Halles.
[20] V. Halles, Boerhaave etc.
[21] Il signor Redi in una sua lettera dice che dopo avere esperimentati tutti li sudoriferi e li diuretici vantati dalla medicina e dalla chimica, non avea trovato cosa più giovevole che il bere molt’acqua e lo stare ben coperto in un letto ben caldo. Parmi che la buona fede di questo celebre fisico, morto nel secolo scorso, e la di lui diligenza nel fare sperimenti dovrebbe essere di qualche autorità, o dirò meglio, aver luogo di dimostrazione presso li medici del secolo presente.
[22] Vedi Arbutnot, Specimen effectuum aeris in corpore humano.
[23] Uno de’ più eleganti filosofi del nostro secolo così scrisse a questo proposito: Quoi, s’écria, ces peuples enterrent leurs morts dans les mêmes lieux, où ils adorent la divinité? Quoi leurs temples sont pavés de cadavres? Je ne m’étonne plus de ces maladies pestilentielles qui desolent souvent les villes. La pourriture des morts, et celle de tant de vivans rassemblés et préssés dans le même lieu est capable d’empoisonner le globe terrestre.
[24] V. Muschembroeck, Fisica.
[25] Una simile esperienza veggasi nella Storia dell’Accademia delle Scienze di Parigi.
[26] Caffè, t. I, l. cit.
[27] Vedansi le sperienze del signor de la Hire nelle Memorie dell’Accademia di Parigi dell’anno 1699. Secondo le sperienze del signor Amontons, un uomo di ordinaria statura può moversi con qualche velocità, benché pesi tra il carico e il proprio corpo libbre nostre 120 circa. Ivi, anno 1703.
[28] Egualmente prendasi senza timore alcuno la ciocolata, ella è nutritiva e corroborante; ma avvertasi che non sii troppo rara e poco cotta; mentre è facil cosa che in tal caso cagioni delle nausee e delle irritazioni allo stomaco, massime se presa a digiuno; generalmente è sempre più sana prenderla col pane. Al ciocolate crudo non vi famigliarizzate di troppo, né di frequente.
[29] Dalle storie delle pestilenze in questo e nel secolo passato in Germania e altrove, come quella stata a Nimega, descrittaci dal Diemberbroch, e quella stata in Marsiglia, si ricava che gli abitatori di diversi luoghi elevati e abitanti in strade larghe ed esposte ai venti settentrionali scampavano dal contagio. Parimenti appresso gli antichi sono stati sempre riputati dannosi i venti australi e salubri quelli di settentrione, come in specie ce ne assicura Ipocrate, Varrone e Plinio. Il primo tra i nominati, nel libro De morbo sacro, dice: Saluberrimus omnium ventorum Aquilo existit; Auster autem contraria huic operatur. Aristotile ancora, nel settimo dei Politici insegna che le città esposte all’oriente sono salubri, come ancora tutti i venti che spirano da quella parte. Finalmente abbiamo per esperienza che i mali contagiosi poco o niente infestano le città ed i paesi settentrionali. Quindi gli abitanti dei monti sono più alacri, robusti e sani, e relativamente agli altri vivono assai più. Il Cardano, nei commenti al libro d’Ipocrate De aere, aquis et locis, riporta che gli abitanti delle montagne della Libia giungono per la maggior parte ai 100 anni; laddove quelli che abitano quelle pianure non giungono comunemente che all’anno sessantesimo. Certi popoli dell’Africa chiamati Psili con mano armata escivano fuori a combattere contro il vento Austro, tanto lo riputavano pregiudiciale alla loro salute; attestandolo Erodoto nel lib. I e IV. Vedi Sawages, Dissert. intorno gli effetti dell’aria sul corpo umano.
[30] Vedi la risposta del Galileo al problema onde avvenga che l’acqua appaia più fredda allorché vi si immerge, ed in seguito più calda dell’aria esterna.
[31] Il signor Halles ed il signor Sutton in Inghilterra ed il signor Triewald in Svezia furono li primi ad inventare questa macchina utilissima. Il ministero inglese, determinato dalla riputazione del signor Halles, fece costruire un ventilatore nella prigione di Savoia, e si conobbero ben presto i vantaggi grandi che questa utilissima macchina produceva, che furono sì considerabili che in vece di 50 a 100 persone, preda annua della febbre pettecchiale in questa prigione, quando vi si pose in opera il ventilatore, cioè dal principio dell’anno 1749 fino all’ultimo giorno del 1752, quattro sole persone morirono, ed una morì di vaiuolo ed un’altra per intemperanza; comecché in questi tre anni la prigione fusse più ripiena di quello eralo prima della costruzione del ventilatore.
L’effetto del ventilatore nella prigione di Savoia determinò il ministero a farne uno simile nella prigione di Newgate; e mosso da un mulino a vento, gli effetti furono gli stessi, e la lista de’ morti diminuì fin dal primo anno da’ 16 a’ 7. Leggesi nel Gentleman’s Magazine, vol. 23, pag. 75, una dotta discussione sopra i vantaggi grandi che possono ricavarsi da questa macchina ingegnosa. Estratto della letteratura europea, 1764, tomo 4.
[32] Il signor Tronchin, medico genevese, celebre per il felice innesto del vaiolo nel Principe reale di Parma fatto l’anno scorso, ha guarito molte dame in Parigi ed in Ginevra col farle lisciare tutte le mattine i pavimenti di legno de’ loro gabinetti e farle viaggiare su di carri per strade sassose.
[33] Quante belle cose si sono dette da’ nostri barbuti vecchioni per provare che la notte fusse fatta per dormire e ’l giorno per lavorare, e con quale sciocca dabenaggine si sentono ripetere dai papagalli nostri contemporanei. In verità che gli esempi che si adducono per dimostrare il danno alla salute nel fare, come dicono, di notte giorno, e di giorno notte sono convincenti. Lo saranno forse per essi, per me no certamente. Il disordine della salute di chi passando tutte le notti al giuoco, il giorno alla toletta, al pranzo, alle visite, non ha conseguentemente ora certa per dormire, non sarà mai una dimostrazione di ciò per un uomo ragionevole.
[34] Nelle Memorie e nella Storia dell’Accademia delle Scienze di Parigi vi hanno molti esempi de’ mali cagionati dal verderame lasciato da’ vasi di cucina ed immischiato con le vivande. Fra gli altri ve n’è uno d’una donna morta cogl’intestini forati per aver mangiato poche ore prima del fegato fritto in una padella di rame. Veggasi la Nouvelle bigarure, janvier 1754; dove si ha la descrizione e l’approvazione e l’esperienze de’ deputati dell’Accademia delle Scienze di Parigi per la vera maniera di fabbricare gli utensili di cucina de fer battu à froid, et blanchi; invention du sieur de Pomery.
[35] La morale è quella scienza che non ha altro oggetto che le relazioni tra uomo e uomo; e siccome queste, s’egli non ha voluto essere solo ed isolato, sono state quelle che per necessità ha dovuto prima d’ogn’altra cosa conoscere, così la morale è la scienza più dell’altre vicina alla sua perfezione. Ma non così è la fisica, la quale non è appoggiata che a’ fatti, che per lo più sfuggono dal diligente esame del più industrioso. Perciò vedesi perché li proverbi popolari sieno ordinariamente esattissimi e veri in genere di morale, ma erronei e contrari all’esperienza allorché riguardano le cose fisiche.
[36] Il mezzo più utile per umettare interiormente le viscere si è il clistere di quando in quando d’acqua pura e fredda, ossia del grado temperato dell’aria esterna. Esso ridona alle fibre degl’intestini la naturale loro elasticità. Ma guardisi dall’usarne per proccurare le evacuazioni. Elleno, generalmente ed ordinariamente parlando, non devono mai essere, senza positiva necessità, eccitate a forza.
[37] È dunque un errore comune il credere che a’ vecchi sia più che in altra età necessario il vino ed altri liquori spiritosi.
[38] Vedi Memorie dell’Accademia delle Scienze di Parigi.
[39] Il burro di cacao ha un ontuoso leggiero e non crasso, imperocché egli è vegetabile e non animale, ed è l’unico che può arrischiarsi sulla nostra pelle per ammollirne le fibre, allorché fossero troppo secche, o per impedire che lo diventino.
[40] Il signor Redi ha bensì mostrato che il tabacco può essere in alcune occasioni velenoso e dannoso se passa nello stomaco, ma non ha provato in qual maniera preso pel naso possa cagionare gli accidenti capitali, come credesi dal volgo, e che pure seguita a prenderne e ne prenderà ancora immoderatamente.
[41] Bocaccio, gior. 8, num. 3.
[42] G. 3, in fine.
[43] G. 2, n. 10.
[44] G. 7, n. 9.
[45] G. 1.
[46] G. 1. n. 3.
[47] G. 8, n. 2.
[48] G. 2, n. 9.
[49] G. 1, n. 7.
[50] G. 1, n. 2.
[51] G. 2, n. 8.
[52] G. 2, n. 3.
[53] G. 1, n. 3.
[54] G. 5, n. 3.
[55] G. 9, n. 5.
[56] G. 1, n. 4.
[57] G. 2, n. 6.
[58] De liberis educandis.
[59] De charlataneria eruditorum.
[60] La buona madre, ossia la scelta del marito.
[61] Il signor Diderot parlando di Terenzio dice ch’egli non si prendeva gran pensiero di legare insieme le scene delle sue commedie. Il laisse le théatre vuide, dit-il, jusqu’à trois fois de suite, et cela ne me deplait pas, sur tout dans les derniers actes: ces personages qui se succedent et qui ne jectent qu’un mot en passant, me font imaginer un grand trouble. Essendo in questo di diverso parere, io non intendo però di dire che non vi possino essere circostanze che lo permettano, anzi lo consiglino; ma egli è facile il distinguerle, ed in tal caso diventerà una bellezza quella che sarebbe stato un difetto.
[62] Quel ouvrage qu’un plan, contre le quel on n’auroit point d’objection! Y en a-t-il un? Plus il sera compliqué, moins il sera vrai. Did., pag. 225, tom. 2 Oeuvres de théatre.
[63] Il divorzio felice.
[64] Et j’ajouterai qu’il y a bien de la difference entre peindre à mon imagination, et mettre en action sous mes yeux. On fait adopter à mon imagination tout ce qu’on veut; il ne s’agit que de s’en emparer. Diderot, pag. 233, tom. 1 Oeuvres de théatre.
[65] S’introducono, è vero, sulla scena le descrizioni ed i racconti, ma questi non sono che episodi, e non formano parte dell’azione.
[66] Monsieur Voltaire.
[67] V’è chi pretende ch’ogni sorta di monologo sia fuor di natura, e per conseguenza da proscriversi, perché la passione, dicono, le circostanze possono bensì strappare poche parole, ma chi è quel che faccia con se stesso un discorso seguito e regolare? Monsieur Diderot appoggiato alla propria esperienza non sembra di questa opinione, ed io inclinerei forse nel di lui sentimento; ma se la cosa può dirsi questionabile quanto a’ soliloqui, come poi giustificare gli a parte, che oltre l’inconveniente che si oppone ai primi, portano poi l’altra inescusabile inverosimiglianza, vorrei dire l’assurda supposizione, che debbano essere intesi da’ spettatori e non dagli attori? Quanto sarebbe dunque desiderabile che si seguitasse il proposto consiglio di sostituirvi la pantomima.
[68] Lo stesso signor Diderot dice altrove con più forza ancora: Est il possible qu’on ne sentira point que l’effet du malheur est de rapprocher les hommes, et qu’il est ridicule sur tout dans les moments de tumulte, lorsque les passions sont portées à l’excès, et que l’action est la plus agitée de se tenir en rond, separés, à une certaine distance les uns des autres, et dans un ordre symetrique?
[69] Giustino, lib. 22.
[70] Luciano, Dell’astrologia.
[71] Macrobio ne’ Saturnali, lib. I, c. 6.
[72] Paracelso, Paragran., tract. 2.
[73] Nel suo trattato De natura rerum.
[74] Prefazione al Paragran.
[75] De subtilitate, lib. 18.
[76] Filosofia occulta, lib. 1, c. 15.
[77] Popoli selvaggi della Nuova Francia.
[78] Lib. 2, c. 17.
[79] Svetonio lo attesta in Augus., cap. 90.
[80] Istoria dell’Accadem. delle Scienze, anno 1712, p. 24.
[81] Plin., lib. 2, c. 98.
[82] Aelianus, De animalibus, l. 4, c. 46; Plin., lib. 7, cap. 2, et alii etc.
[83] Solino, Pomponio Mela ec. ed altri.
[84] Appresso Cicerone, De divinat., lib. 2.
[85] Lib. 9.
[86] Plutarch., De musica.
[87] Apud Athen., Deipnos., lib. 14.
[88] Apud Aul. Gellium, l. 4, c. 13.
[89] Omero nell’Odissea, III, 266.
[90] Problem., 30, q. 1.
[91] In oraculorum defectu.
[92] In Boëot.
[93] H. N., l. 2. c. 93.
[94] Cicerone, De divinat., l. 2. Mars. Figi., Theol. platonica de immortal. anim., lib. 3, c. 2.
[95] Pomponazio.
[96] Plin., H. N.
[97] Atlas historique, tom. 6, Diss. sur le Congo.
[98] Idem, vol. 6, Diss. sur la Caffrerie.
[99] Idem, tom. 5, Diss. sur la grande Tartarie.
[100] Erodoto, Melpomene.
[101] Le Pere Laffiteau, Meurs des sauvages de l’Amerique.
[102] Tacit., De moribus Germanor.
[103] Esprit des loix, liv. 20, chap. 2.
[104] Essais de Montagne, to. 2, pag. 372.
[105] Plato in Gorgia.
[106] Montesquieu, Esprit des loix, to. 2, liv. 20, chap. 4.
[107] La cagione dell’errore verisimilmente si è che questo animale tiene due grosse vesciche le quali preme co’ piedi, e da esse fa sortire un certo liquore di cui si serve per ingrassare il pelo, ed ancor di rimedio quando abbia perduto l’appettito. Tal materia è detta castoraceum, di cui ne parlano tutte le farmacopee.
[108] Il Bellone, il Gesner, l’Amato, il Rondelletto, il Mattioli ed altri hanno fatto l’anatomia a questo animale, e si sono convinti della impossibilità.
[109] Questa falsa opinione, dopo di esser passata dai geroglifici egiziani nella mitologia dei Greci e nelle favole di Esopo, è stata insensibilmente ricevuta come una verità fisica. Il signor di Bouffon si è ingannato nell’attribuire ad Eliano l’invenzione di tal favola.
[110] Nam virtus medium est vitiorum, et utrinque reductum.
[111] Diog. Laerz., Vita di Zenone; Seneca, Epist. l. 3.95 etc.
[112] Seneca, lib. quod in sapientem non cadit iniuria, cap. 7 et epist. 123.
[113] Platone, nel secondo libro della Repubblica. Cicer. etc
[114] Apud Diog. Laert., in Aristot., et ap. Stobaeum, serm. 1.
[115] Diogene Laerzio nella Vita di Epicuro.
[116] De vita beata, cap. XIII.
[117] I. N., VII, 2.
[118] Lib. 2, c. 6, § 3.
[119] Lib. 3, c. 4, § 9.
[120] Lib. 3, c. 5, § 1.
[121] Lib. 3, c. 7, § 3.
[122] Lib. 3, c. 7, § 7.
[123] Si parla in questo scritto della giustizia coi soli principii dell’umana filosofia, non di quella giustizia che appartiene all’uomo considerato come dipendente dall’Essere creatore. Non conviene sì alto soggetto a fogli periodici.
[124] Heu quantum descivit secutis dein saeculis a prisca gloria medicina, quam turpiter ab efficacissimo artis magistro usu ad figmenta ludentis ingenii defecit! Damnosa quid non imminuit inertia dum ab laboriosa observatione ad philosophorum placita, ab dictatis naturae ad garrulitatem, ab Hippocratis effatis ad libidinem fingendi devolutam dolemus. Boerhaave.
[125] On ne trouve dans les ouvrages de Sydenham l’oracle de tous les bons medecins, spécialement dans la petite vérole que des faits et des observations, et l’aveu de son ignorance tant sur la nature de la maladie que sur les causes de la plûpart de ses symptomes. Boerhaave qui a poussé l’étude des causes dans la medecine plus loin qu’aucun autre, et qui avoit lù plus de mille auteurs sur la petite verole, declare qu’il n’a rien à ajouter à ce que Sydenham en a dit, et se renferme comme lui dans la description des faits et dans l’observation. Le commun des medecins au contraire n’ignore rien: c’est d’après la connoissance de causes qu’ils raisonnent de la petite vérole, et ce qui est encore plus c’est d’après cette connoissance qu’ils parlent de l’inoculation. (Réflexions sur les prejugés qui s’opposent aux progrès et à la perfection de l’inoculation, par M. Gatti, medecin-consultant du Roi et professeur en medecine dans l’Université de Pise, Bruxelles 1764, pag. 14 e segu.).
[126] Mead, De variolar. et morbill., cap. I.
[127] Disputationes ad morbor. historiam et curationem quas collegit Albertus Hallerus, tom. V, pag. 698.
[128] Lettre à Mr. Haen, par Mr. Tissot, pag. 97.
[129] Lettres edifiantes et curiéuses des missionaires, Recueil XX, pag. 304.
[130] Millin, De variolar. inoculatione.
[131] Kirkpatrick, The analysis of inoculation, pag. 92 e 93.
[132] Giornale di Trevoux, 1715.
[133] L’uso d’innestare al dì d’oggi è comune anche ai mussulmani, e si è introdotto perfino nelle repubbliche barbaresche sulle coste d’Africa, come ne attestò Cassem Aga, inviato di Tripoli nell’Inghilterra. Recueil de pieces concernant l’inoculation, Paris 1755, pag. 138.
[134] Così è il titolo del suo libro: Nova et tuta variolas excitandi per transplantationem methodus, stamp. in Venezia nel 1713.
[135] Emanuel Timoni, Epistola ad Joannem Woodward, 1713, trasmessa alla Reale Società di Londra.
[136] De cognoscendis morbis, pag. 150.
[137] Lettre de Mr. de la Condamine à Mr. Maty, pag. 39.
[138] Philosophical Transactions, num. 339 e 347.
[139] Ecco quanto ne dice egli stesso: Quum anno 1721 Regis nostri clementissimi iussu tam familiae suae, quam Reipublicae gratia in septem capite damnatis faciendum erat experimentum an tuto satis immiti possent per insitionem variolae, facile impetravi ut in uno saltem mihi liceret Sinensium morem tentare. Erat ex numero illorum, qui ad hanc rem selecti erant adolescentula quaedam annorum circiter octodecim cuius in nares quum penicillum pure ex maturis pustulis madefactum inde curassem eventus quidem respondit, nam pariter ac caeteri qui facta incisione in cute contagium contraxerant aegrotavit, et incolumis evasit; graviora tamen omnia passa est, statim a recepto naribus veneno accutissimis capitis doloribus cum febre ad pustularum usque eruptionem nunquam intermittente misere discruciata etc… vidi. Multo maiori cum periculo tentari sinicam hanc quam graecam morbum transferendi viam; laedunt enim vehementer cerebrum morbidae particulae per spiritum attractae propter viciniam eius nervis qui olfactui inserviunt. (Richardi Mead Opera medica, lib. 2; De variolis et morbillis, lib. V).
[140] Maitland’s account of inoculating the small pox, London 1722.
[141] De byzantina variolarum insitione Dissertatio medica, Lugduni Bat. 1722.
[142] Lettre de Mr. de la Condamine à Mr. le dr. Maty, Paris 1764, pag. 2 e segu.
[143] Inoculationi Parisiis irrumpere gestienti acerrimum motum est bellum. Millin, De variol. inoculat. Ivi leggesi che da alcuni sostenevasi la tesi che variolas inoculare nefas.
[144] Il signor Boerhaave ne’ suoi scritti del 1726 e 1727 raccomandava l’innesto appoggiato alle osservazioni del signor Sherard di cui aveva molta opinione, e di ciò ne fanno fede i quinternetti del signor Haller, che scriveva le lezioni del suo gran maestro in quegli anni, come può leggersi presso il signor Tissot, Lettre à Monsieur de Haen, Lausanne 1759, pag. 16. Anche nelle opere pubblicate dal signor Boerhaave può conoscersi ch’egli approvava l’innesto. Veggansi Aphorism. de cognosc. et cur. morb., § 1403, dove dice prophilaxis insitiva videtur satis certa, tutaque. Il signor Tralles, nella sua opera De methodo medendi variolis, dice: Me quod attinet cum adhuc studiosus essem medicinae a praeceptoribus et lipsiensibus et halensibus inoculationem non saltem non reiectam, sed laudatam et magnificatam optime memini, atque tum Fischeti et Vateri germanicorum medicorum encomea ipsi tributa egi, et ab optimo praeceptore Hoffmanno discipulis commendatam audivi, qui publice quoque eam commendare non dubitavit.
[145] Journ. encyclopedique, may 1764, pag. 25.
[146] Journ. encyclop., novembre 1763, pag. 73.
[147] Disputationes ad morborum historiam et curationem quas collegit Albertus Hallerus, tom. V, pag. 701 et sequ.
[148] Giornale britanico, novembre e dicembre 1755, tom. XVIII, pag. 484 e Orat. harveian. del dottor Taylor, pag. 52.
[149] Sermon preached before the President etc., London 1756.
[150] The case of receiving the small pox by inoculation, impartially considered in a religious view by D. Some etc., and published by P. Rodrige.
[151] Lettre de Mr. de la Condam. à Mr. le Docteur Maty, pag. 2 e segu. e pag. 97.
[152] Lettre de Mr. de la Condam. à Mr. Maty.
[153] Buttini, Traité de la petite vérole communiquée par l’inoculation.
[154] Manetti, pag. 23 e segu.
[155] Seconda memoria di Mr. de la Condamine.
[156] Manetti, pag. 22 e segu.
[157] Memoire sur l’inoculation.
[158] Manetti, pag. 29.
[159] Relazioni d’innesti del vaiuolo fatti in Firenze, distese dal dottor Giovanni Targioni Tozzetti.
[160] Lettera del signor dottore Ranieri Gamucci, inserita nelle Novelle letterarie dell’anno 1756, pag. 806.
[161] Nuova scoperta a felicemente suscitare il vaiuolo per artificiale contatto. Vid. Novelle letterarie, 1759, pag. 149.
[162] Journ. oeconom., mois de juin 1756.
[163] Collec. halleriana, tom. V, pag. 701 e segu.
[164] Memoir. de l’Academ. des Sciences, 1758, pag. 449.
[165] Lettre de Mr. de la Condamine à Mr. Maty, pag. 10.
[166] La Condamine, Lettre à Maty, pag. 145; Memoir. de l’Acad. des Sciences, 1758, pag. 454; Mercure, mars, pag. 169.
[167] Novelle letterarie, 1760, pag. 319.
[168] Journ. encyclop., octobre 1763, pag. 40.
[169] Journ. encyclop., 1° juillet 1763, pag. 75.
[170] In variolarum inoculationem dissertatio epistolaris nobili sapienti viro D. Sylvestro Antonio Ponticelli comiti Farnatae ec., Franciscus comes Roncalli Parolinus, Brixiae, 4 Januarii 1759.
[171] Veggansi le Novelle letterarie, 1759, pag. 155 e segu. ove trovansi che il fondamento delle opposizioni del signor dottor Bianchi è questo ch’ei chiama effatum philosophicum, cioè che quidquid recipitur, ad modum recipientis recipitur.
[172] Le obbiezioni ch’io sono per riferire sono state eccellentemente sciolte già dai signori Buttini, Traité de la petite verole communiquée par l’inoculation; Tralles, De methodo medendi variolis hactenus cognita saepe insufficiente etc.; Kirkpatrick, The analysis of inoculations; De la Condamine, Memoire etc.; Tissot, L’inoculation et Lettre à Monsieur de Haen; James Burges, An account of the prepar. and menagement necessary to inoculation. Veggansi le opere dei celebri medici Joachim, Pizzorno, Jurin, Langrisch, Tronchin, Mead, il Tableau de la petite verole. Molti giornali altresì d’Europa: Année litteraire, 1755, tom. V, pag. 261 e 288, tom. VI, pag. 27 e 48, tom. VII, pag. 66 e 72; Journal des sçavans, octobre 1755; Journal etranger, fevrier 1756, pag. 127 e 144; Journal britanique, novembre e decembre 1755, pag. 483 e 484. Veggansi le Memoires de l’Academie des Sciences, 1758, pag. 451 e seguenti. Veggansi Miscellanea medica, authore R. Taylor, Londini, apud J. Nourse, 1761, ed altri ancora che hanno sciolte, molt’anni sono, le obbiezioni che tutto dì si ripetono.
[173] Atti dell’Accademia delle Scienze di Siena, tom. I, pag. 185.
[174] Le opere de’ medici Ahron, Isaac, Bachtishua, Abubaker, Haly Abbas, Avicenna, Forestus, Platerus, Rembert, Sennert, Prospero Alpino, Primeroso, Riviere, Diemerbroek, Sebisius, Fernel, Tulp, Sorbait, Villis, Sydenham, Hofman, Baglivi, Ramazini, Riedlin, Helvetius, Roger, Hillary, Hahn, Haller, Clerghorn, Winter, Juncker, Horrebow, Muratori, tutte provano che il vaiuolo naturale è una mortale malattia.
[175] “Morbus qui universos cuiuscumque aetatis mortales fatali quadam necessitate involuit, qui decimam generis humani partem demetit”. Disputationes ad morbor. histor. et curat. facientes, quas collegit Albertus Hallerus, tom. V, pag. 697.
[176] Relazione del signor Jurin pubblicata a Londra nel 1723 e tradotta in francesa da monsieur Noguez, Parigi 1725.
[177] Jurin’s Letter to Dr. Crotesworth containing a comparison between the mortalities of the natural small-pox and that by inoculation. Veggasi pure il signor Maytland, il quale ci dà una idea della mortalità per il vaiuolo ne’ paesi caldi.
[178] Kirkpatrick, The analysis of inoculation, pag. 109, ci attesta come nell’epidemia che venne nella Nuova Inghilterra l’anno 1721, 5759 furono ammalati per il vaiuolo naturale, e 844 ne perirono.
[179] Lettera del signor Mather inserita in vari giornali, in cui vedesi che nell’epidemia del 1760, 6000 persone ebbero il vaiuolo naturale, e 900 ne perirono. Ved. Manetti, pag. 8 e seguent.
[180] Recueil des pieces concernant l’inoculation de la petite verole, pag. 62, 88 e 131.
[181] Relation des succès de l’inoculation précedée d’un discours preliminaire par Monsier Noguez, medecin de Paris.
[182] Trattato dell’inoculazione del vaiuolo del signor Schulz, tradotto dallo svedese nel tedesco dal signor Murray.
[183] Buttini, Traité de l’inoculation, Paris, chez Herissant, pag. 53.
[184] “Licet variolae nemini parcant observatione constat tres, aut quattuor ex hominibus centum ab his immunes per totam vitam esse”. Disput. ad morborum hist. et curat. quas collegit Albertus Hallerus, tom. V, pag. 704. Vid. Jurin, Relat. des succès de l’inoculation, pag. 9; Richard Mead, Opera, Parisiis 1751, De variol. insit., pag. 343; Buttini, Traité de la petite verole communiquée par inoculation, cap. 3; Guiot, Memoire sur l’inoculation; Sydenham, cap. 2, pag. 21; Cantwel, Disserta. sur l’inoculation, cap. 74 e 77.
[185] Kirkpatrick, pag. 106 e 108.
[186] Manetti, pag. 98.
[187] Lettera del Sig. Dottor Manetti al Sig. Dottore Casagrande, Firenze 1762, p. 37.
[188] Il dottore Werlhoff, De variol. et anthrac., asserisce che una fanciulla ricevette il vaiuolo per una lettera scrittale da suo fratello, che dimorava assai discosto, ma in mezzo all’infezione del vaiuolo. Nello spedale dell’innesto in Londra non si lasciano entrar le lettere agl’innestati prima che il vaiuolo non sia schiuso per tema che non ne contraggano un vaiuolo naturale. Journal encyclopedique, juillet 1763, pag. 82. Un uomo ha contratto il vaiuolo naturale per esser stato semplicemente in una stanza, dove tre mesi prima v’era stato uno col vaiuolo: Kirkpatrick, pag. 167.
[189] “Neutiquam in dubium vocare volo auctorum duplices variolas asserentium testimonia; ego saltem in mea praxi tale exemplum non vidi, neque etiam a collegis meis recordor. Novi bene spurias variolas aliquoties pro veris habitas a matronis sapere volentibus, quibus moleste contradixi. Credo etiam decipi posse medicum ut spurias pro veris benignis habeat”. Tralles, De methodo medendi variolis hactenus cognita saepe insufficiente magno pro inoculatione argumento, Bratislaviae 1761. Vid. Kirkpatrick, pag. 30; Verner, Dissertatio causam cur homines semel tantum variolis veris et morbillis corripiantur adumbrans, Koenigsberg 1760.
[190] “Presque tous les medecins établissent que quand on a eu une fois cette maladie on en est exempt pur toujours; il y a cependant quelques exemples du contraire, mais en tres-petit nombre”. Lettre à Mr. Haen par Mr. Tissot, pag. 108.
[191] “Obiiciunt variolis per artem excitatis functos iisdem tamen communi naturae via denuo laborare. Ast fatendum est id si verum sit tam raro usu venire ut inter mille inoculationem passos vis unum numeres. Ergo ne una aut forsitan altera observatio in normam statim ducetur?” Millin, De variol. inoculat., in Collect. halleriana, tom. V, pag. 710.
[192] “Experientia compertum est nunquam iterum reverti posse variolas, et vix millesimum quemque eas per totam vitam effugere… quod ad illos autem spectant, qui variolis arte factis perfuncti iis tamen denuo laborasse dicantur, ipse profecto summa licet diligentia adhibita ne unum quidem documentum quo id satis constaret adhuc rescire potui”. Richardi Mead Opera medica, lib. De variolis et morbillis, cap. V, De variolarum insitione.
[193] Veggasi la Lettera di Mr. de la Condamine al Sig. Dottor Maty, pag. 57.
[194] Manetti, Della inoculazione del vaiuolo, pag. 87 e segu.
[195] Il dottore Wagstaffe, il dottore Blankmor e lo speziale Massey hanno divolgate diverse favole per discreditare l’inoculazione, giugnendo a segno di nominare le persone dei Lordi Plunker, Preston, Grafton e Kanoues. Fu scoperta l’impostura, e dovettero farne una pubblica ritrattazione. V. Manetti, pag. 89. Il signor Wags taffe fu convinto dal signor dottore Jurin coll’attestato del padre istesso di quella fanciulla che veniva citata per esempio del ritorno del vaiuolo, e l’attestato assicura sul suo onore e coscienza che la fanciulla non ha mai avuto altro vaiuolo che l’innestato. V. Account for the Year 1742. Il signor Cantwel suppone un fatto sul conto di Milord Montjoye, ed è convinto d’impostura dal signor dottor Maty, Journ. etranger, fevr. 1756, pag. 140. Fu spacciato da alcuni che ad uno innestato dal signor dottore Nettleton fosse di nuovo venuto il vaiuolo naturale, il che si disse pure del figlio d’un certo Jones; e queste due menzogne furono pure autenticamente smentite con una pubblica protesta inserita nelle opere del signor Kirkpatrick, pag. 123, e con una lettera dello stesso Jones diretta al signor Jurin. Anche per la Toscana s’era sparsa una favola sul ritorno del vaiuolo ad uno innestato dal signor Cei, ma fu smascherata classicamente co’ più solenni attestati: ved. Manetti, pag. 89. Troppo sarebbe lungo il catalogo delle menzogne evidentemente smentite, colle quali non hanno arrossito il comparire al pubblico alcuni oppositori dell’innesto, i quali hanno provata la loro insigne malafede in faccia all’Europa tutta, e screditata la loro causa.
[196] Journal britanique, 1754.
[197] Veggasi la prima memoria di Mr. de la Condamine. pag. 25 e segu.
[198] Manetti, pag. 96 e segu.
[199] Gazetta di Sciaffusa, n. 11, e molti altri fogli pubblici.
[200] Manetti, Lettera al Sig. Dottor Casagrande, Firenze 1762, pag. 43.
[201] Réflexions sur les préjugés, qui s’opposent aux progrès et à la perfection de l’inoculation par Mr. Gatti, médicin-consultant du Roi et professeur en médicine dans l’Université de Pise. Se vend à Paris, chez Musier fils libraire, Quai des Augustins, 1764.
[202] Nel vaiuolo naturale tanto è men grave il pericolo, quanto minore è il numero delle bolle che compaiono sul viso: Animadvertendum est autem hunc magnum aestimari non pro variolarum frequentia quae reliquum corpus, sed pro earum numero tantum quae faciem obsedere. Sydenham, Observat. medic., sect. 3, cap. 2, pag. 22, colonn. 2.
[203] Lettre du Docteur Hadow au Docteur Pringle. Recueil periodique d’observations de medicine, 1755, tom. 3, pag. 341.
[204] Origine, progrès et registres de l’Hospital de la petite verole naturelle et inoculée depuis le 26 septembre 1746 époque de sa fondation, jusqu’au 24 mars 1763.
[205] Millin, De variolar. inoculat., e Kirkpatrick, pag. 110.
[206] Manetti, Dell’inoculazione del vaiuolo, pag. 15.
[207] Manetti, loc. cit.
[208] Collect. halleriana, tom. V, pag. 709.
[209] Richardi Mead Opera, cap. V.
[210] Lettre de Mr. de Beaux à Mr. de la Condamine.
[211] Kirkpatrick.
[212] Manetti, pag. 15.
[213] Parole del signor Manetti, pag. 29.
[214] Manetti, pag. 30.
[215] Lettera del Sig. Dottore Gio. Paolo Centenari chirurgo di Pirano al Dottor Gio. Paolo Pellegrini, 27 dicembre 1759, stampata in seguito delle due Memorie del Sig. de la Condamine, Venezia, presso Deregni, 1761, pag. 112.
[216] Lettre de Mr. de la Condamine à Mr. Maty, pag. 91.
[217] Lettre à Mr. Belletête doyen de la Faculté de medicine à Paris, par Mr. Razoux, docteur en medicine de l’Université de Monpellier.
[218] Lettera del Sig. Manetti al Sig. Casagrande, pag. 31.
[219] Manetti, pag. 33.
[220] Lettera di Mr. Amyand, riferita da Mr. Coste in sua lettera al Sig. Dodard a Parigi, 1723, pag. 68, e Mr. de la Condamine, prima Memoria, Venezia 1761, presso Deregni, pag. 7.
[221] Graunt, Observations made upon the bills of mortality; Petty, Observations upon the Dublin bills of mortality; Halleius, Philosoph. Transact., 1689; Deparcieux, Essai sur la probabilité de la vie humaine; Gesnerus, De termino vitae; Buffon, Hist. naturelle; e altri.
[222] Lettre sur l’état présent de l’inoculation en France, de Mr. de la Condamine à Mr. le Docteur Maty, pag. 64.
[223] Ciò viene attestato da tutti gl’inoculatori, e tra gli altri dal signor Schultz, il quale ha assistito a un prodigioso numero d’innesti e nell’Inghilterra e altrove, nel suo Trattato dell’innesto del vaiuolo. Ved. Journ. encyclopedique, juillet 1763, pag. 84.
[224] Timoni, Pilarini, Jurin, la Coste, la Montraye, Viaggi di Circassia, ec.
[225] Manetti, Lettera al Sig. Dottor Casagrande, pag. 40.
[226] Novelle letterarie, 1760, pag. 319 e segu.
[227] Gazetta oltramontana ristampata in Venezia in data 3 giugno 1762, e Lettera del signor dottor Manetti al Casagrande, pag. 44.
[228] Veggasi il signor Schulz, e il Giornale enciclopedico, luglio 1763, pag. 80.
[229] “Cuiusvis aetatis ab anno quinto ad trigesimum, idque tam felici successu ut quum maximam partem essent Aetiopes ne unus quidem periret; quamquam enim Americani omnes pestilentia hac correpti gravissime semper laborent, maius tamen ab ea periculum Afros subire experientia notum est”. Richardi Mead Opera medica, lib. 2, De variolar. insitione.
[230] Trattato dell’inoculazione del vaiuolo, tradotto dallo svedese, Journ. encyclopedique, juillet 1763, pag. 78.
[231] Relazioni d’innesti del vaiuolo fatti in Firenze nel 1756, distese dal signor dottor Gio. Targioni Tozzetti, pag. 6, not. 4.
[232] Atti dell’Accademia delle Scienze, tom. I, pag. 180.
[233] Lettera del Sig. Dottor Centenari al Sig. Dottor Pellegrini, stampata in Venezia per Deregni, pag. 112.
[234] Lettre de Mr. de la Condamine à Mr. Maty, pag. 91.
[235] La Condamine a Mr. Maty, pag. 112. Aggiungo un paragrafo di lettera scritta dal signor Cei da Livorno al padre Frisi in data del 21 gennaio 1765. Così egli: Alla domanda ch’ella mi fa se l’innesto possa essere più rischioso nello stato di gioventù che nella più tenera e fresca età, replico che l’inoculazione del vaiuolo porta sempre un bene assoluto a qualunque età, potendo questo rilevarlo dalle proprie conoscenze e da tutte le istorie che abbiamo dell’innesto, per le quali si contano infiniti adulti innestati che con eguale felicità hanno assicurato la loro vita, occhi, bellezza ec. dalla mortifera potenza del vaiuolo naturale. A questo proposito una relazione ben significante me ne ha dato giorni sono il signor Roberto Ruterfurt, mio e suo stimabilissimo amico. Mi dice, dunque, che un capitano, proveniente ora dalla Nuova Inghilterra con carico di taluni alla sua consegna, gli ha raccontato che l’anno passato assieme con la sua moglie e una brigata d’amici e parenti, in numero di venticinque, si partirono tutti insieme per andare a trovare un medico loro vicino per farsi innestare il vaiuolo. Questo fu ad essi tutti in un giorno inoculato dopo averli precedentemente purgati, e tutti, nella medesima casa abitando, ebbero il piacere di trovarsi ben contenti della loro gita; ella servì ad essi per assicurare le loro vite dal mortifero tributo del vaiuolo, e come una piacevolissima villeggiatura. Questo medico prese il nome e cognome di ciascuno per inserirlo nel catalogo de’ suoi innestati, che allora era al numero di cinque mila e parecchie centinaia, colla contentezza di numerarne soli due dei morti. Il mio catalogo ne compone sin ora delle centinaia fatti in Livorno, Pisa e sua campagna, senza il dispiacere che alcuno mi sia perito. La ragione e la sperienza, gran maestra delle cose, adagio adagio va conducendo gli uomini ai doveri di umanità ed indebolisce la stupida ignoranza dei nemici dell’innesto, senza dei quali il mortifero vaiuolo naturale avrebbe cessato di affliggere (mediante questa divina invenzione, che già da cinquant’anni la nostra Europa conosce) la infelice e povera specie umana ec.
[236] Manetti, pag. 87.
[237] Manetti, pag. 48 e segu.
[238] The practice and theorie of inoculation with an account of its success in a letter to a friend, London 1749.
[239] An account of the preparation and manegement necessary to inoculation, London 1754.
[240] The analysis of inoculation.
[241] Journ. encyclop., juillet 1763, pag. 80.
[242] Atti dell’Accademia delle Scienze di Siena, tom. I, pag. 35.
[243] Atti dell’Accademia delle Scienze di Siena, tom. I, pag. 72.
[244] Réflexions sur les préjugès qui s’opposent aux progrés de l’inoculation, pag. 72.
[245] Nov. letter., anno 1759, pag. 528.
[246] Manetti, pag. 78.
[247] Relazioni d’innesti di vaiuolo fatti in Firenze, 1756.
[248] Atti dell’Accademia delle Scienze di Siena, tom. I, pag. 174 e segu.
[249] “Phrenitis nonnumquam aegrum corripit”. Sydenham.
[250] Veggasi tra i molti la Storia d’innesti fatti dal signor dottor Francesco Caluri; ivi gl’innestati nelle braccia tutti lagnavansi di certi dolori lancinanti all’ascelle.
[251] Craftman, foglio periodico di Londra, 1761, num. 334; e Journ. encycloped., novembre 1763, pag. 66.
[252] Magazino inglese degli anni 1754, vol. XXIV, e 1755, vol. XXV.
[253] “A propos de la maladie, je vais vous apprendre une chose qui vous fera désirer d’être ici. La petite vérole, si générale et si cruelle parmi nous, n’est qu’une bagatelle dans ce pays par le moyen de l’inoculation qu’on a découverte (c’est le terme dont on se sert). Il y a une troupe de vieilles femmes dont l’unique métier est de faire cette opération. Le tems qui lui est le plus propre est au commencement de l’automne, lorsque le grand chaud est passé. Les chefs des maisons s’envoient demander les uns aux autres s’il y a quelqu’un dans leur famille qui veut avoir la petite vérole; on n’assemble plusieurs et, lorsque le nombre se monte à 15 ou 16, on fait venir une de ces vieilles femmes, qui apporte de la matière de petite vérole de la meilleure espèce plein une coquille de noix. Elle demande quelle veine on veut se faire ouvrir; et, d’après la réponse, elle en ouvre une avec un grande aiguille qui ne fait pas plus de mal qu’une égratignure, et y introduit autant de matière qui elle en peut prendre avec la tête de son aiguille: elle lie ensuite la plaie en y appliquant un petit morceau de coquille: elle fait la même opération à quattre ou cinqu’autres veines. Les Grecs ont ordinairement la superstition d’en ouvrir une au milieu du front, une à chaque bras, et une sur la poitrine pour imiter le signe de la croix; mais cette pratique a un très mauvais effet, parce qu’il reste des cicatrices à toutes ces petites plaies. On ne se fait ordinairement ouvrir les veines, pour cette opération, que à des parties du corps qui sont cachées, comme aux jambes ou aux bras. Les enfans qui ont fait l’inoculation jouent et se portent bien pendant huit jours, au bout des quels la fièvre les prend; ils gardent alors le lit deux jours, rarement trois; ils n’ont ordinairement que vingt ou trente grains au visage, qui ne marquent jamais. Enfin, au bout de huit jours, ils se portent aussi bien que s’ils n’avoient pas été malades. Les plaies qu’on leur a faites jettent beaucoup pendant leur maladie; ce qui attire sans doute le venin de la petite vérole, et l’empêche, de se répandre ailleurs avec violence. On fait tous les ans cette opération à des milliers d’enfans, et l’ambassadeur de France dit qu’on prend ici la petite vérole par amusement, comme ailleurs les eaux. On n’a vu mourir ici personne de l’inoculation: et je suis si convaincue de la bonté de cette opération, que j’ai résolu de la faire faire à mon cher petit enfant. J’aime assez ma patrie pour tâcher d’y introduire cet usage, et je ne manquerois pas d’écrire exprès à nos médecins, si les croyois assez zèlés pour sacrifier leur intérêt particulier au bien du genre humain, et pour perdre une partie si considérable de leur revenu: mais je craindrois, au contraire, de m’exposer à tout leur ressentiment, qui est dangereux, si j’entreprenois de leur faire un tort si considérable. Peut être qu’à mon retour en Engleterre j’aurai assez de courage pour leur declarer la guerre. Admirez le zèle héroique de votre amie, etc.”.
