IL CAFFÈ
ossia BREVI E VARI DISCORSI DISTRIBUITI IN FOGLI PERIODICI
Tomo primo
Dal giugno 1764 a tutto maggio 1765
| Testo critico stabilito da Gianni Francioni (Il Caffè 1764-1766, Torino, Bollati Boringhieri, 1998) |
| INDICE Al lettore Indice dei discorsi contenuti in questo primo tomo Introduzione Pietro Verri, Storia naturale del caffè Pietro Verri, V’erano ier sera… Cesare Beccaria, Il Faraone Pietro Verri, Così terminò… Ebbimo nel caffè… Pietro Verri, Il tempio dell’Ignoranza Ricevo una lettera… Pietro Verri, Elementi del commercio Cesare Beccaria, Frammento sugli odori Alessandro Verri, Rinunzia avanti notaio degli autori del presente foglio periodico al Vocabolario della Crusca Pietro Verri, La commedia Pietro Verri, M’è stato dato… Pietro Secchi, La coltivazione del tabacco Pietro Verri, Così termina… Ricevo da ottimo cittadino… Sebastiano Franci, Dell’agricoltura. Dialogo. Afranio e Cresippo Pietro Verri, In fatti, lettori cortesi… Alessandro Verri, Le riverenze Pietro Verri, Le lettere ci piovono… Giuseppe Visconti, Osservazioni meteorologiche fatte in Milano. Sul barometro Alessandro Verri, Discorso sulla felicità de’ Romani Pietro Verri, La festa da ballo Giuseppe Visconti, Osservazioni meteorologiche fatte in Milano. Sul termometro. Su i venti Cesare Beccaria, Risposta alla Rinunzia Giuseppe Visconti, Osservazioni meteorologiche fatte in Milano. Sul clima La lettera ch’io ricevo… François Baillou, Lettera d’un violinista Un causidico ci ha annoiati… Alfonso Longo, Osservazioni su i fedecommessi Io ho migliore opinione… Pietro Verri, Avvisi ai signori caffettieri Alessandro Verri, Saggio di legislazione sul pedantesimo La giusta e discreta doglianza… Alessandro Verri, Memoriale ad un rispettatissimo nostro maestro Pietro Verri, La vendetta Pietro Verri, La disattenzione Sebastiano Franci, Alcuni pensieri politici Pietro Verri, La fortuna dei libri Alessandro Verri, La bugia Alessandro Verri, L’ingratitudine Pietro Verri, Il secreto Pietro Verri, I filosofi Ci è stata diretta… Pietro Verri, Considerazioni sul lusso Alessandro Verri, Conversazione tenutasi nel caffè Pietro Verri, Le delizie della villa Cesare Beccaria, Tentativo analitico su i contrabbandi Pietro Verri, La coltivazione del lino Alessandro Verri, Di Giustiniano e delle sue leggi Alessandro Verri, Pensieri scritti da un buon uomo per instruzione di un buon giovine Pietro Verri, Saggio d’aritmetica politica Pietro Verri, Qual sia il miglior ingegno Pietro Verri, Quai sieno gli uomini grandi Pietro Verri, L’ambizione Pietro Verri, La medicina Pietro Verri, Pensieri sullo spirito della letteratura d’Italia Giuseppe Colpani, Dialoghi dei morti Pietro Verri, I giudizi popolari Giuseppe Visconti, Descrizione d’una famiglia rustica Alessandro Verri, Promemoria che serve a maggior spiegazione della rinuncia al Vocabolario della Crusca Sebastiano Franci, Difesa delle donne Alessandro Verri, Alcune riflessioni sulla opinione che il commercio deroghi alla nobiltà Pietro Verri, Storia naturale del caccao Punti di vista Cesare Beccaria, Frammento sullo stile Pietro Verri, Dell’onore che ottiensi dai veri uomini di lettere Alessandro Verri, Dell’ozio Paolo Frisi, Degl’influssi lunari Pietro Verri, Le osservazioni degli influssi… Pietro Verri, Lettera d’un freddista Luigi Lambertenghi, Delle poste Pietro Verri, Gli studi utili Alessandro Verri, I beni della insensibilità. Racconto antico Ai lettori Pietro Verri, Sulla spensieratezza nella privata economia Pietro Secchi, Anecdoto chinese Pietro Verri, I tre seccatori Ruggero Boscovich, Estratto del Trattato astronomico del signor de La Lande Pietro Verri, Lettera d’un medico polsista Pietro Verri, Un ignorante agli scrittori del Caffè Opinione che debbesi tenere delle cognizioni proprie Alfonso Longo, Dissertazione sugli orologi Pietro Verri, Le maschere della commedia italiana Pietro Verri, Sin tanto che la commedia… Pietro Verri, Ai giovani d’ingegno che temono i pedanti Alessandro Verri, Lo spirito di società Demetrio ai lettori di questi fogli |
Brevi complector singula cantu.
Al lettore
Questo lavoro fu intrappreso da una piccola società d’amici per il piacere di scrivere, per l’amore della lode e per l’ambizione (la quale non si vergognano di confessare) di promovere e di spingere sempre più gli animi italiani allo spirito della lettura, alla stima delle scienze e delle belle arti, e ciò che è più importante all’amore delle virtù, dell’onestà, dell’adempimento de’ propri doveri. Questi motivi sono tutti figli dell’amor proprio, ma d’un amor proprio utile al pubblico. Essi hanno mosso gli autori a cercare di piacere e di variare in tal guisa i soggetti e gli stili che potessero esser letti e dal grave magistrato e dalla vivace donzella, e dagl’intelletti incalliti e prevenuti e dalle menti tenere e nuove. Una onesta libertà degna di cittadini italiani ha retta la penna. Una profonda sommissione alle divine leggi ha fatto serbare un perfetto silenzio su i soggetti sacri, e non si è mai dimenticato il rispetto che merita ogni principe, ogni governo ed ogni nazione. Del resto non si deve e non si è mai prestato omaggio ad alcuna opinione, ed anche negli errori medesimi alla sola verità si è sacrificato.
Forse potran col tempo sembrar troppo animosi alcuni tratti contro i puristi di lingua; ma la pedanteria de’ grammatici, che tenderebbe ad estendersi vergognosamente su tutte le produzioni dell’ingegno; quel posporre e disprezzare che si fa da alcuni le cose in grazia delle parole; quel continuo ed inquieto pensiero delle più minute cose che ha tanto influito sul carattere, sulla letteratura e sulla politica italiana meritano che alcuno osi squarciare apertamente queste servili catene. È ridicola cosa il raccomandarsi alla benevolezza del pubblico, conviene meritarsela. Come gli autori per amor proprio hanno scritto, così per amor proprio il pubblico ha letto e leggerà. Ciò che è piaciuto diviso in fogli conviene sperare che piacerà riunito in questo primo tomo; al quale altri verranno in seguito se il favorevole giudizio del pubblico continuerà a dar lena a questo periodico lavoro.
Indice dei discorsi contenuti in questo primo tomo
DI ECONOMIA PUBBLICA
Elementi del commercio
Pensieri politici
Considerazioni sul lusso
Tentativo analitico su i contrabbandi
Sul commercio della nobiltà
Su i fedecommessi
Sulla legislazione di Giustiniano
Coltivazione del tabacco
Coltivazione del lino
Le poste
Danno che recano all’industria nazionale alcune caritatevoli instituzioni: anecdoto chinese
DI AGRICOLTURA, STORIA NATURALE E MEDICINA
Dialogo sull’agricoltura
Osservazioni meteorologiche fatte in Milano sul barometro
Sul termometro
Su i venti
Sul clima
Storia naturale del caffè
Storia naturale del caccao
La medicina
Degl’influssi lunari
DI VARIA LETTERATURA
Giuoco del Faraone calcolato
Il tempio dell’Ignoranza
Frammento sugli odori
Sulla commedia
Le riverenze
Sulla felicità de’ Romani
Descrizione d’una villeggiatura
Sullo spirito della letteratura italiana
Dialoghi de’ morti
I giudizi popolari
Descrizione d’una famiglia rustica
Difesa delle donne
Sullo stile
Lettera d’un freddista
Gli studi utili
I tre seccatori
Estratto del Trattato astronomico del signor De la Lande
Lettera d’un medico polsista
Lettera d’un ignorante
Paragone fra l’orologio italiano e l’europeo
Le maschere della commedia italiana
AI PEDANTI
Rinunzia alla Crusca
Risposta alla Rinunzia
Saggio di legislazione sul pedantesimo
Memoriale ad un rispettato maestro
Conversazione tenutasi nel caffè
Promemoria al Vocabolario della Crusca
Dell’onore che ottiensi dai veri uomini di lettere
Ai giovani d’ingegno che temono i pedanti
DI MORALE
La vendetta
La disattenzione
La bugia
L’ingratitudine
Il secreto
Pensieri d’un buon vecchio ad un giovane
Qual sia il miglior ingegno
Quai sieno gli uomini grandi
L’ambizione
L’ozio
I beni dell’insensibilità
La spensieratezza nella economia privata
Opinione che debbesi avere delle cognizioni proprie
Lo spirito di società
Num. I
IL CAFFÈ
[Introduzione]
Cos’è questo Caffè? È un foglio di stampa che si pubblicherà ogni dieci giorni. Cosa conterrà questo foglio di stampa? Cose varie, cose disparatissime, cose inedite, cose fatte da diversi autori, cose tutte dirette alla pubblica utilità. Va bene: ma con quale stile saranno eglino scritti questi fogli? Con ogni stile che non annoi. E sin a quando fate voi conto di continuare quest’opera? Insin a tanto che avranno spaccio. Se il pubblico si determina a leggerli, noi continueremo per un anno, e per più ancora, e in fine d’ogni anno dei trentasei fogli se ne farà un tomo di mole discreta; se poi il pubblico non li legge, la nostra fatica sarebbe inutile, perciò ci fermeremo anche al quarto, anche al terzo foglio di stampa. Qual fine vi ha fatto nascere un tal progetto? Il fine d’una aggradevole occupazione per noi, il fine di far quel bene che possiamo alla nostra patria, il fine di spargere delle utili cognizioni fra i nostri cittadini divertendoli, come già altrove fecero e Steele, e Swift, e Addisson, e Pope ed altri. Ma perché chiamate questi fogli il Caffè? Ve lo dirò; ma andiamo a capo.
Un greco originario di Citera, isoletta riposta fra la Morea e Candia, mal soffrendo l’avvilimento e la schiavitù, in cui i Greci tutti vengon tenuti dacché gli Ottomani hanno conquistata quella contrada, e conservando un animo antico malgrado l’educazione e gli esempi, son già tre anni che si risolvette d’abbandonare il suo paese: egli girò per diverse città commercianti, da noi dette le scale del Levante; egli vide le coste del Mar Rosso, e molto si trattenne in Mocha, dove cambiò parte delle sue merci in caffè del più squisito che dare si possa al mondo; indi prese il partito di stabilirsi in Italia, e da Livorno sen venne in Milano, dove son già tre mesi che ha aperta una bottega addobbata con ricchezza ed eleganza somma. In essa bottega primieramente si beve un caffè che merita il nome veramente di caffè; caffè vero verissimo di Levante, e profumato col legno d’aloe, che chiunque lo prova, quand’anche fosse l’uomo il più grave, l’uomo il più plombeo della terra bisogna che per necessità si risvegli, e almeno per una mezz’ora diventi uomo ragionevole. In essa bottega vi sono comodi sedili, vi si respira un’aria sempre tepida e profumata che consola; la notte è illuminata, cosicché brilla in ogni parte l’iride negli specchi e ne’ cristalli sospesi intorno le pareti e in mezzo alla bottega; in essa bottega chi vuol leggere trova sempre i fogli di novelle politiche, e quei di Colonia, e quei di Sciaffusa, e quei di Lugano, e vari altri; in essa bottega chi vuol leggere trova per suo uso e il Giornale enciclopedico, e l’Estratto della letteratura europea, e simili buone raccolte di novelle interessanti, le quali fanno che gli uomini che in prima erano Romani, Fiorentini, Genovesi o Lombardi, ora sieno tutti presso a poco Europei; in essa bottega v’è di più un buon atlante, che decide le questioni che nascono nelle nuove politiche; in essa bottega per fine si radunano alcuni uomini, altri ragionevoli, altri irragionevoli, si discorre, si parla, si scherza, si sta sul serio; ed io, che per naturale inclinazione parlo poco, mi son compiaciuto di registrare tutte le scene interessanti che vi vedo accadere, e tutt’i discorsi che vi ascolto degni da registrarsi; e siccome mi trovo d’averne già messi in ordine vari, così li dò alle stampe col titolo Il Caffè, poiché appunto son nati in una bottega di caffè.
Il nostro greco adunque (il quale per parentesi si chiama Demetrio) è un uomo che ha tutto l’esteriore d’un uomo ragionevole, e trattandolo si conosce che la figura che ha gli sta bene, nella sua fisonomia non si scorge né quella stupida gravità che fa per lo più l’ufficio della cassa ferrata d’un fallito, né quel sorriso abituale che serve spesse volte d’insegna a una timida falsità. Demetrio ride quando vede qualche lampo di ridicolo, ma porta sempre in fronte un onorato carattere di quella sicurezza che un uomo ha di sé quando ha ubbidito alle leggi. L’abito orientale, ch’ei veste, gli dà una maestosa decenza al portamento, cosicché lo credereste di condizion signorile anziché il padrone d’una bottega di caffè; e convien dire che vi sia realmente una intrinseca perfezione nel vestito asiatico in paragone del nostro, poiché laddove i fanciulli in Costantinopoli non cessano mai di dileggiare noi Franchi, qui da noi, non so se per timore o per riverenza, non si vede che osino render la pariglia ai levantini. Gli Europei che si stabiliscono in quelle contrade vestono quasi tutti l’abito o armeno, o greco, o talare in qualunque modo, né se ne trovano male, anzi ripatriando risentono il tormento del nostro abito con maggior energia, in vece che nessun di essi, stabilendosi fra di noi nelle città dove il commercio li porta, può risolversi a fare altrettanto. Noi cambiam di mode ogni vent’anni, e vedremmo la più ridicola incostanza del mondo se ci si presentasse una collezione degli abiti europei da soli quattro secoli a questa parte: i ritratti antichi ce ne fanno fede, sembra che andiamo ciecamente provandoci con ripetuti tentativi per trovare una volta la forma dell’involto in cui deve rinchiudersi il corpo umano, ch’è pur sempre lo stesso; e quel ch’è più si è che malgrado tutte le nostre instabilità, e malgrado la sicurezza in cui siamo che da qui a vent’anni chi si vestisse come facciamo ora noi sarebbe ridicolo, pure crediamo ridicole le ragioni medesime che ci dimostrano l’irragionevolezza del nostro vestito. Gli orientali in vece tagliano gli abiti loro sulla stessa forma su cui li tagliavano i loro antenati alcuni secoli fa, poiché quando si sta bene non v’è ragione per variare; l’abito loro perfine è più elegante, più pittoresco, più sano, più comodo del nostro. Su quest’argomento io scriverei volentieri molte pagine, se non vedessi che si scriverebbero inutilmente. E sapete perché le scriverei? Perché io nato, allevato in Italia non ho mai potuto naturalizzarmi col mio vestito; e quando devo ogni mattina soffrire che mi si sudici il capo colla pomata, che mi si tormenti con cinquecento e non so quanti colpi di pettine, che mi s’infarini, e mi si riempian gli occhi, gli orecchi, il naso e la bocca di polve; quando vedo rinchiudere i miei capelli entro un sacco che mi pende sulle spalle, quando mi sento cingere il collo, i fianchi, le braccia, le ginocchia, i piedi da tanti tormentosi vincoli, e che fatto tutto ciò al minimo soffio d’aria la sento farsi strada sino alla pelle e intirizzarmi nell’inverno; e devo portar meco un pezzo inutile di panno, che si chiama cappello, benché non sia un cappello; e devo portar meco una spada, quand’anche vado dove son sicuro da ogni oltraggio, né ho idea di farne; non so contenermi che non esclami: Oh ragionevoli, oh felici sartori, berettieri e uomini dell’Asia, ridete di noi che avete ben ragione di ridere!
Son pochi dì dacché il nostro Demetrio ebbe occasione di parlar del suo mestiere, e ne parlò da maestro. Si trovavano nel caffè un negoziante, un giovane studente di filosofia, ed uno dei mille e ducento curiali che vivono nel nostro paese; io stava tranquillamente ascoltandoli, non contribuendo con nulla del mio alla loro conversazione. Il caffè è una buona bevanda, diceva il negoziante, io lo faccio venire dalla parte di Venezia, lo pago cinquanta soldi la libbra, né mi discosterò mai dal mio corrispondente; altre volte lo faceva venir da Livorno, ma v’era diversità almen d’un soldo per libbra. V’è nel caffè, soggiunse il giovane, una virtù risvegliativa degli spiriti animati, come nell’oppio v’è la virtù assoporativa e dormitiva. Gran fatto, replicò il curiale, che quel legume del caffè, quella fava ci debba venire sino da Costantinopoli! Qui Demetrio, il quale in quel punto era disoccupato, prese a parlare in tal modo:
Storia naturale del caffè
Il caffè, signori miei, non è altrimenti una fava o un legume, non nasce altrimenti nelle contrade vicine a Costantinopoli; e se siete disposti a credere a me, che ho viaggiato il Levante ed ho veduto nell’Arabia i campi interi coperti di caffè, vi dirò quello che egli è veramente. Il caffè, che noi orientali comunemente chiamiamo cauhè, e cahua, è prodotto non da un legume, ma bensì da un albero, il quale al suo aspetto paragonasi agli aranci ed a’ limoni quand’hanno le loro radici fisse nel suolo, poiché s’alza circa quattro o cinque braccia da terra; il tronco di esso comunemente s’abbraccia con ambe le mani, le foglie sono disposte come quelle degli aranci, come esse sempre verdi anche nell’inverno, e come esse d’un verde bruno; di più l’albero del caffè nella disposizione de’ suoi rami s’estende presso poco come gli aranci, se non che nella sua vecchiezza i rami inferiori cadono alquanto verso il pavimento. Il caffè cresce e si riproduce con poca fatica anche nelle terre le quali sembrerebbero sterili per altre piante; e in due maniere si moltiplica, e col seme (il quale è quell’istesso che ci serve per la bevanda) e col produrne di nuove pianticelle delle radici. È bensì vero che il seme del caffè diventa sterile poco dopo che è distaccato dall’albero, ed alla natura deve imputarsi, non alle pretese cautele degli Arabi se ei non produce portato che sia da noi, poiché non è altrimenti vero che gli Arabi lo disecchino ne’ forni, né nell’acqua bollente a tal fine, come alcuni spacciarono. L’albero del caffè finalmente s’assomiglia agli aranci anche in ciò che nel tempo medesimo vi si vedono e fiori e frutti, altri maturi, altri no, sebbene il tempo veramente della grande raccolta nell’Arabia sia nel mese di maggio. I fiori somigliano i gelsomini di Spagna, i frutti sembrano quei del ciriegio, verdastri al bel principio, poi rossigni, indi nella maturanza d’un perfetto porporino. Il nocciolo di esso frutto rinchiude due grani di caffè, i quali si combaciano nella parte piana, e son nodriti da un filamento che passa loro al lungo, di che ne vediamo vestigio nel grano medesimo: si raccolgono i frutti maturi del caffè scuotendone la pianta, essi non sono grati a cibarsene, si lasciano diseccare esposti al sole, indi facendo passare sopra di essi un rotolo di sasso pesante si schiudono i gusci, e ne esce il grano. Ogni pianta presso poco produce cinque libbre di caffè all’anno, e costa sì poca cura il coltivarla, ch’egli è un prodotto che ci concede la terra con una generosità che poco usa negli altri.
Nell’Oriente era in uso la bevanda del caffè sino al tempo della presa di Costantinopoli fatta da’ maomettani, cioè circa la metà del secolo decimo quinto; ma nell’Europa non è più d’un secolo da che vi è nota. La più antica memoria che sen’ abbia è del 1644, anno in cui ne fu portato a Marsiglia, dove si stabilì la prima bottega di caffè aperta in Europa l’anno 1671. La perfezione della bevanda del caffè dipende primieramente dalla perfezione del caffè medesimo, il quale vuol essere arabo, e nell’Arabia stessa non ogni campo lo produce d’egual bontà, come non ogni spiaggia d’una provincia produce vini di forza eguale. Il migliore d’ogni altro è quello ch’io uso, cioè quello che si vende al Bazar, ossia al mercato di Betelfaguy, città distante cento miglia circa da Mocha. Ivi gli arabi delle campagne vicine portano il caffè entro alcuni sacchi di paglia, e ne caricano i cameli; ivi per mezzo dei banian i forestieri lo comprano. Comprasi pure il buon caffè al Cairo ed in Alessandria, dove vi è condotto dalle caravane della Mecca. I grani del caffè piccoli e di colore alquanto verdastro sono preferibili a tutti. Dipende in secondo luogo la perfezione della bevanda dal modo di prepararla, ed io soglio abbrucciarlo appena quanto basti a macinarlo, indi reso ch’egli è in polve, entro una caffettiera asciutta lo espongo di nuovo all’azione del fuoco, e poiché lo vedo fumare copiosamente gli verso sopra l’acqua bollente, cosicché la parte sulfurea e oleosa, appena per l’opera del fuoco si schiude dalla droga, resti assorbita tutta dall’acqua; ciò fatto lascio riposare il caffè per un minuto, tanto che le parti terrestri della droga calino al fondo del vaso, indi profumata altra caffettiera col fumo del legno d’aloe, verso in essa il caffè che venite a prendere, e che trovate sì squisito.
Il caffè rallegra l’animo, risveglia la mente, in alcuni è diuretico, in molti allontana il sonno, ed è particolarmente utile alle persone che fanno poco moto e che coltivano le scienze. Alcuni giunsero perfino a paragonarlo al famoso nepente tanto celebrato da Omero; e si raccontano de’ casi ne’ quali coll’uso del caffè si son guarite delle febbri, e si son liberati persino alcuni avvelenati da un veleno coagulante il sangue; ed è sicura cosa che questa bibita infonde nel sangue un sal volatile che ne accelera il moto, e lo dirada, e lo assottiglia, e in certa guisa lo ravviva.
Questa pianta animatrice, naturale per quanto sembra al suolo dell’Arabia, fu verso il fine dello scorso secolo dagli Olandesi trasportata nell’isola di Java a Batavia, indi moltiplicatasi, ivi se ne dilatò dai medesimi la piantagione anche nell’isola di Ceylon, poscia col tempo se ne portò in Europa e in Olanda; e in Parigi per curiosità se ne coltivano le piante, le quali nelle serre riscaldate l’inverno reggono e producono frutti, e tanto sen’ è universalizzata la cultura presentemente, che nell’America e nell’Indie Orientali se ne fa la raccolta, cosicché abbiamo caffè di Surinam, dell’isola Bourbon, di Cayenne, della Martinica, di S. Domingo, della Guadalupa, delle Antille, dell’isole di Capo-Verde. Il caffè d’Arabia è il primo, quello dell’Indie Orientali vien dopo, il peggiore d’ogni altro è quello d’America.
Così terminò di parlare Demetrio; ed io credetti al suo discorso, poiché lo trovai conforme a quanto ne aveva letto nelle Memorie dell’Accademia Reale delle Scienze di Parigi dell’anno 1713 in un Memoire del signor Jussieu, a quanto ce ne attestano i Viaggi dell’Arabia felice del signor La Roque, del cavalier di Marchais, le Memorie del signor Garcin. Ma poiché ebbe terminato il suo ragionamento Demetrio, s’alzò il curiale e uscì dalla bottega ripetendo: Gran fatto, che quel legume del caffè, quella fava, ci debba venire sino da Costantinopoli!
P. [Pietro Verri]
Num. II
V’erano ier sera quattro giuocatori al caffè, i quali parlavano del loro mestiere; tutti quattro puntatori abituali del Faraone, e in conseguenza tutti quattro carichi di merletti di ricamo e di debiti. Ieri notte, diceva uno, ho avuta la più grande fortuna del mondo, il tagliatore per più di venti tagli ha continuato a dare la faccia vecchia. Ebbene come l’hai fatta?, interrogava l’altro. Oh taci, amico, sono stato uno stolido, non me ne sono mai voluto fidare, ed ho perdute duecento doppie. È un fatto terribile ch’io debba sempre perdere, soggiungeva il terzo, non posso puntare una carta che non la paghi. Il tagliatore ha il quattro per cento d’utile. No, scusatemi, ha il cinque e mezzo. Cos’è l’utile del tagliatore? I doppietti e l’ultima. Ma anche il puntatore ha la scelta della somma. Ma anche il tagliatore può cessar quando vuole. In somma il tagliatore, poiché paga per tagliare, bisogna che vi abbia dell’utile. Se vi dico il quattro per cento. Signor no, il cinqu’e mezzo. Così proseguivano riscaldandosi, sin tanto che uno di essi indirizzandosi ad un geometra, che se ne stava tacitamente ascoltando la tumultuaria conversazione, propose che ciascuno ascoltasse la decisione del geometra, e lo pregò a voler dire il parer suo; ed egli così disse:
P. [Pietro Verri]
Il Faraone
La vanità, l’avarizia e il tormentoso sentimento della noia, che ad ogni costo si vorrebbe scacciar d’attorno, spingon gli uomini al giuoco. Frattanto che alcuni lo biasimano colla fiducia di render gli uomini migliori, alcuni pochi si contentano di risguardarlo come materia di calcolo, qualità buona o cattiva, come vi piace, ma inerente a chi ha una mente geometrica, la quale suol trascegliere la parte calcolabile degli oggetti e amarli principalmente per questo titolo: così mentre la moltitudine spinge l’inquieta sua attività alle parti esterne, e si move, ed opera, e si agita senza curarsi di conoscere i principii delle cose, un piccol numero d’ oziosi illustri condensa tutta la forza dell’animo nella meditazione de’ principii medesimi. Il signor di Montmort nel suo libro Essai d’analyse sur les jeux de hazard, ed il signor Moivre in quell’altro De mensura sortis, non giuocando mai sono giunti ad intendere il Faraone assai più (permettetemi ch’io ’l dica) che non l’intendete voi, che avete consumata buona parte di vostra vita giuocando e perdendo. I ragionamenti di quest’illustri matematici sono esposti con quella speditissima logica che chiamasi algebra, e involti con segni e cifre che allontanano chiunque non è nato per essi. Proviamoci se col solo linguaggio comune si possa esporre la teorica del Faraone, cosicché qualunque uomo di buon senso l’intenda, il che prima d’ora, ch’io sappia, non è stato fatto da alcuno.
Che nel giuoco del Faraone i doppietti e l’ultima nulla sieno un avantaggio del tagliatore ognuno lo sa; ma la difficoltà consiste nel determinare con qualche precisione quanto sia questo vantaggio. Per saperlo bisogna determinare il numero de’ casi vantaggiosi al tagliatore e il numero de’ casi vantaggiosi al puntatore in tutt’i tagli differenti che si possono fare con cinquantadue carte. Sarebbe necessario trovare l’eccesso dei casi vantaggiosi del tagliatore su quelli del puntatore; ma questo calcolo preso in dettaglio sarebbe impossibile, poiché il numero de’ tagli differenti non può esprimersi con meno di sessantasette cifre, ossia sorpassa la classe degli undicilioni.
E acciocché si veda la vanità di coloro che credono colla meditazione di alcune ore di scoprire la legge con cui le carte si succedono, io ho calcolato che se nel Paradiso terrestre un uomo avesse cominciato a tagliare al Faraone senza mai dormire né mangiare, facendo otto tagli all’ora, e avesse continuato sino al dì d’oggi variando sempre i tagli, non ne avrebbe fatti finora che quattrocento venti milioni e quattrocento ottanta mila, il qual numero è una parte assai più piccola della mezza decilionesima parte delle combinazioni possibili colle cinquantadue carte; e perciò, quand’anche vi fosse una legge costante nella successione delle carte, una inclinazione, un astro, un influsso, e tutte le chimere che vi piacciono, la serie delle sue osservazioni e la sperienza di quell’uomo sarebbe un nulla rispetto all’immenso numero delle combinazioni che restano ancora da vedersi. Sarebbe miliaia di volte più ridicola una conseguenza cavata dalle sue osservazioni di quella che caverebbe un fisico da una sola osservazione in mille fenomeni diversi della natura.
Per darvi un’idea come nonostante questo apparato farraginoso di cifre si possa sottomettere al calcolo il Faraone, comincierò a farvene vedere l’applicazione ai casi più semplici. Prendiamo quattro sole carte, un re rosso, un re nero, un due e un tre: con queste quattro carte si possono fare ventiquattro tagli differenti, e non più. Scriviamo tutti questi tagli, e facciamo due supposizioni: la prima, che il puntatore metta su il due un zecchino, la seconda che lo metta al re a posta secca.
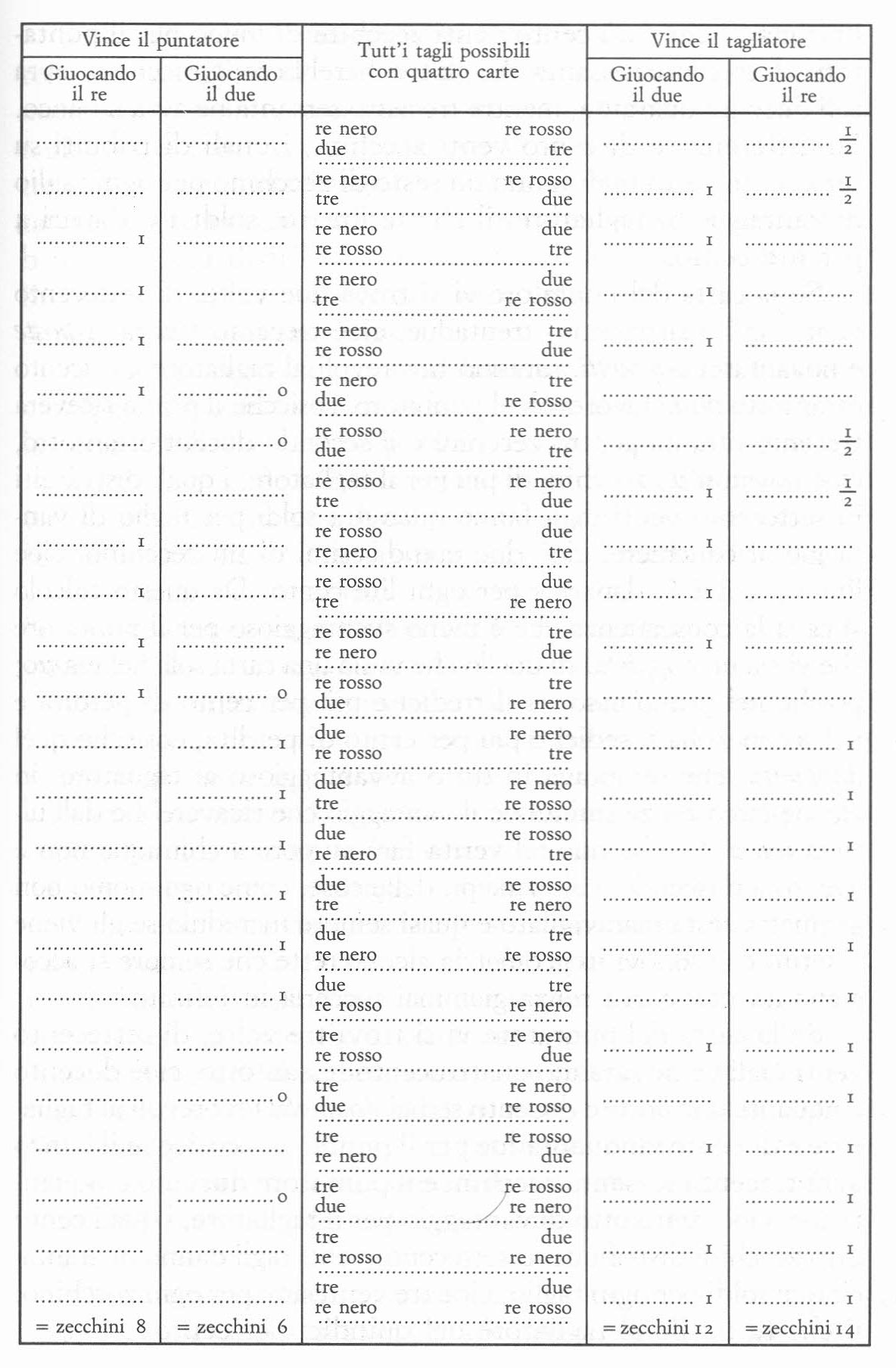
Da questa tavola, sommando i casi vantaggiosi al tagliatore e i vantaggiosi al puntatore, si trova che giocando il due, il tagliatore ha dodici casi per sé laddove il puntatore non ne ha che sei; e si trova che giocando il re il tagliatore ha quattordici casi per sé contro otto favorevoli al puntatore. Il vantaggio adunque del tagliatore è in amendue le supposizioni di sei zecchini, perché se quattordici supera l’otto di sei come dodici il sei, questi sei zecchini, che sono il vantaggio totale in tutti ventiquattro tagli possibili di quattro carte distribuite per ogni taglio, formano un quarto di zecchino per taglio, cioè il venticinque per cento al tagliatore.
Parimente se la carta del puntatore si trova tre volte in quattro carte, si vedrà, scrivendo i ventiquattro tagli possibili, che il tagliatore ha dodici zecchini contro sei, il che forma in questo caso lo stesso vantaggio del venticinque per cento. Finalmente egli è facile il vedere che se tutte le quattro carte fossero simili, dovendo sempre perdere il puntatore la metà della posta, il vantaggio del banco sarebbe il cinquanta per cento.
Passiamo ad esaminare qual sia il vantaggio che ha il tagliatore avendo sei carte in mano. Sarebbe troppo lungo e noioso il trascrivere le settecento venti combinazioni o tagli differenti che si possono fare con sei carte; io mi contenterò di darvene il risultato di questa meccanica operazione. Se la carta del puntatore vi si trova una sol volta, dico che se non vi fosse l’ultima nulla per il puntatore, di settecento venti tagli trecento sessanta gli sarebbero favorevoli e trecento sessanta gli sarebbero contrari; ma in settecento venti tagli differenti la carta del puntatore verrà cento venti volte la prima, cento venti volte la seconda, cento venti volte la terza ec., cosicché verrà cento venti volte l’ultima, il che farà cento venti zecchini di meno per il puntatore, di trecento sessanta che gli toccherebbero; cosicché ne avrà soli ducento quaranta, mentre trecento sessanta ne avrà il banco. La differenza è di cento venti zecchini, i quali distribuiti su settecento venti tagli fanno un sesto di zecchino per ogni taglio di vantaggio al tagliatore, il che fa lire 16, soldi 13, danari 4 per lire cento.
Se la carta del puntatore vi si trova due volte, di settecento venti tagli, quattrocento trentadue, cioè trecento trentasei poste e novantasei doppietti, saranno favorevoli al tagliatore, e ducento ottantotto poste favorevoli al puntatore; cosicché il primo riceverà trecento ottantaquattro zecchini, e il secondo ducent’ottantotto, cioè novanta sei zecchini di più per il tagliatore, i quali distribuiti in settecento venti tagli fanno quaranta soldi per taglio di vantaggio al banchiere, cioè due quindicesimi di un zecchino, cioè lire 13, soldi 6, danari 4 per ogni lire cento. Da questo calcolo si cava la conseguenza che è meno svantaggioso per il puntatore che vi sia un doppietto di quello che vi sia una carta sola nel mazzo; poiché nel primo caso ha il tredici e più per cento di perdita, e nel secondo ha il sedici e più per cento di perdita, cosicché quel doppietto, che sembrava in tutto avvantaggioso al tagliatore, in alcune circostanze sminuisce il vantaggio che ricaverebbe dall’ultima nulla. So che una tal verità farà stupore a chiunque non è avezzo a riascendere ai principii delle cose, come ogni uomo non geometra resta maravigliato e quasi sempre incredulo se gli viene asserito che sonovi in geometria alcune rette che sempre si accostano ad una curva senza giammai toccarla in infinito.
Se la carta del puntatore vi si trovi tre volte, di settecento venti tagli ve ne saranno quattrocento sessantotto, cioè ducento cinquanta due poste e ducento sedici doppietti favorevoli al tagliatore, e ducento cinquantadue per il puntatore; cosicché il banco avrà trecento sessanta zecchini, e il puntatore ducento cinquantadue, cioè cento otto di vantaggio per il tagliatore, i quali cento otto zecchini distribuiti su settecento venti tagli danno quarantacinque soldi per ogni taglio, cioè tre ventesimi per ogni zecchino, il che fa l’utile al tagliatore del quindici per cento.
Se la carta del puntatore vi si trovi quattro volte, di settecento venti tagli ve ne saranno cinquecento ventotto, cioè cento novantadue poste e trecento trentasei doppietti favorevoli al tagliatore, e cento novantadue per il puntatore, cioè zecchini trecento sessanta per il tagliatore, e cento novantadue per il puntatore; il che fa cento sessantotto zecchini di vantaggio per il banco, i quali distribuiti in settecento venti tagli danno tre lire e mezzo al taglio, e per ogni zecchino, cioè lire 23, soldi 6, danari 8 per ogni lire cento.
Prima conseguenza di questa dimostrazione è che il maggiore vantaggio del tagliatore è quando vi siano nel mazzo tutte quattro le carte simili a quella del puntatore; dopo questo il maggiore vantaggio è quando v’è una sol carta, indi quando ve ne sono tre, finalmente il minore di tutt’i vantaggi del tagliatore è quando ha nel mazzo due carte simili a quella del puntatore. Questo salto del massimo vantaggio di quattro carte ad una sola sembrerà un paradosso a chiunque non rifletta che le apparenti somiglianze delle cose ingannano ben sovente.
Un’altra utilissima conseguenza di quanto si è detto è che l’avvantaggio del tagliatore scema a misura che ha maggior numero di carte in mano, perché quando ne aveva quattro, abbiam dimostrato il suo vantaggio essere il venticinque per cento, ma quando ne ha sei essere o il 23, o il 16, o il 15, o il 13 circa per cento, vantaggi tutti minori del primo.
Da questo metodo meditando sulle operazioni più semplici hanno potuto i matematici non solamente scoprire il numero preciso di tutt’i tagli differenti che si possono fare con qualunque numero di carte, ma di più hanno potuto rinvenire la legge con cui crescendo il numero delle carte cresce il numero de’ doppietti, e per conseguenza calcolare di due in due carte qual sia l’avvantaggio del tagliatore, risparmiando l’impossibile operazione di far tutte le combinazioni in dettaglio. Darò qui il risultato delle loro meditazioni in una tavola adattata alla intelligenza comune.
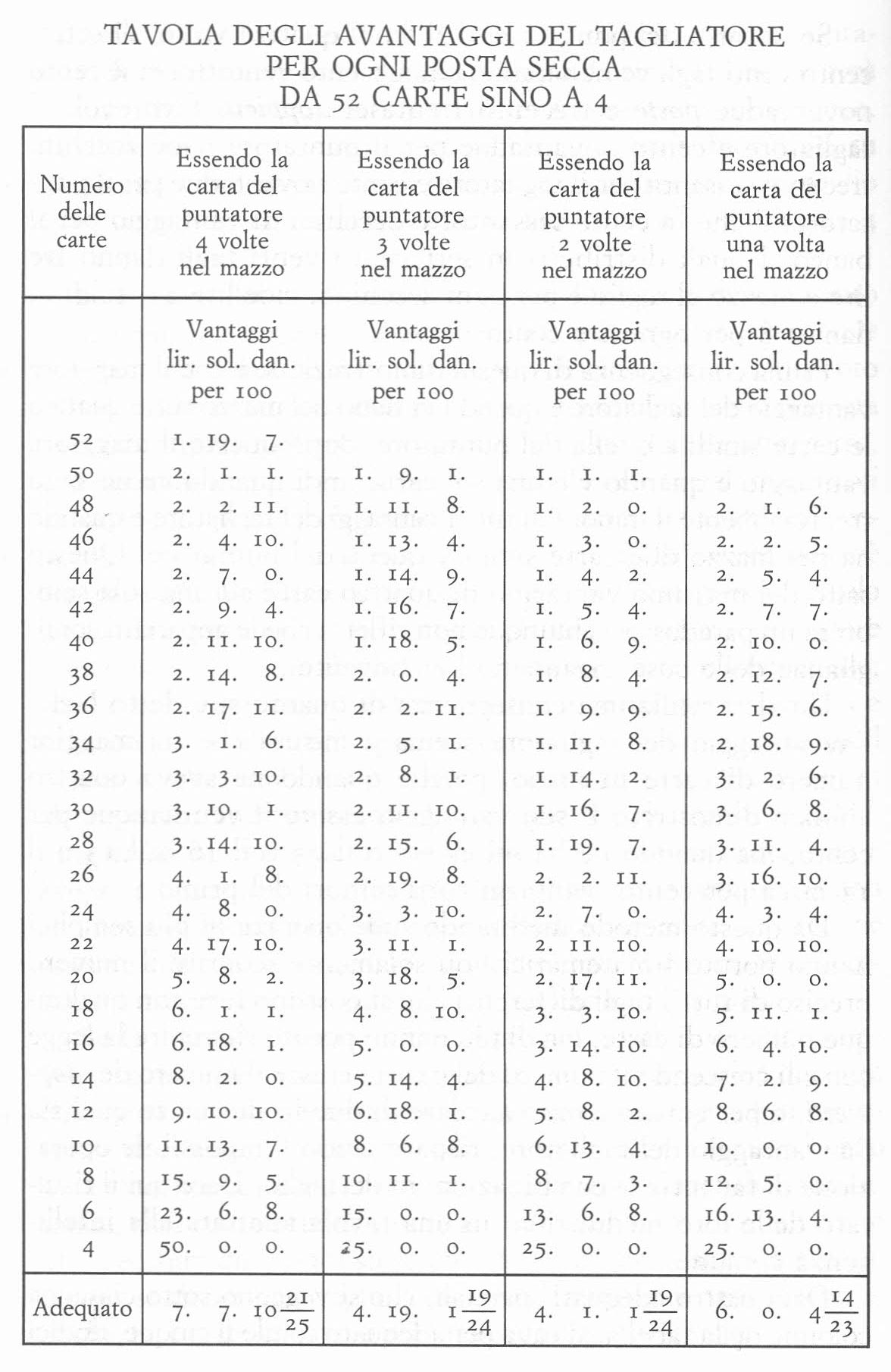
Dai quattro adequati parziali, che si veggono sotto ciascuna colonna della tabella, si cava per adequato totale il cinque, dodici e due per cento, cioè quel vantaggio che ha il tagliatore per risultato di tutt’i vantaggi particolari, i maggiori compensandosi coi minori. Ma vi è un’importante riflessione da fare, che fa crescere al di là del cinque per cento il vantaggio del tagliatore: l’avidità dei puntatori fa che per mezzo dei paroli e delle paci la forza del giuoco si trasporti verso le ultime ventiquattro carte piuttosto che verso il principio del taglio. Per misurare il vantaggio del tagliatore conformemente a questa osservazione basterà prendere gli adequati parziali da ventisei carte sino a quattro, e da questi cavarne l’adequato. L’adequato della prima colonna sarà 12.9.10 1/6 per cento; della seconda 7.17.8; della terza 6.13.6 7/12; della quarta 9.1.2 2/3; e l’adequato totale sarà 9.0.4 per cento: vantaggio assai considerabile, e per cui si può dire che i tagliatori vendano al nove per cento la speranza e il timore e l’altrui povertà.
Si avverta che l’avere trascurati nella tavola per comodo del calcolo alcuni rotti, può portare qualche differenza minima negli adequati dalla esatta verità, la quale non giungendo a formare un intero danaro è di nessuna conseguenza, e che è stata da me ricompensata nell’adequato totale coll’aggiunta di un danaro. Avvertasi di più, che quantunque il vantaggio delle ultime due carte sia stato da me calcolato nella tavola, pure il numero delle carte non giunge che alle quattro, perché il numero delle carte rappresenta il numero delle poste secche che si possono fare in ciascun taglio, e nessuno giuoca sull’ultime due carte.
Da questa tavola si possono con maggior sicurezza ricavare i due teoremi fondamentali di questo giuoco accennati di sopra, cioè che il vantaggio del tagliatore cresce collo scemarsi il numero delle carte, e che il minore suo vantaggio è quando vi è un solo doppietto nel mazzo della carta del puntatore; regole generali che possono servire a coloro che voglion perdere solamente il quattro e uno per cento, il che è l’adequato della terza colonna.
Aggiungasi che le paci e i paroli raddoppiano o triplicano il vantaggio del tagliatore, perché la pace e il paroli è una reale duplicazione o triplicazione della posta, mentre crescendo gli avvantaggi del tagliatore la posta dovrebbe proporzionatamente scemarsi, cosicché la pace ha di discapito lire 11.4.4 per cento, e il paroli ha di discapito lire 16.16.6 per cento. E questo vantaggio è assai maggiore se si prenda l’adequato delle ultime carte, cioè che si punti e si faccia pace o paroli nell’ultima metà; perché allora il discapito della pace sarebbe del 18.0.8 per cento, e il discapito del paroli sarebbe del 27.1.0 per cento.
In ultimo luogo riflettete che il vantaggio del cinque per cento è grandissimo per il tagliatore, quantunque l’interesse del cinque per cento d’un capitale non sia grandissimo, perché questo vantaggio del cinque per cento si ripete tante volte quante poste si fanno, e però dieci zecchini, che girino dieci volte nel giuoco, equivalgono a cento, e il vantaggio del tagliatore sopra questi dieci zecchini sarebbe cinque zecchini, cioè la metà.
C. [Cesare Beccaria]
Così terminò il suo discorso il geometra; ed io sollecitamente me ne venni a casa a scriverlo, ben contento della mia cura se avrò salvato con essa il patrimonio di qualcuno dalla rovina; raro esempio sarebbe che la ragione dimostrata fosse più forte della crescente, della calante, della faccia vecchia, dell’ebraica, della piemontese e cetera.
P. [Pietro Verri]
Ebbimo nel caffè gran soggetto di ridere, e ce lo somministrò un magro poetuzzo, il qual venne a sfoderarci un coronale di sonetti petrarcheschi tanto dolci, tanto armoniosi, tanto esangui e vuoti di pensieri, che avrebber fatta la lor comparsa naturale in una bottega di droghiere frall’oppio e il sugo de’ papaveri. Son già mille e quasi ottocent’anni dacché al nostro buon amico Orazio non piacevano versus inopes rerum nugaeque canorae, eppure certi poverelli si provano anche al dì d’oggi di carpire la stima e l’onore de’ loro cittadini con canore inezie. Fatto sta che sbadigliammo tutti quanti ben bene all’onore e gloria del coronale, e per destarci dal sopore petrarchesco in cui eravamo, un tale si cavò di tasca un pezzo di carta e ci pregò di ascoltare un pezzo di sua poesia in prosa; essa ci piacque, la richiesi, la ottenni; ed eccovi cosa contiene.
Il tempio dell’Ignoranza
In una contrada riposta circa a quaranta gradi di latitudine trovasi una spaziosissima valle, di cui il facile pendio invita gli uomini a scendere sino alla fine, ed ivi sta riposto il magnifico tempio sacro alla dea Ignoranza. Annose querce ricoperte di ghiande gli stanno d’intorno, e il suolo è ripieno dovunque di ginestra e di bruco. La struttura del vasto tempio è gotica, ed alla sommità della gran porta vedesi rozzamente scolpita una enorme bocca sbadigliante; stansi ai due lati di essa porta due statue, una alla dritta e l’altra a manca, le quali voltansi dispettosamente le spalle in atto di allontanarsi una dall’altra, e leggesi scritto sul piedestallo di una Teorica, sull’altra Pratica. Appena entrasi sulla soglia si scopre una infinita turba diversa d’abiti, di volto e di costumi, onde è ripieno il vasto edificio; altri, rappresi da un abituale sopore, lasciansi trasportare avanti e indietro dal moto altrui; altri, occupati a parlar sempre con tuono penetrante di voce, decidono durante tutta la giornata; altri stupidamente sorridono alla vista de’ continui accidenti che si vedono succedere l’uno all’altro fra quella moltitudine; ma tutti ignorano il nome della dea e il luogo ove soggiornano. Ivi sono coperte le pareti di varie pitture e stravaganti arnesi, ivi vedonsi sopraveste inzolferate, ivi manaie e lacci, ivi eculei e torture d’ogni sorte, ivi stan delineati naufragi e guerre civili, ivi d’ogn’intorno vedonsi espresse in varie forme la Morte e la squallida Sterilità. Da un rostro elevato grida e declama ad ogni istante una spolpata vecchia: Giovani, giovani, ascoltatemi, non vi fidate di voi medesimi, quello che sentite entro di voi è tutto illusione, badate ai vecchi, e credete bene quel che essi hanno fatto. Ivi da un altro canto grida e si smania un gravissimo caduco: Giovani, giovani, la ragione è una chimera, se volete distinguere il vero dal falso raccogliete i voti della moltitudine, giovani, giovani, la ragione è una chimera. Frattanto si urta la turba, e s’avvanza e si ritira, e sbadiglia e sorride, e vede e non osserva, e ascolta e non intende, e fendonla di tempo in tempo alcuni medici, i quali in abito da sacerdoti colla sacra bipenne in mano strascinano all’ara della onorata dea le innocenti vittime umane, le quali col loro sangue innaffiano il non mai diseccato santuario. Stassi la possente dea rappresentata in una colossale statua di sughero, a cui servono di base una prodigiosa mole di libri disposti in forma d’un cono. Oh quanti, oh quanti libri venerati da noi e rilegati splendidamente nelle nostre biblioteche servono ivi a questo ministero! Oh quanti potrei io nominarne, se non temessi e la sorpresa de’ miei lettori e la persecuzione infallibile di chi è interessato a nascondere alcune verità! Dietro la grand’ara della dea stassi un piccolo recinto segregato dalla gran nave di cui s’è detto; ivi trovansi alcuni filosofi entrativi per una angusta porticella su cui sta scolpita questa parola: Paucis; vedonsi scritte intorno alle mura di quel recinto queste parole: Elementi de’ corpi, sensibilità, cagione del moto, quantità di moto, cagione dell’attrazione, e simili detti; ivi que’ pochi segregati cantano inni alla dea, ringraziandola perché ascondendoci le malattie, le sventure a venire e la giornata del morir nostro, ci lasci le ore della vita prive di molte sollecitudini. Ma se per ventura qualch’uno di questi osa passar scopertamente in mezzo alla folla della gran nave, voi credereste di vedere una terribile tempesta nell’oceano: grida, urli, malediche voci rimbombano d’ogni parte e fanno eccheggiare le capaci volte; alcuni s’astengono da quel passaggio, e questi scansano così gl’insulti; altri proccurano di deludere la folla coprendosi alla meglio e nascondendosi con una scorza posticcia, ma gli effluvi filosofici per lo più trapellano malgrado le avvertenze, e sono questi i più vivi pungoli per riscuotere i volgari ed animarli alla persecuzione. A’ piedi dell’ara evvi una porta per dove si scende in una spaziosa caverna sotterranea, ed ivi al pallido lume di alcune lampadi sta una schiera di gravissimi sapienti maneggiando ed imparando a mente voluminosi consulenti, repetenti, trattatisti; ivi stanno, ammirando le impatinate medaglie, le rosicate iscrizioni, le patere, i tripodi antichi, alcuni mal sbarbati e mal lavati eruditi; ivi declinano con scrupolosa esattezza i verbi di tutte le lingue i profondissimi grammatici, e giudicano delle opere nuove sulla bilancia delle lor leggi; ivi in somma stanno per anni e lustri scavando il vero sapere quegli uomini i quali credono soli al mondo di possedere la intima cognizione delle vere scienze; ivi si abbruggiano ogni anno, nel giorno della solennità stabilito, le opere di Bacone, di Galileo e di Newton, un esemplare dello Spirito delle leggi e un altro del Trattato delle sensazioni.
Se l’armonia del verso servisse ad abbellire sì fatti pensieri, forse il numero de’ poeti non sarebbe sì grande, né la professione di poeta sì poco onorevole.
P. [Pietro Verri]
IL CAFFÈ )( Fogl. III )(
Num. III
Ricevo una lettera portata al nostro Demetrio, e diretta Agli scrittori del nuovo foglio Il Caffè. Essa così dice:
Amici miei.
Bravi, bravissimi. L’idea del foglio è buona, lo stile piace, e vi annunzio che sebbene gli studi vostri non si chiamino studi utili, frappoco avrete fatto più bene alla vostra patria di quello che non ne facciano due avvocati, tre causidici, quattro sollecitatori e cinque notai de’ più esperti a procrastinare la decision d’una lite per vent’anni. Il progetto di presentare al pubblico le verità utili, spogliandole della noia magistrale, è degno di veri filosofi e di onesti cittadini. Ricevete dunque l’approvazione d’un incognito, la quale avrà in seguito quella di tutti gli uomini dabbene; e preparatevi a lasciar dire quegli avversari i quali non si scansano da nessun uomo se non ascondendosi nella oscurità. Chiunque compera il vostro foglio, ha comperato il diritto di farne e dirne quel che gli piace. Riceverete unitamente a questa lettera gli Elementi del commercio che ho fatti anni sono. Credo che eglino sieno ancora più popolari di quei del signor Forbonnai, siccome quelli dell’illustre franzese sono più grandi e più filosofici de’ miei. Se li credete adattati a spargere i buoni principii nella nazione, stampateli nel vostro foglio; se siete di contrario parere, rendeteli onestamente a Demetrio, e saremo in ogni caso buoni amici.
Filantropo
Rispondo al signor Filantropo che quanto noi siamo insensibili alla opinione volgare, tanto siamo contenti ottenendo quella de’ pari suoi. Gli Elementi del commercio ci paion buoni al nostro fine di pubblicare verità utili, senza noia. Chiunque vorrà somministrarci cose non anco stampate, le quali contenghino verità utili, senza noia, sarà il ben venuto; e le pubblicheremo col nome o colla divisa che sceglierà l’autore. Si faccian cuore i giovani di talento, che avranno a fare con chi non giudicherà né dall’ardimento, né dal nome, né dal vestito. Non venghino essi, mandino i manoscritti, poiché noi non amiamo a perder tempo in visite o offici; ci dieno l’indirizzo, e avranno risposta. Nessuna autorità, nessun impegno ci farà mai piegare ad inserire in questi fogli cosa che a noi non piaccia. La società de’ letterati è repubblicana, e questo foglio è cosa nostra, né vi si devon porre che gl’innesti che vogliamo noi. Ora eccovi gli Elementi.
Elementi del commercio
Il commercio consiste nella permutazione d’una cosa coll’altra. È cagionato dal bisogno che si ha della cosa che si vuole acquistare, e dall’abbondanza che si ha della cosa che si vuole cedere in contracambio.
Quando il commercio è prodotto più dal bisogno delle cose straniere che dall’abbondanza delle proprie, si chiama commercio passivo; così chiamasi commercio attivo quello che viene cagionato più dall’abbondanza delle cose proprie che dal bisogno delle straniere.
Per nome di bisogno si sottintendono due diverse idee, l’una è il bisogno assolutamente detto, il quale è nella serie naturale delle cose, e tale è quello che ci porta ad evitare il proprio deperimento; l’altra è il bisogno artefatto, nato dalla opinione e dal lusso. Il primo cerca le cose necessarie, l’altro le utili.
L’abbondanza pure ha due aspetti: una è l’assoluta, la quale anche può dirsi superfluità; l’altra è relativa, ossia un minor bisogno che sacrifichiamo a un maggiore, e in questo senso non v’è nazione comunicante colle altre che non abbia abbondanza.
Nel commercio attivo l’abbondanza dev’essere assoluta. La nazione avendo più a dare che a ricevere, quella somma che le resta di credito viene compensata colla moneta, contrasegno con cui, per universale consentimento delle nazioni, si valutano le azioni che gli uomini hanno sulle cose. Questa somma che resta a compensarsi in moneta si chiama la bilancia del commercio.
La nazione che ha il commercio attivo preponderante si rende ogni anno per moltiplico padrona, se non di diritto, di fatto, delle nazioni che hanno il commercio meno in vigore del suo. Allora la nazione diventa veramente ricca: la coltura delle terre, la popolazione, i comodi della vita, la copia di tutto sono i beni che un felice commercio produce nell’interno; la stima e i riguardi sono quelli non minori che produce al di fuori.
La nazione presso cui prepondera il commercio passivo perde ogni giorno cotesti beni, e corre alla propria distruzione. Il male va crescendo per moltiplico, i cattivi effetti diventano cagioni sin tanto che ridotta alla perfetta dipendenza da’ suoi vicini, priva d’abitanti, diventa un paese non ad altro buono che a traspiantarvi colonie.
Il commercio interno impedisce la perdita delle ricchezze della nazione, l’esterno ha per oggetto d’aumentarle. Il primo s’oppone al passivo, l’altro lo compensa.
Di qualunque specie sieno i tributi che paga una nazione al sovrano, essi rimontano tutti a un primo principio, che è la capitazione: o sia il tributo sulle terre, o sulla consumazione, ovvero sulle merci; è sempre vero che a misura della popolazione si accresce il numero de’ consumatori e de’ compratori, e che le terre rendono più dove sono più coltivate. Un re che comandi a due milioni d’uomini sparsi nello spazio di mille miglia, è dieci volte almeno più debole d’un re che comandi a venti milioni d’uomini sparsi nello spazio di cinquecento miglia. Le rendite del sovrano crescono colla popolazione dello Stato e scemano con essa, e la popolazione dello Stato dipende interamente dalla natura del commercio. Dove l’industria e l’agricoltura danno più facili mezzi a sussistere, ivi non mancano giammai gli abitanti. È dunque massimo interesse del sovrano la buona direzione del commercio.
Se tutte le nazioni intendessero i propri vantaggi, farebbero in modo d’avere nel loro interno le cose che loro bisognano per quanto fosse possibile. Allora il commercio esterno sarebbe il minimo possibile, essendosi ridotto al minimo possibile il bisogno che lo produce. Cresce il commercio sin tanto che egli è ben inteso da alcune nazioni, e scema quando è universalmente conosciuto. Intanto però che i corpi politici non giungano a questo forse chimerico grado di perfezione universale, la nazione che avrà in prima aperti gli occhi sul commercio profitterà della indolenza delle altre, e diverrà ricca, popolata e florida a loro spese.
Quando una nazione è giunta ad avere dentro di sé quanto occorre al compimento de’ suoi bisogni, ella è nella intera indipendenza dalle altre, né ha più a temere il commercio rovinoso; ma per ottenere questo conviene che la nazione sia estremamente ristretta o vasta estremamente. Nel primo caso il governo travaglia più a diminuire i bisogni che a soddisfarli, e questo freno alle passioni degli uomini non si può imporre che a un numero limitato, e per un tempo pure limitato: gli antichi Lacedemoni furono in questo caso. Quando poi la nazione sia vasta in guisa da potere cogli interni frutti della terra e dell’industria soddisfare interamente i propri bisogni, allora pure è nell’indipendenza; ma la natura in un ristretto spazio non suole produrre quanto richiedono i bisogni d’opinione degli uomini. Nella China cento millioni d’abitanti in un clima de’ più felici hanno potuto rinunziare ad ogni straniera mercanzia senza invidiar nulla ai forestieri.
Ogni nazione che sia nella mediocrità non può sperare né di contenere interamente le voglie degl’individui, né di naturalizzare entro di sé tutte le cose delle quali è avvezza a far uso. Egli è però vero che se questo non è sperabile perfettamente, pure a misura che una nazione s’accosta a questo stato d’indipendenza ne risente efficacemente i vantaggi, e col commercio attivo può ricompensare e sorpassare le perdite che le restano, e decidere per sé la bilancia. Questo è il solo scopo che si può proporre nel sistema presente d’Europa.
Tutto si fa per gradi nella natura. Il corpo politico è una macchina, le di cui diverse e complicate ruote né sono percettibili a molti, né soffrono impunemente d’essere molte ad un tratto scomposte. Ogni scossa è fatale, e dai funesti effetti discoprono poi gl’incauti la contiguità che non avevano ravvisata in prima. Vi vuole l’opera di chi perfettamente ne conosca tutta la mecanica per mettervi mano. I progetti più pronti e universali se più abbagliano, sono altresì più difficili e pericolosi ad eseguirsi, ed è tanto più stabile la felicità d’una nazione, quanto per gradi se ne innalza l’edificio. Miglior metodo di tutti è il cominciare dal por rimedio alle perdite attuali, alle quali provveduto che si sia, più facile assai riesce il distendersi al commercio lucrativo. L’umanità non consente che si facciano de’ saggi a spese della pubblica felicità, sulla quale nulla conviene intentare di nuovo, se la evidenza non ci previene sull’esito felice della nostra intrapresa.
I primi oggetti i quali si presentano sono quelli che risguardano la più grande, la più utile e la più infelice parte della nazione, che è il popolo. Quanto è di suo uso, forma i capi principali del commercio, come quelli che sebbene separatamente presi sieno di poco valore, riuniti però e tante volte ripetuti formano le somme più considerabili. Chi vive nelle città è colpito d’ordinario dalle sole spese del lusso di alcuni pochi cittadini, in vista delle quali sembrano non degne d’attenzione le più grandi realmente, cioè quelle della plebe e de’ contadini: ma chi vi riflette, vede che appena un uomo, ogni trecento, spende negli oggetti del lusso, e che gli abiti di ducento novanta nove uomini comuni costano assai più della gala del ricco.
Non v’è paese in cui non si possa introdurre fabbrica di panni e tele, quali fanno bisogno al vestito del popolo, e quand’anche le terre non somministrassero lini e lane bastanti, o le somministrassero di qualità cattiva, è sempre vero che converrebbe anzi prendere da’ forestieri queste materie prime e tesserle, che comperare le manifatture, poiché tutto il prezzo della manifattura non uscirebbe; e tanti cittadini di più avrebbero il vitto nel paese, quanti sono impiegati nella manifattura. Frattanto però pongasi ogni studio per migliorare il prodotto delle lane e de’ lini nello Stato.
Le manifatture per i bisogni del popolo sono, come si è detto, le più importanti per ritenere la maggior somma del denaro; ma di più sono le più facili a stabilirsi non richiedendosi per esse né una straordinaria destrezza o eleganza ne’ manufatturieri, né i grandiosi capitali che vi vogliono per le fabbriche di lusso. Molti non intendono questi principii, e in una nazione rovinata vorrebbero cominciare dalle stoffe di lusso, come se a un ammalato che sviene per la perdita del sangue, un chirurgo, negligentando di chiudergli la vena, cominciasse a proporgli di cavalcare per rendere più robusto il temperamento.
Le tele e più ancora i panni difficilmente si distinguono se sieno legalmente tessuti e tinti allorché sono nuovi, l’uso soltanto lo discopre. Se si lascia ad ogni fabbricatore la libertà di tessere e tingere come vuole, nessuno nemmeno nell’interno della nazione si fiderà delle manifatture del suo paese. Come v’è una marca legittima agli argenti, senza di cui nessun uomo cauto li comprerebbe, così deve esservi una marca legitima ai panni, senza di cui nessuno arrischia il suo denaro. Nessuna fabbrica di panni può riuscire senza questa precauzione eseguita a rigore.
La facilità d’un lungo uso nel commercio, ovvero la scarsezza del denaro della nazione che ci vende le merci fa sì che talora esse giunghino a minor prezzo di quanto costerebbero fabbricate da noi medesimi; d’onde ne nasce una sorte di ritrosia in chi deve metter mano al commercio, come se fosse una legge poco giusta e umana l’obbligare il minuto popolo a pagare di più quanto può ottenere a minor prezzo. Questa difficoltà cessa qualora s’abbi di mira il pubblico bene, e si rifletta che chiudendo questa uscita del denaro della nazione essa ne rimarrà tanto più fornita, onde crescendo la copia del denaro, il prezzo delle opere tutte e de’ generi crescendo a proporzione, s’accresceranno nelle mani di ognuno i mezzi per provvedersi colle interne manifatture.
In un paese, che non sia un’isola, la proibizione d’una merce che vi ha spaccio è un inutile tentativo, che essendo innosservato ricade in discredito del legislatore. Perché il popolo non preferisca le merci forastiere alle nazionali, conviene primieramente diminuire quanto è possibile il prezzo delle nazionali; 2. accrescere il prezzo delle manifatture straniere; 3. proccurare che le manifatture nazionali non la cedino in bontà alle forastiere.
Questo timone della nave è sempre nelle mani del sovrano. Colle esenzioni o colle somministrazioni fatte ai fabbricatori egli diminuisce il prezzo delle interne manifatture; aggravando le imposizioni alla introduzione delle merci straniere egli accresce il prezzo delle manifatture esterne; e con abili ministri e buone leggi egli perfeziona le interne manifatture. Il primo passo naturale dunque verso la riforma del commercio è la deputazione di persone di zelo e d’intelligenza, la retta costruzione delle tariffe e la rettificazione delle leggi commercianti.
L’uomo naturalmente corre all’utile, e sebbene non sia per lo più sensibile alle attrattive della verità per se stessa, pure per un secreto niso la sente, quando questa lo conduce a migliorare la sua fortuna. Travaglia esso per il bene della società, quando vi trova l’utile proprio. La grand’arte del legislatore è di sapere ben diriggere la cupidigia degli uomini. Allora si scuote l’utile industria de’ cittadini; l’esempio, l’emulazione e l’uso fanno moltiplicare i cittadini utili, i quali cercano a gara di farsi più ricchi col somministrare alla patria merci migliori a minor prezzo.
La libertà e la concorrenza sono l’anima del commercio; cioè la libertà che nasce dalle leggi, non dalla licenza. Quindi ne siegue che l’anima del commercio è la sicurezza della proprietà fondata su chiare leggi non soggette all’arbitrio; ne siegue pure che i monopoli, ossia i privilegi esclusivi, sieno perfettamente opposti allo spirito del commercio.
Stabiliti che sieno in una nazione i buoni principii del commercio, allora s’accrescono le nozze de’ cittadini abilitati a mantenere una famiglia; allora vengono da’ paesi esteri e meno attenti al commercio nuove famiglie chiamate dall’utile e dai maggiori comodi della vita, e si naturalizzano tanti cittadini quanti erano in prima gli operai che in paesi esteri vivevano colle manifatture comperate da noi; allora, consumando essi il prodotto delle terre, sull’agricoltura ricade una nuova rugiada che la rinvigorisce; in somma il primo passo al bene come al male facilita gli altri, come i gravi, il di cui moto s’accellera colla caduta.
Né alcuna nazione disperi di avere dentro di sé questi beni soltanto che lo voglia. I vari giri che ha fatto il commercio sulla terra, ora per l’Asia, ora sulle coste d’Affrica, ora in Grecia, ora in Marsiglia, ora in Italia, ora nel Portogallo, ora nell’Olanda, consecutivamente mostrano ch’egli non è legato dal clima. Il buon governo lo invita, lo scaccia il cattivo; onde dovunque il commercio è in rovina, è legittima conseguenza il dire che vi sia un difetto organico nel sistema, a meno che un’accidentale cagione e passaggera non possa assegnarsi.
Gli uomini del volgo credono che sieno in contraddizione gli attuali interessi della nazione con quelli del sovrano in fatto del commercio. Credono essi impossibile rianimare il commercio, se il principe non diminuisce le imposizioni per qualche tempo. Ora, essendo ogni anno necessaria al sovrano la stessa rendita, sulla quale è fondato il mantenimento della milizia e de’ magistrati, ogni riforma si risguarda come una bella speculazione e nulla più. Questa falsa supposizione non deriva da altro se non dalla poca riflessione che fassi sulla diversa natura de’ tributi, de’ quali, se una parte si trova attualmente così incautamente posta che s’opponga all’utile commercio, è sempre però vero che dall’abuso di una cosa non si può provare l’intrinseca pravità della sua indole. I tributi sono per loro natura indifferenti al commercio, al quale anche possono contribuire; né lo rovinano che quando o sono mal diretti, o quando realmente eccedono le forze d’uno Stato.
Ogni tributo sulla uscita delle manifatture fabbricate internamente, ovvero sulle derrate nate nello Stato e che non possono ridursi a manifattura, è pernicioso al commercio.
Ogni tributo sulla introduzione delle materie da lavorarsi nello Stato è pernicioso al commercio.
Ogni tributo sulla uscita delle materie nazionali che servono alle manifatture interne è salutare al commercio.
Ogni tributo sulla introduzione delle manifatture straniere è salutare al commercio.
Tali sono i principii universali per regolare le tariffe, i quali si moderano ne’ casi particolari, avendo riguardo alla dipendenza de’ forestieri ed all’incentivo al contrabbando, il quale cresce colla gabella. Ed ecco come il principe possa, conservando i tributi, animare il commercio, togliendo soltanto la viziosa ripartizione del tributo medesimo. Un millione in mano d’un imbecille fa men bene ad una nazione che la sola penna in mano d’un abile ministro.
Finalmente altri vi sono, i quali credono che il primo passo per rianimare il commercio sia promulgare leggi, ossia prammatiche per annientare il lusso; cioè quel lusso sul quale vive la maggior parte degli artigiani; quel lusso il quale è il solo mezzo per cui le ricchezze radunate in poche mani tornino a spargersi sulla nazione; quel lusso il quale lasciando la speranza ai cittadini d’arricchirsi è lo sprone più vigoroso dell’industria; quel lusso finalmente il quale non va mai disunito dalla universale coltura e ripulimento delle nazioni.
Ovunque il suolo basti ai bisogni fisici degli abitanti, non può esservi industria senza lusso. Le terre sono in proprietà della minor parte della nazione; i proprietari, se non hanno lusso, non le fanno coltivare che quanto giovi a riceverne i bisogni fisici; ma conosciuti i bisogni del lusso, promoveranno l’agricoltura, cercando da essa come soddisfare, oltre ai primi bisogni fisici, anche ai bisogni sopravvenuti del lusso. Quindi i contadini troveranno facile sussistenza, s’accresceranno le nozze e si moltiplicherà la popolazione.
Le prammatiche non convengono che a quelle terre ingrate che non somministrano quanto basta alla vita fisica degli abitanti; ed è ben miserabile quella pretesa politica che insegna a conservare le ricchezze nelle mani d’alcune famiglie; poiché dovunque sieno disegualmente distribuite le ricchezze, tutto ciò che tende a diminuire la diseguaglianza è un bene prezioso agli occhi d’un illuminato legislatore, a cui deve esser noto che più le ricchezze sono egualmente distribuite su molti, più s’accresce la ricchezza nazionale, poiché un piccolo patrimonio viene con più attenzione coltivato che un grande. È pure agli occhi d’un illuminato legislatore un bene tutto ciò che tende a riscuotere i poveri e ad eccitarli all’industria coll’aspetto della fortuna. Il solo lusso veramente pernicioso, in una nazione che abiti un suolo fecondo, è quello che toglie alla coltura le terre, consacrandole alle cacce, ai parchi ed ai giardini.
Ogni vantaggio d’una nazione nel commercio porta un danno a un’altra nazione; lo studio del commercio, che al dì d’oggi va dilatandosi, è una vera guerra che sordamente si fanno i diversi popoli d’Europa. Se i buoni autori fossero intesi, si vedrebbe che essi hanno palesato il vero secreto degli Stati; ma per la maggior parte gli uomini non accordano la loro stima che alle cose straordinarie, né sospettano che i principii della politica sieno sì semplici come lo sono.
P. [Pietro Verri]
Num. IV
Frammento sugli odori
Eccovi un frammento di un uomo che ha voluto filosofare sugli odori; ma pare straordinario che un letterato scriva sopra un argomento così frivolo invece d’impiegare il suo ingegno a compilar qualche dissertazione in foglio delle fibbie delle scarpe antiche, o a sciffrare gli smarriti caratteri d’un’iscrizione. A considerarlo sotto un aspetto mi pare che si voglia ridere di noi altri uomini, e sotto un altro sembrami ch’ei ragioni sul sodo. Comunque sia, leggete e giudicate.
Tutti gli uomini, dopoché cessarono di contrastare co’ bisogni della vita e superarono gli ostacoli che la selvaggia natura opponeva ai loro piaceri, si diedero a coltivare il loro corpo e a trasformarlo in qualche guisa, cercarono di multiplicare le sensazioni aggradevoli e di dare una novella vita ai loro sensi. Solo il naso, parte così rispettabile di noi stessi e fedele consigliere di ciò che nuoce e giova, sembra essere stato trascurato, o almeno soggetto alle vicende della moda, ch’io chiamerei la fortuna degli umani piaceri. Come si fanno delle rivoluzioni trai sentimenti dei filosofi, così i piaceri si succedono vicendevolmente, sempre soggetti alla tirannia delle opinioni, come quelli alla tirannia dell’autorità. Non in ogni luogo, né in ogni tempo furono in voga i piaceri dell’odorato. Gli antichi n’erano più ghiotti di noi, e quei vecchi Romani, maestri ugualmente di virtù che di piaceri alle altre nazioni, ne faceano grand’uso ne’ loro conviti, ne’ loro bagni e ne’ loro ipocausti, e ne accarezzavano e ristoravano i corpi esercitati a sudare nelle palestre. I nostri antichi mobili, che sanno ancora di muschio, ci fanno vedere il senno de’ nostri padri. Ma ora, con grave scandalo de’ buoni, tra cento parrucchieri che infarinano e sudiciano di sogna schiffosamente le teste di questa vasta capitale, appena si vedono due profumieri che ne ristorino i nasi; mentre dovunque io volga gli occhi non veggo che latrine aperte, né si pensa a riparar la puzza che
Aequo pulsat pede pauperum tabernas
Regumque turres.
Fino nelle mode e negli ornamenti destinati al piacere ci siamo fabbricati delle catene indissolubili sotto pena del ridicolo a chi osasse scioglierle. Noi ci stringiamo le ginocchia e il collo, parti destinate ad esser libere per la facilità dei movimenti, e ne strozziamo i minutissimi canali che distribuiscono il sangue animatore in tutto il corpo; e le donne i delicati petti circondano di una corazza, barbaro ornamento, che trasforma il loro corpo in un cono rovesciato che ha l’apice appoggiato sopra un gran segmento di circolo; noi ci carichiamo d’oro e d’argento, stendendo una straniera ed aspra superficie sulle membra, che la natura fece morbide e pastose, invece di circondarle di molli e profumate vesti, che si accordino piacevolmente ai movimenti del corpo. A fabbricare questi tormentosi ornamenti io veggo popolate le officine, e deserte veggo quelle che son destinate ai bisogni di un senso così importante. Sarei ben fortunato se potessi convertire questi eretici della voluttà, e se potessi trasportare l’affumicata chimica dagli laboratori alle geniali conversazioni ed alle toelette d’una dama.
Sono pure i piaceri odorosi così innocenti, che io non trovo alcuna setta o religione che gli abbia condannati, né fra le severe instituzioni dei cenobiti alcuna ve n’ha che imponga voto di castità d’odori. Fra i gentili medesimi, i quali hanno deificato tutti i vizi, non trovo adorata la puzza, se n’è eccettuato il deus Crepitus. Sono poi di così facile acquisto, che molti di essi la natura ci somministra senz’arte e preparamento.
Gli uomini nella ricerca della loro felicità si gettano per lo più alle cose straordinarie e difficili, e trascurano quelle che hanno sotto gli occhi ed alla mano. L’ambizioso si annoia nelle anticamere de’ grandi, veglia le notti in studi secchissimi; si consuma l’avaro di timore e di fame di un metallo per lui inutile, mentre un altro più saggio se la passa
IL CAFFÈ )( Fogl. IV )(
con un flaccone sotto il naso. Ben è vero che anche il naso dell’ozioso starebbe male, se molti fanatici non avessero avuto il coraggio di annoiar se medesimi o gli altri. Io studio gli odori, e stimo che questa ricerca vaglia tant’altre di una secca ed inutile erudizione. Stimo coloro che hanno pesato quei vasti globi che ruotolan con noi attorno del Sole, ed hanno calcolato questa tenue porzione dell’immensità della natura; ma questi uomini grandi ci hanno fatti accorgere della nostra piccolezza, e appunto per questo amo di ristringermi nella mia sfera e ricercare ciò che può farmi piacere, senza offender le leggi divine ed umane.
Distinguo gli odori in semplici e composti. Gli semplici sono quelli delle erbe, dei fiori, di alcune piante, di alcuni minerali, come l’ambra e il buchero, e di qualche parte animale, come il muschio e il zibetto. Molti di questi, come i fiori e l’erbe odorifere usuali, sono alla portata egualmente del povero e del ricco, poiché è giusto che anche i nasi volgari abbiano le loro consolazioni. Alcune resine di poco valore, qualche vaso di erbe fragranti possono rimbalsamare l’aria infestata dalle esalazioni che circolano e fermentano fra i cenci e il sudore nella stretta abitazione di una famiglia. Dovrebbero i medici de’ poveri e i luoghi pii, che somministran medicine per carità, distribuirne, essendo più stimabile, benché meno brillante, la medicina che previene i mali, che quella che li guarisce. La maggior parte de’ mali dei poveri, che scorrono le città intiere e ne distruggono i più laboriosi ed infelici cittadini, nascono dell’immondezza. Qual risparmio di vite non ne farebbe la popolazione, ch’è la vera ricchezza d’uno Stato? Gli odori composti sono preparati dall’arte, che combina i doni della natura, destinandoli al lusso ed alla voluttà delle persone agiate. Io ne distinguo tre classi principali, le quali però non son dalla natura separate che per insensibili differenze, come ogni altra cosa. Le classi non sono che punti di appoggio, che aiutano la nostra mente a scorrere la varietà degli oggetti naturali, e spesse volte la sviano dal vero.
La prima specie è quella degli indifferenti, i quali non oltrepassano di là dell’odorato, contentandosi di solleticarlo piacevolmente, come l’acqua di garofani, l’incenso ec. Questi odori, oso esprimermi così, non parlano all’animo; sono come una stampa di un bel disegno, di cui l’occhio è contento, ma senza espressione e poesia. Questi odori servono alle persone moderate e che temono la tempesta delle passioni. Coloro che amano di conservare una fredda indifferenza sugli oggetti, ne faccian uso, perché io son di parere che anche la incontinenza del naso sia da temersi… Sono di parere, che altri dovrebbero essere i profumi delle serie matrone, che sono fra le donne quel ch’era Catone in Roma; ed altri quelli di una leggiera e vivace donzella, alla quale gli scherzi e giuochi e la difficile arte di tener sottomessi molti amanti formano la sua politica e i suoi affari di Stato. Quando gli odori diventassero più importanti di quel che or sono, vi sarebbero gli odori di gala e di cerimonia, gli odori di amicizia e di familiarità, quegli dei solitari diversi da quelli dei uomini di mondo. Ma io riserbo tutte queste distinzioni ad un’opra che sto meditando di tre volumi in foglio, che avrà per titolo Elementa naseologiae methodo mathematica demonstrata.
La seconda classe è quella degli odori dolci, quali sono tutte l’essenze estratte dai fiori, dall’ambra, dal muschio ec. Passano i fiori, e perdono il loro odore, né in tutte le stagioni appaiono, ma l’essenze si conservano per lungo tempo, ed in piccola mole spandono una soavità che si estende per molto spazio. Né deono far caso gli uomini amanti di gustar quelle sensazioni, che fanno dolcemente languir l’anima, e di quell’abbandono di tutte le nostre facoltà ai piaceri ed alla molle indolenza. Esigge il ben pubblico (il quale non fo consistere in altro che nella massima somma di piaceri divisa egualmente nel massimo numero d’uomini) che i fiori, che rallegrano due sensi in una volta, passino dai giardini ad impiegar più utilmente le mani di coloro che manipolano i veleni consacrati dalla medicina.
Il muschio, e l’ambra, s’insinua talmente nelle intime parti del corpo, che la traspirazione di chi ne usa è tutta di odor di muschio fragrante. Ciò si chiama un migliorare la nostra macchina, che per lo più esala un sudore ingrato. Uomini traspiranti muschio ed ambra sembrano divinità di poemi e di romanzi, e pur niente di più facile ad un petit-maître. La terza classe è quella degli odori aerei e spiritosi, quali sono le erbe odorose distillate nello spirito di vino. Non è tale la forza di questi odori, che lo spirito di vino perda di quell’acuto e pungente che stimola con frequenti vibrazioni i nervi della macchina, e ne produce quella viva, ma aggradevole sensazione, che rasserena e rischiara l’animo scuotendolo da quel letargo in cui è sopito dal lento moto delle fibre e dalla noiosa uniformità degli oggetti. Quelle piccole scosse che ne sente il cervello, pare che facciano cadere un velo dinanzi agli occhi, e si destino le idee più limpide e chiare.
Trovo molta analogia tra gli odori e i colori: degli uni e degli altri ve ne ha di molli e voluttuosi, di forti e vivaci, di seri e ridenti; e come vi sono degli colori cangianti, così non dubito che dal miscuglio di molti odori non ne nasca un odor cangiante. E come vi sono i colori primitivi della luce, non è provato che non vi possano essere odori primitivi, che sian la base di tutte le altre combinazioni. Chi sa che un giorno non nasca il Newton degli odori? Questa idea non è più stravagante per noi di quello che lo possi essere per un ottentotto la teoria della luce, e dubito che noi non siamo qualche poco ottentotti. Con questi principii io non dubito punto che i nasi raffinati fabbricheranno da qui a qualche milione d’anni una musica d’odori, come una di colori n’è stata immaginata. Imperocché qual cosa è mai sì strana, che non possa accadere in questa continua rivoluzione di cose? E poi essendo gli odori un’azione delle particelle della materia, che si spandono come una sfera, e scema in ragione inversa dei quadrati delle distanze, e per quella universal legge di natura, che niente operando per salti passa per tutti i gradi intermedi, potrebbesi fabbricar una scala di cui si misurassero i tuoni e i semituoni, e se ne calcolassero le concordanze e le discordanze; chi sa se un giorno non si odorino dei concerti e delle sinfonie? Come non ogni orecchio è atto alla musica, dipendendo la maggior finezza di esso dalla maggior facilità di sentire le minime differenze de’ suoni e dalla maggior reazione delle fibre alle impressioni musicali, così vi sarebbono dei nasi ignoranti e insensibili all’armonia degli odori. E siccome ogni senso potrebbe da per sé essere un eccellente algebrista, potendo benissimo ogni senso avere un’idea chiara del più e del meno, così potrebbe anche divenir musico, ma non giammai poeta, poiché la forza principal della poesia consiste nel percuoter più sensi in una volta, e nel dipingere le immagini che appartengono ad un senso coi colori di un altro.
Ogni sensazione ha una sorta d’analogia colle altre nella celere o lenta successione delle impressioni, nei differenti gradi d’intensione di esse e nella riunione che se ne fa negli oggetti esterni; come il dilicato color della rosa si unisce con una voluttuosa fragranza, e la pallida violetta con un soave odore, l’acuto odor del gelsomino e di tutti i cedri col vivo e allegro color aureo o bianco.
Se questo fosse vero, forse si raffinerà a segno di accompagnare i drammi colla musica degli odori, e mi figuro che saranno destinate le essenze di rose, di ambra ec. ai dialoghi amorosi, gli odori forti ai discorsi galanti e spiritosi, e gli odori seri ai gravi e politici. Non saprei qual odore assegnare alle commedie, poiché non ho ancora trovati degli odori ridicoli. Il ridicolo dipende da un certo raffinamento della umana società, poiché vediamo ogni altra classe degli animali e i medesimi uomini selvaggi esserne esenti; e in fatto di odori non vi siamo ancor giunti, quando ridicoli non si chiamino quei bizzarri assortimenti di puzza e di fragranza che di spesso s’incontrano; poiché credo esser domma di buon gusto che gli odori facciano un tutto, un sistema corrispondente al vestito, all’età ed al carattere della persona.
Dagli odori ai sapori non v’è che un piccolo passaggio, e questi due sensi sono amici e fedeli l’uno all’altro. Ciò che offende l’odorato è per lo più pessimo al palato, e ciò che offende il palato è quasi sempre nemico dell’odorato. Crederei ancora che ciocché offende l’uno o l’altro sia velenoso per la sanità, se in ciò non avessi tutta l’autorità dei medici e de’ speziali contraria; senza di essa sembrerebbemi che ciò che disgusta il palato o l’odorato, cioè ne disordina le fibre, dovesse produrre lo stesso effeto sui delicati organi dello stomaco.
Provo in esperienza che l’odore mi eccita l’idea del sapore, che gli sapori forti sono quasi sempre accompagnati da odori forti. In somma trovo una fisonomia nelle cose, come negli uomini, che in qualche maniera ne dipinge il carattere.
Sin ora si è fatto troppo poco per il naso, mentre si è fatto anche troppo per la bocca. Noi siamo passati dai cibi più semplici preparati dalla natura ai più facili da comporsi, indi agli ultimi raffinamenti delle tavole francesi. Ma negli odori abbiamo appena formate le più semplici combinazioni, ed il lusso, che crea nuovi bisogni e nuovi piaceri, non ha per anche perfezionata la cucina del naso.
Siamo ancora ai cibi più grossolani e il nostro maggior alimento si è il tabacco, che in vece di lusingare piacevolmente le fibre, le stimola e le punge, e solo col tempo si può vivere familiarmente con lui, né solo ci morde il naso, ma ci appesta ed avvelena la bocca, quando ne assorbiamo dalle pippe l’ingrato fumo, potendo invece imbalsamarla col fumo di pastiglie odorose, come fanno i Turchi, più saggi di noi. Chi fra i nostri posteri (quando questa usanza cadrà sotto l’inevitabil legge del tempo, che tutto consuma per far rinascere), chi mai potrà credere che questa polve fosse la delizia dei nasi più colti; che le tenere donne, che i leggiadri giovani se ne servissero negli amorosi colloqui, e i più gravi politici nei trattati della pace e della guerra; che sempre seco si portasse questo pungente stimolo racchiuso in cassette preziose fra l’oro e le gemme? Quali volumi in foglio faranno scrivere i primi stranuti di quel fortunato antiquario che ne farà la scoperta? Questa polve non piace che dopo che ha già incallite le fibre e rintuzzatane la sensibilità. Allora è che la sensazione prima dolorosa divien piacevole, ma questo piacer così vivo ce ne fa perdere un gran numero di più dilicati. Una saggia economia del piacere è altrettanto necessaria che quella del danaro, che non è altro che un cambio di essi.
La cucina degli odori è una manifattura che manca al nostro secolo; e pure io trovo che si potrebbono fare altrettante combinazioni quante colle vivande se ne fanno. Io mi figuro di vivere in un secolo più raffinato, e di vedere nelle famiglie de’ grandi due cuochi, uno per il naso e l’altro per la bocca, e di assistere ai banchetti odorosi serviti di salze, manicaretti di profumi, vedere il naso avere i suoi parasiti ed essere accarezzato a segno di avere i suoi pasti regolati al giorno; gli odori secchi disposti con simmetria in scatolette d’oro e di argento, e gli odori liquidi presentati come bevande in boccette di cristallo. Vi sarebbono gli odori caldi, gli odori freddi, e i giorni consacrati al digiuno ed all’astinenza dovrebbero essere sbanditi gli odori voluttuosi e dolci, ma permessi i soli seri e indifferenti. Alcuni odori più forti terrebbono luogo di vino, poiché parimente alcuni di essi, come il tabacco, eccitano una momentanea gioia e fino l’ubbriacchezza. Allora qualche nuovo Anacreonte ne canterà le lodi, e qualche nuovo Maometto ne vieterà l’uso.
Una nuova medicina d’odori (oso predirlo, poiché non la sola bocca è all’uomo veicolo di mali e di rimedi, ma tutti i sensi, anzi tutte le membra lo sono) sorgerà in quei tempi. Ricette e spezierie, e una farragine di rimedi inutili con cinque o sei utili, che per la loro semplicità saranno i più trascurati, arricchiranno i medici e popoleranno i sepolcri. Ma perché possano i medici con decoro addottarne l’uso, sto compilando un dizionario di parole greche su gli odori, ad uso non solo dei medici, ma di tutti quelli che parlano per non farsi intendere. Spero che in quei tempi guariranno le donne di parto in Lombardia di quella superstiziosa opinione, che le allontana dagli odori soavi e le avvicina al fetore ed all’immondezza, che loro fa credere che la più forte scossa del puzzo non debba irritare le deboli fibre più efficacemente che le dilicate titillazioni dei profumi. Spero che non il solo cioccolate avrà il privilegio di comparire nelle nostre adunanze, benché spanda un forte odor di vainiglia, ma tutti i profumi e i bagni odorosi, e tutto ciò che forma l’eccessiva mondezza, che credo uno dei rimedi più efficaci se non per guarire, almeno per rallegrare e ristorare un ammalato, il che non è la meno importante parte della medicina. Cosa strana, che in Roma si allontani da una donna di parto, come veleno, il cuoio, che si mette al capezzale delle nostre più dilicate dame in tempo di parto! Cosa strana, che nella Francia tutta, nell’Inghilterra, che nella Toscana abbiano le donne il naso così diverso dal lombardo!
Ecco ciocché ho pensato per perfezionare questo senso; ma qui non si fermano le mie fatiche. Ecco una lista di opere che sto scrivendo non già per amor mio, ma per ben pubblico.
Una descrizione di una macchina in forma di cannochiale, che avvicini ed ingrandisca gli odori da una parte, e dall’altra impiccolisca il puzzo e lo allontani. Credo che l’uso di questa macchina sarà più frequente dalla parte che allontana, che dall’altra, al rovescio de’ cannochiali da vista.
Saggio di morale e progetto di educazione con gli odori.
Tavole logarithmiche per misurare l’intensione degli odori.
Della temperanza degli odori. Trattato all’antica, colle note alla moderna.
Eccovi i deliri d’un filosofo; e un delirio sugli odori può benissimo interessare quanto le monadi di Leibniz; né io condanno o l’uno o l’altro, sapendo benissimo che dalla fermentazione degli errori, dall’entusiasmo filosofico e dalle infinite combinazioni delle umane idee ne sortono le luminose verità che rischiarano gli uomini, e gli rendono più felici, e che finalmente quelli che hanno delirato in filosofia non turbarono la pace umana, né coprirono d’orrore e di stragi la faccia dell’universo.
C. [Cesare Beccaria]
Rinunzia avanti notaio degli autori del presente foglio periodico al Vocabolario della Crusca
Cum sit, che gli autori del Caffè siano estremamente portati a preferire le idee alle parole, ed essendo inimicissimi d’ogni laccio ingiusto che imporre si voglia all’onesta libertà de’ loro pensieri e della ragion loro, perciò sono venuti in parere di fare nelle forme solenne rinunzia alla pretesa purezza della toscana favella, e ciò per le seguenti ragioni.
1. Perché se Petrarca, se Dante, se Bocaccio, se Casa e gli altri testi di lingua hanno avuta la facoltà d’inventar parole nuove e buone, così pretendiamo che tale libertà convenga ancora a noi; conciossiaché abbiamo due braccia, due gambe, un corpo ed una testa fra due spalle com’eglino l’ebbero,
… quid autem?
Caecilio, Plautoque dabit Romanus, ademptum
Virgilio, Varioque? ego cur adquirere pauca
Si possum invideor? quum lingua Catonis et Enni
Sermonem patrium ditaverit ac nova rerum
Nomina protulerit.
Horat, De art. poet.
2. Perché, sino a che non sarà dimostrato che una lingua sia giunta all’ultima sua perfezione, ella è un’ingiusta schiavitù il pretendere che non s’osi arricchirla e migliorarla.
3. Perché nessuna legge ci obbliga a venerare gli oracoli della Crusca, ed a scrivere o parlare soltanto con quelle parole che si stimò bene di racchiudervi.
4. Perché se italianizzando le parole francesi, tedesche, inglesi, turche, greche, arabe, sclavone noi potremo rendere meglio le nostre idee, non ci asterremo di farlo per timore o del Casa, o del Crescinbeni, o del Villani o di tant’altri, che non hanno mai pensato di erigersi in tiranni delle menti del decimo ottavo secolo, e che risorgendo sarebbero stupitissimi in ritrovarsi tanto celebri, buon grado la volontaria servitù di que’ mediocri ingegni che nelle opere più grandi si scandalizzano di un c o d’un t di più o di meno, di un accento grave in vece di un acuto. Intorno a che abbiamo preso in seria considerazione che se il mondo fosse sempre stato regolato dai grammatici, sarebbero stati depressi in maniera gl’ingegni e le scienze che non avremmo tuttora né case, né morbide coltri, né carrozze, né quant’altri beni mai ci procacciò l’industria e le meditazioni degli uomini; ed a proposito di carrozza egli è bene il riflettere che se le cognizioni umane dovessero stare ne’ limiti strettissimi che gli assegnano i grammatici, sapremmo bensì che carrozza va scritta con due erre, ma andremmo tuttora a piedi.
5. Consideriamo ch’ella è cosa ragionevole che le parole servano alle idee, ma non le idee alle parole, onde noi vogliamo prendere il buono quand’anche fosse ai confini dell’universo, e se dall’inda o dall’americana lingua ci si fornisse qualche vocabolo ch’esprimesse un’idea nostra meglio che colla lingua italiana, noi lo adopereremo, sempre però con quel giudizio che non muta a capriccio la lingua, ma l’arricchisce e la fa migliore.
Dixeris egregie notum si callida verbum
Reddiderit iunctura novum. Si forte necesse est
Indiciis monstrare recentibus abdita rerum,
Fingere cinctutis non exaudita Cethegis
Continget: dabiturque licentia sumpta pudenter,
Et nova factaque nuper habebunt verba fidem…
Horat., eod.
6. Porteremo questa nostra indipendente libertà sulle squallide pianure del dispotico Regno Ortografico e conformeremo le sue leggi alla ragione dove ci parrà che sia inutile il replicare le consonanti o l’accentar le vocali, e tutte quelle regole che il capriccioso pedantismo ha introdotte e consagrate, noi non le rispetteremo in modo alcuno. In oltre considerando noi che le cose utili a sapersi son molte, e che la vita è breve, abbiamo consagrato il prezioso tempo all’acquisto delle idee, ponendo nel numero delle secondarie cognizioni la pura favella, del che siamo tanto lontani d’arrossirne, che ne facciamo amende honorable avanti a tutti gli amatori de’ riboboli noiosissimi dell’infinitamente noioso Malmantile, i quali sparsi qua e là come gioielli nelle lombarde cicalate sono proprio il grottesco delle belle lettere.
7. Protestiamo che useremo ne’ fogli nostri di quella lingua che s’intende dagli uomini colti da Reggio di Calabria sino alle Alpi; tali sono i confini che vi fissiamo, con ampia facoltà di volar talora di là dal mare e dai monti a prendere il buono in ogni dove.
A tali risoluzioni ci siamo noi indotti perché gelosissimi di quella poca libertà che rimane all’uomo socievole dopo tante leggi, tanti doveri, tante catene ond’è caricato; e se dobbiamo sotto pena dell’inesorabile ridicolo vestirci a mò degli altri, parlare ben spesso a mò degli altri, vivere a mò degli altri, far tante cose a mò degli altri, vogliamo, intendiamo, protestiamo di scrivere e pensare con tutta quella libertà che non offende que’ principii che veneriamo.
E perché abbiamo osservato che bene spesso val più l’autorità che la ragione, quindi ci siamo serviti di quella di Orazio per mettere la novità de’ nostri pensieri sotto l’egida della veneranda antichità, ben persuasi che le stesse stessissime cose dette da noi e da Orazio faranno una diversa impressione su di coloro che non amano le verità se non sono del secolo d’oro.
Per ultimo diamo amplissima permissione ad ogni genere di viventi, dagli insetti sino alle balene, di pronunciare il loro buono o cattivo parere su i nostri scritti. Diamo licenza in ogni miglior modo di censurarli, di sorridere, di sbadigliare in leggendoli, di ritrovarli pieni di chimere, di stravaganze, ed anche inutili, ridicoli, insulsi in qualsivoglia maniera. I quali sentimenti siccome ci rincrescerebbe assaissimo qualora nascessero nel cuore de’ filosofi, i soli suffragi de’ quali desideriamo, così saremo contentissimi, e l’avremo per un isquisito elogio, se sortiranno dalle garrule bocche degli antifilosofi.
A. [Alessandro Verri]
La commedia
Che inconvincibil razza di gente che sono mai que’ pedanti, i quali nelle cose che sono fatte per eccitar nell’animo que’ moti che si chiamano sentimento, in vece di abbandonarsi alla magia della illusione cavan di tasca il pendolo o il compasso per esaminarle freddamente e giudicarne? Si presenta ad essi un quadro pieno di poesia e di espressione, dove l’atteggiamento, la disposizione e le fisonomie delle diverse figure sarebbero atte a porre la parte sensibile di noi in movimento, e spingerla o verso l’orrore, o verso la compassione, o verso la maraviglia, o verso qualch’altro stato significato con altro vocabolo; in vece, dico, di presentarsi all’azione che l’artefice ha cercato di far nascere in chi deve rimirare, e dalla natura di essa azione giudicar poi del merito della pittura; in vece, dico, di ciò, si restringono a criticare il disegno e la proporzione d’una gamba o d’un dito, una piegatura stentata di una calza o simile piccolo difetto, e della scoperta di esso gloriosi perdono un vero piacere con una spensieratezza che mal corrisponde alla cautela con cui sono essi sì raramente sparsi nella serie delle nostre sensazioni. Lo stesso che dico della pittura dicasi della musica, dicasi della poesia, di tutte le arti in somma che hanno per mira di fare una dolce illusione ai sensi nostri, e di eccitarvi col mezzo della immaginazione un dolce turbamento. Chi non si scaglierebbe contro uno di costoro, il quale alla lettura del più bel pezzo di Dante, mentre fa dire al conte Ugolino quel doloroso
Ahi, cruda terra, perché non t’apristi!
in vece di lasciarsi agitare dall’azione che fa il poeta sopra ogni cuore sensibile, si fermasse ad osservare che l’accento cadendo sulla settima sillaba, cioè sul perché, il verso non è dolce, e che la terra non può esser crudele, molto meno cruda? Eppure i mezzo eruditi sono appunto in questo caso, né v’è chi giudichi bene delle cose di sentimento che o il popolo, quando possa prestarvi attenzione, ovvero gli uomini di lettere e i filosofi veramente tali, i quali a forza d’un felice naturale e d’un continuato viaggio sono passati al di là della sommità di quel scoglio a cui ci fa ascendere una mal ragionata educazione, e sono giunti a scoprire questa grande verità, che le regole e le leggi d’ogni cosa dipendente dal sentimento sono stabilite con questo nome unicamente perché sono credute necessarie per produrre l’effetto a cui si destina l’opera qualunque ella sia, e che in conseguenza qualora l’opera ottiene il suo effetto, in vece di trovarla cattiva per le regole che vi si trasgrediscono, ragion vuole che si trovino tante regole inutili quante sono le trasgredite.
Ma io potrei scrivere un in foglio inutilmente, poiché la classe, come ho già detto, di questi pedanti non si muta mai, a costo di ribattere la dimostrazione medesima, quand’ella potesse spargersi in materie che non possono rappresentarsi coi segni di più e meno. Uno di costoro appunto s’è scatenato nel nostro caffè contro il valoroso, il benemerito, l’illustre
IL CAFFÈ )( Fogl. V )(
signor dottor Goldoni, uomo al di cui talento comico ha resa giustizia in prima l’Italia, e al dì d’oggi può dirsi la parte colta dell’Europa, al di cui onestissimo carattere e amabili costumi ne rendono giustizia i molti e rispettabili suoi amici. Pretendeva costui che gl’Italiani hanno torto quando trovano piacere alle commedie del Goldoni, declamava che il Goldoni non ha il vero talento comico, che il Goldoni non osserva nessuna regola, che il Goldoni non sa la lingua, che il Goldoni non può paragonarsi a Moliere in verun conto, e continuava su questo gusto. Io, che son persuaso che il più gran castigo che possa darsi ad un ignorante ardito è di lasciarlo ignorante e ardito; io, che sono persuaso che il peggior impiego che possa farsi della ragione umana è adoperandola con un pedante, mi sono fatto portare una tazza dello squisito caffè del buon Demetrio, e me la sono sorbita deliziosamente lasciando declamare il pedante a sua posta; ma giunto a casa me ne vendico, e vendico l’onore non dirò del Goldoni, al quale un elogio di più aggiunge poco, ma l’onore del popolo d’Italia, il quale frequenta e applaude al nostro protocomico.
La commedia è destinata a correggere i vizi dilettando, e questa definizione della commedia, s’ella non è conforme a quella che ne danno gli eruditi scrittori che hanno imparato ogni cosa fuori che l’arte di distinguere le cose buone dalle cattive, mi pare preferibile all’altra, che la commedia è quella che purga l’animo col riso, poiché mi pare che il riso purghi così poco l’animo, quanto la slogatura delle ossa dell’omero purghi l’infamia nella tortura.
Nelle commedie del signor Goldoni primieramente è posto per base un fondo di virtù vera, d’umanità, di benevolenza, d’amor del dovere, che riscalda gli animi di quella pura fiamma che si comunica per tutto ove trovi esca, e che distingue l’uomo che chiamasi d’onore dallo scioperato. Ivi s’insegna ai padri la beneficenza e l’esempio, ai figli il rispetto e l’amore, alle spose l’amor del marito e della famiglia, ai mariti la compiacenza e la condotta; ivi il vizio viene accompagnato sempre dalla più universale e possente nemica, cioè l’infelicità; ivi la virtù provata ne’ cimenti anche più rigidi riceve la ricompensa; in somma ivi stanno con nodo sì indissolubile unite la virtù al premio e la dissolutezza alla pena, e sono con sì vivi e rari colori dipinte e l’una e l’altra, che v’è tutta l’arte per associare le idee di onesto e utile nelle menti umane con quel nodo, il quale se una volta al fine giungessimo a rassodare, sarebbero i due nomi di pazzo e di malvaggio sinonimi nel linguaggio comune.
Io non dirò che le ottanta e più commedie del signor Goldoni dilettino tutte; dirò che spirano tutte la virtù, e che la maggior parte di esse veramente diletta. Che diletti me, ogni lettore deve accordarmelo, poiché parlo in materia in cui non v’è miglior giudice competente; che dilettino gli spettatori sembra cosa molto probabile, direi quasi delle probabilmente probabili, anzi delle probabilmente probabiliori, posto che vediamo il concorso ch’esse hanno avuto ed hanno tuttavia per tutto ove si rappresentano.
Gli abitatori di Parigi, quelli cioè che sono avvezzi ogni giorno a vedere su’ loro teatri le più belle produzioni drammatiche che gli uomini abbiano fatte, almeno dacché le memorie sono giunte a noi, essi ascoltano con applauso le commedie del valoroso nostro italiano. Nella Germania molte delle sue commedie si rappresentano tradotte ed applaudite. Pongasi tutto ciò da una parte della bilancia, pongasi dall’altra parte il piccol numero degli insensibili pedanti, e poi si giudichi se in una cosa che piace così universalmente vi sia una ragione perché piaccia, oppure se sia un effetto senza cagione.
La vita degli uomini di genio è sempre stata il bersaglio delle frecce degli uomini mediocri, e Moliere sarebbe stato da essi oppresso, se la protezione d’un gran monarca non lo avesse difeso. Sia detto a gloria nostra, gl’Italiani hanno fatto per quest’illustre paesano quello che avrebbe potuto fare un monarca, e la sensibilità della nazione al merito ha offerto in tributo all’eccellente comico l’allegria, le lagrime e gli applausi de’ pieni teatri.
Sin dalle montagne ove ha scelto di passare i giorni della gloriosa sua vecchiaia il maestro vivente del teatro, il signor di Voltaire, vengono gli elogi al ristoratore della commedia, al liberatore dell’Italia dai barbari, al vero dipintore della natura, signor Goldoni; ed in fatti il nostro comico, per liberarci dalla vera barbarie in cui erano le scene d’Italia, ha dovuto superare i primi ostacoli, cioè la difficoltà di avvezzare i commedianti a imparare a memoria e la difficoltà di avezzare gli uditori a gustare le cose imparate a memoria. Il nostro comico ha dovuto per gradi mostrarci la commedia, e molte ce ne ha mostrate, le quali, oso predirlo, si mireranno un giorno con gloria dell’Italia, come ora con diletto e istruzione.
Egli è vero che il nostro autore sapeva poco la lingua italiana quando cominciò a scrivere; ma nelle opere che diede in seguito si ripulì di molto. Egli è vero che i suoi versi quanto sono facili, altrettanto ancora sono lontani da quell’armonia e da quell’apollinea robustezza che fa piacere la poesia, e tal difetto lo ha comune col Moliere. Egli è vero ancora che il pennello di questo dipintore della natura riesce meglio assai nel rappresentare i caratteri del popolo, che riesca rappresentando i caratteri delle persone più elevate, e di ciò son d’accordo. Ma sieno d’accordo ancora tutti i sensibili e ragionevoli nel trovare che il Goldoni ha tutta l’anima comica e tutto il merito della più pura virtù, che scaturisce dappertutto nelle sue produzioni.
Il soggiorno ch’egli ora fa, per sua gloria, in Parigi, spero che sia per esser fruttuoso all’Italia, alla quale manca ancora la vera arte de’ commedianti. Qui m’avveggo che alcuno, e forse molti de’ miei lettori sospetteranno ch’io cada in un accesso di delirio, ma si tranquillino, si calmino, e se vogliono delle verità leggano, e se non ne vogliono restino come sono.
Nella Francia dunque, dove il comico Moliere, il comico Baron erano insieme commedianti, essi che sentivano tutta la energia dei ridicoli e delle passioni che dovevano rappresentare, diedero esempio agli altri e servirono di modello del modo di rappresentar sulla scena. Essi erano ben veduti alla corte allora la più brillante d’Europa, essi erano ben accolti nelle più nobili e pulite compagnie del regno, e così agevolmente impararono l’arte di parlare, di moversi, di vestirsi e di rappresentare in somma al naturale ogni nobil personaggio. Stabiliti gli esemplari, i quali frequentemente si mostravano, facil cosa divenne l’averne buoni allievi, e tali sono per tradizione i commedianti che in Francia anche al dì d’oggi rappresentano le composizioni drammatiche. Là non vedreste gl’innamorati parlare alle lor belle con una canna in mano, come se sempre fossero di viaggio, col cappello in testa (indecentissima cosa), con un abito malfatto e logoro, avvanzo di un rigattiere. Là non udireste gli urli e il tuon di voce
Lacerator di ben costrutti orrecchi
cose tutte che quasi universalmente accompagnano le compagnie de’ commedianti d’Italia. Là vedreste in somma la nobile natura, il costume rappresentato come egli è, anzi vedreste la commedia divenuta una vera scuola di gentilezza e di buone maniere; onde, se il nostro signor Goldoni, che sente il bello, che conosce il buono, al suo ritorno in questa patria, a cui ha fatto tanto onore, avrà forze tali da portare la riforma ed atterrare gli avvanzi della barbarie che ancora abbiamo pur troppo, spero che ciò si farà. Voglia il buon genio d’Italia che ciò si possa, e che nasca qualcuno degno d’imparare l’arte onorata del Goldoni, e degno di sostenerne la gloria presso i figli nostri.
P. [Pietro Verri]
M’è stato dato un progetto sulla coltivazione del tabacco, ch’io volentieri ripongo nel foglio. Ogni cittadino risente gli effetti del pubblico bene, ogni cittadino deve desiderarlo, e meritano la riconoscenza del pubblico quei che vi meditano e somministrano i loro lumi, sebbene la maggior parte delle volte non l’ottenghino da’ loro contemporanei. Credo che sia un bene che molti scrivino e pensino su gl’interessi veri d’una nazione, sulle finanze, sul commercio e sull’agricoltura; la nebbia ed il mistero servono alla impunità di pochi e alla miseria di molti. I fatti dell’economia politica è bene che si sappiano, poiché è un bene che vi si pensi da molti, e dal fermento delle diverse opinioni sempre più si separa e rende semplice la verità. Chiunque ci somministrerà scritti ragionevoli in queste materie avrà sempre un luogo onorato in questi fogli. Il progetto dunque così dice:
P. [Pietro Verri]
La coltivazione del tabacco
La prima e principal massima di chi dirigge il commercio d’una nazione quella dev’essere di renderla il più che sia possibile indipendente dalle altre, sì quanto all’industria che quanto ai generi di prime necessità, nell’abbondanza de’ quali consiste realmente la vera ricchezza d’uno Stato. Egli è vero che sarebbe una chimera il voler pretendere di conseguire una totale indipendenza: non omnis fert omnia tellus; ma come perdonarla a chi potendo con facilità trapiantare qualche prodotto entro i propri confini volesse ciò non ostante con grave discapito della massa circolante andare a procacciarselo altrove?
Cinquanta mila filippi costa l’annua provista delle foglie per i tabacchi che si consumano in questo Stato; il nostro clima (a dispetto di chi non lo vuole), i nostri terreni, la nostr’aria sono ottimi per la coltura di questa pianta. L’esperienza cotidiana lo mostra ad evidenza, eppure si prosegue a comperarli fuor di paese, né mai il progetto di farne qui le piantagioni fu fin ora, ch’io sappia, o proposto o tentato, quantunque unito al pubblico vantaggio trovar vi potesse il particolar guadagno anche chi ha il diritto di venderli, colla diminuzione dell’intrinseco valore del tabacco istesso.
Qualche calcolatore del gusto dell’oppositore al bellissimo progetto della natural spurgazione del canale detto Naviglio della nostra città, troverebbe forse questa mia proposizione erronea ed iperbolica, e mi proverebbe in via di moltiplico con un bel conto dimostrativo che il valore de’ fondi che s’impiegassero a questo fine, e sopratutto le sole giornate necessarie alla di lui coltura, basterebbero per far ammontare al doppio il prezzo del tabacco che si raccogliesse, a fronte del forestiero, e con ciò ne minacciarebbe un gravissimo pregiudizio alla regalìa. Aggiungerebbe in seguito le dispendiose disposizioni di attrezzi e di fabbriche; la difficoltà di trovar gente pratica per coltivarlo e manufatturarlo nelle debite forme; quindi lega facendo con alcuni nasi rispettabili, più squisiti e dilicati degli altri, concluderebbe con una declamazione sul gusto delle Verrine contro l’enorme spesa, l’insuperabile difficoltà, la pessima qualità del tabacco e la chimerica idea del progetto.
Prima però d’entrare a confutar queste obbiezioni, convien premettere per conforto dei nasi parasiti ch’io non intenderei già che si dovessero proscrivere i tabacchi di Siviglia, del Brasile; anzi da principio né meno le stesse foglie ordinarie. Devesi in tutto andar per grado, poiché quand’anche per supposto conseguir non si potesse che di sostituire il tabacco nostrano al più ordinario e grossolano, non sarebbe sempre questo ancora altrettanto oro risparmiato all’interna circolazione? Non verrebbe il pubblico a guadagnarvi la sussistenza di tutte quelle persone che venissero impiegate alla di lui coltura? Ho ragione nulladimeno di credere che non anderebbero molti anni, che l’introduzione della foglia forastiera verrebbe naturalmente e colla sola sperienza sempre più a sminuirsi ed a cessare.
Ciò premesso (oltre che io non saprei se il prodotto de’ fondi si dovesse punto computare in un paese che abbia una considerabile quantità di buon terreno tuttora incolto da surrogare a quel poco destinato alle proposte piantazioni), egli è certo che il prodotto del tabacco (ritenuta sempre la necessità di questo genere) sarà a dir poco d’una doppia rendita di qualunque altro, potendovi assicurare, dopo replicate esperienze fatte qui, quando eravi libero il traffico di questo genere, che una sola pertica, poco più, di terreno ben coltivata a tabacco è giunta a produrre di netto i dieciotto, fino i venti filippi; differenza enorme certamente in confronto di qualunque altro de’ nostri prodotti. La spesa della coltura poi, ed è necessaria alla produzione di qualunque altro frutto, e si potrebbe di molto sminuire coll’impiegarvi tutti quei condannati che doniamo così liberalmente. Così risparmiare pure in gran parte si potrebbero le altre spese di attrezzi e di fabbriche, essendo i primi poco differenti dai soliti praticarsi nell’ordinaria agricoltura, e potendo supplire alle seconde molti vecchi ed ora quasi inutili edifici; e per dirne d’un solo, il vastissimo recinto del Lazaretto, il quale ci offre ad un tempo stesso ed un ottimo fondo per coltivarlo ed un opportuno fabbricato per riporlo, manufatturarlo e custodirlo. In risposta poi a chi promove la difficoltà di trovar gente pratica per ciò fare, direi che in nostro paese non ne manca, e lo rimanderei al Dizionario del commercio del Savarì, dove troverà per esteso le varie colture che si danno al tabacco secondo i paesi. Quella che si pratica in Francia mi sembra da preferirsi nel caso nostro.
Altro non resta adunque che il timore della cattiva qualità. A ciò rispondo che quando la foglia del tabacco nostrano si raccolga ben matura, e si lasci sopratutto riposare da un anno all’altro, riesce per le fatte sperienze molto buona; ottima poi per formarne dei tabacchi fermentati ed artificiali d’ogni qualità.
Ed eccovi il più brevemente che mi sia possibile esposto il mio pensiero, quale riunendo alla pubblica utilità (coll’impedire ogni anno la sortita d’una somma cotanto grandiosa, e col procurare la sussistenza a buon numero di famiglie) il vantaggio tanto della regalìa quanto di chi la tien in affitto (colla diminuzione dell’intrinseco valor del tabacco) potrebbe meritare qualche esame, massimamente presso persone non volgari, né facili a impaurirsi al sol vocabolo di cosa nuova, né prevenute da un inconsiderato amor proprio a segno di trovar male tutto ciò che non ha preso il primo nascimento nella loro immaginazione.
S. [Pietro Secchi]
Così termina il breve progetto, il quale a nostro giudizio potrebbe aver luogo a beneficio d’ogni paese che voglia non trascurare i propri vantaggi anche a costo di pensare a’ spedienti che non sieno venuti in capo ai nostri avi. Ma per fare un bene qualunque un po’ grande a una nazione vi vogliono di quegli uomini che il volgo chiama imprudenti, e che la posterità chiama uomini grandi. Se essi nascono in una felice combinazione di cose, ripuliscono una nazione selvaggia, e si chiamano Pietro il Grande; se nascono in una privata condizione, scrivono tutto al più qualche libro, e ottengono per sommo elogio quello che ebbe l’Abate di San Pietro, cioè d’autore di sogni, d’un buon cittadino.
P. [Pietro Verri]
Ricevo da ottimo cittadino il seguente dialogo da inserirsi nel nostro Caffè. Ei ci pare molto utile da presentarsi al pubblico, poiché se non è possibile in un breve scritto d’illuminare profondamente su una materia tanto interessante per gli uomini, è sempre un bene grande il far conoscere che le cose non sono a quell’apice di perfezione a cui credono che siano giunte gli uomini volgari, ed è sempre pure un bene il mostrare quai sieno gli autori e le mire che debbono seguirsi per innoltrare i progressi d’un oggetto tanto necessario qual è l’agricoltura. Speriamo che i lettori nostri saranno contenti di questo breve saggio per ora, e speriamo altresì che chiunque abbia cose utili, nuove e ragionate, le quali per la tenuità del loro volume non possano star bene pubblicate da sé, vorranno far capo al nostro Demetrio e contribuire alla nostra raccolta, ricevendone in premio un esemplare annuo gratis, quando però piaccia a noi di farne uso. Ecco in somma il dialogo.
Dell’agricoltura. Dialogo. Afranio e Cresippo
Afr. Non so se vi ricordiate, signor Cresippo, della promessa che un giorno mi avete fatta, d’istruirmi come noi potressimo far valere l’agricoltura, le arti e l’industria per togliere lo sbilancio che soffre il nostro commercio. Io spero che dalla vostra cortesia otterrò questo piacere.
Cres. Mi sovviene benissimo, né ricuso di mantenervi la parola; ma siccome sono queste materie importantissime, e che meritano d’essere separatamente trattate, così non mi comprometto di potervi subito intieramente compiacere. Se vi bastasse per ora di ascoltare le mie riflessioni intorno l’agricoltura, io sono in grado di servirvi, riservando in altro tempo il discorso sopra le altre materie.
Afr. Io sono persuasissimo dell’importanza dell’agricoltura, e volentieri sentirei a parlarne, se ciò si potesse fare utilmente. Tutt’altro abbiamo di bisogno, che d’imparare i precetti d’agricoltura. Siamo nati in un paese in cui la medesima è ridotta a quella perfezione che non può ricevere miglioramento alcuno. Mi accorderete anche voi che non v’ha forastiere, il quale passando per questo Stato non esclami: che belle campagne! che fertilità! che fin’agricoltura!
Cres. Io convengo che lo Stato di Milano, considerato in complesso, sia ben coltivato, e che paragonato alla maggior parte dei regni europei si distingua fra di essi; ma vi devo dire altresì che in certi capi d’agricoltura è superato d’alcune altre nazioni, e che in tutti puol essere migliorato, onde il mio ragionamento non vi sarà inutile.
Afr. Se l’affare è nei termini nei quali voi me lo rappresentate, io son ben contento di udirvi e di profittare dei vostr’insegnamenti, benché, qualunque sia il miglioramento che siete per progettare, non mi sembra sperabile dalla sola scienza. La sperienza, che deve precedere le nostre operazioni, esigge una seria applicazione, e spese non indifferenti. L’incertezza della riuscita, la nostra pur troppo sensibile povertà ci toglie affatto il coraggio e ce ne allontana il pensiere. Ho letto nei dialoghi di Xenofonte che: Agricultura magnum incrementum sumeret, si quis vel per agros, vel per vicos optime terram excollentibus praemia constitueret. Ho inteso che in molte provincie della Francia, nella Svizzera, in Toscana, in Modena, si erigono opportune accademie, e si distribuiscono premi a chi fa qualche utile scoperta, o meglio d’ogn’altro fertilizza un terreno incolto.
Cres. È certissimo che i progressi dell’agricoltura sono più veloci, quando con mezzi valevoli si promovono. Vi dissi già, se non m’inganno, che l’agricoltura contiene tre articoli, cioè il moltiplicare i frutti, il perfezionarli, e l’introdurne dei nuovi. Per la moltiplicazione e perfezione dei frutti fa d’uopo in primo luogo renderne abile la terra. La di lei diagnostica resta peranche imperfetta. Si può essa distinguere colla profondità della vegetabile, per la qualità del letto che sotto vi giace, per la specie dell’erbe che sopra naturalmente vi crescono, per il colore, per la durezza, il peso, la dissolubilità, vitrificazione, calcinazione, per il gusto, e generalmente per ogn’altra qualità sensibile. Sarebbero necessarie molte cognizioni, lunghe osservazioni, che ancora non trovansi presso dei naturalisti. Le storie naturali de’ fossili del signor Hill, e di Emanuele Mendes da Costa, membro della Società Reale di Londra, ci possono ora somministrare dei lumi molt’importanti per quest’effetto. L’Accademia di Bordeaux propose il premio nell’anno 1761 a chi insegnava la migliore maniera di conoscere la diversa qualità delle terre per l’agricoltura. Il signor Kubel ha fatta una dissertazione sopra la cagione della fertilità della terra. Tre sorte di terra noi in presente conosciamo, la grassa, l’argillosa e la saboniccia, alle quali convengono diferenti aiuti per migliorarle. Uno di questi aiuti si è la mischianza vicendevole delle terre medesime, giudiziosamente fatta. Giova assai alla buon’agricoltura l’unire per mezzo di cambi i piccoli pezzi di terra dagli altri disgiunti. Incredibile riesce la spesa, l’incomodo e la perdita del tempo che fa di mestieri impiegare per lavorarli; sovente per questi difetti poco o nulla se ne cava. Un’usanza ugualmente profittevole sarebbe quella di fare gli affitti a lungo tempo. Il proprietario vedrebbe i suoi fondi più a dovere coltivati, e con maggior prontezza sarebbe pagato dall’affittuario, l’industria del quale avrebbe un campo più vasto da svilupparsi e d’intrapprendere a fare tutto ciò che deve godere per molto tempo, invece che la certezza o il timore di travagliare unicamente per gli altri lo costringe a pensare ai soli miglioramenti annuali, e fa perdere a lui egualmente che al pubblico tutto ciò che intraprenderebbe senza questo corto e fatal termine, che fa passare il prodotto delle sue fatiche nelle mani altrui. Il dissodare e porre a frutto le brughiere e le paludi, che in abbondanza trovansi nello Stato, lo stesso è che l’ingrandire lo Stato medesimo. Il valore d’un paese non si misura dalla di lui estensione, ma bensì dalla quantità e qualità dei prodotti, dall’utilità dei lavori, e dal numero degli abitanti mantenuti da quelli. Riflette ottimamente il signor Nikolls[1] che ogni terra, la quale nulla produce o cessa di produrre, fa una mancanza notabile ad una nazione, a togliere la quale ci esortano le Sagre Carte:[2] Novate vobis novale, et nolite serere super spinas. In Annover, per ordine del re d’Inghilterra, suo sovrano, si è dato al pubblico un metodo eccellente per rendere fruttifere le brughiere, metodo che troverete esposto nel Giornal economico dell’anno 1751. Il signor Turbilly ha fatta una memoria sur les defrichemens,[3] i di cui insegnamenti sono stati utilissimamente sperimentati. Ottimi precetti d’agricoltura troverete, signor Afranio, nel Traité de la culture des terres par Mr. Du-Hamel de Monceau, nell’Essai sur l’emelioration des terres de Mr. Patullo, nei Principii d’agricoltura del signor Home, scozzese, tradotti e stampati in Milano. Avrete ancora varie belle cognizioni delle opere degli inglesi signori Evelyn, Laurance, Miller, Thull; dagli Atti delle Accademie Reali di Francia, di Londra, di Svezia, di Berlino, di Pietroburgo, dall’Enciclopedia, Maison rustique, settima edizione, dal Dizionario economico di Chomel, dal Gentiluomo coltivatore.[4] In Danimarca si sono recentemente pubblicate le seguenti opere: Breve istruzione sopra l’agricoltura; Pensieri patriotici su l’economia ed agricoltura; Saggio sopra la maniera di perfezionare l’agricoltura. Nello stesso regno trovasi un Magazzino economico sopra l’agricoltura ed economia rustica.[5] Da’ torchi di Scozia è sortito un trattato intorno la vegetazione, la coltura o lavoro della terra, gl’ingrassamenti e loro effetti, ed i terreni.[6]
Oltre d’avere preparata la terra, altre diligenze sono da usarsi per ottenere la desiderata moltiplicazione e perfezione dei frutti. Fra questi tengono il primo luogo le biade, perché sono agli uomini d’assoluta necessità. La loro semenza dev’essere preparata, al che può servire la maniera che insegna il suddetto Giornale economico del 1751,[7] da
IL CAFFÈ )( Fogl. VI )(
cui pure potrete imparare come preservarle dalle brine. Vedete ancora: Le precis des experiences faites à Trianon par Mr. Tillet d’ordre du Roi. Un buon agricoltore cangia di spesso la semente medesima, e la sperienza gli suggerisce che quella la quale viene tratta dai paesi più lontani, maggiormente fruttifica, ma sopra il tutto rara la spande. Il risparmio della semente è un grand’oggetto negli anni di carestia; la perdita che fa esso agricoltore quando prodigamente la semina, diviene sempre più considerabile allorché l’abbondanza dell’anno seguente fa bassare i prezzi dei grani. Egli è obbligato di vendere a basso prezzo il prodotto d’una semenza che gli è costata assai. Nel primo tomo del trattato del signor Du-Hamel vi è la descrizione d’un istromento opportunissimo per seminare i grani con economia e con eguale distanza. Il signor Patullo consiglia a non seminare giammai né segala, né avena; la prima, dice egli, puol essere rimpiazzata dal frumento prodotto anche dalle brughiere, qualora vengano a dovere coltivate; alla seconda supplisce l’orzo, ch’è molto più sano per i cavalli. Il signor Tourbilly al contrario trova molto profittevole il seminare la segala, perché più abbondantemente cresce del frumento. Il Gentiluomo coltivatore esalta l’avena sopra l’orzo; ciascheduno potrà regolarsi a seconda del prezzo, del bisogno e dello spaccio che avrà nel proprio paese. L’annona ben regolata suole portare l’abbondanza delle biade; ella deve considerarle e come una mercanzia, e come l’alimento principale dell’uomo: come una mercanzia ha da procurarne un pronto esito presso gli esteri. Questa politica ha guadagnata all’Inghilterra in cinque anni di tempo, cioè dal 1746 a tutto il 1750, cinque milioni ducento ottantanove mila ed ottocento quaranta sette lire sterline, equivalenti in circa alle nostre lire milanesi 173.464.951, e ne ha dippiù aumentata di modo nel regno la copia, che il loro prezzo nei predetti anni fu minore degli antecedenti. Qualora poi le risguarda come il principale sostegno della vita umana, è necessario ch’ella usi un’esatta diligenza a provedere i pubblici forni della migliore qualità di esse, e che preveda e si opponga agl’inganni non pochi dei castaldi, dei mercanti e dei mugnai. Ma ciò non basta, se non invigila ancora alla fabbrica del pane, dal quale ben fatto o mal fatto dipende in gran parte la conservazione o la perdita della pubblica salute. In Londra è stato stampato un trattato del pane intitolato: Il veleno discoperto. Nella città medesima fu mandata ad un segretario di Stato una lettera anonima intorno ai suddetti abusi. Finalmente il signor Giacomo Mannin, inglese, ci ha istrutti più ampiamente col suo libro: Della natura del pane secondo la sua qualità, dei di lui effetti, del metodo sicuro per iscoprirvi le materie eterogenee introdottevi e tutte le altre frodi dei fornai, e ci ha regalati d’una facile maniera di farne dell’ottimo nelle case private.
Vi sono alcune produzioni della terra, le quali essendo ancor immature, sono nella loro perfezione a godersi, e di questa sorta sono i spargi ed i piselli. Chi sa se il nostro grano turco, colto e fatto seccare tuttavia bianco e non affatto maturato, non ci dasse una farina più dilicata e saporita? Dopo le biade, ha da cadere la cura nostra sopra la vigna. Ell’ha bisogno d’essere meglio trattata nel tagliarla, nel coltivarla ed ingrassarla. È un errore il credere che nulla sia più atto a promovere l’abbondanza dell’uve che il lettame ordinario delle nostre bestie domestiche; anzi sono per dirvi che un tale ingrassamento nuoce infinitamente alla bontà del vino, e che non è pure molto utile a procurarcene una copiosa raccolta. La calce delle vecchie fabbriche, i cuoi usati, le corna e l’onghie bovine, la marga, la caligine e la cenere ne portano una bontà e fertilità maggiore. Si può consultare: Le Traité de la culture des vignes par Mr. Bidet.[8] L’Accademia di Bordeaux ha proposto nell’anno 1759 il premio per chi suggerisse i migliori principii del taglio della vigna per rapporto alle varie spezie di essa ed alla diversità dei terreni. Nelle Memorie dell’Accademia Reale Svedese, nel tomo vii, vi è una dissertazione intorno alla potagione. Che vini squisiti avressimo, se nel manipolarli v’impiegassimo la diligenza degli oltramontani? Non ci mancherebbe il vino di Borgogna, di Sciampagna, la manifattura dei quali trovasi descritta nel Dizionario economico di Chomel. La prova è già stata fatta, manca solo il coraggio di assumere annualmente questa fatica. Il chimico Gionchero insegna l’arte di formare un vino eccellentissimo con poca pena e minore spesa. Pongasi, dice egli, del buon vino in un vaso di fondo esteso, all’altezza di due dita, sotto qualche coperto, all’aria fredda nelle notti più rigorose del verno; si troverà questo, nella seguente mattina al levar del sole, tutto pieno di ghiaccio, che si avrà cura di levarlo. Per un’altra notte o per due rinoverà quest’operazione, ed il vino restato s’infonderà in caraffe di vetro, le quali dovranno seppellirsi al rovescio in una buca asciutta sotto terra, e copertele d’arena si lasceranno ivi sin alla state affinché fermenti. Questo vino, essendo stato privato di tutta l’acquosità, diverrà ottimo. L’Accademia di Dijon ha offerti i premi negli anni 1760 e 1761 per chi indicherà quali siano le cagioni della mucellaggine del vino ed insegnerà il modo di preservarlo. Di gran vantaggio sarebbe l’incoraggire nello Stato nostro la piantagione degli ulivi, giacché l’olio di questi frutti tanto scarseggia fra di noi, che ci fa mandare ai forastieri una grossa annua somma. Tutte le situazioni montagnose poste al mezzo giorno, e spezialmente in riva dei laghi, dovrebbero occuparsi da queste piante a preferenza dei gelsi, a’ quali è destinata la pianura. V’è un buon trattato della coltivazione degli ulivi di Pietro Vettori,[9] che ce ne dà la norma. Le pesche, le prugne, le pera, i ficchi, le mela e tutti gli altri frutti sono abbandonati da noi quasi alla sorte, di modo che di rado se ne ponno gustare dei perfetti. Gli abitanti di Montreulle, terra non molto lontana da Parigi, usano ben altre diligenze. Dispongono essi queste piante a’ piedi d’una muraglia, che le difende dalla tramontana, le tengono basse, le coprono nel verno d’un tetto di paglia, le potano e governano con grand’arte. Vestono pure di paglia il loro tronco nel piede, perché sono ben consapevoli che i vapori i quali risalgono dalla terra sono più nocivi di quelli che cadono dall’alto. In Erfurt ed in tutta la Bergues-Strassen s’inoculano i maroni sopra dei rami di quercia molto profittevolmente, al cui effetto si servono quelle genti del marone di cuore, il qual è la parte media delle tre che alcuni ne contengono.[10] Per fare riprodurre generalmente tutte le piante vecchie, ottimo rimedio riesce l’incidere al lungo la loro prima corteccia nel tronco principale, incominciando dove sorgono i rami, sino a fior di terra. La sperienza di questa operazione corrisponde perfettamente alla ragione, perché non trovando più il sugo nutritivo della pianta la resistenza che le fa la prima scorza dal tempo indurita, più facilmente monta e promove la vegetazione. È desiderabile che l’invenzione introdotta di cingere i campi di siepi fatte di piccoli virgulti di mori bianchi si moltiplichi, poiché sempre più si accrescerà l’abbondanza della seta. I boschi non si tagliano fra di noi, ma si distruggono. Devono questi essere scalvati colle regole precisamente contrarie a quelle colle quali si potano le piante da frutto, e meritano una gran cura, affinché non perisca una specie tanto necessaria, e che incomincia a scarseggiare. Il re di Francia ed il re di Sardegna, fra le istruzioni che sogliono dare agli intendenti delle provincie vi inchiudono anche quella di non lasciare tagliare bosco alcuno senza che sia in seguito ripiantato. Il sopraccennato Evelyn, della Società d’Inghilterra, ha composto un libro detto: Silva et pomona. Si ha da consultare in questa materia: L’agriculture parfaite, ou novelle decouverte touchant la culture et la multiplication des arbres.[11] Si può riconoscere ancora La teorie de la coupe des pierres et des bois.[12] La detta Accademia di Bordeaux costituì il premio nell’anno 1759, a chi saprà insegnare la miglior maniera di seminare, piantare, propaginare, conservare e riparare le querce. Vi è la Fisica degli arbori del signor Du-Hamel.[13]
Il lino è molto in uso nel nostro paese, e di buona qualità. Egli ha il vantaggio, come ben sapete, di produrre due frutti: il filo e l’oglio. Col primo somministra la materia a molte preziose e necessarie manifatture, e col secondo supplisce alla mancanza degli ulivi. Merita certamente che la di lui coltura sia ampliata ed estesa nello Stato nostro unitamente a quella del colzar, da’ Francesi detto colesat, e da’ bottanici napus sylvestris, ch’io suppongo essere il nostro ravizzone, l’oglio del quale è eccellente a pettinare le lane. L’esatta cura degli orti ridonderà in grande nostro profitto, giacché le loro erbe ed i frutti ci regalano di cibi sanissimi e di poca spesa. La Maison rustique e molti altri dei sopracitati autori ne trattano. Nelle Memorie dell’accennata Accademia Reale Svedese vi è una particolare dissertazione sopra la coltura delle radici, o siano rape. Ella è contenuta nel tomo VII degli Atti della medesima.
Non bisogna limitarsi unicamente a procurare la moltiplicazione e perfezione dei frutti conosciuti, ma un’ottima cosa sarà l’introdurne dei nuovi. Ancorché le praterie stabili e naturali siano nello Stato nostro molto abbondanti e ben tenute; le artifiziali però, de’ quali non ne facciamo grand’uso, sarebbero opportunissime principalmente dentro delle città e soborghi, a’ quali nuocono le abbondanti irrigazioni necessarie alle prime. Questi prati artifiziali ben coltivati producono eguale abbondanza, e forse anche maggiore degli altri, e possono formarsi in ogni genere di terre. Le buone e le più forti vengono seminate a trefoglio, ma la semente si dee tirare dalla Fiandra, dove si trova ottima. Alle terre di bontà mediocre conviene l’erba medica, detta in francese luserne. Quelle poi d’infima qualità portano l’erba detta falsa segala, faux-seigle. Ella è fecondissima e facilissima a nascere in ogni luogo; ed in Inghilterra se ne fa molta stima. Di questi prati artifiziali ne tratta il signor De la Salle nel libro suo intitolato: Prairies artificielles.[14] Nelle suddette Memorie dell’Accademia Reale Svedese, tomo VII, havvi una dissertazione intorno al modo di prevenire la putrefazione del fieno raccolto nell’umido. In difetto del fieno, giova valersi d’una buona quantità di piccole rape, le quali date da pascere agli animali domestici mirabilmente a quello suppliscono.
Il canape è raro fra di noi, benché abbia la proprietà di crescere quasi in ogni sorta di terre. La piantagione di questo somministrarebbe allo Stato una gran manifattura di corde, di gomene, di vele ec. intorno a cui s’impiega un gran numero di poveri e d’idioti inabili ad altro più fino lavoro. Il signor Dodard, intendente della provincia di Berrì in Francia, gran sollecitudine v’impiega per promoverne la coltura, ed ha ottenuti dal governo premi considerevoli per chi vi si applica. Il signor Mercandier nel suo Traité du chanvre[15] ci dà un detagliato metodo di coltivare e trattare questa pianta. Minore diligenza richiede, ma non minor utile porta l’ortica grossa. Nasce questa nei fondi più sterili, e dalla medesima se ne cava un sottilissimo filo, con cui se ne formano tele di grande prezzo. Il Dizionario di Chomel ed il Giornale economico dei mesi di marzo ed aprile del 1751 ne insegnano la maniera di renderla ad uso. Vittorio Amedeo, re di Sardegna, fece piantare a Reconigi il tabacco, e lavoratolo da uomini periti, ne ricavò degli ottimi tabacchi. Il sesamo, erba da far oglio molto usitato nella Grecia, fu trasportato in Italia e qui seminato da due nobili bolognesi con molto loro profitto. Forma egli bacelli longhi un’oncia e mezza in circa, pieni di semi bislunghi alquanto più grossi del miglio, i quali sono tanto ubertosi che d’una libra d’essi pesante once dodici se ne cavano ott’oncie d’oglio limpidissimo e di color giallo. In vista d’un utile così rimarchevole dovressimo noi pure usarlo. I nostri campi sono capaci di produrre lo zafferano, il guado, la garancia, in francese garance, e la soda, erbe per la tintura, per il sapone e per le cristalliere.
Afr. Credete voi, signor Cresippo, che i frutti, l’erbe e le piante oltremarine possino allignare nel paese nostro?
Cresip. Chi ha incominciato a fare la storia naturale dei nostri monti mi assicura d’avervi trovate naturalmente nate delle piante americane, come fra le altre il guaiaco, ed anche molt’erbe affatto incognite ai bottanici, onde forz’è il dire che trasportate qui le medesime o altre simili vi allignerebbero. Con tutto ciò non ardirei d’assicurarvi che tutt’i vegetabili oltremarini possino crescere fra di noi; ma se vari d’essi non prendono piede nelle terre nostre, io sono di parere che non sempre ciecamente si debba incolpare la diversità del clima e dei terreni, ma bensì principalmente la poca cura che si ha nel trasporto da sì lontane parti delle sementi e degli arboscelli vivaci. Pochi anni sono fu stampato in Parigi un ottimo libro, da cui possiamo imparare quest’arte. Egli è intitolato: Memoire instructif sur la maniere de rassembler, de preparer, de conserver et d’envoyer les diverses curiosités d’histoire naturelle.[16] Di fatti siamo venuti a capo di far nascere e maturare il caffè, gli ananas, il cottone e varie sorte di fiori, quando abbiamo voluto impiegarvi le necessarie diligenze. Nel Brandemburghese si trova chi è arrivato a far crescere l’arbore della cannella. Chi sa che noi pure non giungessimo a vedere nato fra di noi il cacao e lo zuccaro, oppure trovassimo almeno la maniera di supplire a queste droghe senza cavarle da un nuovo mondo? Nel Portogallo v’è una pianta comunissima, che fruttifica una sorta di ghiande similissime a quelle della nostra rovere, e che contiene una polpa saporitissima ed ardirei dire migliore di quella del cacao. Questa cresce in siti di poca coltura, e crederei che non fosse per ricusare il nostro suolo nel caso che il cacao assolutamente resistesse alle nostre premure. Il grano turco in un certo determinato tempo della sua vegetazione è pieno d’un suco dolcissimo niente inferiore a quello delle canne di zucchero, e chi sa se sottoposto anch’egli alle operazioni che impiegano tanto numero di negri nelle coste meridionali dell’America, non fosse per rendere un nazionale zucchero?
Afranio. Tutto va bene, ma se ci dilettassimo di tante non ordinarie piantagioni toglieressimo alla produzione dei grani una gran parte delle terre, e così verrebbesi a privare lo Stato d’una rimarchevole quantità d’una sì necessaria derrata.
Cresippo. Dovete sapere, signor Afranio carissimo, che in buona regola di commercio, quando uno Stato permuta collo straniero il più grande prodotto delle sue terre contro il più piccolo, egli ha lo svantaggio; e quando lo Stato medesimo cangia il prodotto de’ suoi fondi con lo travaglio del forastiere, resta similmente pregiudicato, perché il forastiere stesso viene mantenuto a nostre spese. Il signor Cantillon, nel suo Saggio sopra il commercio in generale, ci dà una prova convincente di questa massima, e ci fa comprendere che 25 pertiche francesi di terra producenti 150 libbre di lino purgatissimo da lavorarsi in merletti finissimi di Fiandra, equivalgono ad un milione e secento mila pertiche coltivate a vigna, che mantiene per un anno due mila persone e guadagna cento mille once d’argento. Lo Stato nostro è per ordinario così ubertoso in grani, che glie ne sopravvanza una gran copia da vendere ai vicini in controcambio del loro più piccolo prodotto, qual è la materia delle arti nostre più fine, e del loro travaglio, come sono le merci di molta fattura ch’essi ci mandano. Ora dunque se noi in vece di seminare i campi di tanta copia d’una derrata in parte superflua ai nostri bisogni, li destinassimo alle produzioni da me collaudate, produzioni atte a promovere le nostre manifatture, moltiplicaressimo in infinito la nazionale popolazione e le ricchezze.
Non cesserei per gran tempo di ragionare, se volessi rappresentarvi in dettaglio il pregio e l’utilità dell’agricoltura; la mia intenzione tende unicamente a darvene una sufficiale idea per innamorarvi di questa scienza, la quale, dice Columella: tam discentibus aeget, quam magistris. Voi dovete impararla dagl’insegnamenti di quei dotti maestri che hanno impiegato il loro sublime ingegno ad indagare i segreti della natura, e molto più dalla sperienza propria fatta nel vostro paese ed osservata con occhio filosofico. Quest’occhio filosofico, che ha fatto trovare al signor Koelreutter il sesso delle piante, ed al signor Linneo i sponsali[17] ed il sonno delle medesime, farà conoscere anche a voi le leggi della vegetazione, che sono state il soggetto delle fatiche del signor Hill; la gradazione della natura per arrivare alla perfezione, sopra del qual argomento v’è un’opera intitolata: Divertimenti fisici;[18] ed anche forse qual sia l’influsso dell’aria e della luna sui corpi vegetabili, proposizioni esposte al premio dall’Accademia di Bordeaux negli anni 1750 e 1760. Non fate gran conto del sapere dei contadini: questi non producono che una semplice, triviale pratica, che fu la stessa dei loro bisavoli e che non fu giammai capace d’avvanzare in un punto la scienza dell’agricoltura. Ricordatevi di quel detto di Catone: Male agitur cum domino, quem villicus docet. Voi dovete all’incontro essere il loro maestro, ed essi gli esecutori dei vostri precetti. L’idiotismo e la simplicità di questa povera gente non deve però dispensarvi dall’amarla teneramente e di considerarla il sostegno principale della società umana, in cui fa una figura molto più importante di quella di coloro che si fanno strascinare in carri dorati per la città. Ella è dedicata ad un’arte che è la più utile fra le terrene scienze, che ha fatte le delizie a molte teste coronate e che fu comunissima ai più potenti cittadini, ai trionfatori del mondo, quali furono i Romani: Ipsorum (disse Plinio) manibus triumphatorum colebantur agri, ut fas sit credere, gaudentem tunc terram vomere laureato, uberiorem dedisse fructum.
F. [Sebastiano Franci]
In fatti, lettori cortesi, quando uno scritto non facesse altro che dar delle viste agli uomini onde giunghino ad esaminare le loro opinioni, ed a non crederle le vere, le sicure, unicamente perché sono opinioni loro, quello scritto, dico, sarebbe da chiamarsi utile. L’ostacolo più forte che incontrano le arti tutte e le scienze a perfezionarsi è la tenace prevenzione della maggior parte degli uomini in favore delle cose vecchie. Buona parte de’ possessori delle terre e buonissima parte de’ rustici credono il sistema attuale d’agricoltura il migliore fra i possibili, e sono ostinatissimi partigiani dell’ottimismo leibniziano e popesco; eppure altrettanto convien dire che ne pensassero gl’Italiani che vivevano nel secolo decimoquinto; e chi sa allora quante risate avrà ottenuto quel novatore che nella sua patria proponeva il primo di coltivare i gelsi? Ora questi gelsi appunto formano uno de’ principali prodotti del commercio d’Italia, colla seta che per essi coltiviamo. Quante buffonate non avrà dovuto ascoltare quel novatore che avrà proposto il primo di coltivare il grano turco fra di noi nel secolo passato? Eppure da questa coltivazione forse ne è derivato il non avere più carestia, massimamente nell’Insubria, ove, se scorriamo le storie, rare volte erano passati cinquant’anni per l’addietro senza provarla. Correr dietro alle novità per puro piacere della novità è cosa da cervelli sventati e incapaci di far buon uso degli oggetti che conoscono. Stare immobilmente inchiodati alle cose che ritroviamo stabilite è cosa da cervello di corta vista, che non osando conoscere nulla per i suoi principii non ha per decidersi che la sperienza. Cercare l’utile e il buono indifferentemente, sia nuovo, sia vecchio, questo è il principio che regola le azioni dell’uomo di testa. Un buon bicchiero di vin di Capo vale più che tutti i più squisiti Falerni onorati col nome del più antico consolato, come un pezzo del Colosseo val più che tutti i nostri moderni disegni di architettura, a parer mio. Se il czar Pietro non avesse osato pensare che la sua nazione era incolta, non avrebbe fatto ad essa gl’insigni beneficii che la rendono al dì d’oggi gloriosa; ed è, cred’io, ottimo indizio d’essere un buon patriota italiano quello di persuaderci che le nostre opinioni anche in fatto d’agricoltura possono cambiarsi con altre più ragionevoli e di maggiore profitto della nazione.
P. [Pietro Verri]
[Le riverenze]
Amico Demetrio.
Dite ai vostri scrittori del Caffè ch’io sto per pubblicare un’opera molto instruttiva, che avrà per titolo Trattato matematico-logico-politico sulle riverenze. Il titolo è pomposo, e spero di farvi brillare l’ingegno e l’erudizione. Voi sapete, o benedetto Demetrio, che gli uomini del dì d’oggi vogliono dappertutto analisi, dimostrazione e ciffre algebraiche; io da uomo di giudizio mi servirò di questo linguaggio, e darò la teoria per calcolare l’indole e il carattere delle nazioni e degli uomini sulla maniera diversa di far riverenze. Mi spiego. Considerisi il corpo umano come una linea perpendicolare all’orizzonte, questa linea la chiamo felicità; considerisi l’uomo disteso a terra paralello all’orizzonte, questa linea la chiamo miseria; l’angolo che fanno queste due linee è appunto di gradi novanta, cioè angolo retto; ora tutte le riverenze possibili io farò vedere come siano comprese fra questi due termini; e proporrò la soluzione della natura delle società e degli uomini derivata dal grado dell’angolo a cui sono abituati. Farò inoltre vedere come la perpendicolare dinoti divisione di beni, e l’orizzontale coalescenza dei medesimi; quindi aggiungerò una tavola esattissima de’ diversi angoli che fansi nel salutare sotto diversi gradi di latitudine.
Le prime riverenze, scostandosi appena dalla perpendicolare, si chiamano riverenze di protezione, quando son fatte da pochi, e riverenze di sicurezza, quando son fatte da molti: sono elleno accompagnate da un sorriso o da uno schiavo, se son rare, e da un buon giorno, amico, se sono comuni.
Le ultime riverenze sono le prosternazioni orientali, accompagnate sempre dalla genealogia del Sole e della Luna in favore del riverenziato.
Ho già mostrata col calcolo una grande verità, ed è questa, che laddove l’uso della perpendicolare sia di pochi, le massime riverenze sono quelle che fanno i creditori ai debitori qualificati.
Il cortigiano riceve una insigne riverenza dal nobile, il nobile ne riceve una quasi fuori d’equilibrio dal curiale, il curiale ne riceve di officiose e patetiche da qualche litigante; il facchino nec dat, nec tollit, né riceve, né fa riverenze.
Parlerò in seguito di alcune riverenze, le quali non si distinguono per la loro inclinazione, ma bensì per certe altre piccolissime, leziosissime grazie, che proprio innamorano. Se per esempio volete salutar taluno, e fargl’intendere che siete suo
IL CAFFÈ )( Fogl. VII )(
svisceratissimo amico, dovete sbracciarvi accostando e allontanando ambe le mani alternativamente dalla bocca; facendo più volte un orate fratres, e secundum qualitatem personarum talora a ciò s’aggiunga un riso, un ah ah, e persino un ruggito da leone; ed eccovi fatto un amico intrinseco.
Aggiungerò poscia la esatta calcolazione di quelle riverenze le quali si fanno più dilicatamente, accostando bel bello l’estremità delle dita della mano destra al labro con un insensibile curvamento, indi scostandola adagio adagio con uno schiavo per lo più nasale e con un vezzoso increspamento di pelle da mandarino chinese che sorride.
Vi sarà una annotazione su i profondissimi; e sono questi profondissimi coloro i quali da animali a due piedi diventano ad un tratto quadrupedi, e presentando al protettore tutto il disco della loro umilissima schiena pare che voglian dire: Vossustrissima mi faccia l’onore di bastonarmi. A questi implacabili facitori di riverenze io mostrerò come le carotidi secondate dalla gravità della terra debbano fare una inondazione di sangue nel capo, ed entrerò a degustare un po’ di fisica, dilucidando l’azione che questo rigurgito deve fare sulle meningi e quindi sull’ordine delle idee per quel nesso occulto per cui la disposizione organica vi influisce. Finirò poscia consigliando ai profondissimi di stringersi ben bene la parrucca in capo, acciocch’ella non cada in segno d’omaggio ai piedi del riverenziato.
Poiché tutto ciò sia fatto, entrerò a dare una corsa alla istoria, e farò vedere come alcune epoche memorabili abbiano fatto cambiare le riverenze in diversi luoghi. Così la battaglia famosa di Salamina fece mutare tutte le lezioni di ballo ai Greci; così la battaglia d’Azio fu cagione che mutassero riverenze i Romani; e discendendo poi verrò allo stabilimento di Costantinopoli, agl’imperatori Ottoni, a Federico primo, e nelle altre nazioni ad altri principi e uomini illustri, fra’ quali avran luogo distinto Cromwell, il cardinale Richelieu, Filippo secondo, Carlo duodecimo ed il czar Pietro.
Delle donne converrà ch’io dica qualche cosa. Elleno non secondano i cambiamenti che accadono negli uomini, e ciò cred’io perché sono esse come uno status in statu, che non ha immediata parte nel governo. Da ciò farò vedere come la maggior parte delle donne europee né abbassino il capo, né incurvinsi negl’inchini, ma si contentino di rannichiarsi ed allungarsi, conservando rigidamente la perpendicolare.
Entrerò poi in una complicatissima questione, cioè se di due, uno de’ quali faccia una profondissima riverenza e l’altro la riceva, possa dirsi che ciascuno di essi abbia sincerità, cognizione e stima dell’altro; e la risolverò stabilendo che almeno una di queste tre cose manca in uno dei due.
Per dire poi qualche cosa dei caratteri degli uomini farò vedere che l’uomo saggio risguarda tutte le cerimonie come mezzi efficacissimi per tenersi lontani gl’importuni o i malvaggi. Egli fa una moderata riverenza lontana dal fasto egualmente e dalla bassezza; e poiché gli uomini hanno fatta una tacita convenzione, per cui l’incurvarsi il dorso è un segno d’ossequio, egli urbanamente lo mostra a chi conviene con questo segno.
Gli uomini timidi fanno per lo più o profondissime riverenze, o non ne fanno di sorte alcuna. Le fanno profondissime a coloro da’ quali sperano; e non ne fanno nessuna a coloro che odiano, essendo propria della debolezza la rusticità.
Gli uomini pessimi sono bene spesso de’ più officiosi, poiché temendo essi in ogni uomo o un testimonio, o un rimproveratore delle loro iniquità, implorano colle riverenze e colla adulazione quella connivenza di cui tanto hanno bisogno. Sono essi ben sovente gli uomini i più compiacenti di tutti.
Gli sciocchi poi (che sono pur pochi!) sono stravaganti nelle riverenze loro, come lo sono ne’ loro ragionamenti. Altri pare che vacillando vi cadino a’ piedi; altri serpeggiano e gambettano in mille sconci modi, ed or con l’uno, or con l’altro piede alternano, come se scagliassero calci; ed altri in varie guise, le quali saranno distinte in sei dissertazioni divise in trenta capitoli, e ciascun capitolo in tre sezioni, e ciascuna sezione in quaranta paragrafi, col che sarà fatto un mirabil ordine di parole sempre pregievole, quand’anche non vi fosse nessun ordine nelle idee.
Per interrompere poi la noia al lettore d’una continuata lettura, interporrò un bellissimo intaglio in rame, rappresentante la celebre riverenza che Marco Tullio Cicerone fece a Cesare, quando venne trionfatore da Farsaglia, delineata da un antico basso rilievo.
Farò menzione della celebre riverenza del signor Cristoforo, quando inchinandosi al signor Tommaso gli urtò colla testa sì potentemente nello stomaco, che il signor Tommaso perdette la respirazione e il signor Cristoforo la parrucca; onde uno stordito dalla percossa e l’altro a testa ignuda, rimasero stupidi guardandosi in viso per ben due minuti, finché uno ricuperato il fiato e l’altro la parrucca, il signor Cristoforo disse chiamo mille scuse, e il signor Tommaso rispose non v’è niente di male, con che s’accomodò anche questa, come tutte le differenze cerimoniose, per ispasmodiche ch’elleno possan essere, hanno fine con quelle magiche parole.
Finalmente farò vedere quanto siano incomodi i saluti di taluni, che inchinandosi profondamente vi afferranno come in una tenaglia a tutta forza la mano, e replicatamente tutto il braccio vanno scuotendo; quindi in segno d’estrema benevolenza digrignano per fine i denti quasi per tener raccolto il fiato a sì gran fatica, e terminano sciogliendo uno schiavo, sprigionando un addio, lasciandovi un carissimo, uno stimabilissimo di tutto cuore, con un tuono falsetto penetrante che consola. Questi vi farò vedere come siano i veri amici. Non avete che ad aspettarne l’occasione per essere convinti che sono di vero cuore.
Quanto poi agl’inchini de’ preziosi, io non ardirò di esprimerli altrimenti, se non trascrivendone la corta e vivace descrizione che ne fa un nuovo Giovenale in questi termini:
…egli all’entrar si fermi | Ritto sul liminare, indi elevando | Ambe le spalle, qual testudo il collo | Contragga alquanto, e ad un medesmo tempo | Inchini il mento, e col estrema falda | Del piumato cappello il labro tocchi.
Tale è finalmente, Demetrio amico, il piano della mia opera, il quale comunicherete ai vostri scrittori, pregandoli da mia parte acciocché vogliano presentarlo ne’ loro fogli al pubblico e proccurarmi degli associati per l’edizione che medito di farne.
A. [Alessandro Verri]
Le lettere ci piovono da ogni parte, e quello che ci consola si è che speriamo che siano per piacere al pubblico. Almeno ella è cosa sicura che piacciono a noi. Dalle riverenze passiamo ad un soggetto interessante la fisica, e sono le Osservazioni sul clima milanese. Ecco la lettera che ci è stata diretta.
P. [Pietro Verri]
[Osservazioni meteorologiche fatte in Milano. Sul barometro]
Amico.
Se non mi conosci, ecco in pochi tratti quale in parte io mi sia. Altro Polo, altre costellazioni invisibili su quest’orizonte videro i miei occhi allorché nacqui. Altre terre non ancora calpestate da piede europeo diedero forma al mio corpo; ed altro clima, cui il quadrante non ancora, ma il calcolo solo dell’immortale inglese fissò i confini, modellò il mio spirito e le mie passioni. Una catena di eventi mi ha fissato da qualche anno in queste lombarde pianure. Le lingue europee hanno impiegato per alcun tempo i miei studi. La francese e l’italiana sono le due che ho voluto rendermi più famigliari. L’una per la sua universalità mi parve indispensabile; l’altra per la dolcezza e la forza dell’espressione mi piacque. Lo stile conciso, spogliato da parole superflue, è l’unico al mio gusto. Tale è il genio del mio idioma natio. Il tempo che ho perduto nell’astrologia mi ha fatto conoscere che l’osservazione ed il seguitare ne’ suoi fenomeni la natura, benché a passi lenti, è il solo mezzo onde fissare qualche regola o legge nella scienza delle meteori; scienza che può essere anch’essa delle più utili, e nella quale relativamente al volerne predire gli evenimenti non vi hanno ancora che chimere ed inconseguenze.
L’esempio della francese Accademia delle Scienze, che quasi da cent’anni non ha interrotto le giornali osservazioni de’ fenomeni dell’atmosfera, mi ha determinato ad osservare io pure e scrivere di giorno in giorno quelli di questo insubre cielo, e gli effetti che seco traevano. Queste osservazioni, e le illazioni che si possono derivare, non sono indifferenti allo scoprire maggiormente la natura di questo tuo patrio suolo. A Demetrio ho domandato il tuo nome. Se possono essere di qualche uso a te, cui sprona il vero utile e l’amore non fanatico di tua patria e di tutti gli uomini, le mando, altrimenti gettale al fuoco.
I giornali delle osservazioni meteorologiche da me fatte in questa città e in questi contorni cominciano dall’anno 1756. Quest’epoca in tal genere di cose è rimarchevole, cominciando essa da una fisica universale rivoluzione di tutto quasi questo terrestre emisfero. Ad ognuno è noto che nella fine dell’antecedente anno 1755 fu l’Europa, e buona parte dell’Africa e dell’Asia ancora, da’ diluvi di piogge, da debordamenti di fiumi e da torrenti inondata, da turbini di vento agitata, e finalmente da terremoti scossa, de’ quali il centro Lisbona porterà per lungo tempo la funesta memoria. Se è vero che nelle cose fisiche dopo una grande e forte rivoluzione succeda un nuovo sistema, o in parte cambiato, fortunata per me sarebbe quest’epoca, perché qualunque sieno le conseguenze che dalle mie osservazioni possono derivarsi, partirebbero da un punto cronologico non già, ma fisico ed originario.
Il barometro ed il termometro sono anch’essi divenuti alla moda. Sono due mobili necessari per un gabinetto; anzi dirò più, sono diventati capo di mercanzia, e per questa ragione sotto una vernice lucida ed una risplendente indoratura soggetti ad essere più facilmente falsificati, ed erronei essere ne’ loro moti. Passeggiano per le strade di questa città, la maggior parte condannati ad essere quasi nel medesimo istante comperati e fatti in pezzi dalla stessa inesperta mano, o ad essere alla polvere e a un chiodo in un angolo dimenticati. Molti ne sanno promiscuamente e indifferentemente il nome, pochi ne conoscono l’uso e pochissimi li sanno osservare. Io ho avuto la pazienza, già quasi da nove anni a quest’oggi, di consultare in ore fissate ogni giorno i movimenti e le variazioni di questi due stromenti. Eccone però i risultati.
Le osservazioni barometriche fatte nell’Osservatorio di Parigi, già quasi da cent’anni, sono tutte di un barometro construito sino nelli principii dell’Accademia delle Scienze dal signor de la Hire, e il di cui diametro è poco più di una linea del piede parigino. Generalmente tutte le osservazioni barometriche finora pubblicate, e nelle quali si ha la descrizione degli stromenti su’ quali sono state instituite, tutte furono fatte su de’ barometri a presso poco di questo diametro; ed universalmente il diametro di quelli ben construiti e purgati che si vendono è di una linea, o poco più o poco meno. Parimenti le seguenti mie osservazioni ho tutte riferite ad un barometro ben purgato d’aria, che agitandolo rende luce molto vivida, e il di cui diametro è circa una linea parigina.
Le maggiori altezze del barometro, che io ho veduto dal gennaro a quest’oggi sono: una volta 28 pollici 4 linee 1/2, rare volte 28 pollici 4 linee, più frequentemente 28 pollici 3 linee. Le minori altezze in tutto questo tempo da me osservate furono: una volta 26 pollici 10 linee 1/2, rare volte 26 pollici 11 linee, più frequentemente 27 pollici. Facciasi però il medio aritmetico tra tutte queste maggiori e minori altezze, si avrà costantemente 27 pollici 7 linee 1/2, che chiamerò media altezza. Ho veduto costantemente qui in Milano che il punto dove più comunemente sta fisso il barometro, ovvero l’altezza corrispondente al tempo variabile, è 27 pollici 9 linee circa, poco più poco meno; e questo è quello che chiamerò punto di variabile, che non è lo stesso di quello della media altezza, col quale da tutti gli osservatori, non so il perché, è stato fin ora confuso.
Ho osservato generalmente che se il barometro è costante sopra il punto di variabile, nel tratto di tempo dal mezzo dì alla mezza notte trovasi per lo più meno alto che tra la mezza notte e il mezzo giorno; e parimenti se la variazione va per gradi ho veduto che per lo più il maggior abbassamento succede dopo mezzo giorno, o prima della mezza notte, od avanti il mezzo dì.
Generalmente, quando la variazione del barometro va lentamente per gradi senza salti, certo è il cambiamento dopo di tempo, bello all’innalzarsi, cattivo all’abbassarsi; e il cambiamento che succede ad una lenta e gradata variazione è di lunga durata, e la variazione precede anche di due o tre giorni. Ma se la variazione è subitanea e grande, costantemente accade dopo cambiamento di tempo. Ad un subitaneo e grande abbassamento succede per lo più un gran vento di tramontana o levante; ad un presto totale cambiamento di tempo lungamente piovoso e rotto in sereno bello, precede ordinariamente un pronto e grande innalzamento del barometro, e questo innalzamento e sereno non sono in tal caso per lo più di lunga durata; e generalmente la pronta variazione del barometro non precede al presto cambiamento del cielo che al più lungo tempo di sei o sette ore. Finalmente varia il barometro alle volte nell’atto stesso che muta il tempo, e tali cambiamenti allora non sono di molta durata.
Allorché sta costante non per ore circa il punto di variabile, il cielo non è né sereno, né piovoso né rotto; è in uno stato indifferente del bello e del cattivo tempo. Che se dopo essersi sostenuto alquanto all’altezza del punto di variabile abbassa sensibilmente sotto, è certa la pioggia o il vento; se innalza sopra, è certo il bel tempo.
In questi ultimi quattro paragrafi si hanno tutti li risultati che io ho saputo cavare da’ giornali delle mie osservazioni barometriche. Il primo di questi sembrami nuovo, o almeno non ho fin ora veduto che altri abbiano fatte simili osservazioni. Gli ultimi tre confermano colla mia stessa esperienza ciò che altri hanno veduto forse più in complesso e con men ordine. Vedesi dunque in detti quattro ultimi paragrafi quali sieno i cambiamenti del tempo, ossia del cielo milanese, che succedono alle differenti altezze del barometro, cioè quando si fissa, o si abbassi, o s’innalzi sopra il punto variabile, e quando fa tali movimenti per gradi e lentamente, o pronti e subitanei. Queste costanti osservazioni possono essere altrettante regole sulle quali stabilire i principii almeno di una nuova arte divinatoria; perché posta la barometrica verga in mano di uno spregiudicato, paziente ed illuminato osservatore, potrà forse diventare un giorno di non piccolo uso nelle predizioni delle stagioni e cambiamenti della terrestre atmosfera.
Una delle più importanti conseguenze che si può ricavare dall’aver determinato con una reiterata osservazione di più anni il punto di variabile, ossia il limite tra le altezze corrispondenti al bel tempo e quelle corrispondenti al cattivo, e circa il qual limite tiensi la colonna di mercurio più frequentemente sospesa, è lo stabilire l’altezza del pian-terreno di Milano sopra il livello del mare. È noto a tutti che tra li tropici, e particolarmente sotto l’equatore, le variazioni del barometro sono quasi insensibili, e che al mare è costante a 28 pollici, e che questo è il punto fisso da cui partono o al quale si riferiscono i metodi finora inventati per calcolare le altezze dell’atmosfera corrispondenti a quelle del mercurio nel barometro su differenti piani più o meno elevati della terra. Dunque l’altezza alla quale sta più comunemente fermo il milanese barometro sarà corrispondente all’elevazione del piano di detta città sopra quello del mare. Ho sopra fissato con replicate osservazioni di più anni il punto variabile in Milano a 27 pollici 9 linee, misura di Parigi. Dunque sarà il pian-terreno della città di Milano più alto della superficie delle acque del Mediterraneo, secondo il metodo delli signori Cassini e Maraldi, 31 tese parigine, o 101 5/11 braccia milanesi, e giusta il metodo delli signori Bouguer e Niedam, 109 33/55 braccia milanesi, ossia 33 7/15 tese parigine.
G. [Giuseppe Visconti]
Il rimanente delle Osservazioni meteorologiche lo daremo in breve.
Discorso sulla felicità de’ Romani
Se la grandezza e la gloria fossero sempre accompagnate dalla felicità come lo sono dall’ammirazione, avremmo molto da imparare da quelle nazioni che si resero famose coll’arrivarvi, e potrebbero le storie loro essere una utilissima scuola dove apprendere la difficile scienza di esser felice. Ma è ben diverso il sembrare felice dall’esserlo; il che siccome accade tante volte in ciascun uomo che agli altri sovrasti, così pure alle nazioni. Ammira ed invidia il volgo il fasto e l’opulenza de’ grandi, né sa quanta noia e quanti timori compensino o superino questa apparenza di felicità. Volgo io pur credo che siamo talvolta noi, venerando le conquistatrici nazioni, e loro invidiando la gloria e ’l potere. Si squarcia agli occhi d’un freddo ragionatore quel velo che col nascondere l’interno delle cose accresce loro venerazione. Quindi ritrovasi ben sovente il pianto e la miseria là dove brilla il riso ed il piacere.
Da tali verità non furono guidate le penne della maggior parte degli storici, che tutti intenti a descrivere le battaglie, le vittorie, gli eserciti ed i trionfi, abbastanza contenti di dare il nome di grandi e di gloriose, non mai di giuste e virtuose alle nazioni, mandarono a’ posteri una congerie di miserande grandezze, e ne celarono e tacquero tutti que’ mali che accompagnano le grandi rivoluzioni. Quelle gloriose carnificine, in cui quasi fiere arrabbiate gli uomini miseramente si divorano e distruggonsi, ottengono gli encomi della poesia e della eloquenza, né senza fremere nel fondo del cuore, che anzi in rime canore ed in purissimo stile sono celebrati i massacri di molte migliaia d’uomini tagliati a pezzi, come oggetti indifferenti di mera curiosità ed erudizione. Niente di più comune all’adulazione di una sonnifera dedicatoria che il lodare i nemici sconfitti e le gloriose conquiste, mali, che se pur talvolta son necessari, dovrebbero esser sepolti nel silenzio e nella oscurità, anzicché esser per lungo tempo il soggetto delle umane cognizioni. Quanto studio per un antiquario per rintracciare fra le tenebre delle antiche cose in qual giorno fu la famosa battaglia di Canne o del lago Regillo? Eppure, che cerca egli mai, se non se di rischiarare la cronologia degli umani delitti? E quale elogio avremo noi fatto alla umana natura, quando manderemo a’ nostri nipoti la memoria delle nostre crudeltà? Perché piuttosto non consacrare la storia agli esempi di virtù, di clemenza, di beneficenza, che alle illustri sceleratezze?
La storia del popolo romano, oggetto sì comune della curiosità d’ognuno, fu per tanti versi e scritta e contemplata, e dalla sagace erudizione rischiarata, per modo che ormai nulla rimane d’aggiugnere a tanta folla di scrittori. Alcuni questa storia hanno scritta sì diffusamente, che i menomi fatti non tralasciarono, esaurendo il proprio sapere e la pazienza del leggitore; altri con molta filosofia hanno rintracciate le cagioni della grandezza e decadenza di tanta Repubblica; altri i fasti, la cronologia ed i costumi romani illustrarono. Nessuno, ch’io sappia, scrisse della felicità di questa nazione; punto ben più interessante che la raccolta delle medaglie dei trenta tiranni o la scienza delle iscrizioni: giacché, se malgrado tanti secoli di storia e tanta grandezza, non fosse stata quella nazione felice, ne verrebbe in conseguenza ch’ella, benché vantisi il modello delle altre, non lo dovrebbe essere in conto alcuno, il che, se risulti dalla storia istessa, scorrendovi brevemente sopra il vedremo.
Quanto turbolento ed incostante fosse il sistema di Roma ne’ 244 anni della sua monarchia ben ce lo prova il leggere che Romolo, Tullo Ostilio, Tarquinio Prisco furono tutti assassinati per congiura. Argomento non debole, che era il governo dispotico, non potendosi dare tal successione di reicidii in un moderato governo. E certo il più grande dispotismo Numa, il religiosamente sagace Numa stabilì, interessando gli dei a proteggere la sovrana podestà; ed allora fu che ogni legge discese dal cielo, e che industriosamente fu condotto il popolo al dispotismo colla invenzione de’ giorni fasti e nefasti, col collegio de’ pontefici al re divoti, e cogli augurii, insensibili ed occulti ingegni della somma potenza. Allora al non mai ragionante popolo colla veneranda maestà d’una falsa religione celaronsi gli arcani del dispotismo; e la guerra e la pace e le leggi dai prodigi, dal tuono, dal volo degli uccelli, dalle palpitanti viscere delle vittime ebber norma. Quindi per altra via tal sistema corroborò Tullo Ostilio, avveduto legislatore, che i pubblici comizi ridusse ad una pura apparenza di libertà, ben sapendo che gli uomini contentansi dell’esterno delle cose, gli usi ed i costumi rispettando, né più in là vibrano lo stupido sguardo, sicché lasciandogli le parole gli si tolgono le cose agevolmente.
Ridusse Tullo Ostilio, colla famosa divisione delle centurie, in mano di pochi il governo, ed in tal guisa indusse nella nazione forse il più fatale d’ogni sistema, cioè una corrotta repubblica, non vi essendo dispotismo più duro di quello che ha molti tiranni.
Al principio del terzo secolo di Roma era il numero de’ cittadini romani ottantaquattromila settecento (84700),[19] numero minore di quello di Roma d’oggidì. Con sì ristretta popolazione ben vedesi perché tante piccole e sanguinose tenzoni facessero coi vicini senza stendere i confini, e quale durissima vita menassero per resister continuamente a’ popoli più di loro agguerriti che li circondavano.
Destossi finalmente il popolo dal letargo di due secoli, e s’accorse di sua schiavitù. Fu tutta la nazione in fermento per l’attentato di Tarquinio; ella che sofferse in pace che Tullia il padre assassinasse, e sul di lui cadavere scorresse col cocchio quasi in trionfo. Furono banditi i re, ma altro con loro non bandissi che il vocabolo rex; e Mario e Silla, de’ Tarquini più crudeli, Roma dappoi insanguinarono impunemente, chiamati dittatori; ma se avessero osato aggiugnere alla loro potenza quella odiata parola, avriano ritrovato in ogni cittadino un Bruto.
Tolsesi il popolo romano dalla tirannia per slanciarsi ad una estrema libertà, e dall’avvilimento passossi alla tirannia della virtù; quindi per un crudele amor della patria Bruto fé uccidere i figli ribelli; ed il popolo feroce per la nuova libertà quanto fu infingardo sotto al dispotismo, disfece console Collattino, che d’esser parricida ricusò; ed il console Valerio dovette abbassare la sua casa al comune livello, tanto temeasi ogni spirito di diseguaglianza.
In questo intervallo di pericoli e di torbidi ripieno (come lo sono tutte le violenti mutazioni nella forma di governo), fu Roma veramente libera, e forse non lo fu mai in altro tempo. Gli esempi memorandi di virtù, che altro non è che l’utile comune,[20] allora sfoggiarono,
IL CAFFÈ )( Fogl. VIII )(
onde Orazio, Scevola e per fine il sesso imbelle di Clelia, tutti dal nuovo vigore di libertà animati, fero attonite le genti; son domi i nemici dallo stupore di tanta virtù; e Valerio Pubblicola, benché console (gran prova ch’era il governo repubblicano), muore sì povero che li funerali songli fatti a pubbliche spese. Altro non dubbio segno che Roma era patria, e patria amata da’ suoi cittadini, in che consiste la felicità delle nazioni, fu l’aver dato licenza con un senato consulto alle donne latine sposate ai Romani ed alle romane sposate ai Latini di ritornare ciascune alle case loro, e l’essersi le latine fermate a Roma e le romane spose dei Latini alla patria ritornate.[21]
In tale stato di cose resisté il romano popolo agli implacabili Tarquini, che i Toscani, i Latini ed altri popoli eccitavano contro di lui, ed al lago Regillo il primo dittatore Postumio uccide e fa prigionieri 30 mila Latini. Videsi allora qual differenza passi dal valore di soldati liberi a quello de’ schiavi, poiché libertà e vittorie rapidamente si succedettero.
Ma questo fu un momento di repubblica, giacché cominciarono le gare civili fra i nobili ed i plebei, e crebbero a segno che questi ricusarono di andare alla guerra contro de’ Volsci, e da ciò ben comprendesi che i soldati non guerreggiavano per proprio utile, ma per l’altrui. Allora il console Servilio trionfò malgrado la proibizione fattagli dal collega ed il non comando del Senato. Veggasi da ciò s’ella era democrazia questa, in cui tanto era lecito ad un console, quando che pochi anni prima il console non potea nemmeno avere una casa più alta di quelle de’ plebei. Di fatto ben presto i nobili, cioè i più ricchi, la plebe cominciarono a deprimere, ed ella, passata la metà del secolo terzo, si ritirò nel Monte Sacro, dolendosi che i nobili per tenerla schiava la impegnassero in continue esterne guerre. Creossi allora il primo tribun della plebe, e Coriolano, volendo abolire questo nuovo tribunale, viene esiliato dal popolo. Ma è forse Roma libera per questo? L’esule Coriolano collegasi co’ Volsci, e riduce la patria a chiedergli pace e perdono, benché ribelle. Quindi Cassio, che cerca colla pubblicazione di una legge agraria di favorire l’eguaglianza de’ beni, vien rovesciato dalla Rupe Tarpea, cittadino illustre per tre consolati e due trionfi. Tale era lo spirito di quella chiamata sì facilmente Repubblica, nella quale i plebei eran clienti ed i nobili patroni, cioè questi padroni e quelli servi; del che puossi convincere chiunque esamini le antiche leggi di Roma intorno ai clienti e patroni.
Tutti i vicini voleano pur distruggere questo nascente impero, ed egli non dovea la sua sussistenza che ai continui suoi sforzi per conservarsi. Per il che in Campo Marzio s’indurì ogni cittadino alle fatiche guerriere, ed ognuno fece del suo corpo una vittima alla patria. La lotta, il corso, il cesto ed ogni penosa fatica incallirono la sensibilità, sempre preparandosi ad una gloria avvenire colla perdita dell’attuale ben essere. So che il fanatismo della gloria ed il vivissimo piacere di sovrastare alle emule nazioni poteano compensare i continui disaggi d’una vita durissima; ma tali sentimenti non credo io già che saranno nati nel cuore della maggior parte de’ cittadini, pochi essendo gli uomini capaci di quell’estro trionfatore che gli muove alle grandi azioni a traverso d’ogni stento e d’ogni fatica. Bruto, Scipione, Attilio, Valerio poteano avere un’anima grande; ma il volgo, benché volgo di Roma, non credo io che si nodrisse di grandi sentimenti. Un popolo di eroi è una chimera, ed in ogni società d’uomini il numero de’ sublimi è sempre il minore. Onde tutta quella durissima militar disciplina descrittaci da Vegezio, che noi risguardiamo come un effetto dell’eroismo, era piuttosto un effetto della ferocia istessa de’ loro costumi. La forza de’ muscoli e l’agilità del corpo era il solo pregio de’ Romani. Ed in fatti alla parola virtus eglino non attaccavano le nostre idee, ma bensì l’idea della forza; e fu poscia in seguito chiamata virtù l’abitudine di esser utile alla società; e con tal nome a ragione chiamossi allora la forza, come la qualità più utile alla patria in un governo guerriero.
Al principio del quarto secolo li Romani abbisognarono di leggi, e quasi che non sapessero essere legislatori, mandarono a mendicare la greca sapienza. Funesta fu tal spedizione, poiché i decemviri, eletti a raccoglierle e promulgarle, s’eressero in tiranni. Ritornò la plebe nel Monte Sacro lasciando la vuota città in preda alla tirannia. Fu spento col dispotismo ogni resto di virtù; e fecesi allora quel vilissimo ed iniquissimo giudicio fra gli Aricini ed Ardeati. Questi confinanti popoli avendo rimessa la controversia di un campo limitrofo fra di loro agli Romani, eglino finirono la causa coll’usurparselo.
Appena la plebe comincia a togliersi dalla depressione de’ nobili potenti, aggiungendo al tribun della plebe il diritto di avere il matrimonio comune co’ nobili, che ricusavano gli soldati di andare alla guerra, onde vien loro fissato, circa all’anno CCCXVIII, lo stipendio del danaro pubblico; ed il mestiere della guerra, che pria faceasi con non altra ricompensa che con quella che dà la gloria, cominciò a divenir venale.
Scendono i Galli dalle Alpi nel CCCLXIII; distruggono Roma; e poco mancò che per fin la di lei memoria non s’annientasse; e Manlio, difensor del Campidoglio, troppo favorito dalla plebe, viene gettato dalla Rupe Tarpea, miseramente sfrantumato alle falde di quel colle ch’era monumento di sua gloria e del suo supplicio.
Mentre che sono incerti e fluttuanti i confini dell’autorità della plebe e de’ nobili, fannosi lunghe, continue e sanguinose guerre coi Volsci, coi Galli Insubri, coi Tiburtini, Falisci, Tarquiniesi. Pure, malgrado tanto esercizio di guerreggiare, al principio soltanto del quarto secolo si spinsero l’armi romane nella Magna Grecia, appresso a poco il Regno di Napoli d’oggidì. Malcontenta di nuovo, la plebe ritirasi per la terza volta nel monte Gianicolo. Quale era mai la felicità di questo popolo sempre impiegato in durissime guerre, e costretto ogni tratto a fuggire la tirannia de’ nobili?
Ma successe un fenomeno nel popolo romano, ben raro a mio avviso; poiché il popolo sempre turbolento ed oppresso scosse a poco a poco il giogo della servitù; quindi nell’anno CCCLXXXIV Settimio Laterano fu console, benché plebeo; e nel CDLIII stabilissi che anche gli plebei potessero eleggersi auguri e pontefici. Quest’epoca è memorabile per il popolo romano, attesa l’influenza della religiosa impostura sul sistema di governo. In altre nazioni con violento moto fu in un lampo decisa la gran questione, se doveasi esser libero o schiavo; ma il popolo di Roma si tolse a poco a poco dal giogo de’ potenti, e per ben cinque secoli ora un privilegio or l’altro ottenendo, divenne sì licenziosamente libero che pesògli la sua indipendenza istessa. Ella è indole del popolo d’animarsi e fermentare tutto ad un tratto, di torsi violentemente dalla tirannia; ma il popolo romano con arte, con politica, con costanza intraprese ed eseguì il progetto di esser libero, del che non era al certo debitore a sé, ma piuttosto alla saggia ferocia de’ suoi tribuni.
Ma breve fu il periodo di questa libertà, che anzi appena fu ella rapita dalle mani de’ nobili, che ritornossi a perdere per non mai riacquistarla. Dal tempo de’ Gracchi Roma cadde sempre nel dispotismo; e tanto a poco a poco v’inclinò, che ogni cosa dipendé dalla volontà di un solo. Misera e luttuosa fu la sorte di questa nazione nel tempo stesso della sua grandezza, mentre che Silla, Mario, Cesare, Pompeo se la disputavano. Le proscrizioni, le accuse segrete, ogni sorta di frode e di tenebrosa crudeltà succedettero al fanatismo d’una disprezzata e pericolosa virtù; e dopo le stragi di più di un secolo ebbe Roma sotto Augusto quella pace che nacque dalla impotenza di esser libera. Ella fu una mancanza totale di moto. Or rivolgi, se ’l puoi senza fremere nell’intimo del cuore, il pensiero ai tempi de’ Tiberi, Neroni, Claudi, Domiziani, ed a tutta quella orrenda schiera di mostri, la di cui sola vendetta ch’or rimane a farsi è di odiarli o seppelirli nell’obblio.
Lo spazio di cinque secoli impiegato in dure e continove guerre non bastò per conquistare tutto quel paese che Italia chiamiamo oggidì, onde infinito sangue si sparse per conquistare una piccola pennisola. Quindi vennero le tre lunghe e terribili guerre puniche, per il che per ben sette secoli il popolo romano mai non cessò di guerreggiare da Romolo sino ad Augusto, se non eccettuato qualche intervallo di pace sotto di Numa. Quanto barbari fossero per tal cagione i costumi, quanto crudele fosse la sua superstizione, ce ne fa fede l’orrendo sacrificio a’ dei d’Averno di un uomo e di una donna delle Gallie, e di un uomo e di una donna greci, fatto nel Foro Fabio, allorché Annibale discese in Italia con portentosa prestezza. Duro ed insoportabile era altresì il romano governo nelle provincie, poiché i Galli Insubri, i Liguri e le Spagne sempre furono ribellanti; e molte città delle Spagne ridotte alla disperazione s’arsero con tutti i loro cittadini. Il barbaro costume di uccidere i prigionieri, proprio delle selvagge nazioni, fu adottato da’ Romani, e CCCL Tarquiniesi de’ più illustri furono frustati, poscia uccisi nel Foro Fabio; ed altro rimarcabile esempio di ferocia si fu quello di CLXX matrone romane, che tramarono di avvelenare i loro mariti.
In vano cerchi fra quel popolo di guerrieri e fra quelli eroi o le arti, o le scienze, o i comodi della vita. Di ciò ne sia prova l’essersi veduta in Roma la prima moneta argentea l’anno CCCCXXXVIII, ed un mal organizzato orologio fu esposto ed ammirato in pubblico l’anno CCCCXC,[22] e vi fu portato dal console Valerio dopo la presa di Cattania. Né conobbe questo popolo trionfatore i piaceri della vita che dopo la distruzione della sua grand’emula; e Siracusa, e Corinto, e le ricchezze del re Attalo nuova foggia di vita gl’insegnarono. Allora fu odiata l’eguaglianza delle fortune, e nell’anno dcxx il proporre che fece Tiberio Gracco la legge agraria fu lo stesso che il farsi trucidare. Ma malgrado il lusso e la mollezza de’ costumi, che meritossi tante declamazioni, Roma molle ed effemminata fu più grande e conquistatrice di Roma parca e frugale; e rispose alla stoica severità di Catone colle vittorie di più secoli, sinché giunse ad avere l’adulazione di que’ poco geografi scrittori che la nominarono regina dell’universo.
In vista di questi fatti giudichisi se veramente la grandezza fece i Romani felici. Il decidere tal questione sarebbe un’opera di una immensa erudizione, e fors’anco ripor dovrebbesi fralle impossibili. Poiché se tanto c’inganniamo ogni giorno nel decidere della felicità od infelicità degli uomini in particolare, quanto più sarà dubbiosa la decisione intorno ad una intiera nazione? Nel che io mi confermo pensando che le storie altro per lo più non ci forniscono che la cognizione degli universali avvenimenti; ma di condurci col pensiero nei gabinetti della politica e nelle capanne de’ plebei; di esaminare la felicità, la morale, i costumi d’una nazione, e i piccioli ordigni, con cui bene spesso movonsi gl’imperi, ben di rado il fanno. Per il che io non pretendo d’aver deciso della felicità de’ Romani, ma d’aver dubitato, unica strada che rimane a chi vive quasi due mila anni dopo di loro, e che altro di essi non può sapere che quanto in pochi libri contiensi, l’autorità de’ quali passata al traverso di molti secoli e di molte passioni è ragionevolmente sospetta. Poiché se cedono al tempo gl’imperi, la gloria, e ’l globo istesso ha le sue rivoluzioni, egli è ben di ragione il credere che pochi libri, per tante mani e tanti trascrittori passati, sieno stati soggetti a sensibili mutazioni. E chi sa di qual conseguenza non fossero poche righe sole cangiate, inserite o tralasciate? Onde se in questo mio breve ragionamento le mie asserzioni non fossero talvolta geometricamente evidenti, sarà utile il ricordarsi ch’io vivo nel decimo ottavo secolo, e che scrivo d’una nazione che esisté prima dell’era cristiana. Per fine, se ho trattato quest’ampio soggetto troppo di fretta, e se molt’altre cose rimangano a dire, per ora mi basti d’esporre le presenti alla fortuna del pubblico giudizio.
A. [Alessandro Verri]
La festa da ballo
Oh quanti sbadigli, quanti stiramenti v’erano ieri mattina al caffè! Gente che era stata tutta la notte al ballo, gente annoiata, e che voleva far credere d’essersi divertita, veniva in folla a ricercare qualche sorte di vita, e a ripigliare un po’ di vigore alla spossata sensibilità con una tazza del nostro eccellente caffè. Il nostro Demetrio era tutto in facende, e di tratto in tratto mi slanciava qualche occhiata greca furbissima, perché egli ed io eravamo i soli, che dopo aver ben cenato la sera, ben dormito la notte, colle gambe in vigore, colla mente senza nebbia, godevamo del dolce sentimento di non esistere male fra tanti che combattevano colla lassitudine, col sopore e colla incallita sensibilità. Pallidi e sformati erano i volti, rauca la voce, scomposti gli abbigliamenti, stordita la testa. Chi aveva mal di capo, chi mal di gola, chi una potentissima tosse. Oh che spedale, lettori miei, che era mai quello! Basta, dopo aver distribuita una mezza botte di caffè, un dopo l’altro partirono tutti i nostri noiosamente divertiti, e restammo soli Demetrio ed io, onde ebbimo tutto il campo di ragionare sulla scena che ci era presentata.
Mi raccontò allora Demetrio come ne’ primi mesi dopo il suo arrivo da noi un suo amico gli propose di venire una sera al ballo, ed ei, curiosissimo di conoscere le usanze ed i costumi de’ paesi, accettò l’invito e si preparò a godere d’un delizioso spettacolo. Venne la sera, ed entrato appena nella sala del ballo restò offeso dall’aria veramente malsana che vi si respira, e che si manifesta e per la sensibile polve che viene ad imbrattarvi il viso, le mani, gli occhi e la bocca, e per quel sciagurato potpourry di odori di materie passate per gli ureteri, di arrosti, di traspirazione di corpi non tutti mondi, e di altre simili cose non certamente amene all’immaginazione. Appena, disse Demetrio, m’avvidi che era pur forza che alternativamente entrassero nel mio polmone tanti rifiuti d’altri uomini, appena mi sentii rosicar la pelle, impastare la bocca e causticamente rodere gli occhi da tante materie eterogenee immiste in quell’aria, che mi trovai mal contento di esservi venuto. In fatti i Greci e gli abitatori tutti di quelle felici contrade sono avvezzi a respirare l’aria del Peloponeso imbalsamata dagli aranci, ed a cercare il piacere ne’ giardini, dove la natura tutta depurata ed abbellita sembra sollevarli al di là della condizione dell’uomo terreno; né può far maraviglia, se la grave, la malsana, la fetida ammosfera, in cui Demetrio si trovò trasportato, gli parve un cattivo preludio per trovar ivi il piacere. Pure, rinvenuto Demetrio da questa prima scossa, girò l’occhio intorno per incontrarsi nei leggiadri ichinguis (tale è il nome che nell’Impero ottomano dassi ai ballerini), e non rincontrando altri che uomini e donne, vestiti tutti a lutto con nere gramaglie, s’accrebbe la sorpresa di lui sentendo che non già ad un funerale, ma ad un ballo così si costuma da noi di vestire, e che tutti gli uomini e donne che ivi vedeva erano tutti gli ichinguis. Stette quasi per ritornarsene Demetrio a fare i fatti suoi, ma la curiosità di veder tutto lo trattenne ancora. Vide egli dunque molti ichinguis, che passeggiando in costa ed inciampando in chi voleva passar loro framezzo, si davano ora la dritta, ora la sinistra con una serietà colla quale si tratterebbe un affare di Stato, indi contenti d’aver ballato dieci minuetti sbadigliavano soavemente sdraiati su una sedia. Vide Demetrio delle file, ossia delle lunghe strisce irregolari di ichinguis grandi, piccoli, zoppi, gobbi, le quali si movevano e s’intrecciavano senza che alcuno potesse intenderne la simetria, e fra quelle due strisce ora cadeva un cappello, ora nel presentare sollecitamente la mano si dava un amoroso pugno, ora un buon piede impresso sul lembo della tonaca nera della donna gliela lacerava; sudavano frattanto, e si smaniavano, e facevan polvere molta gli ichinguis, sin che giunti alla estremità della striscia protestavano di non poterne più, e quasi esiggevano la compassione de’ spettatori per una fatica che non avevano intrappresa né per far bene ad alcuno, né per divertire alcuno, ma colla speranza di divertire se stessi, malgrado la sperienza di tre mila volte di seguito nelle quali si sono noiosamente stancati. Frattanto le trombe, i timpani e i contrabassi avrebbero proibito ad ogni uomo di poter ragionare per poco con un altro, quando il continuo vagare della maggior parte e l’urto e il passaggio irregolare non l’avessero già reso difficile. In fatti, cercando sempre il piacere, vanno errando da una parte all’altra della sala molti ammantati colle nere zimarre, e il piacere si rifugia sempre altrove. Quindi tutti i viventi che s’incontrano fra quelle innumerevoli linee incrocicchiate, destinate all’errore dei passeggianti, ricevono urti e scosse tali che chi volesse parlare non sarebbe mai sicuro verso qual parte del mondo debba terminare un periodo già innoltrato. I seguaci di Macone anche più fervidi ivi non potrebbero fare certamente le lor preghiere rivolte alla Mecca.
Almeno, soggiunse Demetrio, almeno avessi potuto vedere qualche oggetto che mi ricompensasse di tutt’i mali che soffriva; ma le donne erano coperte il volto con una tela annerita e con una melanconica barba di velo nero; gli uomini con una maschera, che aveva l’aspetto d’un cranio umano imbianchito; e chi russava sonoramente da una parte, chi spalancava eloquentissimamente la bocca dall’altra, annunziandoci il tedio mortale in cui era assorto, chi svogliatamente andava errando con un perpetuo moto, sin tanto che la pazienza del buon Demetrio fu tutta esaurita, e se ne venne a casa sua più convalescente che sano, ripetendo quel detto d’Orazio: Sic me servavit Apollo.
Demetrio non v’incappa più. Oh uomini, si pose egli ad esclamare, oh uomini, che volete avere la definizione di animali ragionevoli; non basta a voi l’aver trovata nel mondo la febbre, la podagra, il mal di pietra e l’infinita schiera degli altri mali innestati alla natura umana, che volete anche cambiare in tormenti veri e reali quelle azioni che avete destinate alla vostra gioia! Oh uomini, non sapete ancora che l’indole d’ogni piacere è di essere di breve durata, e che protraendo per tutta la lunga notte d’inverno i vostri baccanali, quand’anche fossero tutti all’opposto di quello che pur sono, dovete ritornarvene carichi di noia! Oh uomini, non sapete ancora che l’uniformità è la madre del tedio, e che una variata successione di oggetti è la sola che può tenervi l’animo in un dolce movimento, e che perciò condensando tutti i vostri tetrissimi, lunghissimi balli in un solo mese dell’anno, e ripigliandoli più volte la settimana, dovrebbono stomacarvi, quand’anche fossero le feste che davano le fate ne’ romanzi! Oh uomini… Bel bello, caro Demetrio, soggiunsi io, lasciate a parte le vostre filippiche, lasciate lo stile del patriota vostro Demostene; ne patirebbero i vostri polmoni, e gli uomini non si cambieranno per tutto ciò. Gli uomini cercano il piacere, ma la maggior parte degli uomini crede di trovar piacere negli oggetti dove si dice che vi si trovi, e quando non ve lo trovano, essi ne incolpano se stessi anzi che rivocare in dubbio l’autorità della moltitudine; onde per non aver la taccia di avere un guasto sentimento del buono, fingono di aver gioia, laddove adoperano sforzi infiniti per farla comparire. Così la moltitudine, composta tutta di individui che rispettano il parere della moltitudine, è un vero composto di tanti uomini, i quali non palesano il loro vero sentimento, ma bensì ciascuno lo simula, credendo che gli altri non lo simulino.
Ebbene, soggiunse Demetrio, io lascio le mie declamazioni, lasciate voi le vostre riflessioni filosofiche, e se volete, questa primavera nel mio casino fuori di città balliamo ogni quindici giorni per tre o quattr’ore. Avremo dodici signore, avremo venti signori. La sala è comoda, l’aria salubre, a mezza notte il ballo sarà finito. Vi darò una cena dilicata e non pesante; ritornerete sani e allegri alle vostre case, e vedrete che è miglior mestiero il passar bene il nostro tempo ed il cercare i piaceri nostri di quello che non lo sia colle declamazioni o colle ragioni il voler insegnare alla moltitudine a passar bene i suoi giorni, cosa che non farà mai.
Così terminò la nostra conversazione. Entrò nella bottega in quel punto un nuovo sonnacchioso, venuto dal ballo, il quale si disperava pensando di dovervi ritornare fra poche ore, quasi che dovesse perire lo Stato, s’egli vi avesse mancato; ed io me ne venni placidamente verso mia casa a scrivere questo fatto, e mi preparo a godere delle deliziose feste del mio Demetrio. Frattanto ecco il seguito delle Osservazioni meteorologiche.
P. [Pietro Verri]
[Osservazioni meteorologiche fatte in Milano. Sul termometro]
Il termometro è una piccol machina molto interessante anch’essa per l’uomo. Le conseguenze derivate dalle osservazioni de’ moti della medesima sono molto relative a’ differenti gradi di calor del corpo umano, o dell’aria, o degl’altri corpi che immediatamente lo circondano. Sino dal dicembre 1755 ho marcati a ore fissate e scritti i diversi fenomeni di questo stromento, ed eccovi in breve ciò che fino al dì d’oggi vi ho veduto.
La minore altezza del termometro, ossia il maggior freddo effettivo, che in tutto questo tratto di tempo ho io osservato, fu nell’anno 1758, il giorno 27 gennaio, nel quale dì il termometro a mercurio, graduato colla scala del signor di Reaumur, abbassò a nove gradi sotto il termine del ghiaccio, e nel 1763 , il 5 gennaio, parimenti a nove gradi sotto il freddo del ghiaccio, essendosi trovato otto giorni prima a 8 1/2 sotto il termine suddetto. Il maggior caldo effettivo, o la maggiore altezza dello termometro da me veduta in tutto il già nominato tratto di tempo sino al dì d’oggi, è stata ne’ giorni 8, 9 agosto 1757, 29 giugno 1760 e 22 luglio 1762, a gradi 29 sopra la nulla.
Ne’ miei giornali trovo che ordinariamente il maggior freddo in Milano accade tra li 21 dicembre e la metà di gennaio, ed il maggior caldo dalla fine di giugno a tutto luglio, ed alle volte anche fino alla metà di agosto; dipendendo il più o il meno del caldo e del freddo dalla combinazione de’ venti colle piogge, o colle nebbie, o coll’asciutto.
Ho costantemente col termometro osservato che il vento di mezzo dì è sempre il più caldo o il men freddo in tutto l’anno, quello di tramontana il più freddo nell’inverno, quello di ponente il meno caldo nella state, massimamente di notte; ed il vento di levante il più umido in tutto l’anno. Più volte ho io medesimo sperimentato sentendomi in un eguale stato di salute, tranquillità di moto e di spirito; e per quanto nell’atto istesso venivami confermato dall’asserzione di altri che trovavansi nelle eguali disposizioni alle mie, secondo era l’aria o nuvolosa e nebiosa, od umida, o asciutta e ventosa, o serena e tranquilla, differente era parimenti la sensazione che provavano, cioè di maggior o minore
IL CAFFÈ )( Fogl. IX )(
freddo, se il termometro era a 10 gradi sopra il ghiaccio, e di maggior o minor caldo, se il termometro stava a 12 gradi di dilatazione. Istessamente più di una volta riscaldata con stuffa, con la stessa quantità di legne la camera, nella quale solitamente mi sto d’inverno quasi tutto il giorno, a 10 gradi di dilatazione, ho sentito minor freddo o maggior caldo in que’ giorni che l’aria era umida, o più carica di particole acquose, che ne’ sereni e secchi; benché il termometro, esposto all’aria esteriore, sì negli uni che negli altri si trovasse allo stesso punto. Da tutto ciò bisogna inferire che i termometri fin ora trovati soltanto misurano la quantità reale maggiore o minore del calore dell’atmosfera, de’ fluidi e di alcuni solidi, ma non sono stromenti atti ad indicarci il più o il meno delle nostre sensazioni, cagionate dal maggiore o minor calore dell’aria, o atmosfera, che ci circonda.
In tutte le mie osservazioni ho anteposto il termometro di mercurio ad ogni altro come più eguale e costante nelle di lui dilatazioni e condensazioni; e la scala reaumuriana come la più conosciuta.
Tutti gli uomini sono per natura portati a giudicare con maggior facilità di quelle cose che immediatamente appartengono ai fisici bisogni a proporzione delle loro sensazioni, e la difficoltà di questo giudizio tanto si fa maggiore, quanto più piccola diventa la relazione delle cose co’ bisogni medesimi, e conseguentemente meno sicuro. Una più lunga serie di osservazioni, di esperienze sarà dunque necessaria per adequare la mancanza di relazione delle cose cogl’immediati bisogni nostri, perché minore si faccia la difficoltà in conoscerle. Pochi sono coloro che hanno la pazienza, o si trovino in combinazioni di circostanze, onde seguitare una così lunga carriera: di pochi conseguentemente sarà il diritto di giudicare con qualche accertatezza di quelle cose che meno agl’immediati bisogni dell’uomo appartengono. Ciaschedun individuo crede aver ragione di accertare de’ principii e regole sul ben essere presente del proprio corpo e futuro del proprio spirito, su i propri interessi, e relativi al lucro, e relativi a tutto il resto degli uomini, e finalmente anche su gl’influssi che può risentire dall’aria e da tutti gli altri corpi che lo circondano; ciascheduno in somma vuol essere medico, teologo, legista, morale ed anche astrologo. Eccoti, amico, la sorgente più ampia del caos orribile e informe de’ popolari errori.
[Su i venti]
La scienza de’ venti, come tutte le altre, ha corso questo destino. Sul mare istesso l’esperto piloto, ammaestrato da tanti naufragi già quasi per tre secoli di tanti incauti e mal addestrati navigatori, ha più fin ora studiato la direzione e la forza de’ venti che li fenomeni da’ venti istessi cagionati. Li nomi de’ 32 venti della greca bussola, e gli epiteti de’ favolosi poeti di nero Aquilone, di freddo Borea, di Zefiro ristoratore, di mal sano e caldo Austro ec., quanto in tal genere di cose ci hanno lasciato gli antichi. Tramontana e scirocco, vento di bello, vento di cattivo tempo, senza accertate regole alle osservazioni corrispondenti, vocaboli indifferentemente e promiscuamente usitati da’ vostri concittadini, ed alcuni altri barbari nomi, che io non ho mai potuto ritenermi in memoria, e che più volte ho sentiti in bocca degl’infelici coltivatori di queste fertili campagne, e che ho per altro alcune volte trovato corrispondenti alle mie osservazioni medesime, sono tutte le cognizioni che ho potuto dalla esperienza de’ naturali abitanti di questo paese ricavare intorno a’ venti di questo tuo clima.
I venti sono la principale cagione de’ cambiamenti delle apparenti irregolarità e stravaganze delle stagioni. A questo fine già da tre anni più particolarmente vi ho rivolto le mie osservazioni, colle quali, unitamente alle altre de’ cambiamenti di tempo, in ciaschedun tempo e giorno dal 1755 al presente, ho potuto accertare le seguenti regole.
Quando soffia impetuoso e forte il nord l’aria è nettissima da’ vapori, serena quanto può essere, scoprendosi i monti molto da lontano; il cielo è allora il più atto ad essere osservato col telescopio. Spirando il ponente, per lo più e quasi sempre ho veduto o attualmente bel tempo, o apportar sereno. I venti che vengono dal levante e dal mezzo-giorno, o dagl’intermedi a questi due, e tra il levante e tramontana, ho quasi sempre veduto che portano costantemente cattivo tempo, cioè o pioggia, o nebbie assai umide, o per lo meno cielo rotto.
Circa prima gli equinozi di marzo, in alcuni anni domina la tramontana serena; ma per lo più sono dominanti gl’intermedi tra quella ed il levante, qualche volta con pioggia, ed ordinariamente con secchi, e con nuvoli erranti. Da circa prima il solstizio di giugno si fa costante il ponente sino quasi a tutto settembre sereno, massime di notte, il quale non è interrotto che da’ venti irregolari di non lunga durata de’ temporali. Circa dopo l’equinozio di settembre cominciano e continuano i venti di levante, piovosi ed umidi. Finalmente da circa un mese prima fino al solstizio d’inverno si fa dominante il nord, alcune volte con pioggie, ma per lo più secco, impetuoso, sereno e freddo; continuando dopo sino a marzo ad essere irregolari, ed ordinariamente di levante.
Dopo l’equinozio di primavera, cominciano le pioggie impetuose, ma interrotte, ed abbondanti fino circa la metà di maggio; e da qui fino al solstizio d’estate il cielo si fa costantemente sereno, benché incomincino li temporali, che non sono ancora che brevi e passaggeri. Dopo il solstizio d’estate li temporali sono più frequenti; ed in luglio ed agosto più impetuosi. Il settembre è ordinariamente il mese più bello di tutto l’anno. Dopo l’equinozio d’autunno fino circa prima la metà di novembre tornano le pioggie continue. Il resto, sino al solstizio d’inverno, ventoso e rotto. Dal solstizio d’inverno fino alla metà di febbraio è la stagione più cattiva di tutto l’anno, pioggie lenti o minute, o nevi. Il febbraio, fino al cominciar de’ venti di marzo, è molte volte sereno e meno rigido del marzo istesso, che a cagione de’ venti è alcune volte più freddo.
Al riferire de’ vecchi abitanti di queste campagne, avevasi altre volte negli inverni molta quantità di neve e ghiacci, ora più, ora meno; sono però già più anni che in Milano se ne hanno pochissimi e degli uni e delle altre. Le mie osservazioni fino dal 1757 mi mostrano che le nevi sono d’allora in qua cadute in pochissima quantità, e i ghiacci pochi, e di brevissimo tempo; anzi in tutto l’inverno del 1758 non n’è caduta niente, non vedendosi ghiacci, essendo stata l’aria alquanto, e quasi continuamente, serena e temperata.
Parimenti, secondo la tradizione de’ vecchi, le nebbie in Milano, ed in tutto il territorio all’intorno di questa città, non incominciavansi a vedere che in dicembre, ed erano in tutto l’inverno non così frequenti come negli anni presenti, onde riuscivano gl’inverni più secchi e meno agghiacciati; anzi osservavasi con maraviglia se in primavera se ne fosse alzata alcuna. Egualmente mi è stato asserito da alcuni vecchi abitatori di que’ contorni, che rarissime volte vedevasi qualche nebbia, e anche questa molto rara e di poca durata sulle colline al piede del monte chiamato di Brianza. I miei giornali mi fanno vedere fino dal 1756 che le nebbie a terra si vedono anche al principio di ottobre; che in tutto l’inverno vi siamo sepelliti, trovandosi quasi tutti gl’inverni da me osservati assai umidi, e vedendosi le nebbie a terra anche fino alla metà di maggio. Io, che ho passate più di una volta delle autunnali vileggiature sulle accennate colline del monte di Brianza, ho avuto più volte occasione di vedere delle nebbie densissime sulle più alte, che hanno durato de’ giorni intieri.
Più volte stando su delle più alte delle accennate colline, anche in agosto, due volte ho veduta tutta la pianura milanese, che da colà si dominava, come un gran lago, o mare cenericcio biancastro, su del quale osservando con un buon cannocchiale terrestre si vedevano spuntare alcune cime de’ campanili de’ villaggi più vicini, e in una maggior lontananza la sommità più alta del Duomo di questa città.
Mi sovviene d’essermi trovato un giorno oltre la metà di maggio in una casa di campagna vicino al borgo di Melegnano; colà ho trovato alla mattina una nebbia densa e continua, quale facendosi nella valle vicina più fitta circa il mezzogiorno, con vento improvviso sud-est, si alzò con turbine qualche lampo, e tuoni e poca pioggia, e venne a scaricare con temporale impetuoso uno rovescio di acque sotto le mura della città. Moltissime volte ne’ primi giorni di ottobre trovandomi in vileggiatura all’ovest, poche miglia lontano di Milano, ho rimarcato in tutte le ore del giorno come una lunga siepe nuvolosa e cenericcia, chiara all’orizonte meridiano, parte di levante e ponente, che alzavasi per gradi, e che arrivando al zenit in breve tempo ci seppelliva sotto una densa nebbia a terra.
Ordinariamente ho veduto che i temporali di estate si alzano o dal levante o dal mezzodì, e che girando da quella parte, o portandosi sopra Milano, vanno ad urtare e scaricare la loro furia contro li monti al settentrione di questa città, o che alzandosi da que’ monti medesimi poco s’avvanzano, e là svaniscono; ond’è che per lo più il danno delle campagne è dalla parte del sovraccennato Monte di Brianza, o al nord di Milano. Al contrario que’ pochi temporali che s’alzano dal ponente, se strisciando dietro a’ monti non vanno come gli altri a terminare a tramontana, sono quelli che devastano le campagne della pianura, massime al ponente di Milano.
Nella descrizione del viaggio d’Egitto e della Nubia del signor Norden leggesi che l’obelisco chiamato di Cleopatra, presso Alessandria, è benissimo conservato nella faccia occidentale ed al nord; al contrario nella faccia orientale, e particolarmente in quella rivolta al mezzo-giorno, non vi si possono più leggere i geroglifici. Qui nella Lombardia, e come credo accada in tutte le parti meridionali dell’Europa, ho osservato tutto al contrario: le case, gli edifici, le statue, le piramidi ne’ giardini sono danneggiati all’oriente, e massime a tramontana, conservandosi benissimo le parti rivolte al mezzo-giorno ed al ponente. Li venti caldi e meno secchi, e però più dolci, vengono dal mare; quelli che vengono dalla terra e da’ monti dovranno essere più secchi, e perché strisciando sulle nevi, su’ boschi, su’ terreni grassi e paludosi, più carichi di nitro e particole eterogenee; dunque tutti gli edifici della Lombardia e tutti quelli situati ne’ paesi meridionali dell’Europa dovranno maggiormente soffrire nelle parti all’aspetto dell’oriente, ed in particolare di settentrione, da dove derivano li venti di terra, e per dove si estendono li monti, avendo li meridionali paesi europei il mare a mezzodì ed a ponente. L’Egitto al contrario ha il Mediterraneo a tramontana; tutta l’Arabia co’ suoi monti all’oriente, ed all’Austro pure co’ suoi monti ed arene l’Affrica tutta, non avendo all’occidente che parte delle coste dell’Affrica medesima. Dunque gli obelischi e tutti gli edifici affricani poco lungi dal Mediterraneo dovranno patire agli aspetti di est e sud maggiormente che del nord ed ovest.
Il signor Bradley, nelle sue osservazioni sull’arte di coltivare i giardini, dice che l’arruggine delle piante viene cagionata dagl’insetti trasportati da venti orientali, e che si situano su di quelle che sono proprie al loro nudrimento. Più volte ho io pure considerato nel vedere sulle piante de’ mori e de’ gelsi di queste campagne codesta arruggine all’oriente e settentrione, e non agli altri aspetti; come parimenti quella verde oscura lanugine, o picciol erba, che teppa è volgarmente chiamata, sulle piante, massime le più vecchie, agli accennati aspetti di oriente e tramontana. Il signor Reaumur, che ha fatte diligenti ricerche intorno a quelle macchie che si osservano sulle pareti delle case, le crede essere una specie di piante o erbe. Queste ho io più volte parimenti osservato su’ muri delle case rivolte al settentrione, principalmente di quelle più ai venti esposte nelle aperte campagne e sulle alture, ed anche su’ nudi sassi de’ monti all’aspetto del nord. Tutte queste osservazioni altrui e mie sembranmi confermare l’accennata ipotesi.
Aggiungasi, come mi è stato riferito da un uomo che pareami ragionevole e di qualche buon gusto, che 15 o 17 anni sono qui in Milano furono mutate in altre nuove le due antiche piramidi di marmo sulla facciata del magnifico tempio chiamato della Madonna presso S. Celso, perché le due antiche, essendosi talmente piegate ed incurvate al nord-est, quella alla destra particolarmente, più all’Aquilone esposta, minacciavano rovesciare, le quali per risparmiare la fatica o qualche maggior dispendio nel calarle intiere abbasso (il che coll’istesso grandioso ponte costruito per innalzare le nuove, e il di cui disegno fummi dal medesimo uomo mostrato, sarebbe stata cosa molto agevole), furono messe in pezzi sul sito medesimo, distruggendosi in tal maniera due antichi monumenti della prodigiosa azione dell’aria e de’ venti.
Nelle tavole che ho costruito su i giornali delle mie osservazioni trovo che in un anno intiero (intendendosi da un marzo all’altro) il numero de’ giorni belli in Milano a quello de’ cattivi, per adequato di osservazioni in più anni, è come 17 a 19 circa, cioè che la somma de’ giorni belli in un anno intiero è meno della metà del medesimo, e de’ cattivi più della metà istessa; che il numero de’ giorni in cui piove in un anno, per adequato, è la quarta sua parte in circa, ossia in un anno piove poco più poco meno in tutto tre mesi; che il numero de’ giorni cattivi senza pioggia, per adequato, in un anno è maggiore della di lui quarta parte, ovvero di tre mesi e mezzo circa; che finalmente l’altezza media della quantità di acqua che piove in un anno, sono 21 in 22 pollici parigini; e che la maggior quantità di essa cade tra l’equinozio di marzo e di settembre.
Eccoti, amico, stretti in piccol nodo gli annui fenomeni, e in certa maniera periodici di questa natia tua atmosfera, che teco già da qualche anno respiro, ed a cui prima d’ora attento non fissò occhio filosofico, o curioso almeno lo sguardo. A tutt’altri che a te sembreranno assai frivole cose, o al più di semplice oziosa curiosità, onde impegnare l’attenzione di chi alla gran scienza di un maggior guadagno tutte ha rivolte le cure, e nella quale tutta ripone la propria filosofia.
G. [Giuseppe Visconti]
[Risposta alla Rinunzia]
Amici.
Ho letta la vostra patente, e dopo seria e matura riflessione sono costretto mio malgrado a darvi torto. Eccovi le mie ragioni, che son tutte di buona moneta vecchia e di corso corrente.
In primis, voi siete, grazie al Cielo, autori vivi, e però tutta la forza della verità si annienta in bocca vostra; la morte, signori miei, la morte sola potrà far sospettare che abbiate ragione; e però era meglio per la vostra causa che in un buon testamento in scriptis esponeste i vostri sentimenti, piuttosto che in un miserabile foglietto volante.
2. È osservazione costante che la forza delle ragioni cresce in proporzione del volume in cui sono scritte; e il vostro foglio, che non pesa due dramme, potrà resistere a migliaia di rubi di tomi in foglio, in cui sta scritto tutto il contrario?
3. Il testimonio d’Orazio, che veramente come autorità, devo confessarlo, val più d’ogni raziocinio, non vale un zero. Il governo della lingua latina era repubblicano, e non monarchico come il nostro, avendo per re la sacra maestà del Dizionario della Crusca; e la vostra patente potrebbe benissimo esser condannata come sediziosa, e ribelle, status in statu.
4. Chi vi ha detto che le parole son fatte per le cose, e non le cose per le parole? E non sapete voi che per parole si sono sparsi torrenti di sangue umano; che in Francia una parola, che chiamavasi Missisipi, ha valso un tesoro al regio erario; che in Moscovia la parola Demetrio ha alzato al trono cinque oscuri personaggi? Io ne ho di questo mio argomento gli esempi a biseffe ed a millanta.
5. E perché avere l’inumanità di togliere l’unico pregio al bene, all’unica sostanza di tanti uomini dabbene, che si beano al leggere i loro madrigaletti, sonetti, poemetti tutti lindi, tutti melati, tutti tessuti di ricamo fiorentino su di un buon fondo lombardo?
6. Qual miserabile ragione quella che dite, che l’istesso ius del gran Villani, del grandissimo Casa, del tersissimo, anzi transparentissimo Passavanti, di trovar nuove parole e nuovi modi, spetta a voi?
Avete voi fatto, come questi veneratissimi gran padri della lingua nostra, il glorioso sacrificio dei pensieri alle parole? Avete voi acquistata l’arte soprafina di stemprare un pensiero, anche comune, con qualche centinaio di parole, e poi impastarne tutto il composto in un bel periodone di mole gigantesca, e tutto cascante di vezzi, e sostenuto da tante minutissime particelle, che fanno poi il secreto dell’arte; il di cui gran capo, le di cui grandi braccia, il gran busto, le grandi gambe si legassero con sottilissime fila? E non vi sembra perciò una bellissima cosa un’orazione italiana simile ad una processione di tanti vuoti colossi di carta pista, tutti tremanti? Passa il primo colosso, che si chiama Esordio, ed è per lo più il più grande degli altri, egli è sempre in forse sul cadere, egli è per lo più posto in ginocchione in atto di dimandar perdono agli spettatori; con una mano cerca la carità, con l’altra fa un gran gesto, che significa la confessione della propria debolezza. Passa il secondo in atto grave e posato, intorno al quale vi stanno moltissime figurine più piccole, che pare che interroghino l’uditore; l’altre s’urtano di fronte tra di loro. Passa il terzo, che è per lo più composto di pezzi di rapporto e di pergamene scritte, o d’indici di libri; io ne ho veduti molti, di cui il busto era tutto di Cicerone e le coscie di un santo Padre, altri avea gli occhi formati di versi di Giovenale e il naso di versi del Petrarca. Tutte queste statue esalano un odore narcotico che addormenta il volgo e fa solamente sbadigliare quelli che ammirano il capo d’opera; così successivamente passano altri colossi fino all’ultimo, che ha un gran cartello in mano, su cui sta disegnata in miniatura tutta la passata processione, e con l’altra prende congedo dagli uditori, come io faccio da voi.
C. [Cesare Beccaria]
[Osservazioni meteorologiche fatte in Milano. Sul clima]
Ma tempo è di dare ai lettori il compimento delle Osservazioni meteorologiche, ed eccomi a mantenere la parola.
Il ben essere degli uomini tiene ad un tutto. Il sistema generale dell’universo è collegato co’ moti del globo terracqueo che noi abitiamo, e da questi e da quello le agitazioni dell’atmosfera nella quale nuotiamo. Le meteori sono i fenomeni particolari dell’aria in un sito; tutt’insieme constituiscono il clima; questo influisce sulla natura, sulle sensazioni e sull’idee ancora di chi lo abita. La facilità di trovare abbondanti sul sito medesimo le cose necessarie a’ fisici bisogni dell’uomo ne constituisce la fertilità; la non mancanza di quelle necessarie a’ piaceri ne forma l’amenità; la purezza ed il sereno dell’aria istessa, e la squisitezza maggiore di dette cose necessarie a’ bisogni fisici e piaceri fanno il clima salubre, e tutte insieme ne constituiscono il bello.
Vedi, amico, su questi principii e su questi risultati che ti mando delle lunghe mie osservazioni, qual sia il patrio tuo clima milanese. Milano è quasi centro di tutta la Lombardia, la sua elevazione di poco meno di 100 braccia sopra il Mediterraneo comparata a’ fiumi, che le scorrono a destra ed a sinistra, può senza errore assumersi come la media di tutta l’altezza di quest’ampia pianura, che dal piede delle Alpi alle foci del Po si stende. Dell’acque de’ due canali che traversano questa città, tratti superiormente dall’Adda e dal Ticino, per la maggior parte disperse su queste campagne, colano inferiormente gli avvanzi verso Pavia, ove poco sotto il Ticino col Po si unisce, e li di cui argini e sostegni più alti minacciano il più basso territorio cremonese e ferrarese. I fiumi intorno a questa città sono lontani delle miglia, l’arte sola ci ha scavati i due navigli che bagnano queste mura. Basta un’occhiata sulle carte topografiche di questo paese, che i tuoi concittadini chiamano Ducato, e dello Stato, per convincersi senza altre prove che non è dalla natura piantato Milano in una pozza e in mezzo alle paludi. Ampie e stese sono queste pianure, vi hanno pochissimi boschi onde trattenere stagnanti le acque piovane, e più umida colla traspirazione delle piante rendere quest’aria; ella non è ristretta tra’ monti; liberi sono, e spaziar possono i venti. La latitudine di questa capitale, benché da occhio astronomico non ancora determinata, si sa essere circa il mezzo della zona temperata. I monti più vicini sono la continuazione della catena delle Alpi al nord, e questi, quasi bariera, la difendono dal gelato Aquilone. La quantità de’ grani, che sopravvanza il consumo che ne fanno gli abitanti, e della seta, a dispetto di una antica ostinata agricoltura molto da una maggior perfezione lontana, prova abbastanza la fertilità di queste terre. La natura in somma pare che abbia in maniera combinato le fisiche circostanze più fortunate per constituire sugli accennati principii bello e felice il clima milanese.
I risultati però delle mie osservazioni, i fenomeni di quest’aria medesima, ed una contraria esperienza da altre accidentali cagioni dipendente, ti sembrerà forse smentire così belle apparenze. Il lungo tempo piovoso, e de’ cattivi giorni maggiore de’ dì sereni; la quantità delle acque che piovono in un anno; le nebbie dense ed umide quasi di tutto l’anno; i temporali frequenti nell’estate; l’aria mal sana e le acque putride di molti villaggi; i venti freddi del marzo e dell’autunno; il caldo spossatore del luglio; l’aria grossa e colata della città; i morbi cronici; le idropisie; i mali di petto, di tubercoli, di tossi, cattarri ec. e la lunga processione de’ malanni assai quasi maggiori in numero di quelli scappati fuori dalla cesta di Pandora, che ogni giorno senti sputare dalle amare bocche de’ tristi sprezzatori de’ tempi presenti, ti destano forse il melanconico prurito di cantare con Virgilio
… Fuge litus iniquum
o col Toscano
Sol col forte spronar salvo è il fuggire.
Il desiderio di un maggior lucro de’ soli particolari fa universalmente abbracciare un nuovo genere di coltivazione, e nel tempo istesso, per una maravigliosa contraddizione frequente tra gli uomini, generalmente abbandonare ad antiche costumanze la più naturale agricoltura. Queste sono le accidentali cagioni delle apparenti alterazioni di questo clima fortunato ed ameno per natura, ma in parte reso infelice e meno salubre coll’arte.
Non v’ha alcuno presentemente, che possessore di una pertica di terreno non cerchi con qual siasi mezzo di poterla adacquare, farla prato o renderla risaia; di maniera che così proseguendosi vedrassi un dì tutto il milanese territorio sotto l’acque. Tutto il Lodigiano e tutto il Pavese è ora adacquatorio: lungo il piccol fiume Olona ed il gran canale Naviglio, che sorte dal Ticino, cominciando all’insù di Abbiate Grasso, sino al Pavese vi si estendono li prati e le risaie, e parimenti lungo il canale che ha origine dall’Adda, cominciando da Cassano fino al Lodigiano, e fino sotto le mura della città continuano i prati adacquatori e di marcita. Tutto il Milanese è un labirinto continuo di canali per ogni verso, per ogni direzione, per ogni curvità; vi sono pochi giorni nell’anno che questi terreni non sieno attualmente irrigati. Qual prodigiosa umida vaporosa esalazione non si solleverà dunque per tutta codesta atmosfera da un così esteso pian-terreno
IL CAFFÈ )( Fogl. X )(
continuamente bagnato, perché non sia da una continua nebbia imbrattata? Il vento istesso che spira dal levante o dal sud-est, che ci viene già umido dall’Adriatico, passa su le paludi del Mantovano, o del Ferrarese, sul Lodigiano, o sul Cremonese, ed è quello che porta, come ho sopra notato, su questa città le piogge e le nebbie più umide. Il vento parimenti di mezzo-giorno è anch’esso, come già ho dimostrato, nebbioso e piovoso alcune volte, perché per la medesima ragione passando sul Pavese porta seco le umide esalazioni di quel bagnato terreno.
L’industria degli uomini in quelle cose ancora che credono di maggior utile è lenta e pigra. Tempo ed anni furono perciò necessari, perché con l’arte si dilatassero le acque su quelle terre, che per natura e situazione asciutte, a poco a poco diventassero umide e bagnate; ed ecco, come ho già sopra osservato, in qual maniera si dilatarono e resero più continue, ed innalzarono anche sull’alte colline le nebbie, in prima più rare e brevissime. Questa è la cagione perché sì tarda è negli anni presenti la stagione calda; quando, al riferire de’ più attempati, altre volte ne’ primi dì di maggio erasi obbligato dal caldo ad appigliarsi all’abito di estate.
Egli è universalmente costante, e come ho io avuta occasione di verificare colla propria mia esperienza, che non v’ha cosa più dannevole a’ frutti della campagna, alle biade, a’ gelsi, alle uve quanto le nebbie principalmente, e le piogge troppo abbondanti e continue; mentre è osservazione altresì costante che negli anni il cui maggio, giugno e settembre sono asciutti e sereni tutte le raccolte delle campagne del Milanese sono abbondantissime, mature e nella loro perfezione; al contrario negli anni piovosi e nebbiosi più dell’ordinario sono generalmente assai scarse e cattive, di maniera che è meno dannosa una siccità ostinata o scarsezza di pioggia de’ mesi più caldi, cioè di luglio ed agosto, che le piogge continue e le nebbie di maggio, giugno e settembre.
Che se le nebbie del Milanese fossero di sole evaporazioni acquose, così mal sana certamente non renderebbero l’aria che con esse respira chi vi si trova immerso. Su’ prati le acque vi stagnano de’ giorni intieri; e tutto l’inverno su quelli che si chiamano di marcita, ne’ risi de’ mesi continui e de’ più caldi. Queste sciolgono i sali diversi della terra, delle erbe infracidite, degl’insetti, ranocchi, rospi, rettili ed altri animali d’acqua imputriditi, quali sali, resi volatili, co’ vapori acquosi s’innalzano, e immischiandosi co’ nitrosi dell’aria fermentano ed infettano l’elemento della respirazione. La maggior parte di queste acque restano inzuppate nella terra, per la quale filtrando, ed in alcuni siti seco traendo le dissoluzioni eterogenee fatte sulla superficie, s’immischia con quelle de’ pozzi per rendere così all’assetato lavoratore principio di morte il cristallino fluido ristoratore. Le sentine e cisterne di questa città, sì frequenti in ogni casa, non sono forse delle più piccole cagioni, perché nella stessa maniera si rendano men buone le acque che si bevono? Le immonde colature di tanti lavatoi che scorrono per le strade le più frequentate, le quali trovansi di continuo imbrattate, ammorbano l’aria e i cittadini.
A queste cagioni alteratrici di questo clima e di questa atmosfera aggiungasi che io medesimo ho veduto più volte nelle campagne sulle piazze, o nel centro delle case, o nella maggior vicinanza delle più frequentate abitazioni di molti villaggi del Milanese, delle grandi fosse o piscine per servire di abbeveratoio alle bestie di lavoro e ad altri usi, sul lembo delle quali vi si trovano ancora in alcuni siti de’ pozzi; anzi mi viene assicurato essere tale costumanza quasi universale in tutto il Milanese, di raccogliere in fosse e conservare le colature delle acque piovane, che non vi giungono per lo più che torbide e fangose. I letamai si conservano pure e si trovano nel mezzo delle abitazioni de’ coltivatori di queste campagne. Chiunque ogni poco abbia corso le strade di questo paese non ha bisogno che altri gli dica quanto universalmente sieno fangose ed impastate di putride fetenti acque stagnanti quasi tutto l’anno, e molte anche ne’ mesi più caldi, come generalmente mal conce, mal pianate ed intrattenute finanche sotto le mura e le porte della città.
Di più la coltura degli erbaggi e delle frutta è così abbandonata a’ villani pigri ed inesperti, a’ quali bastando avere guadagnato un tozzo di pane per essi e per la famiglia, più in là non curano estendere una esperimentata industria. La coltivazione degli erbaggi consiste a gettare indifferentemente delle sementi sopra una terra impastata di liquide spazzature fetenti d’ogni genere, trasportate ogni notte dalla città, e strappare dal suolo le erbe, allorché bastantemente nate, innalzate e verdeggianti per potersi vendere, e le quali più volte risentono il cattivo odore dell’accennato ingrasso. Le frutta si vendono la maggior parte acerbe o selvatiche, essendo quasi tutte le loro piante abbandonate e senza innesto; prova di ciò sono le corbe intere gettate ogni anno, per pubblica autorità, a’ letamai; una gran quantità, che si consuma in Milano, le vien portata dal Pavese, e la insipidezza di queste è un effetto necessario di quel suolo per arte bagnato.
Mi è stato finora impossibile il fissare con qualche metodo le mie osservazioni su’ morbi e le malattie di questo paese relative a’ cambiamenti de’ tempi dell’aria, delle stagioni e delle meteori. Anzi a me sembra che siano nel sistema presente degli universali costumi di tutta l’Europa, suscettibili di poche fisse conseguenze o regole. È difficilissimo da’ soli effetti, moltissime volte simili o gli stessi, lo sviluppare le tanto differenti cagioni de’ morbi provenienti dall’abuso de’ cibi, o dall’uso di questi cattivi e mal condizionati; dall’abuso parimenti de’ comodi e de’ piaceri della vita, o da’ disaggi e dalle fatiche; dallo sregolamento di tumultuose contrarie passioni, o da celtica infezione; da una mal organizzata fisica costituzione, o con una cattiva educazione malamente piegata; finalmente dal respirare un’aria differente ed una atmosfera men pura, o dalle rivoluzioni, da’ cangiamenti, dalle non solite agitazioni ed alterazioni di essa cagionati. Il poco uso che si è potuto finora ricavare da’ giornali medici e meteorologici de’ diligenti accademici di Parigi mi conferma in questa opinione. Le poche cose che io ho potuto osservare relativamente a ciò sotto questo cielo mi hanno fatto vedere che le malattie più universali sono le febbri maligne putride, o febbri croniche con idropisie in chi respira l’aria e beve l’acqua de’ prati e delle risaie, massime ne’ tempi delle asciutte, come dicesi dal volgo, o ne’ mesi più caldi, cioè dalla metà di giugno sino alla metà di settembre. Le febbri verminose, universalmente ne’ poveri coltivatori della campagna, principalmente nella state, e finalmente gli attacchi di petto e mali di polmone sono le più universali malattie, e la cagione di morte degli abitatori di questa città.
Io non ho aggiunto alcuna dimostrazione positiva a quanto ho fin qui asserito o indicato. Quando ne abbia la volontà, è un lavoro che riserbo ad un altro scritto più metodico e più esteso. Ti basti, amico, sapere che tutte quelle cose che ho fin qui asserito sono altrettante conseguenze di lunghe e replicate mie osservazioni ed esami, già da più anni a quest’oggi. Se queste provano la necessità di restituire queste terre alla naturale loro asciuttezza, non deve ciò non pertanto spaventarti l’avaro zelo de’ particolari. La quantità de’ grani e delle sete raccolte da quelle sole campagne che non sono ancora coperte dalle artificiali irrigazioni, ed il maggior numero di braccia che domanda la loro coltivazione e la loro manifattura, e conseguentemente il maggior numero degli uomini che ne traggono il lor vitto; finalmente il denaro, che la quantità degli uni e delle altre, sovrabbondante al consumo, fa da’ paesi forestieri colare in questo, deve dissipare qualunque panico timore di un minor lucro, benché particolare.
La ricchezza e povertà di una nazione si misurano dalla quantità delle cose necessarie a’ bisogni ed a’ piaceri della vita che essa nazione trovar può nel suo paese; dal numero degli uomini che vi acquistano diritto colla propria industria e lavoro in cercarle, coltivarle e prepararle; e dal numero di quelli che vi si possono perdere colle malattie, colle fatiche e colla morte nel loro dissotterramento, cultura e preparazione; più la quantità di dette cose necessarie trovate nel proprio paese, e che sopravvanzano al consumo ed effettivamente transmettono alle altre nazioni, e di quelle che mancano ed effettivamente ricevono dalle nazioni forestiere. Chi vede questa verità, e conosce la proporzione colla quale concorrono gli accennati elementi a formare questo tutto, può facilmente calcolare l’utile o ’l disavvantaggio de’ fieni e de’ risi, soli frutti delle terre bagnate, relativamente a tutti gli altri frutti che con una esperimentata e maggiormente perfezionata agricoltura ottenere si possano da’ terreni asciutti e con arte non adacquati.
A te questo mio scritto io mando. Io straniero, se per avventura v’è alcuna cosa utile, altro interesse non vi posso avere che per l’amor solo di tutti gli uomini. Questa è tua patria, la natura sua, e il suo commercio a te non è sconosciuto. Impegnare adunque può la tua curiosità almeno a perdervi una mezz’ora in leggerlo, quand’anche tu debba correre il rischio di sbadigliare più di una volta.
Possano i tuoi lumi e il tuo cuore tutti maggiormente più felici rendere i dì di tua vita. Tali sono i sinceri voti del tuo amico.
G. [Giuseppe Visconti]
La lettera ch’io ricevo da un professore di violino, che sta al soldo d’un principe di Germania, mi ha fatto ridere; e giacché vedo universalmente approvata coll’uso la moda di far dei saggi, ossia sperimenti col pubblico, mi determino a fare un breve saggio anch’io, per vedere se anche il pubblico vuol ridere di quello che ha fatto ridere me. La lettera è stata veramente scritta così.
[Lettera d’un violinista]
Grandi magnificenze, feste grandi si sono fatte in questo carnevale; per averne una idea si figuri che le feste dell’anno passato hanno sopravanzato di molto quelle delle quali le ho spedita due anni sono la descrizione; e quelle di quest’anno fanno dimenticare affatto tutte le antecedenti. Per noi però tutte queste superbe cose facevano lo stesso effetto che fa l’arrosto al povero cane che deve farlo girare. Oh vanità terrene, quanta amarezza non si mescola col poco dolce che avete! E quel che più mi scotta si è che la chimica politica è giunta a separare il dolce dall’amaro, e quella piccola porzione la riserva per alcuni pochi uomini, e l’amarezza la regala alla moltitudine:
Ed io pur son di quel bel numer uno.
Giammai in vita mia non ho avuto tanta voglia da moralizzare quanta ne ho avuta in questi giorni, e sì davvero ch’io quasi mi persuado che il talento delle riflessioni cresca colla miseria. Si figuri dunque che noi citaredi quanti siamo ora dovettimo far la figura di dei, ora di satiri, or di ciclopi ed ora di contadini, cosicché abbiamo scorse diverse condizioni e sublunari e sopra lunari, e in tutti questi diversi salti sempre più ci siamo confermati nella opinione degl’incomodi della grandezza. Siamo stati per alcun tempo dei, e allora appunto fu che per ventiquattr’ore non ci fu permesso né mangiare, né bere, né dormire, né riposare, né sedere, in somma non abbiamo fatto nulla di quello che richiede la bassa natura d’un corpo mortale. Io era, cred’io, il nume Morfeo, o almeno l’estrema sonnolenza che aveva me lo ha persuaso; ma il decoro della mia celeste carica mi teneva in guardia contro le palpebre, che pure ad ogni tratto minacciavano di chiudersi, e in alcuni momenti, pieno del mio nume medesimo, gettava uno sguardo proteggitore su alcuni poveri mortali stanchi delle feste, i quali miseramente s’empievano il loro mortal ventre di squisite vivande artificiosamente disposte da alcuni empi, che pensavano più agli uomini che ai dei. Misera umanità, diceva io fra me stesso, a quanti bisogni non sei tu soggetta, e quanto non ti dà a pensare il tuo mortal corpo! Qualche bottiglia di zampillante sciampagna o qualche pasticcio sublime che mi si presentavano più da vicino allo sguardo di tratto a tratto ammansavano il mio etereo orgoglio, poiché sì fatti talismani hanno una irresistibile possanza sulle intelligenze anche superiori; ma alla fine, dopo un lungo combattimento fra la mia terrena originaria natura e l’elevazione de’ sentimenti del nuovo mio stato, gli uomini anch’essi si stancarono e lasciarono i dei in libertà; ed io, riprendendo le frali mie spoglie, quando al Ciel piacque feci la parte da lupo ad una buona mensa, e cessai di sentire l’invidia che in prima provava verso i rimedi inventati dagli uomini per riparare i loro mali. Ora son uomo, e spero che avrò la degnazione d’esserlo per qualche tempo, ed al di più sono obbligatissimo servitore, ec.
[François Baillou]
Un causidico ci ha annoiati nel caffè lodando e difendendo l’instituzione de’ fedecommessi; il mio amico L. gli si è opposto con ragioni sì evidenti che a tutti noi, che eravamo ivi radunati, non restò dubbio che il causidico difendesse le sue entrate anzi che la verità. Ho pregato l’amico a darmi in iscritto le ragioni addotte in quella conversazione, ed egli me le invia nello scritto seguente.
Osservazioni su i fedecommessi
Non vi posso dare prova maggiore della mia amicizia della presente. Voi sapete quanto io sia lontano dallo stendere in iscritto i miei pensieri; poco, anzi niente mi curo degli applausi popolari, quand’anche fossi sicuro di riportarli; né potendo io aver fuor di questo altro stimolo, m’abbandono interamente alla forza d’inerzia, che in me può moltissimo. Pure voi volete ch’io scriva i miei pensieri su i fedecommessi; ed io a dispetto della pigrizia devo ubbidirvi. Nel far la qual cosa non crediate già ch’io sia per produrvi nuove idee, e ch’io intenda dimostrarvi alcuna verità che voi non abbiate ancora ritrovata. Io non farò che esporre ciò che deve affacciarsi a prima vista agli occhi d’un mezzano metafisico o d’un mediocre politico.
Sembrami che se ’l rintracciare l’origine d’una cosa conduce al rischiararla moltissimo e depurarla, ciò particolarmente sia vero de’ fedecommessi, e penso inoltre che sia opportuno ’l trasportare la nostra mente a’ primi tempi della Repubblica romana ed alla sorgente de’ fedecommessi, ma ’l trasportarvisi con quell’occhio discernitore che basti a conoscere l’utilità e l’indole de’ medesimi.
Aveva Romolo[23] divisi i poderi che formavano il piccol territorio di Roma nelle famiglie de’ suoi concittadini; divisione confermata da Numa Pompilio e ristabilita da Servio Tullio. Per conservar l’uguaglianza fra i cittadini conveniva per tanto che i beni non uscissero da una famiglia per passar in un’altra; cosa ch’avrebbe col tempo accumulate in mano di pochi le ricchezze che a tutti ugualmente appartenevano. Fu perciò fatta la legge Voconia, che proibendo di lasciar eredi le donne e loro anteponendo anche i più lontani agnati, impediva ch’esse dalla famiglia del loro padre trasportassero in quella dello sposo l’eredità. Ma introdottosi poco a poco l’arbitrio di far testamento, ne venne aperta la strada d’eludere questa legge col lasciar erede un terzo, incaricandolo a rimetter l’eredità nelle mani di quella che altrimenti non v’avrebbe avuto parte alcuna. Il restituir però quest’eredità era piuttosto dovere d’un fedele amico che d’un buon cittadino, che né pure indirettamente deve trasgredir le leggi. Augusto fu il primo che con legge ordinò la restituzione de’ fedecommessi; e gli imperadori che vennero in appresso ne autenticarono il comandamento. La barbarie che in que’ tempi stendeva la feroce e letargica sua forza nell’Impero romano, il poco conto che facevasi della felicità degli uomini, l’ignoranza delle scienze economiche, e più ancora la vastità sterminata degli Stati che componevano quest’impero, non permisero a’ principi d’esaminare l’utilità de’ fedecommessi. Diviso, anzi oppresso l’Impero romano, nacquero i feudi, origine incessante di liti, di guerre e di desolazioni. Ridotti quest’ultimi in gran parte dell’Europa in confini più stretti e meno nocivi all’umanità, l’indolenza e l’ignoranza lasciarono sussistere i fedecommessi, e questi dalla scaltrita avidità de’ curiali talmente s’estesero che appena puovisi riconoscerne la vera origine. Dicevasi fedecommessa quell’eredità ch’era un amico pregato a restituire, abbandonata alla fede d’esso questa restituzione. Ora noi chiamiamo fedecommesso un podere, che lasciato da un testatore ad un terzo, devesi da questo in vigor delle leggi tramandare al sostituito in quella maniera ch’è propria di ciascuna delle specie d’essi, e così successivamente per tutto quel tempo fissato dal testatore, la cui volontà serve di legge inalterabile, e che obbliga il più delle volte tutt’i successori all’infinito.
Cercasi se tale instituzione utile sia al ben pubblico, o pure se convenga restrignere il troppo esteso arbitrio di dispor del fatto suo per testamento, ed o proibire i fedecommessi, le primogeniture, i maiorascati, o limitarli almeno fino ad un dato termine. Questa sarà la mia ricerca.
È certo che l’unico scopo del legislatore vuol essere la felicità del pubblico. Questa felicità devesi ricercare da esso e promovere con tutt’i mezzi, né assicurare il godimento a pochi cittadini, ma anzi più che si può dividerla infra tutt’i sudditi, né ammassare gli agi e le ricchezze in mano d’alcuni, abbandonata la parte più necessaria e più numerosa del popolo ad una compassionevole indigenza. Io so che data una società civile conviene ammettere distinzione di grado e di condizione; ma so che un provido legislatore fa che i segni rappresentativi delle derrate dalla mano del ricco passino in quella del povero, in maniera che ammessi vengano i più infimi plebei a partecipare della dolcezza del governo, dell’abbondanza del denaro, del profitto del commercio. Sia pure un pessimo e necessario effetto della civile società l’odiosa a’ poveri disuguaglianza d’uomini. Devono però le leggi rendere più sopportabile questa differenza, devono proteggere la plebe, ed animarla al travaglio colla speranza delle ricchezze e d’una vita più comoda. Deve anzi così bene esser regolata la macchina politica che non v’abbia povero se non l’ozioso, cioè quegli ch’è affatto inutile e solo a carico alla società. Per ottener questo fine pare indispensabile che gli onori tutti e le ricchezze siano un premio proposto all’industria, sicché que’ soli possansi dal volgo distinguere che o per virtù o per commercio si resero utili alla patria. Io ben vedo che se volessi lasciar libero il corso alle mie idee, un ben vasto campo qui mi s’offre da trarne le più luminose conseguenze. Converrebbemi allora combattere molti pregiudizi non del popolo solo, ma d’alcuni uomini ancora creduti dotti e certamente ragguardevoli pel loro sapere. Ma rimettiamo ad altro tempo le pur troppo infruttuose filosofiche specolazioni intorno agli onori, ed atteniamoci all’uso delle ricchezze, che per le sagge mire del legislatore devono, quanto si può, essere meno disegualmente distribuite.
Voglionsi dunque in un buon governo libere lasciare le sostanze de’ cittadini, perché que’ che per trascuratezza le perdono, come que’ che per industria le ammassano, siano un forte stimolo a risvegliar gli animi de’ cittadini dall’indolenza e spingerli a far fiorire il commercio, sorgente unica delle ricchezze della città non meno che de’ privati.
Noi per lo contrario siamo ormai giunti a segno che ben poche sono le sostanze libere, e non v’è quasi fondo che vincolato non sia, e dalla massa comune de’ beni segregato, che al commercio liberamente appartengono. Io so che non per i soli fedecommessi vengono tolte le sostanze alla libera circolazione che dà vita e moto alla società; ma lascio ch’altri si prenda la briga di scoprire altre sorgenti del ristagno politico che vassi accrescendo. Bastami l’asserire che la decadenza del commercio in gran parte devesi alla comune voga di fondar de’ fedecommessi.
È assioma evidente in politica che acciocché libero sia e florido il commercio, devesi da buone leggi provedere che i negozianti possano facilmente trovar imprestito del denaro, e con un discreto interesse, onde ne vengano col rigiro a cavarne profitto. Or come ottener questo, se non se coll’usar un sommo rigore perché nissuno impunitamente fallisca, e così cauto sia il prestatore del suo capitale? Perciò alcuni savi legislatori, trascurate le poziorità de’ crediti e la loro forma legale, sono passati ad ordinare perfino che colle opere e con una limitata servitù del debitore compensassesi onninamente il creditore. Questo fine, che pur è necessario d’avere, non viene egli apertamente tolto da’ fedecommessi? Chi m’assicura che quegli che ricercami del denaro, e men’offre per sicurezza l’ipoteca sopra i suoi fondi, non ne abbia che di sottoposti ad antichissimi vincoli di fedecommesso? Come mai potrà trovar sovvenitori un padre di famiglia che voglia migliorar la sua condizione col traffico, ed i cui poderi non siano liberi, essendone esso per la volontà d’un suo antenato un puro amministratore ed usufruttuario? Come mai sarà scosso dall’indolenza ed eccitato a trafficar quegli che abbia una mezzana rendita in fondi, che essendo suoi e non suoi, gli assicurano il sostentamento e non gliene lascian temere la perdita?
È certo che l’interesse, ossia la speranza d’arricchire e di procacciarsi maggiori piaceri, è il determinativo di tutte le azioni mondane. È ugualmente certo che i costumi e la maniera di pensare d’una nazione dipendono dalle massime ricevute dalla gioventù e radicate col crescer degli anni. Ciò posto, un figlio d’una famiglia, ove non sianvi fedecommessi, ancorché veda il padre dovizioso, cercando però di vivere più indipendente da esso e d’accertarsi un buono stato, dovrà sciegliere una delle due: o coll’ubbidienza acquistarsi l’amore paterno, ed interessarlo a somministrargli del denaro ed a lasciargli una ricca sostanza, o pure rendersi intendente ed abile nel commercio, ed impetrando l’autorità di leggi provide farsi assegnare dal padre una somma di denaro col quale possa trafficare ed arricchirsi. Ma facciamo che questa famiglia non abbia fondi che non siano fedecommissari: in questo caso il figlio, essendo sicuro che il padre non potrà mai privarlo della pingue eredità, poco si cura di guadagnarsene l’affetto, ed all’ozio abbandonasi, più dannoso ancora al pubblico bene che al privato. Ecco l’evidente ragione perché gli uomini più attivi sorgano dagli stati intermedi; e perché ben pochi sono que’ che avendo ricevuta una molle educazione, ed aspettandosi una immancabile facoltosa eredità, sian arrivati a distinguersi nelle scienze. Ecco una delle cagioni che più influiscono nella sì comune ignoranza de’ nobili.
Ma qual mai si è lo scopo de’ fedecommessi, delle primogeniture, de’ maiorascati? Quello, dirammisi, di conservar ricca ed illustre una famiglia. Che così si ragioni da un vecchio imbevuto di pregiudizi, che crede di rivivere nella sua discendenza e pascesi nell’idea di veder perpetuata la sua linea, non deve far istupore; ma poco importa alla pubblica felicità che tal famiglia conservisi eternamente ricca, anzi molto importa che le ricchezze accumulate passino di mano in mano, circolino nello Stato e siano il premio dell’industria d’un negoziante, più utile alla società che mille nobili sfaccendati.
Nella succession de’ monarchi è giusto che le provincie d’uno Stato siano riputate inalienabili dal principe,
IL CAFFÈ )( Fogl. XI )(
e che il governo, ch’è indivisibile, tocchi al solo primogenito, perché non venga a sciogliersi la monarchia, e da possente ch’essa era, ridursi in piccoli principati, preda sicura d’un vicino più grande. Ma la cosa va diversamente nelle famiglie private. Abbandonansi da ridicole leggi alla miseria i cadetti in una casa dove siavi primogenitura, e rendonsi vittima alla felicità del primogenito. E questo dirassi mantener la casa in lustro? Cosa è mai questa casa e questo lustro? Pel nome di casa credo doversi intendere non il solo primogenito, ma i membri tutti d’una famiglia. E per lustro d’una casa io intendo gli agi e le ricchezze distribuite nei componenti della casa. Conservasi forse il lustro d’una famiglia rendendo infelici i cadetti, per caricare di ricchezze quegli che ha avuta la sorte di nascer prima? Allora solo dovrassi chiamare una famiglia ricca ed illustre quando una facoltosa sostanza sia, più egualmente che si può, distribuita ne’ membri della famiglia; quando tutt’i fratelli siano messi in istato di vivere comodamente, di scegliersi ciascuno una sposa e di dare alla patria de’ cittadini. Pare che l’uso della primogenitura sia incompatibile colla mira della popolazione, che pur dev’essere la principale.
Chi asserisse, che divise le sostanze tra molti fratelli, nissuno d’essi si crederebbe in istato di caricarsi dell’ormai eccessiva spesa del mantenere la moglie, e che per voler dare moglie a tutti, tutti si ridurrebbono alla impossibilità di prenderla, questi mostrerebbesi ben poco pratico de’ principii delle scienze economiche; poiché allora il lusso si diminuirebbe a proporzione della ricchezza de’ particolari; ed in vece che la moglie del primogenito ha più cocchi, e più paia di cavalli, e più paggi, e più servidori al suo comando, non avrebbe nella mia ipotesi che una carrozza ed un discreto numero di servi, quanto appunto ne manterrebbono gli altri fratelli, non richiedendo il ben pubblico, cioè la maggiore felicità possibile divisa colla maggiore egualità possibile, che un nobile abbia venti cavalli, dieci carrozze, trenta servidori ec.
Qual maggior disordine (per quanto a me sembra) autorizzato dalle nostre leggi di quello che un figlio, che trovisi beni fedecommissari, possa impunemente defraudar i creditori del padre col ripudiarne l’eredità? Questo mezzo d’arricchirsi a danno altrui e di burlarsi de’ creditori e dell’onestà è ormai divenuto sì comune che niente perde della sua riputazione chi se ne serve. Cosa dirà mai il povero creditore schernito e ridotto alla povertà nel vedere il suo debitore strascinato indolentemente in dorate carrozze, sfoggiare livree superbe, dar sontuosi banchetti e vivere deliziosamente? Dirà che questo è un aperto insultare a’ principii tutti della morale e della legislazione; ch’egli è una manifesta violazione del patto sociale; che ben vedesi da chi siano fabbricate coteste leggi, che tutto l’avvantaggio danno al nobile ed in preda gli abbandonano il plebeo; dirà che i denari co’ quali il nobile appaga i suoi vizi, stipendia i servi, convita gli amici, è tutto denaro ad esso rubbato; che per queste frodi, mentre chi ha dichiarato fallito il padre vive nel lusso, la povera sua famiglia giace squallida nella miseria; che egli ha dovuto interrompere i suoi traffici, che, costretto a pagare a chi doveva, non ha potuto esiggere da chi gli era debitore.
Altro dunque non sono i fedecommessi e le primogeniture che un ritrovato per sorprendere i creditori e defraudarli. A che altro mai servono, che a fomentare l’ozio e a rendere inutili, anzi perniciosi alla patria que’ cittadini, che avendo dinanzi gli occhi i virtuosi esempi de’ loro gloriosi antenati, dovrebbero più degli altri esercitare la virtù per non essere creduti degenerare da’ loro maggiori? A che giovano le primogeniture, che a render ineguali quei che hanno un diritto eguale a’ beni paterni; ed i fedecommessi, che, ammassando e conservando i beni in una famiglia, ad accrescere la disuguaglianza delle fortune tra i cittadini? Fingasi il territorio d’una nazione esteso di cento mila pertiche; di queste sia la metà sottoposta a’ fedecommessi od altri vincoli, ed in mano di cinque o sei famiglie. Lascisi la facoltà a’ testatori di toglier la libertà al resto de’ beni col vincolo del fedecommesso od altro. È certo che in poco tempo tutte le sostanze saranno inalienabili, che tolto sarà l’adito all’industria, che i soli ricchi saranno i cittadini, il resto del popolo languirà nella miseria e nella schiavitù, tanto più detestabile quanto che non vi sarebbe mezzo per redimersene.
I politici del secolo addietro avevano più in mira il presentaneo utile del principe che ’l suo vero interesse, che non va mai disgiunto dalla felicità de’ popoli. Purché i fondi non andassero esenti dal pagare tributo al sovrano, loro poco importava se accumulati fossero in poche famiglie, se vincolati ed obbligati ad arricchire perpetuamente una famiglia. Adesso però che lo spirito filosofico s’è molto esteso, che le potenze tutte considerano il commercio, l’agricoltura, l’industria, la popolazione de’ sudditi come oggetti importantissimi; adesso che più che colle armi si fa una vivissima guerra d’industria da nazione a nazione, dovrebbero le leggi stendere le loro mire a far fiorire queste sorgenti della ricchezza d’una nazione e prendervisi con tutt’i mezzi. È vero che alcuni pubblicisti, stimando i fedecommessi e le primogeniture contrarie al buon governo delle repubbliche, le asserirono però necessarie in una monarchia per conservarvi il lustro della nobiltà da loro stimata indispensabile. Io qui non esaminerò se negli Stati monarchici sia necessaria la nobiltà ereditaria, quale, sconosciuta nel resto del mondo, è in uso nella sola Europa; solo dirò che parmi strano che il bene d’una monarchia esigga che un fratello viva nell’opulenza, gli altri non abbiano come maritarsi, come appagare que’ desideri che la loro necessità ed educazione ha convertiti in veri bisogni; parmi strano che in una monarchia sia necessario che un cittadino faccia de’ debiti e non li paghi, allegando che i suoi beni sono fedecommissari; parmi strano che in una monarchia si richieda una somma disproporzione di fortune e che i nobili vivano oziosi. Se ciò fosse vero, avrebber avuto certamente torto quegli scrittori che hanno tanto esaltato il governo monarchico sopra ’l repubblicano.
Per quanto sia rispettabile l’autorità di Montesquieu, e benché io pensi di trattar altra volta della nobiltà, pure stimo indispensabile il doverne qui dire qualche cosa, perché que’ che leggeranno questo foglio, abbagliati dal nome di quell’illustre autore, non abbiano a credere piuttosto alla di lui asserzione che alle ragioni che l’abbattono. Pone dunque per fondamento il signor di Montesquieu che l’essenza della monarchia richiede un’autorità intermedia, cioè dei canali pei quali operi il monarca. Dice in seguito che questo potere intermedio dev’essere la nobiltà, poiché dove non v’è monarca non vi puol essere nobiltà;[24] e tolta la nobiltà, è distrutta parimente la monarchia, ed introdotto in vece o ’l dispotismo o lo Stato repubblicano.[25] Richiede in oltre nella monarchia un corpo depositario delle leggi, quale per sua confessione non può essere la nobiltà, per la sua ignoranza ed indolenza, né meno il Consiglio privato del principe. Asserisce che essendo l’onore il mobile degli Stati monarchici, le leggi debbonvi proteggere la nobiltà, debbono renderla ereditaria, perché serva di vincolo tra ’l principe e ’l popolo; che però è necessario ammettere le sostituzioni per conservare i beni nelle famiglie, e ’l diritto di ricomperare i già alienati; che queste prerogative devono accordarsi alla sola nobiltà; che è bene per i sopraddetti motivi permettervi il diritto di primogenitura. Riconosce però che le sostituzioni impediscono ed opprimono il commercio; che il diritto di ripetere i fondi fedecommissari è la sorgente d’infiniti litigi; che i privilegi annessi alla nobiltà sono d’un eccessivo carico per il popolo. Mostra dappoi, coll’esempio della Francia e dell’Ungheria, che la nobiltà, quale esso la vuole, è il più saldo sostegno della monarchia; che perciò il corpo de’ nobili dev’essere ereditario.[26]
Ardisco dire che il signor di Montesquieu in ciò, come alcun’altra volta, ha piuttosto avuto in vista la costituzione della Francia che gli universali principii del diritto pubblico. Forse una esatta definizione delle due voci onore e nobiltà avrebbe resa questa materia più chiara.[27]
Io stimo che l’essenza d’una monarchia consista in ciò che siavi un corpo di cittadini depositario delle leggi, e che fissate queste leggi, possano i magistrati eseguirne la determinazione costantemente e liberamente… Per altro conveniva distinguere tra potere intermedio e ranghi intermedi, perché anche il tiranno, non potendo operar tutto da se medesimo, è obbligato ad avere dei canali per i quali passi la sua autorità.
Nella monarchia adunque non pare indispensabile che vi sia uno stato di persone distinto dal popolo, non già come depositario delle leggi, non già come esecutore della volontà del principe, ma solo come immaginario vincolo tra esso e il popolo. Questo vincolo non dev’esser altro che leggi fisse, chiare, certe, inalterabili, che determinino e contengano ne’ giusti limiti l’autorità di ciascheduno. Il solo merito dovrebbe, in qualunque Stato, elevare gli uomini all’amministrazione della giustizia ed alle cariche che lo suppongono. Ma dato ancora che sia necessario ammettere una classe di persone distinte con privilegi ed animate dall’onore, che formino una specie di scala dalla plebe al sovrano, non vedo in primo luogo come convenga rendere ereditario il diritto di tali persone a certe prerogative, cioè come la nobiltà si richieda ereditaria. Non basterebbe egli che fossevi un dato numero di nobili, in maniera che la nobiltà potessesi e perdere coll’ozio ed acquistarsi colla virtù? Così tutti potrebbero partecipare de’ privilegi de’ nobili e sussisterebbe questo grado intermedio. Non capisco, in secondo luogo, come anche nella nobiltà ereditaria siano assolutamente necessarie le sostituzioni e le primogeniture, che pure, anche secondo il signor di Montesquieu, si strascinan dietro tanti disordini. Ma quand’anche fosse vero interesse del monarca il conservare la nobiltà ereditaria, non sarebb’ella bastantemente conservata conferendo ai soli nobili le cariche della sua corte; col promoverli a preferenza degli altri nella milizia; col riservar loro certi onori e distinzioni? Con ciò almeno non s’indebolirebbe il commercio, non si aggraverebbe il popolo, né si defrauderebbero i creditori; e col pretesto di favorire un nobile, non si sacrificherebbero i suoi fratelli egualmente nobili. Del resto le ragioni e gli esempi addotti dall’autore dello Spirito delle leggi provano bensì che la nobiltà ereditaria senza giurisdizione, che riceve unicamente il suo lustro dalla volontà del principe, è il più saldo sostegno della persona del monarca. Ma dubito che se ne cavi che questa nobiltà faccia fiorire la monarchia e ne renda felici i sudditi. Vi sono de’ regni che forniscono una prova costante di quanto io dico, malgrado l’ampiezza delle provincie, la felicità del clima e la fertilità del loro terreno.
Ma sia pure necessaria in una monarchia la graduazione delle condizioni, sia pure indispensabile la chimera della nobiltà; anzi sia cosa utile al ben pubblico il conservare l’antico lustro ad alcune famiglie (cosa ch’io credo falsa); come dovremo noi agire per arrivare a questo fine? Forse rendendo oziosa ed inutile, e perniciosa eziandio la classe de’ nobili, con permettere che le loro ricchezze siano assicurate alla loro discendenza? O anzi col permettere che esercitino il negozio e che s’arricchiscano, arricchendo anche la patria; col determinare che ’l commercio niente deroghi alla nobiltà; coll’animar anzi i nobili al traffico e correggere di maniera l’opinione del volgo, che il negoziante non sia rigettato dall’esser ammesso nel corpo della nobiltà, ed ammessovi, non sia più considerato come nobile di data recente, né più serva di bersaglio a’ motteggi de’ nobili anticamente oziosi?
Havvi un’altra specie di fedecommessi non meno assurda dell’altre ed egualmente comune, e sono i fedecommessi fiscali. Gli antichi legislatori hanno creduto di prevenir i delitti col decretare per loro pena l’intera perdita di tutte le sostanze del reo. Questi legislatori non so come abbiano scordato che i figli del reo sono cittadini innocenti, e che pare che per il delitto del padre non meritino d’esser ridotti da uno stato comodo alla più ingiusta e compassionevole povertà. Io sono ben lontano dal voler diffinire che questi legislatori siano stati mossi dal loro privato interesse a far cotali leggi; anzi né pure diffinirò se una tal legge sia utile o dannosa al pubblico. Vedo ragioni favorevoli e contrarie d’ogni parte, e non è mio carico il doverne qui pesare la forza; ma poiché tal legge esiste e si suppone giusta, parmi che ogni buon cittadino vi si dovrebbe assoggettare. La pratica però (nome da cancellarsi da’ dizionari legali a pubblica utilità) dispone diversamente. Sogliono quasi tutt’i testatori ordinare che se un loro discendente incorresse la disgrazia del principe, s’intenda, un’ora prima della trasgressione delle leggi, spogliato dell’eredità, e questa devoluta al più prossimo parente; con che però il reo, subito rimesso nella buona grazia del sovrano per diritto di postliminio, rientri nel possesso della medesima eredità. Pare strano che si soffra una sì manifesta violazione della legge; pare strano che i magistrati incaricati a far eseguire le leggi giudichino in favore della validità di tali disposizioni testamentarie. Tant’è vero che la giurisprudenza non ci offre per lo più che un ammasso di contraddizioni, di sutterfugi, di sottigliezze. Tanta è la venerazione nostra per le leggi romane che abbiamo voluto adottarle, benché incompatibili colle nostre circostanze; e tanto può negli animi de’ giuristi l’avidità del denaro che hanno saputo introdurre ed autorizzare mille finzioni per servirsene a deludere le leggi da loro stimate le più salutevoli.
Ma vediamo noi forse che questi vincoli di primogenitura, di fedecommessi operino ciò di che si lusingarono i loro istitutori? Anzi l’esperienza c’insegna il contrario. Basta che uno voglia scialacquare, che non gli mancano pretesti per carpire da’ giudici la licenza d’alienare; e per questi il vincolo non ha servito ad altro che a sottoporlo alla spesa di queste dispense; e così arricchire i curiali che hanno saputo sì bene raggirar le cose, che alla fine da ogni parte e per ogni cosa cola il denaro nelle loro borse. Chi è che non sappia quanto mai queste istituzioni rendano spinosi e pericolosi tutt’i contratti? Sulla buona fede io compro un podere che a’ miei nipoti sarà coll’autorità sacrosanta delle leggi involato da uno che produrrà una rancida carta, un tarlato testamento fatto vari secoli prima, nel quale chi possedeva quel podere ha disposto che non avesse a sortire dalla sua discendenza. Quindi una scambievole universale diffidenza nel contrattare; quindi mille frodi, mille litigi, e l’incertezza in cui uno sempre trovasi di vedersi cacciato dal possesso d’una roba da lui comperata. E queste leggi dirassi che assicurino la proprietà e ’l diritto a ciascun cittadino?
Hanno ben veduto tutti questi disordini que’ antichi curiali, che tanto estesero la giurisdizione de’ fedecommessi e l’incertezza de’ beni. Videro costoro che i fedecommessi sono una perenne sorgente di denaro per se medesimi; che Baldo assicura aver guadagnato nel consultare sulla sola materia delle sostituzioni fedecommessarie quindicimila scudi d’oro; videro che tolti i fedecommessi sarebbe distrutto il dispotico loro impero; che l’incertezza della proprietà assicurava loro grossi salari;[28] che tolti i fedecommessi sarebbero obbligati od a servire colle armi la patria, od a esercitare l’industria nel commercio. Perciò, invece di giudicare in caso di dubbio per la libertà de’ beni, non v’è quasi testamento nel quale essi non arrivino a farvi sviluppare un fedecommesso in virtù d’una stiracchiatissima interpretazione di clausole infinitanti, mente del testatore, particelle d’orazione, avverbi stesi per lo più da un ignorante notaio senza che v’abbia riflettuto il moribondo testatore. Chi s’è qualche poco applicato al noiosissimo studio dell’informe caos della giurisprudenza, e letto que’ seccantissimi autori che il volgo venera come tanti legislatori, avrà veduto i vari sensi che si danno alle espressioni le più chiare e limpide, ed i mezzi di sostenere in ogni cosa il prò ed il contro.
Potrebbesi qui cercare d’onde proceda che i testatori tanto siano inclinati a fondar primogeniture e fedecommessi. Di fatti, poiché la morte spoglia gli uomini di quanto possedono, qual mai è il motivo che gli interessa tanto a voler disporre delle loro sostanze anche per il tempo in cui non esisteranno? A mio avviso questa ne è la cagione. Siccome essi hanno co’ loro stenti accumulate le ricchezze senza goderle, ne invidiano a’ successori il libero godimento, vogliono comandar dopo morte, vogliono che tutto seguiti a servire a’ loro capricci anche molti secoli dopo la loro vita; e poiché non giunsero ad immortalare il loro nome colla virtù che disprezzarono, godono di conservare alcuna memoria di sé ne’ testamenti e nelle intralciate continue sostituzioni d’eredi chiamati alla loro eredità. Ma esprimano pur costoro quanto più sanno chiaramente la loro intenzione, ne manifestino i motivi, aggiunganvi pene a’ trasgressori, che tutto sarà indarno. La dubbia interpretazione a cent’occhi e cento facce offrirà un ampio campo a’ dottori di deludere i ridicoli loro comandi, mostrando di volerli scrupolosamente adempire; sicché nient’altro avranno guadagnato, se non che il loro nome sarà ripetuto negli atti delle cause, stampato nelle allegazioni, deriso da’ savi pensatori e venerato da coloro che fossero vili ed avidi ministri del loro interesse, piuttosto che delle leggi e della giustizia.
Se però alcuno vi fosse, che ciò non ostante stimasse questi mali irreparabili, e piccoli sacrifici e compense di grandi vantaggi, a questi io guarderommi di voler persuadere più oltre, giacché chi non vuol ragionare, né merita, né deve, né puol essere illuminato.
Ho esposto fin ora quale sia il frutto de’ fedecommessi e quanto male dalla loro istituzione avvenga al ben pubblico. Parrebbe conveniente l’aggiungervi que’ rimedi che mi sembrassero opportuni a torre questo disordine.
S’io dovessi parlare ad un filosofo, direi che non vedo come nel patto sociale gli uomini si siano ragionevolmente riservata la podestà di disporre de’ loro effetti dopo la loro morte. Ciascuno, in vigor di questo patto, dev’essere assoluto e certo padrone delle cose sue finché vive, ma alla sua morte dovrebbe lasciar il carico di disporre dell’eredità a provide leggi che regolino le successioni, e le regolino in maniera più chiara e ragionevole che non fanno quelle stabilite ne’ passati tempi, che sempre sono in contraddizione o colla buona morale o con se medesime. Un amico, un parente, al quale vogliasi esser grato, e si può e si deve beneficare intanto che si vive, lasciata la libertà delle donazioni; altrimenti esso non deve saperne buon grado al testatore, il quale non s’è mai voluto privare del suo; ma sì bene la morte deve ringraziarsi, che abbia fatto venire l’unico caso nel quale il morto volesse soddisfare a’ suoi doveri; direi che tolta la libertà del fare testamento, col partaggio continuo delle successioni le fortune de’ cittadini si rimetterebbono sempre nell’eguaglianza; che avremmo pochissimi avvocati, procuratori, sollecitatori, notai ec., ma più negozianti e più agricoltori; che anche i secondogeniti potrebbero ammogliarsi e contribuire onestamente alla popolazione; che il secondogenito non sarebbe per conseguenza la vittima d’un immaginario lustro della famiglia rappresentata dal solo primogenito; che indarno si pensa a togliere gli abusi ed i vizi in una legislazione se non se ne sradica la sorgente; che sembra ridicolo che un uomo comandi quando ha cessato d’esser uomo. Direi che Solone proibì il far testamento, poiché i figli ereditavan de’ loro padri, ed in loro mancanza i fratelli, i nipoti, i parenti possedevan le sostanze del morto; che appresso i primi Romani, più felici benché non ancora conquistatori, tanto era sconosciuto il testamento che quel che voleva lasciare dopo sua morte la roba ad un cittadino cui la legge non l’attribuisse, doveva far un contratto di vendita della sua eredità coll’erede prescelto, qual vendita in principio non fu immaginaria e fittizia, ma vera e reale. Direi col signor di Montesquieu che l’illimitata facoltà di far testamento introdottasi fra i Romani rovinò poco a poco la politica disposizione sopra il partaggio delle terre; che ad essa facoltà dovevasi in massima parte ascrivere la funesta differenza tra la ricchezza e la povertà; che essendosi riunite più porzioni in una sola famiglia, alcuni ebber troppo, ed una infinità d’altri cittadini dovettero menare una vita stentata e precaria; che con ragione il popolo romano, defraudato dall’inalterabile diritto di possedere la sua parte di poderi, continuamente, anche ne’ tempi di Roma frugale, chiese una nuova distribuzione di terre. Direi liberamente che Grozio, Barbeyrac, Buddeo ed altri s’ingannarono quando asserirono essere di diritto naturale la podestà di fare testamento; poiché non può esservi testamento dove non v’è proprietà; e ’l diritto di proprietà esso medesimo è derivato non già dalla legge naturale, ma sì bene dal gius delle genti. Direi che può sussistere una società civile senza diritto di proprietà; che ammesso ancora il diritto di proprietà, non ne deriva che chi coll’autorità delle leggi ha posseduto vivendo, possa comandare dopo che ha cessato d’essere; che i morti non avendo più parte ne’ beni di questo mondo, non è necessario che la proprietà d’un cittadino s’estenda fino ad esiggere in esso la libertà di disporre del fatto suo con testamento. Direi con Bynkershoek che la terra è destinata all’uso degli uomini di tutt’i secoli, e che ciascuna delle generazioni che si succedono le une alle altre deve avere libero il godimento de’ suoi beni; direi francamente che Puffendorf ed i sopra nominati pubblicisti Grozio, ec. ragionano male, asserendo il primo utile, gli altri necessaria la podestà di far testamento, perché i beni dei defunti non siano dilapidati e dirubati dal primo occupante; poiché le leggi, che sono il risultato della pubblica volontà, debbono regolare chiaramente la materia delle successioni. Oserei dire in fine che ha ragionato peggio dei detti dottori il per altro dottissimo Leibnitz quando disse che “per la forza del solo diritto i testamenti non avrebber alcun effetto, se l’anima non fosse immortale; ma siccome i morti vivono ancora effettivamente, restano perciò sempre padroni de’ loro
IL CAFFÈ )( Fogl. XII )(
beni, in maniera che gli eredi ch’essi lasciano debbono essere risguardati come procuratori per un affare che gl’interessa”.[29] Maniera di tirar conseguenze troppo indegna di Leibnitz.
Ma poiché pochi sono que’, che essendosi innalzati sopra i pregiudizi comuni, ed avendo per così dire steso quanto si può l’orizonte delle loro cognizioni, sono rimontati all’origine de’ mali che innondano la società civile, io m’accontenterò di dire che non saranno mai abbastanza lodati que’ saggi legislatori, che scosso il giogo dell’opinione hanno ardito di pensare alla vera felicità de’ loro popoli, che hanno limitati i fedecommessi quanto hanno creduto di poterlo; dirò solo che permessa la libertà di far testamento, ottima cosa sarebbe il proibire qualunque siasi primogenitura, fedecommesso, sostituzione. Dirò che pochissimi sono gli sconcerti che da un tale repentino cangiamento potrebbero nascere; sconcerti che minorerebbonsi, qual ora un avveduto legislatore li prevedesse e li prevenisse; sconcerti che svaniscono in confronto del gran bene che farebbe la legge che vietasse i fedecommessi; sconcerti finalmente necessari ed irreparabili qualora una cattiva legislazione ha lasciato per lungo tempo accrescere gli assurdi, per passare da un cattivo regolamento ad uno che avesse di mira la maggior felicità possibile de’ cittadini distribuita colla maggior egualità possibile.
Con tutto ciò io conosco abbastanza gli uomini, e so talmente fissare il pregio della loro ragione e considerare l’uso che ne hanno sempre fatto, che capisco che queste mie riflessioni debbono parere alla maggior parte d’essi sogni d’un fanatico, idee stravaganti e ridicole, progetti chimerici. Felice me, se non mi s’attribuiranno intenzioni maligne, e se alcun uomo ragionevole, benché sconosciuto o disprezzato, applaudirà segretamente, se non alla giustezza de’ miei ragionamenti, almeno all’amor della umanità che mi ha spinto a pubblicarli. Finirò con Montesquieu: “Je crois que ce petit ouvrage est le plus inutile qui ait jamais été écrit. Quand il s’agit de prouver des choses si claires, on est sûr de ne pas convaincre”.[30]
L. [Alfonso Longo]
Io ho migliore opinione degli uomini di quello che ne ha il mio amico L., e mi lusingo che non sarà tanto piccolo il numero di quei che troveranno sode le ragioni che ci ha addotte, quanto ei se lo immagina. Il male che fanno i fedecommessi è sì frequente e sì palpabile che l’animo degli uomini è già disposto a ragionar bene su questo proposito; coloro che trovano rendita in questo disordine certamente che non gusteranno la ragione; quegl’imbecilli che non ragionano, ma ripetono le declamazioni di quei redituari de’ mali pubblici, anch’essi non saranno del suo parere; ma la massima parte de’ lettori non sarà di queste due classi. In molti Stati d’Europa con nuove leggi s’è già posto freno alla eternità de’ fedecommessi, il che prova che le ragioni del mio amico sono conosciute concludenti.
Veniamo ora ad un altro articolo. Riceviamo diversi avvisi consegnati a Demetrio per ricapitarceli, e siccome la repubblica delle lettere sarà per aggradirli come tendenti tutti a promovere le cognizioni umane, così ne inseriamo alcuni colle risposte che abbiamo ad essi fatte.
[Avvisi ai signori caffettieri]
Avviso primo.
Signori caffettisti.
Nel foglio primo, nella Storia naturale del caffè, vi siete serviti della voce pavimento, e dovevate dire suolo; ve ne do avviso per vostra regola. Il ciel vi salvi.
Risposta.
È vero che nel foglio primo nella Storia naturale del caffè ci siamo serviti della voce pavimento per dinotare il suolo; ne riceviamo l’avviso, e il ciel lo conservi.
Avviso secondo.
Signori del Caffè.
La Storia naturale del caffè è descritta nel Dizionario enciclopedico e nel Savary, onde non è cosa nuova. State sani.
Risposta.
È vero che i due dizionari citati descrivono il caffè colle proprietà che gli assegniamo noi, ma non è colpa nostra se il caffè è sempre la stessa pianta e per Savary e per gli enciclopedisti e per noi. Se tutt’i lettori del nostro foglio avessero letto in prima que’ due dizionari, la descrizione da noi fatta del caffè non sarebbe stata cosa nuova. Stia sano anch’egli.
Avviso terzo.
Signori caffettieri.
Avete detto nella prima pagina del primo foglio la notte è illuminata: sproposito insigne, perché la notte è oscura, non illuminata. Scusate la libertà, e sono ec.
Risposta.
Quando vi siano accese delle buone candele ci pare che la notte possa dirsi illuminata. In avvenire diremo così: era oscurata la notte da moltissime candele. Scusiamo la libertà, e lo lasciamo quale ec.
Avviso quarto.
Signor Demetrio.
Dite ai vostri scrittori che è cosa facilissima lo scrivere come essi fanno, e che li riverisco.
Risposta.
Amico Demetrio.
Dite al vostro corrispondente che ce lo provi scrivendo anch’esso qualche cosarella del suo, e che frattanto gli diamo il buon giorno.
Avviso quinto.
Signori del foglio.
Il discorso sul giuoco del Faraone è tutto preso dalle Ricreazioni matematiche dell’Ozanam, e dall’Accademia de’ giuochi.
Risposta.
Né il signor Ozanam, né l’Accademia de’ giuochi hanno calcolato il Faraone. Ciò non è stato mai fatto che dai due autori citati, Montmort e Moivre, i quali hanno scritto per gli algebristi.
Per consolazione poi di tutti quei che ci trasmettono tanti avvisi, pubblichiamo il seguente
P. [Pietro Verri]
Saggio di legislazione sul pedantesimo
E quando fia che sappiano anche le delicate madamigelle alle loro toillette, e le tenere spose fra i soavi profumi d’un solitario gabinetto, che razza d’uomini furono coloro che vissero ne’ secoli addietro, sicché nominando Epaminonda, Tullo Ostilio, comizi, Campomarzio, centurie, non s’abbia ad interrogare che razza d’animali sono eglino costoro? Ciò non oso dire che accada a’ dì nostri, ma per certo non averrà che quando ci spoglieremo ormai di quell’austero pedantesimo che sparge la melanconia sopra tutte le cognizioni, e che ha fatto delle belle lettere la cosa più sonnifera del mondo. Chi ci vien di questi eruditi ad opprimere con grossi volumi, chi con largamente stemprate dissertazioni, chi con medaglie, iscrizioni, pergamene ci addormenta; in somma la maggior parte vendonci al caro prezzo di eterna noia molte parole e poche cose. Nelle scienze e nelle lettere, in ogni umana cognizione per fine, vi abbisogna ogni sorta di moneta; grande, minuta, d’oro e d’argento, poiché come in uno Stato dalle grosse monete d’oro fa d’uopo discendere sino a quelle di rame o d’argento, acciocché ad ognuno venga facilitato il commercio, onde chi non può spendere la dobbla, spenda il paolo; così pure convien fare nelle scienze. Vi partecipino tutti gli uomini se è possibile, sappia il volgo la decima parte di quello che sa l’uomo illuminato, sappia l’artigiano il triplo del volgo, sappia il mercante più dell’artigiano, sappia per fine ogni vivente qualche cosa di più che mangiare, bere, dormire, sbadigliare e seccare il suo prossimo, le quali doti mirabilmente sono unite per lo più alla vita priva di miserie e di bisogni. Ma che farò io meschino, sepolto in un canto dell’universo, di non altra autorità munito che di quella che somministra la ragione? Pretenderò io forse a questo tavolo, in quest’oscuro gabinetto d’esser legislatore? Pure per quanto piccola cosa io mi sia in questo mondo, non credendomi l’ultimo degli uomini, io scriverò per quegli che mi vengono addietro; e se pur nessun m’ascolta a te io parlo, o Calif mio fido can barbone, che pur sei sì buono e sì ragionevole, senz’astio, senza maldicenza, senza inimicizia del merito; ascolta e dimmi poi se i precetti ch’io propongo non meritano quattro sonetti, cinque madrigali, otto canzoni e due mila pasquinate da quelle penne felici che da Socrate sino al 1764 esercitarono la pazienza degli uomini ragionevoli.
I. Quando taluno avrà la malaugurata voglia di diventar autore, non cominci col dire: Io voglio fare un libro in foglio per esempio sull’Etica, ma bensì dica: Ho varie idee su di questa materia, proviamoci a scriverle più chiaramente e concisamente che si può; venga poi il libro in ottavo, in quarto, in foglio, ciò non importa. Per lo che sia ogni libro proporzionato alla sua materia.
II. Saranno proibite tutte le prefazioni veramente prefazioni, al Leggitor cortese, al benigno Lettore, ad cupidam Iuventutem, e gli avant-propos, avis au public, du Libraire, buona parte delle note e de’ commenti, le tavole degli autori citati, li testimoni intorno all’autore, e simili riempiture che ingrossano inutilmente i volumi, come l’esperienza ci dimostra; e ciò a cagione che non pochi si disgustano della grossezza de’ libri, e misurando da quella la fatica che si deve fare per intenderli, prendono il comodo partito di restar ignoranti.
III. Converrà cominciare le opere dove cominciano le idee chiare e precise, e non al di là di quelle, come fanno coloro che con un lungo proemio (che per esser della vera razza de’ proemi starebbe tanto a capo di un libro di astronomia come di uno di legge), con un lungo proemio, dissi, vi spuntano da lontano e vi si aggirano intorno intorno alla materia di cui imprendono a trattare per tanto tempo che finalmente non vi cadono che alla metà del volume, e poi non hanno rossore di dirvi per entrare come si dice di piè pari in materia, per non istar più sul proemiare, e simili tradimenti.
IV. Chiunque vorrà stampare alcuna sua opera, dovrà sempre aver di mira d’instruire gli uomini, non di affogarli in un mare di erudizione, o di sfoggiare tutte le sue cognizioni a luogo e fuor di luogo, inserendole, se non lo può nel contesto dell’opera, in note, addizioni, rimarche, nota bene e simili cose, che fanno i libri sgraziatamente abbondanti, gonfi piuttosto che pregni d’idee.
V. Dovrassi dalla studiosa gioventù prima d’ogni cosa dar buon ordine alle proprie idee, avvezzarsi a far uso della ragione ed a sentire la verità a preferenza della autorità d’opinione, e poi sarà loro concesso di seriamente occuparsi, se il vogliono, della ortografia e della lingua; ma non mai comincieranno da quest’ultime, atteso che sono sterili facoltà, serve e non padrone de’ nostri pensieri, e che altro produrre non sogliono che miseri pedantelli, o come la Crusca vorrebbe, pedantuzzi, altrettanto vuoti d’ingegno e d’idee quanto gonfi d’accenti gravi, acuti, di apostrofi, interponzioni, raddoppiamenti di vocali, consonanti, e di tante belle bellissime parolette e periodini che non pronunciano mai senza sorridere per una secreta compiacenza, di modo che sono nel medesimo tempo attori e spettatori di se stessi.
VI. Abbandonerassi la ormai ridicola e smascherata impostura d’alcuni gravissimi eruditi, che si arrogano la dignità di primi ministri della storia, delle medaglie, delle antichità, di modo che sembrano avere sempre in corpo una dozzina di Marc’Aureli e di Vespasiani, ed esigano per loro medesimi la venerazione a quegli dovuta; e perché son pieni di storia greca, or credonsi Filippo, ora Amilcare, or Pausania, onde col contegno grave e severo ne sostengano meravigliosamente il decoro. Così pure alcuni mediocri rimatori converrebbe che più non facessero gli occhi sviati e stravolti, il crine o la parrucca rabbuffata, o tenessero gli abiti laceri, sucidi e negletti, affettando così di essere assorti in un estro che non ponno avere; e mill’altri pure converrebbe che si riformassero, i quali per esser un poco ragionevoli affettano una tale negligenza delle umane cose che fa odiare la sapienza istessa ne’ suoi professori, e che fa che il popolo malamente unisca la sacrosanta idea di filosofo a quella di delirante.
VII. Scrivendo in italiano o in altra qualunque lingua non farassi una vana pompa di termini rari e prelibati, facendo in tal modo che la lingua nazionale diventi forestiera, e che abbisogni di traduzione; ma bensì rinunciando a questa misera superbia scriverassi per essere inteso da tutto il mondo, giacché non si deve scrivere o stampare che per far sapere a quanti più si può quello che sappiamo noi.
VIII. Non si chiameranno più superficiali quegli uomini insigni che sapendo la difficil arte di mescolare l’utile al dolce resero comuni e piacevoli le lettere che in prima erano ispide di pedantesimo. Più non si dica che il signor N.N. ne’ suoi saggi della Storia universale è pieno di falsità, senza indicare quali sieno queste falsità, anzi leggendola e rileggendola, ed essendo alla fine debitori ad essa di quel poco che sanno in questa materia, sicché nel medesimo tempo che la biasimano forz’è che se la tengano come un inesausto magazzino di filosofia e di erudizione, che non fu mai sì bene accoppiata colle grazie.
IX. La sapienza non consisterà più nella sola memoria, né più dirassi scire est reminisci, ma bensì scire est ratiocinari. Onde non dovrassi avere per uomo di buon senso colui che sappia molto d’istoria, di erudizione, e molti frontispizi di libri, e molti nomi di re barbari, qualora tali cognizioni non saranno che un inerte deposito nella sua mente, dalle quali nessuna conseguenza ne deduca e nessun ragionamento; poiché la ragione vuol esser signora della mente umana, e nessuna delle umane cose si deve sottrarre al dolce suo impero; onde costoro, che hanno ripieno il capo di una disordinata erudizione, non chiameransi che meri vocabolari della reppublica letteraria. Ma non credino essi per ciò di essere inutili ad ogni cosa, che anzi è giusto il dire che di tali creature ve ne vogliono, come quelle che alla occasione rischiarano la storia e le antichità anche nelle sue miniature, ed allora soltanto meriteranno il nome di soperchiatori, quando passando incautamente gli stretti confini del loro sapere alzeranno orgogliosamente la garrula voce decidendo indiavolatamente d’ogni cosa, ed opprimendo con una facile vittoria a forza di polmoni la modesta gioventù, e sempre parlando e non mai ascoltando crederansi, non so perché, di non potere se non ben ragionare, e che il restante degli uomini non merita di lasciargli terminare un periodo, per sensato ch’egli sia.
X. Taluni hanno fatto della ragione una cosa sì dutile, e maneggievole che credonsi di poterla stirare qual molle cera in ogni parte, per il che non amano la verità per se medesima, ma bensì con ordine inverso cominciano dal supposto, e poi vi addattano le ragioni. Del qual male sono in buona parte cagione quegli institutori della gioventù che insegnano a sostenere a spese della logica, che pur è una sola, qualunque tesi, e che gettano la sterile scienza de’ loro sogni nell’avida turba di più scolari, i quali inaffiati da questa pioggia di sapienza, anzi che diventare pacifici indagatori del vero divengono ostinati e loquaci sostenitori di quanto di buono o di cattivo scrissero ed ascoltarono; ed a ragione disse l’eccellente poeta del Mattino, che fanno nascere avversione agli studi di Pallade
… i queruli recinti
Ove l’arti migliori e le scienze
Cangiate in mostri e in vane orride larve
Fan le capaci volte eccheggiar sempre
Di giovanili strida.
Per il che dovrassi ivi accrescere il numero delle ferie sino a trecento sessanta cinque all’anno.
XI. Sarà proibito il dire che il tavolino ammazza l’uomo, il che non concedo se non nel senso che si dia il tavolino sopra la testa; poiché anzi gli esempi ci provano che gli amatori della vita sedentaria e studiosa vissero lungo tempo, e tali sono, per dirne alcuni che mi cadono sotto alla penna, Platone che visse anni 108, e ne’ moderni il padre Calmet, il signor Giovanni Bernoulli, il cavalier Newton, il signor di Fontenelle ed il signor Lodovico Antonio Muratori, ec., i quali tutti vissero lungamente, benché fossero stati molto al tavolino. Per la qual cosa releghiamo questa frase pedantesca fra di coloro che interrompono i loro studi con frequenti sbadigli, e che ne preparano a’ cortesi Lettori; essi la usino, che hanno ragione, poiché certo la noia indebolisce la complessione, come io lo provo in certi luoghi, più di raro però che posso.
XII. Dovranno in oltre tutti li seguaci della ragione guardarsi bene dall’insultare o deridere personalmente i pedanti, poiché egli è da uomo ragionevole il tolerare gli errori ed i difetti degli animali della nostra specie; onde non sarà permesso che di burlarsi del pedantismo, ma non mai personalmente de’ suoi professori, i quali tutt’al più possono essere compresi nel numero degli uomini che hanno una particolare pazzia, e non è fuor di luogo il credere che fra tante cose curiose che fanno gli uomini, in qualche paese vi sia stato o vi sia un Ospedale de’ Pedanti.
Tali sono le leggi preliminari ad un Codice compito che sta sotto il torchio, e che vedrà la pubblica luce allorquando sarà permesso di dire delle verità senza pericolo delle sassate, che il ciel vi salvi.
A. [Alessandro Verri]
La giusta e discreta doglianza fattaci da alcuno de’ più rispettabili nostri lettori intorno all’incomodo di vedere ne’ nostri fogli interrotto per lo più il senso, terminando il foglio dove la materia non è terminata, ci ha mossi a proccurare in avvenire di fare che ogni foglio, come distintamente si distribuisce, così anche possa far casa da sé. A questo fine occuperemo gli spazi che non bastano a contenere tutto un discorso con alcune riflessioni sopra vari soggetti che si dicono nel nostro caffè, senza cercare d’interporvi quella unione che l’indole loro non comporta; essendo esse nate dal fortuito giro de’ diversi ragionamenti che vi udiamo, e scelte a salti, a misura che ci paion degne d’essere scritte. Eccone frattanto alcune.
Memoriale ad un rispettatissimo nostro maestro
Illustrissimo signore.
Alcuni degli autori del Caffè, umilissimi servitori di V.S. Illustrissima, avendo udito vociferare ch’ella trovi temerario il loro assunto di diventare autori in sì fresca età ed intempestiva la voglia di ragionare (delitto enorme che non si perdona che dopo la morte), e che perciò sia mal contenta che s’ardisca scrivere così un poco ragionevolmente, senza avere acquistato tal diritto con mezzo secolo di laborioso tirocinio; queste, ed altre tali serissime riflessioni avendo essi udite con infinito dispiacere, punti quindi nel più vivo del cuore d’avere incontrata l’alta di lei disapprovazione, chiedono benigno compatimento e promettono a V.S. Illustrissima che mai più non offenderanno d’ora in avanti l’illustrissimo amor proprio della medesima col pretendere che senza la di lei protezione si possa ragionare anche tolerabilmente, e col dare a divedere che basta avere una testa, la quale possa ricevere delle idee, e che tenga due occhi uno di qua e l’altro di là dal suo bravo naso, i quali occhi abbiano la facoltà di vedere gli oggetti almeno alla lontananza di un palmo, leggendo con questi occhi su tanti buoni libri ch’ora vi sono in ogni bottega di libraio, si possa, senza incomodare V.S. Illustrissima, sapere così qualche cosetta. Ma sono molto bene puniti della loro temerità i poveri autori da V.S. Illustrissima, la quale non annuncia il foglio del Caffè senza abissarlo con un censorio sorriso in quella oscurità di cui lo giudica clementissimamente degno.
In tale stato di cose osano pur supplicare V.S. perché si degni di abdicare in grazia de’ supplicanti una minima porzione di quel diritto, che a V.S. compete, per immemorabil possesso, sulle libere menti degli uomini, su’ loro studi, sulle oneste loro occupazioni, ed a rilasciare un tantino dell’alto di lei dominio nel regno della ragione; conciossiaché accordano benissimo i supplicanti che V.S. Illustrissima ha già da molto tempo il monopolio della facoltà ragionatrice, in cui tanto si distingue, ma, se di tanto possono lusingarsi, ella sarà una grazia singolare degna del bel cuore di V.S. Illustrissima il concedere loro almeno a titolo di precario un pocolino di ius a ragionare. È vero, verissimo che taluni de’ sopradetti autori hanno non molta barba sul mento giovanile, hanno i respettivi loro denti in bocca, sono vegeti, sani, robusti grazie al Cielo; è vero che non hanno inondata la repubblica letteraria con una dozzina di volumi in folio; egli è vero altresì che l’età di tutti quanti insieme non eccede di molto un secolo; ma siccome che la ragione sembra che non debba misurarsi dagli anni, poiché loro è stato detto che vi furono a questo mondo de’ grandi uomini di vent’anni e de’ gravissimi buffoni di sessanta, così i supplicanti pregano V.S. Illustrissima a giudicare delle produzioni indipendentemente della loro gioventù. E certo V.S. intenderà benissimo che il sapere dipende e dal primo getto della testa, e dal metodo con cui nella testa s’introducono e si collocano le idee; onde se mai alcune teste, che non fossero le più male organizzate che natura abbia poste fra due spalle, avessero con ordine, scelta ed intensione studiate e meditate le cose di quaggiù, vi sarebbe fra i casi possibili quello che queste tali teste potessero essere ragionevoli benché non per anche calve. In ogni caso sperano i supplicanti di placare co’ loro letterari sudori il ben giusto sdegno di V.S. Illustrissima; e finalmente per ora di null’altro la supplicano se non se di voler accordar loro la superiore protezione che implorano e per giustificazione di loro medesimi, se in avvenire ragioneranno, e per la indennità del buon senso di tanti, i quali hanno sin ora osato leggere con qualche piacere gli scritti loro; che della grazia ec.
[Alessandro Verri]
[La vendetta]
L’uomo è generalmente più sensibile alle ingiurie che non ai beneficii; e la vendetta offre all’animo della maggior parte più stimoli di quel che ne offra la gratitudine: parmi che ciò provenga perché una offesa rare volte è equivoca, e al di contro sovente anche un beneficio non nasce da una sincera benevolenza; quindi è che, generalmente parlando, hai più da temere da un uomo che offendesti di quel che tu abbia a sperare da un uomo da te beneficato.
[Pietro Verri]
[La disattenzione]
Vi sono delle anime tanto sterili, o vogliam dire tanto pigre, che nulla posson fare da loro medesime; sono elleno nella fisica necessità d’aver un libro fralle mani tosto che son sole, e di scorrerlo rapidamente per distraersi dalla noia che sta sempre loro al fianco: tosto che sia chiuso il libro, accade loro quel fenomeno appunto che scorgesi all’aprire di giorno la finestra della stanza in cui fassi vedere la lanterna magica. La tela è bianca quale appunto era da prima, e di tutte le figure e colori diversi che l’hanno successivamente occupata, non ve ne rimane più traccia veruna.
[Pietro Verri]
IL CAFFÈ )( Fogl. XIII )(
Alcuni pensieri politici
Alla conservazione ed accrescimento della pubblica felicità sono naturalmente indirizzate le sollecitudini d’ogni corpo politico costituito dalla società degli uomini. A questo fine ha egli cinte di mura le città, ha fabbricate fortezze, armate numerose schiere di cittadini e coperto d’infinite navi il mare. Da questo principio ha tratta l’origine il tanto decantato equilibrio del potere fra le nazioni europee, per cui s’intrapresero aleanze ed unioni fra più potenze per la comune difesa, e furono fatti vigorosi sforzi per indebolire le troppo grandi, dalle quali poteano esse per avventura restare oppresse. Vi fu un tempo in cui si credette troppo grande quella nazione che superava le altre nella gloria militare. Gli antichi Greci, da una parte frugali nel vitto e bisognosi di poco, e dall’altra pieni d’entusiasmo per l’onore e per il valore guerriero, credeano di tutto perdere se non sosteneano la superiorità in quest’eroiche virtù; perciò bastava loro d’aver vinto per avvilire la nazione rivale. Di fatti gli storici riguardano le guerre che vicendevolmente si sono fatte le repubbliche greche come guerre d’emulazione piuttosto che di politica. Ciascheduno Stato parve d’aver avuto meno per oggetto una conquista che l’onore d’essere alla testa dell’altro. Introdottosi poi a poco a poco il lusso e nuovi bisogni fra gli uomini, senza che l’equivalente industria gli accompagnasse, si trovò che il possesso di poca terra non bastava a mantenere ciascun individuo, e ch’era ristretta una piccola provincia per nodrire una grande quantità d’abitanti. Un sovrano che fosse stato desideroso d’avere un maggior numero di sudditi era costretto di conquistare una maggior estensione di paese. Quest’estensione, formando proporzionatamente la potenza d’un regno, sembrò all’ambizione dei dominanti necessaria e conveniente, e si procurò da essi coll’arme alla mano.
Intorno al secolo XIII i Fiorentini, i Pisani, gli Amalfitani, i Veneziani ed i Genovesi cominciarono ad adottare una politica diversa per ingrandirsi. Si avvidero che le scienze, la coltura delle terre, l’applicazione alle arti ed all’industria e l’introduzione d’un esteso commercio poteano formare una copiosa popolazione, provedere ad infiniti bisogni, sostenere un gran lusso ed acquistare ricchezze immense, senza una vasta ampliazione di domini, e vi riuscirono con sì felice successo che fecero per la seconda volta rivolgere verso l’Italia lo sguardo di tutto il mondo. L’esempio loro fu ben tosto imitato dai Fiaminghi, dagli Olandesi, dagli Inglesi, dalle città anseatiche e da’ Francesi; ed ora tutta l’Europa addottrinata conviene che da tali principii si dee cavare la potenza dei re e la felicità dei popoli, e sembra inconveniente il ricercare fuori dalle accennate sorgenti la grandezza propria e l’equilibrio dell’altrui. Questa grandezza e quest’equilibrio invano si proccurano nel rapporto della massa delle armate. L’esperienza ha provato mille volte che del pari vi possano essere delle grandi ineguaglianze fra due armate d’un numero eguale di soldati, come si può trovare una certa eguaglianza di altre due armate composte d’un numero ineguale d’uomini. L’abilità del comandante, l’ubbidienza degli ufficiali, la confidenza delle truppe, la libertà d’operare contribuiscono infinitamente alla superiorità d’un partito. L’interesse privato ha sovente indebolite le armi ed oscurata la gloria dei sovrani. Il maresciallo di Biron rispose a suo figliuolo, che gli suggeriva il mezzo di terminare ben presto la guerra: Come? Vuoi tu che in tempo di pace andiamo a Birone a piantar cavoli?
La guerra altro non fa che spargere a rivi il sangue umano, senza ottenere l’intento che si desidera. Le battaglie non sono oramai più decisive. Il comandante prima d’assalire il nemico pensa come possa ritirare le sue truppe, se la sorte dell’armi non lo seconda. Infinite sono le circostanze che nella guerra avvanzano o ritardano i progressi delle imprese militari. La Francia, nella guerra terminata colla pace di Ryswick, resistette non solamente ad una gran parte dell’Europa riunita contro di essa, ma fece ancora delle conquiste in Fiandra, in Germania, in Italia e nella Spagna. Poco tempo dopo ella ebbe a sostenere una seconda guerra contro le stesse nazioni. Erale aleata la Spagna, che avea già avuto contro di lei, e non ostante una differenza così forte, ella fu ridotta alle più disgustose estremità. Nel medesimo tempo la Svezia, attaccata da un nembo di nemici, avrebbe data a questi la legge, se il suo re avesse saputo fare la pace in Sassonia nel momento glorioso in cui l’Europa si tacque avanti questo moderno Alessandro. L’augustissima erede di Carlo VI nel 1741, senz’alleati, senza finanze e senz’altro appoggio che il di lei grand’animo, respinse coraggiosamente una lega formidabile che da ogni parte l’investiva. La guerra ultima ci ha offerti dei risultati ch’era impossibile alla politica di prevedere. Se da due corpi ineguali si tolgono due quantità uguali, essi resteranno ancora ineguali. Ora questo è quello che presentemente arriva in tutte le guerre d’Europa. I due partiti si vuotano d’uomini e di denaro, poi si ritrovano nel fare la pace ai medesimi termini d’onde partirono. Ho inteso a dire che la suddetta pace di Ryswick, fatta nel 1697, era stata offerta nel 1682, che in Francoforte si potea pure sottoscrivere la pace nel 1743 alle stesse condizioni che le potenze belligeranti furono ben contente d’accettare in Aquisgrana nel 1748.
Ancorché si venga coll’armi a fare una conquista, la conservazione di essa e le spese della guerra arrivano per lo più a superarne il valor capitale, onde l’erario, lungi d’aver approfittato, si trova infine d’aver fatto una considerevole perdita, a cui per ordinario va congiunta la rovina degli antichi Stati patrimoniali, ed alcune volte il pericolo ancora della real persona. Alessandro e Cesare hanno distrutti più di due milioni d’uomini. Si sono impadroniti di grandi ricchezze; ma nel sommo della grandezza loro sono periti di morte violenta, ed ambidue non hanno lasciato alle proprie ed alle conquistate nazioni che pene ed orrori. Il re di Francia Luigi XIV, dopo d’aver fatte grandi conquiste, tenne un consiglio dove s’agitò se la di lui persona era sicura in Versaglies. La Svezia è ancora occupata a saldare le ferite fattele dal glorioso suo monarca Carlo XII nel volerla ampliare. La sperienza insegna che la felicità durevole dei Stati è sempre nata dalla pace e dalla moderazione.
Ognuno vede i disordini che seco loro strascinano le guerre; ma come sarà mai possibile l’evitarle? Ogni nazione sente la necessità di difendersi da’ suoi nemici; bisogna pur anche ch’ella ricerchi il modo di debellarli, affinché non prenda più ad essi talento di offenderla; e siccome per un naturale istinto ciascheduno si procaccia in primo luogo la sua che l’altrui felicità, così pare doversi ragionevolmente proccurare le conquiste, se da queste la medesima dipende. Come dunque si otterrà tutto questo senza spargimento di sangue?
Ed il difendersi da’ nemici, e l’opprimerli, ed il fare conquiste è possibile, anzi direi più facile, senza la distruzione del genere umano. Sono gli uomini tacitamente convenuti fra di loro di far consistere le ricchezze nel possesso di molt’oro e di molto argento, perciò i nemici più crudeli d’una nazione sono coloro, che privandola di questi metalli, tentano d’introdurvi la povertà. La povertà è una sola parola, ma non è un sol male. Fu con ragione chiamata dal poeta turpis egestas, e collocata su le soglie dell’Inferno, perché ella sola porta un’infinità di miserie a quei regni de’ quali s’impadronisce. Spopola le città dei buoni cittadini, non vi lascia che i soli mendicanti e malviventi; diminuisce la potenza del principe; oscura lo splendore della corona; avvilisce in modo singolare gli animi, e quello ch’è peggio li sottopone al più sensibile de’ mali, qual è la derisione ed il disprezzo. Nihil habet paupertas durius in se, quam quod ridiculos homines facit. Quest’è l’ombra più nera che le vada addietro, quest’è la pesante catena che si strascini al piede. Se v’è un popolo neghittoso che non sappia provvedere ai propri bisogni, le industriose nazioni accorrono puntualmente, e con una simulata pietà gli presentano tutto ciò che gli è opportuno: gli danno il vitto, il vestito, lo esimono d’ogni fatica, e se lo vedono inclinato al lusso gli pongono in vista mille inezie per fomentarlo ed appagarlo. A questi grandiosi danni si dee sollecitamente por rimedio, e da questi perniciosissimi nemici vigorosamente difenderci colle arme più opportune, che sono le scienze, le arti, l’industria ed il commercio.
La prima diligenza dev’essere rivolta all’agricoltura, la quale è una scienza chiamata da’ più saggi politici il sostegno delle arti, la base del commercio e delle ricchezze. Ella ha tre articoli: il moltiplicare i frutti della terra, il perfezionarli e l’introdurne dei nuovi; e con questi va congiunta la moltiplicazione delle bestie domestiche e la migliorazione della loro specie. La storia naturale, mettendo in palese le produzioni della terra, dell’acque e dell’aria, che fin ora sono restate nascoste, deve unirle alle già cognite, e presentarle alle arti ed all’industria per essere lavorate e perfezionate all’uso universale degli uomini. Saviamente riflette il signor di Cantillon, supposto autore del Saggio sopra la natura del commercio in generale, che la terra dà la materia prima alle ricchezze, ma che il travaglio degli uomini le somministra la forma per cui vengono queste aumentate. Ecco la maniera efficacissima per impedire l’esportazione de’ nobili metalli; ed ecco le armi colle quali una nazione si difende da’ suoi nemici, che la procurano con ogni impegno.
Quindi oso io asserire che non è impossibile di rimediare alla povertà d’uno Stato e di allontanare i nemici che la cagionano.
Polibio dice che tutto si dee porre in opera per opporsi a quella potenza che è troppo grande. Se mai una nazione ha tratta a sé la maggior parte dell’universale commercio, ancorché noi ci fossimo particolarmente sottratti dalla sua tirannide, è nostro interesse, ed anche di tutte le altre nazioni meno commercianti, l’applicarci unitamente ad aumentare fra di noi le reciproche negoziazioni, ed a diminuire il nostro comune rapporto colla prima, affinché un giorno non venga ella ad imporci le catene. Si devono impedire non solo le di lei importazioni nello Stato nostro, ma essendo queste a noi necessarie, si hanno da favorire le importazioni delle altre. In conseguenza di questi principii dovrebbe la Francia preferire il bue d’Ostein e della Prussia a quello d’Irlanda, e qualunque altro tabacco ad esclusione di quello della Virginia. La Spagna potrebbe promuovere il commercio austriaco ne’ suoi Stati a preferenza di quello d’Inghilterra, d’Olanda e d’altri regni molto commercianti. Un popolo debole e di poca ricchezza, generalmente parlando, fa male di somministrare al più forte ed al più ricco le sue materie prime. Queste nazioni piene d’industria le manifatturano, raddoppiano più volte il loro valore, e sostenendo con quest’arte finissima una gran parte della loro popolazione, e facendo guadagni immensi, mantengono costantemente la superiorità.
Se una nazione rifiuta d’ammettere ne’ suoi porti le navi straniere cariche di merci d’un altro paese, tutti gli altri regni non devono mancare di fare lo stesso rispettivamente a quella. Se gli abitanti d’una tale nazione pescano molto, bisogna sempre preferire la compra del pesce degli forastieri che pescano meno. La pesca delle aringhe e del merluzzo contribuisce assai alla superiorità degli Inglesi ed Olandesi sulla Spagna, Portogallo ed Italia; e forse i nostri riti medesimi vi contribuiscono.
Se la supposta nazione invita gli stranieri industriosi e sapienti col presentargli il modo da vivere con qualche comodo, gli altri paesi devono anch’essi adottare questa buona massima, sforzandosi in primo luogo di conservare i nazionali, non già per mezzo di proibizioni sempre mai impotenti in simili casi, ma bensì col rendere loro amabile la patria.
Debellato che sia il più formidabile dei nemici, si può tentare di far delle conquiste. Il più sicuro metodo si è di ridurre le manifatture, portate già alla possibile perfezione, a quel tenue prezzo al quale non possono venderle gli altri, indi ricercare diligentemente la strada di farle penetrare ne’ paesi forastieri per mezzo del commercio e degli opportuni trattati coi principi. Noi Italiani guadagnamo ogni anno una riguardevole somma colla vendita delle nostre sete; ma se di queste sete ne formassimo delle stoffe e dei drappi colla maggior economia di spese, e c’ingegnassimo d’introdurle in Germania, nel Nord ed in America per la scala di Cadice, non è egli vero che triplicaressimo almeno la suddetta somma? I lini venduti informi fanno passare a noi ogni anno anch’essi del denaro; se riducessimo quelli in tele ed in merletti, che maggior somma di denaro non ci acquisterebbero? Ecco in che modo si possono fare importanti conquiste.
La saggia politica insegna che un monarca, il quale accresce la popolazione de’ suoi Stati, che possede un erario abbondante d’oro e d’argento, che fabbrica città e fortezze, che dà sussidi, e che mantiene un numeroso esercito frutto della guerra d’industria, si trova in una situazione da farsi temere, rispettare, amare da’ suoi vicini, e di spaventare ogni genere di nemici. Vide, è vero, Cartagine i Romani alle sue porte, ma non cessò d’essere temuta, ed in questo stesso estremo pericolo si ammirarono dagli agressori le rissorse di questa ricca città. Catone ne fu sorpreso. Pochi anni dopo la battaglia di Zama, dove ella avea tanto perduto, vi osservò una florida gioventù, una quantità d’oro e d’argento, un ammasso prodigioso d’armi, un ricco apparato di guerra, un’ambizione, una confidenza a tutto intraprendere. Ritornato a Roma vi sparse lo spavento, ed in Senato arringò che si distruggesse Cartagine. Cartagine fu distrutta, ma da una potenza cui il mondo intiero non poté resistere.
In ogni caso poi, in cui le antiche guerre siano assolutamente inevitabili, e chi non sa che per essere queste al sommo dispendiose, in qualunque maniera ed in qualunque luogo esse si facciano, bisogna marciare coll’oro alla mano, metallo che altronde non può aversi presentemente che dalla guerra d’industria? Il mantenimento d’una quantità sproporzionata di truppe mercenarie, l’attiraglio immenso delle munizioni, la perfezione della marina, il furore degli assedi, la moltiplicazione delle piazze forti, il lusso degli ufficiali, tutti questi oggetti obbligano ad una spesa enorme. Infine la guerra d’industria in ogni tempo ed in ogni occasione felicita i popoli, rende potenti i dominanti, impedisce le guerre sanguinose, oppure compera la vittoria.
F. [Sebastiano Franci]
La fortuna dei libri
Son pochi dì che un filosofo venne a visitarmi per cercare il mio parere su un libro destinato da esso per pubblicarsi colla stampa. Qual è il fine, gli dissi, amico, per cui volete andare al pubblico, ed aggiungere il vostro nome alla lunga lista degli autori? Dalla vostra risposta sceglierò la misura con cui stimare il merito dell’opera vostra. Io voglio, mi rispose il filosofo, farmi un nome presso agli uomini miei contemporanei, col mezzo del quale procurarmi la loro considerazione, che contribuisca al mio ben essere. La impresa è difficile, risposi io, e voi saprete meglio di me quanta parte abbia il capriccio della fortuna nell’accreditare un autore, o nel lasciarlo nell’angolo polveroso d’una stamperia esposto alle tignuole ed alle maledizioni dello stampatore; pure leggete, poiché volete il parer mio ve lo darò schiettamente. Allora il filosofo cominciò così:
La politica sacrifica molte miliaia di vittime umane per disotterrare sino negli antipodi nuove rappresentazioni di valore, né altro effetto produce che quello di renderne l’uso più incomodo. Si cercano a dilatare i confini, né si riflette che la circonferenza è alla massa come il quadrato alla radice. Non v’è armata che non si abbandoni alla fuga prima che la decima parte sia estinta; l’abito men fatto alla guerra è quello del soldato. Gli editti di alcuni sovrani di Costantinopoli su alcuni casi particolari, il parere di alcuni privati Romani o di altri oscuri curiali, purché sieno morti, regolano la vita e le fortune.
L’amor del ben essere, più forte di quello della stessa esistenza, dovrebbe servire nel morale come nella meccanica la gravità. Guai alla umanità se si eseguissero alcune teoriche dal volgo rispettate! I geni e il volgo s’assomigliano più che i mediocri fra di loro, e l’uomo… Basta così, amico, gli dissi, il vostro libro non vale un zero. Quest’opera o non sarà intesa o lo sarà malamente, e consegnandola al pubblico non avrete il vostro intento: almeno vent’anni opere sì fatte devono languire sconosciute, e devono passare per la trafila dell’indolenza e del ridicolo per lo meno. Avete voi vocazione di passarvi? No davvero, rispose il filosofo. Ebbene, datemi adunque, mi disse, il parer vostro su un’altr’opera che ho in mente, poiché autore voglio essere, e autore applaudito.
Primieramente, continuò il filosofo, il titolo del libro sarà La cucina politica. Proverò al principio che gli avvenimenti politici dipendono dagli uomini che gli trattano, cosa che nessuno potrà negarmi. Passerò in seguito a dimostrare che gli uomini in gran parte dipendono dal loro attual umore, ossia dallo stato attuale del loro animo or vigoroso e intraprendente, ora debole e timido; e confermerò con molti fatti storici la variabilità di quest’umore, per cui molti eroi in alcuni punti della lor vita sono stati uomini, e uomini meno che mediocri. L’umore farò poscia vedere come dipenda dallo stato della nostra digestione, e la nostra digestione dalla natura de’ cibi che ci alimentano; e qui avrò campo di parlar molto di anatomia e di fisica, coll’aiuto delle quali proverò il mio assunto.
Da questi principii ne nasce dunque che la massima influenza negli affari parte dalla cucina, e che da essa si spediscono come da prima origine le più importanti decisioni. Questo sarà il soggetto della prima parte.
Nella seconda parlerò dei metodi di riformare la cucina e rettificarla secondo le sane viste della politica; e primieramente di destinare il cuoco ad ogni persona che interessi il ben essere degli uomini a quest’oggetto importante, colle istruzioni secrete ora di abbondare, ora di scemare le droghe a misura che d’attività o di ponderazione fa d’uopo; passerò poi ad un’analisi chimica delle particolarità di esse droghe, delle erbe, delle diverse carni, e tutti in somma i materiali di cucina, e della influenza loro particolare a ciascuna sul nostro stomaco, e tutto ciò fondato sulle più esatte sperienze. Finalmente concluderò la mia opera con una compiuta serie di vivande, atte ciascuna a svegliare passioni differenti; con che sarà perfetto il mio trattato. E bene, che ve ne pare?, soggiunse il filosofo
Ottimo, risposi io; il vostro libro è d’una idea tutto nuova, a portata d’ognuno, e dovrebbe piacere. Gli uomini amano più chi li diverte che chi gl’instruisce, poiché sentono il male della noia continuamente, e rare volte il male dell’errore. Il filosofo ha approvato il mio parere. Ebbene, disse, conviene esser frivolo per principio, siamolo di buona grazia. La verità più grande di tutte è che convien cercare onestamente la propria felicità.
Così finì la conversazione, onde fra pochi giorni comincierà la bell’opera, e fra un anno al più ve la prometto pubblicata.
P. [Pietro Verri]
La bugia
La falsità è un vizio che punisce chi lo possiede: chi passa per bugiardo ha perduta la fede, e con essa tutti i vantaggi che ne risultano dalla fidanza che hanno gli altri in noi; questo vizio allontana gli uomini fra loro, li fa diffidenti, onde s’oppone a quella bontà di cuore che è l’anima della società. L’uomo vero si rende interiormente conto delle sue azioni, ed ha in ogni tempo la soddisfazione di ritrovarsi irreprensibile agli occhi d’ognuno, e da qui nasce quella forza d’animo, e quella modesta franchezza che è dipinta sul volto di coloro che hanno il cuore sulle labbra.
V’è un’altra sorta di falsità, ed è quella per la quale taluno non lascia traspirare i sentimenti suoi, e sta sempre in guardia che alcuno non possa conoscere quale egli è. Questa qualità talvolta è un’estrema moderazione; ma bene spesso quegli che fanno tanto mistero de’ loro pensieri non meritano d’essere conosciuti. La falsità è l’appanaggio delle nazioni deboli, e tali erano i Greci, e tali erano gl’Italiani quando queste nazioni ebbero perduta l’antica loro forza. La piccola cabala, l’astuzia, e con essa gli enormi delitti del veneficio, de’ tradimenti, non si veggono nelle grandi nazioni, dove regna per lo più uno spirito di libera bontà. Piccoli e brevi vediamo esser i vantaggi della falsità; e grandi e stabili quelli che produce all’uomo la grandezza e simplicità di cuore. La buona fede è indispensabile in tutte le nostre azioni, perché ogni volta che vi manchiamo, ci facciamo molti inimici, che ci possono far pentire d’essere stati falsi. Il commercio, i depositi, gl’imprestiti e tutti i contratti in somma prendono anima e sicurezza dalla buona fede. Le leggi umane hanno veduta la necessità di punire gli uomini falsi, e dove v’è una legge penale non è utile al certo l’esser falso. Ma se parliamo ancora di quella falsità che dalle leggi non è punita, com’è l’esser bugiardo, vedremo che il disprezzo e la fuga de’ concittadini sono venute in sussidio alla mancanza delle leggi positive; quindi vediamo esser il bugiardo screditato su i teatri colle pubbliche beffe, ed applaudire estremamente gli spettatori all’avvilimento ed alla confusione del mendace.
A. [Alessandro Verri]
L’ingratitudine
L’uomo ingrato non può essere beneficato più volte, perché la gratitudine è ricompensa de’ beneficii, e senza sperare questa ricompensa è difficile che ci potiamo risolvere ad esser benefici. Intende adunque male i suoi veri interessi chi corrisponde a’ beneficii coll’ingratitudine. Tolta questa mutua comunicazione di beneficii e di gratitudine, è tolto ogni adito ad una vera amicizia, e così è annichilato il vero spirito di società, che consiste nell’amicizia; quindi l’ingrato è un uomo diviso dagli altri, e che non può provare l’utilità de’ beneficii e la dolcezza degli amici; egli ha sagrificato per un presente guadagno il diritto di godere più volte gli altrui benefizi in avvenire.
A. [Alessandro Verri]
[Il secreto]
Colui che rivela un secreto confidatogli, perde la propria reputazione; colui che rivela un secreto proprio, per lo più s’espone a gran rischio. L’uomo saggio non manifesta un secreto che allor quando v’è un’onesta utilità nel farlo: scieglie allora per depositario un uomo d’una conosciuta probità, e gli apre il suo cuore in tal guisa che si distingue ch’egli lo fa per ragione e discernimento, non mai per debolezza o impazienza di contenere un secreto. Non affidare mai la metà d’un secreto, la metà è sempre o troppo o troppo poco. Quando il prurito di parlare ti prende, cercati una distrazione al momento; il periodo di questo prurito è corto, e sarai liberato dal pericolo.
[Pietro Verri]
[I filosofi]
I cani di villa al menomo romore abbaiano, i cani di città lasciano rottolare e carri e carrozze senza abbaiare: mi pare che questa sia la differenza appunto che distingue i veri dai falsi filosofi.
[Pietro Verri]
IL CAFFÈ )( Fogl. XIV )(
Ci è stata diretta la seguente scrittura con questa breve lettera.
Amici miei.
Vi ringrazio perché abbiate posto ne’ vostri fogli i miei Elementi del commercio; e siccome quello che ho accennato ivi a pag. 22 sul lusso merita qualche considerazione, così ve ne ho fatte, e le abbandono a voi.
Filantropo
Considerazioni sul lusso
… quid enim ratione timemus
Aut cupimus?
Juvenal. Saty. X
Quando io dico lusso, non intendo già di dinotare qualunque cosa di cui gli uomini faccian uso, senza di cui per altro potrebbero vivere: il secolo in cui siamo e la molle educazione che ci fu data non ci lasciano le severe idee dell’antica frugalità degli Spartani; perciò per lusso intendo ogni cosa realmente inutile ai bisogni e comodi della vita, di cui gli uomini facciano uso per fasto, ovvero per semplice opinione.
Nemmeno qui prendo a scrivere del lusso per la relazione ch’egli ha con un uomo o con una famiglia, ma per la relazione ch’egli ha colla intera nazione. Il lusso è un vizio contro cui declamano a ragione i sacri oratori; il lusso rovina molti patrimoni: ma ogni vizio morale non è un vizio politico, come ogni vizio politico non è un vizio morale.
Suppongo primieramente una nazione, a cui la terra somministri appena il necessario fisico per nodrirsi e difendersi dalle stagioni: gli abitanti di essa non conosceranno il lusso, poiché nessuno vorrà mai spogliarsi del necessario fisico per acquistare un bene di opinione.
Suppongo in secondo luogo che nella nazione medesima, perfezionandosi l’agricoltura, ognuno degli abitanti venga a ricevere, oltre il necessario fisico, una porzione di superfluo: gli abitanti cercheranno di vendere alle nazioni vicine quel superfluo, e con esso procureransi nuovi comodi della vita; e sintanto che i fondi resteranno egualmente divisi fra i nazionali, siccome chiunque cercasse di distinguersi col fasto della profusione si vedrebbe disprezzato e schernito da’ suoi cittadini, e terminerebbe in breve colla totale rovina, così in quella nazione non si conoscerà il lusso.
Dovunque vedesi lusso vi è del superfluo, e vi è sproporzionata divisione di ricchezze. Or ora parleremo di questi due oggetti; ma stabiliamo in prima:
Se il lusso ha per oggetto le manifatture nazionali, è cosa evidente che il restringerlo altro effetto non potrà produrre che quello di togliere il pane agli artigiani che campano sulle manifatture, desolare cittadini industriosi e utili, obbligarli ad abbandonare la patria, dare in somma un colpo crudele e funesto a molti membri della nazione, che hanno diritto alla protezione delle leggi, e alla nazione stessa spogliandola d’un numero di nazionali, diminuendosi il quale scema la vera sua robustezza.
Né credasi di ritenere i maltrattati artigiani con rigorosi proclami; poiché la sperienza c’insegna che leggi tali altro effetto non producono che la creazione arbitraria di nuovi delitti; né la custodia de’ confini può essere sì esatta, né sì facile il punire una trasgressione che non si può commettere che fuori della giurisdizione del legislatore, a meno di non sovvertire tutto l’ordine delle cose pareggiando l’intenzione ai delitti, e coll’imolare poche sventurate vittime, accellerare la partenza di molti.
Poiché dunque il lusso che ha per oggetto le manifatture interne non può proibirsi senza discapito della nazione, ritorniamo a ragionare sul lusso che ha per oggetto le manifatture straniere, quello cioè che suppone un superfluo nella nazione ed una sproporzionata distribuzione delle ricchezze ne’ nazionali.
È male che il superfluo d’una nazione esca per pagare gli artigiani forestieri del lusso: sarebbe bene che altrettanti artigiani si stabilissero nella nazione: così crescerebbesi la popolazione e non uscirebbe il denaro; ma è un male ancora più grande il diminuire il superfluo della nazione.
Principio universale si è questo, che là dove la principal sorgente della ricchezza nazionale venga dai prodotti dell’agricoltura, ogni legge che limiti l’arbitrio di convertire il denaro in un dato genere di merci s’oppone alla prosperità dell’agricoltura medesima; poiché i terrieri pungono i coltivatori per avere il superfluo, perché il superfluo può cambiarsi in denaro, e perciò amano il denaro perché con ciò possono proccurarsi l’adempimento d’infiniti desideri.
Se la nazione impiega il suo superfluo nella compera delle manifatture di lusso d’un dato paese, tosto che sia a lei vietato di procurarsi quelle manifatture, il superfluo non serve più a quell’uso che lo rendeva più caro alla nazione: dunque la nazione cercherà con tanta minore sollecitudine il superfluo quanta era l’avidità con cui prima cercava la manifattura; e gli animi cadendo in una indolente indifferenza, l’inazione e l’inerzia per una facilissima discesa si stenderanno sulla faccia del terreno medesimo, e v’imprimeranno la naturale loro infecondità.
Non si dà azione senza moto, non si dà moto senza un principio impellente. La proposizione è vera egualmente e nelle cose fisiche e nelle politiche: qualunque passione che scuota l’animo de’ cittadini e gli allontani da quel mortal languore che è l’ultimo periodo che precede l’annientamento delle nazioni; qualunque passione, dico, è buona agli occhi d’un politico, né puossi togliere alla nazione senza danno, a meno di non sostituirvene un’altra. Ora la vanità de’ terrieri, spingendoli al lusso, è quella stessa che serve d’uno sprone e stimolo incessante a tener risvegliata l’industria de’ coltivatori, e far sì che non risparmiano né cura, né cautela, né fatica per ampliare il prodotto della nazionale agricoltura. Che se con una legge sontuaria si spenga la vanità de’ terrieri, né uscirà il superfluo, né vi sarà più nella nazione; onde, in vece di accrescere la ricchezza nazionale, si sarà scemata l’agricoltura, che è la vera sorgente della ricchezza nazionale medesima.
Abbiamo accennato dissopra come il lusso supponga le ricchezze sparse disegualmente fra i nazionali, e giova per poco ch’io riascenda ai principii delle cose per presentare le idee con metodo e con chiarezza. Il fine per cui gli uomini hanno stabilita nelle società la forma de’ differenti governi, il fine per cui concorrono attualmente a conservarla, è certamente la propria felicità; d’onde ne nasce che il fine di ogni legislazione non può allontanarsi dalla pubblica felicità senza una violenta corruzione de’ principii d’onde emana la forza legislatrice medesima; e la pubblica felicità significa la maggiore felicità possibile divisa sul maggior numero possibile. Se dunque le ricchezze e i poderi sono un bene, il primo fra tutti gli umani diritti vuole che le ricchezze e i poderi sieno divisi sul maggior numero possibile de’ nazionali. L’anno giubilaico presso gl’Israeliti e la legge agraria de’ Romani erano una immediata emanazione di questi luminosi principii.
Ella è pure cosa per sé chiara che dovunque le vaste possessioni sieno ragruppate in una sola mano, l’opulento padrone minore attività adopera per accrescere il prodotto di esse di quello che non lo facciano i molti, che dovendo coltivare un piccolo patrimonio hanno una incessante occupazione di non trascurarne i minimi prodotti: quindi il totale della raccolta è sempre più abbondante quanto sono più ripartite le possessioni; ed in conseguenza quanto più sono ripartite le possessioni tanto più s’accresce la vera e reale ricchezza d’uno Stato.
Da ciò ne segue che se il lusso nasce, come abbiam detto, dalla ineguale ripartizione de’ beni, e se l’ineguale ripartizione de’ beni è contraria alla prosperità d’una nazione, il lusso medesimo sarà un bene politico, in quanto che dissipando i pingui patrimoni torna a dividerli, a ripartirli e ad accostarsi alla meno sproporzionata divisione de’ beni. Il lusso è dunque un rimedio al male medesimo che lo ha fatto nascere, poiché l’ambizione de’ ricchi che profondono serve di esca ai vogliosi d’arricchirsi, e i denari ammassati, come una fecondatrice rugiada, ricadono su i poveri ma industriosi cittadini; e laddove la rapina o l’industria li sottrassero alla circolazione, il lusso e la spensieratezza loro li restituiscono. Coloro dunque che credono pernicioso il lusso ad uno Stato, perché rovina le famiglie potenti, errano in ciò, che trasportano sul rostro del legislatore le idee domestiche, le quali in quell’altezza dovrebbero scomparire in riverenza delle grandi mire politiche e universali del ben essere di tutti.
Ho detto che l’anno giubilaico e la legge agraria traevano la loro origine dalla natura medesima della umana società; ma non perciò ho detto che sieno elleno stabilimenti buoni e degni d’adottarsi nel caso in cui si trova l’Europa presentemente. Lo spirito della teocrazia de’ Giudei era di distaccarli dal commercio di tutti gli altri popoli: l’aspetto dell’Arca e la possente voce de’ profeti erano spinte fortissime, che da loro sole mettevano in azione quegli uomini. Lo spirito de’ Romani era repubblicano, religioso e guerriero, non già commerciante, onde l’amor della patria, la decisione degli aruspici e la gloria marziale scuotevano sì fattamente quegli uomini alle grandi azioni che d’altri motivi non avevano bisogno. Gli uomini presentemente in Europa trovansi divisi bensì in diverse provincie e sotto diversi governi; ma vivendo tutti sotto una mansueta religione di pace, con usi, costumi e opinioni poco dissimili, formano piuttosto diverse famiglie d’uno Stato che nazioni diverse: un incessante reciproco commercio le unisce; la stampa, i fogli pubblici, i ministri che vicendevolmente risiedono alle corti, i lumi finalmente che ogni giorno più vanno allontanando gli uomini dall’antica ferocia, rendono sempre più importante l’industria come il solo mobile che rimane perché gli animi degl’intorpiditi Europei non cadino in quel mortale letargo che insterilisce e spopola le provincie. Quindi perché l’industria si tenga in moto necessaria è la speranza d’arricchirsi, e in conseguenza è necessario che i patrimoni de’ ricchi spensierati siano un punto di vista agli occhi de’ poveri industriosi, in guisa che, colla speranza d’impossessarsene, lavorino, inventino, perfezionino le arti e i mestieri, e mantenghino nella nazione quel moto che nodrisce, ravviva e rinvigorisce i corpi politici. Quando tutti i beni sono commerciabili, tutti i beni restano esposti in premio della industria; e quanto più beni si sottraggono al commercio e fansi ristagnare separati dalla circolazione, tanto minori incentivi rimangono all’industria.
Qualora dunque ci sforziamo di eternizzare i beni accumulati in alcune famiglie, formiamo un progetto direttamente contrario alla ragione ed alla pubblica utilità, e tentiamo con impotente violenza di distornare il corso della natura delle cose medesime, la quale incontrando gli argini inavvedutamente opposti, freme, s’innalza e squarcia d’ogn’intorno, sintanto che superati gli ostacoli torna al placido e maestoso suo corso. Quindi, malgrado le leggi, rarissime sono le famiglie che possino vantare sei generazioni d’una sostenuta opulenza.
Chiunque s’attenga alle semplici lamentazioni d’alcuni storici romani, attribuisce la caduta di quella terribile nazione al lusso tanto detestato da que’ scrittori: ma noi sappiamo che il genio di quella nazione fu sempre d’ingrandirsi coll’armi, non già di fare l’industriosa guerra col commercio; sappiamo che ivi le arti e i mestieri non erano professioni di uomini ingenui, ma soltanto de’ servi;[31] sappiamo che il regolamento della economia politica romana era tanto lontano dalla vera legislazione che frequentissime erano in Roma le carestie; né v’è maraviglia, sapendo noi tutto questo, che trovinsi gli scrittori imbevuti di quegli errori che erano comuni alla loro nazione.
La potenza e la vera grandezza di Roma è cominciata appunto dopo che il lusso vi si vide introdotto, cioè colla distruzione dell’emula Cartagine, qualunque sieno state le mutazioni interne del governo di Roma. La intera Francia, l’Inghilterra, la Germania sino all’Elba si sottomisero a Roma mentre vi regnava il lusso; e l’intera costa dell’Affrica e le vaste provincie nell’Asia Minore e il valoroso Mitridate non furono vinti che dai Romani nati fra ’l lusso. Quattro secoli trascorsero prima che Roma immersa nel lusso perdesse o del suo credito, o della sua forza, o de’ suoi Stati; che se poi anche Roma piegò alle leggi universali ed ebbe il suo fine come il suo principio, non è mio instituto il riferirne le ragioni, che ha sì bene illustrate l’immortale signor Carlo Secondat. A me basta l’aver provato che il lusso non è stato cagione della rovina de’ Romani.
Che se anche il lusso fosse stato cagione del deperimento della Repubblica, e dello stabilimento del principato, ciò proverebbe l’incompatibilità del lusso col sistema repubblicano, non già coi sistemi degli Stati soggetti a un solo. Il principio delle repubbliche è l’uguaglianza, togliendosi la quale e condensandosi le ricchezze in mano di pochi si apre la strada alla tirannia; quindi il lusso è odioso alle repubbliche, poiché egli è un indizio che le ricchezze sono troppo disugualmente ripartite, e in conseguenza sovvertito il principio stesso del governo. E come la speranza di distinguersi col lusso è un fortissimo incentivo per ammassare le ricchezze, così i saggi legislatori delle repubbliche hanno costantemente proibito il lusso, e preferiscono e proteggono talvolta il giuoco anche più rovinoso, malgrado i disordini che strascina seco, per avere un mezzo discioglitore de’ pingui patrimoni al pari del lusso, il quale però seco non istrascini la pericolosa distinzione nell’esterna comparsa.
Ma il principio degli Stati governati da un solo è la disuguaglianza, poiché si pone la massima disuguaglianza possibile fra un uomo e un altro chiamandone uno sovrano e l’altro suddito; e come questa diversità da uomo a uomo non è fondata su una diversità fisica, ma soltanto sulla base dell’opinione, quindi la splendidezza e la magnificenza hanno lor sede nelle corti o de’ monarchi o de’ loro rappresentanti; e gli uomini, naturalmente spinti a invidiare e pareggiare quei che credono più felici di essi, cercano d’imitarli con altrettanta splendidezza e magnificenza, a misura de’ mezzi che sono in loro potere: così dal sovrano all’ultimo della plebe stendesi quella catena che comincia dall’eccesso del superfluo e per molti gradi termina ai puri fisici bisogni.
Da questi principii, chiari per sé, ma che però non si presentano alle menti degli uomini senza la contenziosa meditazione sulla natura de’ governi, ha tratta il signore di Montesquieu la teorica che si legge nel libro ventesimo, al capo quarto: Le commerce a du rapport avec la constitution. Dans le gouvernement d’un seul il est fondé sur le luxe, et son objet unique est de procurer à la nation qui le fait tout ce qui peut servir à son orgueil, à ses delices et à ses fantaisies. Dans le gouvernement de plusieurs, il est ordinairement fondé sur l’économie.
Quanti accreditati scrittori hanno illustrata in questo secolo e presso le più colte nazioni l’economia politica sono in una universale conformità di parere intorno la felice influenza che ha il lusso ne’ paesi soggetti a un monarca. Le opere di David Hume, del barone di Bielfeld, del signore di Fortbonnais, del signore di Melon, tutte parlano un uniforme linguaggio in favore del lusso. Veggasi la bell’opera che ha per titolo Recherches et considerations sur les finances de France, tom. I, pag. 101; ivi si vede che un secolo fa in Francia v’erano tuttora que’ pregiudizi d’opinione, che facevano credere un male il lusso; così ivi: On étoit persuadé que le royaume s’épuisot par les denrées du luxe qui lui fornissoient ses voisins. On crut y remedier par des loix somptuaires qui acheverent d’écraser nos manufactures. E di quei tempi appunto parlando, il signor Mirabeau nella Teoria del tributo così si spiega a pag. 191: On a quelquefois voulu taxer le luxe sous le pretexte du rétablissement du bon ordre et de la modestie. Les loix somptuaires ne valent rien. Il rispettabile autore dell’Essai politique sur le commerce, al capo IX, pag. 105 , così parla: Le luxe, l’objet de tant de vagues déclamations, qui partent moins d’une saine connoissance ou d’une sévérité de moeurs, que d’un esprit chagrin et envieux… In somma dovrei trascrivere intere pagine se volessi qui riferire le innumerabili autorità de’ scrittori economici più rispettabili, tutte conformi in favore del lusso. La ragione ci prova l’utilità e la necessità del lusso; l’autorità si unisce alla ragione, e la sperienza c’insegna che le virtù sociabili, l’umanità, la dolcezza, la perfezione delle arti, lo splendore delle nazioni, la coltura degl’ingegni sono sempre andate crescendo col lusso; quindi i secoli veramente colti sono stati i secoli del maggior lusso, e per lo contrario i secoli più frugali e parchi sono stati quei ferrei secoli ne’ quali le passioni feroci degli uomini fecero lordar la terra di sangue umano, e sparsero la diffidenza, l’assassinio e il veleno nelle società divenute covili d’infelici selvaggi.
P. [Pietro Verri]
Conversazione tenutasi nel caffè
Filone è un uomo che ride poco, ascolta molto, né parla prima di avere pensato; e per questo l’altro giorno nel caffè, avendo udite molte corbellerie del signor Cristoforo a ventre gallonato, né rise, né parlò prima di avere pensato. Questo eterno chiacchierone parlò delle corti, della politica, della tattica, della marina, della matematica, della fisica, dell’astronomia, della storia; oh Cielo! di che non parlò egli? Qual parte delle scienze o delle cose non fu saccheggiata da questo implacabile declamatore? Dove mai non giunse il suo disragionare? E tutto ciò, lettori cortesi, tutto ciò, vedete, ritto su’ suoi piedi come un obelisco, gesticolando e serpeggiando con due gran braccioni in ogni verso, facendo ne’ punti più brocardici passeggiare la parrucca sul capo; e quello che mi pesava più si era un gran dito indice che mi si accostava dritto dritto ora ad un occhio, ora ad un altro, oltre le frequenti percosse del ritondetto suo ventre che mi veniva ad urtare di fronte; chi potrebbe in somma dire quanto egli in questa eterna sua declamazione si compiacque di se stesso ed annoiò eruditamente tutta la compagnia! Filone, che se ne stava in un canto della bottega tranquillamente bevendo il caffè, avrebbe al certo potuto ragionare meglio di lui, perché, come v’ho detto, pensa prima e poi parla; avrebbe potuto far vedere al signor Cristoforo ch’era un animale benché implume; avrebbe potuto far la revista a tante cose ch’egli andava vomitando una dopo l’altra come un torrente di paralogismi e di confusione. Ma come poteva il povero Filone star a fronte colla debil arma della ragione con colui, ch’era fornito di due potentissimi polmoni vincitori d’ogni buon senso? Cominciava Cristoforo: Ah, che mi dite voi del signor di V…, levategli un poco di poesia e di grazia nello scrivere, che ci rimane mai? E poi quella sua storia è piena di fatti falsi… Interrompeva rispettosamente Filone: Ma signore, ne sapreste voi marcare alcuno di questi fatti falsi? Eh, gli diceva Cristoforo, che? Volete ch’io vi faccia qui una dissertazione? Non la sarebbe mai più finita, e poi la storia, vedete, non si può mica scrivere così leggiermente; bisognava trattare più a lungo e con più esatto dettaglio de’ costumi, delle arti e delle scienze; eh, vi vuol altro che sapere così un poco di storia e riunirla a pezzi separati; eh, che non v’è stato ancora alcuno che abbia scritta la storia come va; poiché è difficilissimo, vedete, figliuol caro, di cogliere lo spirito de’ tempi; perché, vedete, per me sono sempre stato di quel parere che lo studio della storia è un mare magnum, e disse pur bene Cicerone ch’ella è magistra vitae, ma di queste storie, che siano maestre della vita, non ne abbiamo ancor vedute, se ne eccettuate Livio; oh, Livio veramente è un grand’uomo; nessuno, nessuno, vedete, è arrivato a scrivere così filosoficamente la storia; perché mi fanno ridere, vedete, questi moderni, che prendono le cose così dalla superficie; fondo vi vuol essere, fondo… Di grazia, dicea Filone, anzi mi pare che questi ultimi secoli abbiano prodotti eccellenti storici; per esempio, dove troverassi negli antichi una storia del presidente de Tou; un libro come la Decadenza e grandezza dell’Impero romano del signor di Secondat; un’istoria delle case di Tudor e Stuard come quella del signor Hume; un’istoria delle scienze, arti e leggi, attribuita al signor di Gouguet; un’Istoria universale come quella ultimamente compilata da una società di letterati… Eh sì, so cosa volete dire, dicea quell’altro, le ho scorse queste storie; ma, vedete, non hanno un certo giudizio, so ben io,… un certo non so che,… una certa scelta,… e poi erano ben diversi gli antichi; gli antichi, vedete, impiegavano tutta la loro vita a fare un libro; e adesso il fare un libro è come piantare un cavolo; eh, tutto va a impostura, belle parole, bei periodi, un’aria di novità e di brio, e tutto è finito; ecco un perfetto autore; eccolo acclamato da tutta l’Europa, quasi che… Veramente trovate voi, signor Cristoforo, rispondea discretamente Filone, che i nostri moderni meritino tutti questi epiteti che voi prodigamente loro date? Ah sì, disse Cristoforo, voi avete letto quel libro francese di un certo signor Perault, panegirista de’ moderni in paragone degli antichi; ah sì sì, voi altri giovinotti lodate sempre il tempo presente… E forse troppo i vecchi il passato, disse Filone. Tutto bene, replicò Cristoforo, ma bisognerebbe leggere un poco di Senofonte, un poco di Senofonte, vedete, val più che tutti i libri moderni. Veramente l’ho letto, riprendea Filone… Eh sì sì, l’avete letto, ma la traduzione, non è vero? Eh, bisognerebbe vedere l’originale, perché, vedete, v’è una gran differenza fra l’originale e le traduzioni; oh, non vi ha che fare nulla, nulla affatto, leggete l’originale. L’originale, dicea Filone, l’ho letto ed inteso, il greco non m’è ignoto. Ah! come, voi sapete di greco?, riprese Cristoforo aprendo tanto di occhi verso di lui. Signor sì, disse Filone. E poi vinto dalla noia, per ormai tagliare questo discorso: Gran buon caffè che è questo, disse egli… Ah! a proposito di caffè, avete veduto un certo foglio che ha per titolo Il Caffè? Il Caffè, vedete che titolo sguaiato! Il Caffè ad un foglio! Eh, disse Filone, quando che contenga delle cose buone gli perdonerei il titolo, anzi mi pare un titolo senza impostura… Oh, per impostura vi assicuro poi io che la v’è tutta, tutto è tolto di qua e di là… Gran buon caffè che è questo, disse Filone… Sono vari pezzi cuciti assieme, ma stiamo male di lingua… Gran buon caffè che è questo!, disse Filone. E di ortografia poi! oh Cielo, fa nausea… Gran buon caffè, signor Cristoforo, disse ancora Filone; ma il signor Cristoforo non intendea nulla, parlò e declamò ancor per un’ora, sinché, usciti tutti quanti per la noia dalla bottega, egli disse il restante a Demetrio, il quale stette ammalato per tre giorni di febbre, tanta fu la noia che lo oppresse. Or mi direte voi, chi è questo Cristoforo, e chi è questo Filone? Questo è quello che non vi voglio dire.
A. [Alessandro Verri]
IL CAFFÈ )( Fogl. XV )(
Le delizie della villa
Secura quies et nescia fallere vita.
Ho ricevuta la lettera seguente, la quale forse non sarà discara a’ nostri lettori. Io vorrei certamente passare i miei giorni come li passa il mio amico; quella villa che mi descrive è il modello appunto ch’io mi proporrei; tanti cervelli, tante diverse faccie ha la felicità; vedremo se qualch’altro uomo vede quella felicità sotto un aspetto un po’ conforme a quello sotto il quale la vedo io. Ecco in somma la lettera.
Amico.
È ormai trascorso un intero mese dacché me ne sto in questa fortunata campagna albergato dal più cortese e giudizioso ospite ch’io m’abbia conosciuto al mondo; e fa bisogno ch’io lo veda sull’effemeridi per persuadermi che un mese appunto sia già passato. Caro amico, se il tempo della nostra felicità ci pare così corto e quello della noia così lungo, non potremo mai giudicar bene per intimo sentimento della somma de’ momenti felici paragonata a quella de’ momenti infelici; ed ecco forse l’origine delle universali doglianze degli uomini sul loro destino.
Io sono adunque in una villa lontana da X… quattr’ore, cioè lo spazio di circa dieci miglia italiane, appunto quanto basta ad allontanare dai rumori della città e dalle visite importune, lasciandoci comodamente godere degli avvantaggi che si hanno nella vicinanza della capitale. L’aria qui è sana, temperata e ridente; il paese ci presenta da una parte una vasta pianura tutta sì ben coltivata che sembra un seguito di non interrotti giardini; dall’altra parte cominciano le collinette coperte di uve eccellenti, che producono vini squisiti: qui non si sanno i nomi di nebbia, di flussioni o di mal di capo, cose che per isperienza ho provato andar sempre accompagnate: la vista è amena e variata quanto immaginar potete; in conclusione il luogo solo merita il nome che porta, cioè l’Eliso.
In questa deliziosa contrada, il marchese N. vi ha fabbricata la casa, dove ora mi vuole in compagnia d’altri gentili e colti suoi amici. Immaginatevi un salone di otto lati esattamente eguali, il quale finisce in una sorte di cupola, e prende la luce da otto finestre (superiori al tetto della casa), oltre quattro porte che sono a pianterreno in mezzo ai quattro lati opposti perfettamente in croce. Quattro belle stanze quadrate fiancheggiano il salone ai quattro lati che rimangono; così ogni lato del salone ha nel mezzo una porta, e queste alternativamente conducono una alla stanza, l’altra a un portico formato in tre archi e sostenuto da quattro colonne, due ad ogni sostegno, pei quali portici si scende da uno ad un viale che conduce al borgo, dagli altri tre a tre differenti giardini. La scala è in una delle quattro stanze, ed una loggia interna al salone dà la comunicazione a tutte le stanze superiori, delle quali quattro sono sopra quelle descritte a pianterreno e quattro sopra i portici, restando ad ogni stanza un piccolo ritiro triangolare per tenere chi vuole un domestico vicino, o per altro uso. La cucina e gli altri uffici restano sotterra, e gl’impiegati in essi alloggiano in due vicine case, le quali servono d’imboccatura del viale che va al borgo. Tutta la fabbrica è in volta di muraglie massiccie, con tutte le opere di legno egregiamente lavorate, cosicché vi si ha il maggior asilo possibile contro tutte le stagioni. I mobili di questa casa sono fatti corrispondentemente; qui non vedrete oro né argento, ma tutte le sedie e le tavole comode, durevoli e liscie, cosicché maneggiandole non trovate angoli o asprezza che conservi la polve, o v’imbratti, o laceri in verun conto. Il pavimento del salone è di marmo bianco; quello di tutte le altre stanze è di legno di noce connesso con qualche simmetria, e così ben custodito e lucido che quasi riflette l’immagine di chi vi sta sopra. Le muraglie tutte al di dentro sono intonacate d’una sorte di stucco, che al pulimento ed alla dolcezza del tatto lo credereste un vero marmo, cosicché in qualunque parte vi appoggiate non correte verun rischio di sconciare o offendervi né la persona né gli abiti. Qui non vedreste quadri di sorte alcuna, né pitture, trattene quelle della cupola del salone e della stanza detta fra noi Atene; i quadri offuscano le stanze, piacciono al primo colpo d’occhio, poi vi si avvezza, e non se ne sente che l’oscurità e la tetragine: qui tutto è di allegro colore, non però bianco affatto, onde più dolce è la luce, né ferisce dolorosamente gli occhi.
V’è una stanza per le scienze, e questa si chiama Atene: ella è riposta dirimpetto alla scala, la volta di essa è di color celeste, né ha altro ornamento che delle stelle di diversa grandezza disposte nel medesim’ordine in cui sono sul nostro emisfero. Ivi sta sul pavimento un’esatta meridiana, sulla quale cade un raggio di sole attraversando una piccola apertura fatta nella muraglia. I quattro lati dell’Atene sono coperti di quattro quadri dipinti a oglio precisamente coincidenti ai lati, come una tappezzeria: ivi stanno simboleggiate le scienze tutte; d’un canto alcuni amorini che indirizzano un telescopio; ivi vicino un altro che collo specchio ustorio accende fuoco; poco discosto un terzo che osserva attentamente entro un microscopio; chi ha in mano de’ prismi e chi delle camere ottiche. Da un altro canto v’è la macchina elettrica, e diversi amorini che la pongono in moto e ne estraggono le scintille; qui la pneumatica, là l’idraulica; chi disotterra iscrizioni; e così del rimanente tutta a chiaroscuro bianco e celeste è dipinta intorno la stanza. Una tavola immobile sta nel mezzo di essa, sotto la quale stanno riposti circa trecento volumi e non più, tutti scelti e con eleganza rilegati uniformemente. Un esattissimo pendolo astronomico, un quadrante, vari telescopi e cannocchiali, sfere, macchine in somma le più perfette di tutta la fisica riempiono la stanza, della quale ciascuno di noi ha una chiave, acciò s’unisca colla libertà nostra di goderne la sicurezza dai disordini che le visite, che talora vengono in nostra assenza, potrebbero cagionare.
Il giardino che resta dalla parte opposta al viale è tutto sul gusto francese a parterre, circondato da due remote allées di portici verdi; questo è propriamente fatto pel gusto del secolo. I due altri giardini laterali sono fatti pel gusto nostro; quello che resta alla sinistra entrando è destinato alla botanica del palato: ivi trovate tutte le erbe e i frutti più saporiti dell’Asia, dell’Affrica e dell’America, e gli asparagi, i poponi e le lattuche più squisite d’Olanda, le quali senza offendere l’illustre lignaggio degli ananassi e dell’uve di Buona Speranza, s’alimentano sullo stesso terreno: col mezzo delle serre riscaldate attentamente ivi avete i frutti più esotici e pellegrini; ed al finire dell’autunno raccogliete le pesche, le cerase, e tali altri simili doni di primavera e d’estate. Il marchese ha ricusato di ammettere fra questi vegetabili la vastissima serie delle piante forestiere, le quali sterilmente occupano il terreno, né ad altro uso servono che a compiere le pretese classi nelle quali gli uomini si ostinano a dividere le produzioni della natura. Tutto qui servir deve o all’istruzione o ai piaceri dell’odorato e della mensa; il fasto, la vana magnificenza non sono degne d’un uomo di gusto, che cerca il vero, non l’ostentazione e l’opinione del volgo.
L’altro giardino posto alla dritta sembra a chi lo mira dal bel principio ancora da farsi: ivi non vedete viali, non parterre, non simmetria alcuna, ma bensì la natura ferace, che ha prodotto una sorta di boscaglia irregolare per dove non si sa bene come entrare; ma avvicinandovi, un sentiero vi guida in quel delizioso boschetto, dove le erbe che premete son dittamo, timo, serpillo e simili fragrantissime, che imbalsamano co’ lor naturali profumi l’aria che respirate; ivi per tubi sotterranei vi sbocca l’acqua condotta nascostamente dalle vicine sorgenti della collina, e così artificiosamente disposta che sembra nascere e serpeggiare in diversi piccoli ruscelli che vanno inaffiando le rose, le fragole, le violette ed altri fiori ed erbe grate per la figura e la fragranza. Gli uccelli ivi liberamente vivono e fanno il loro nido, e sono sì domesticati cogli uomini (fatti animali benefici in quel recinto) che quasi non temono d’essere da noi toccati. Questo passeggio è delizioso in ogni stagione, ma sopramodo nella state, quando le piante sono ben coperte; e qui sono sì giudiziosamente disposte che sembra opera libera della natura quello che è l’ultimo raffinamento dell’arte. Queste piante poi sono tutte fruttifere, e nessuna sterile vi si sopporta, onde nel passeggio medesimo trovate che la natura vi presenta di prima mano i suoi più deliziosi doni. Nel mezzo di questo incantato boschetto v’è una circolar pianura, nella quale stanno pittorescamente sparsi diversi rottami d’antica architettura, colonne, archi, piedestalli, iscrizioni, scale mezzo diroccatte, statue cadute e infrante, tante anticaglie in somma coperte d’erbe su di esse nascenti; e sì graziosamente disposte e interrotte da alcune piante nate fra’ dirupi ch’io mi rimasi attonito ed assorto per la sorpresa e per la vaghezza del disordine: credea talora d’essere ad una scena di teatro, e talora di premere gli augusti avanzi della commerciante Cartagine o della conquistatrice Roma: in somma, cosa non ho veduto sin ora tanto deliziosa quanto questo disordinato giardino, il quale non costa meno al padrone spesa e incomodo degli altri due.
Eccovi descritto il luogo della mia dimora; ora vi dirò come in questo luogo si viva. Siamo sei ospiti, e il marchese che fa sette; abitiamo ciascuno in una stanza dissopra. Sino a mezzo dì ciascuno vive come vuole, e questo è il tempo in cui, compiuti gli atti di religione, con un libro me la passo nel delizioso boschetto; giunto il mezzo dì ognuno è vestito, e si impiegano le due ore prima del pranzo o in ascoltare la lettura di qualche manoscritto del marchese, o in fare qualche osservazione, ovvero nella lettura di qualche squarcio di buon autore, e talvolta nella declamazione di qualche tragedia o commedia delle più scelte; così passano le due ore dolcissimamente e con profitto. Ne viene poscia il pranzo: ivi non v’accorgereste che il marchese sia il padrone di casa; non comanda, non disapprova, non offre a veruno. La tavola è dilicata quanto essere è possibile; i cibi sono tutti sani e di facile digestione; non v’è una fastosa abbondanza, ma v’è quanto basta a soddisfare: le carni viscide o pesanti, l’aglio, le cipolle, le droghe forti, i cibi salati, i tartuffi e simili veleni della umana natura sono interamente proscritti da questa mensa, dove le carni de’ volatili e de’ polli, le erbe, gli aranci e i sughi loro principalmente hanno luogo. I sapori sono squisiti, ma non forti; ogni cibo che fortemente operi sul palato istupidisce poco o molto il palato medesimo, e lo priva d’un infinito numero di piaceri più dilicati; oltre di che qualunque cibo che fortemente stimoli il palato, fortemente ancora agisce sulle tonache del ventricolo e degli intestini, e da qui ne vengono infiniti mali che compensano con molta usura il piacere della sensazione provata. I vini raccolti dalle vicine colline hanno molto sapore e poca forza, cosicché mischiati con qualche porzion d’acqua rassembrano al legger acido loro alle limonate e sono una gustosa bevanda che aiuta la pronta digestione. Nessun cibo d’odor forte è ammesso alla nostra mensa, ed è proscritta ogni erba che infracidendosi dia cattivo odore; perciò i caci e i cavoli d’ogni sorta ne restano esclusi. Tale è il nostro pranzo, che terminiamo con un’eccellente tazza di caffè, soddisfatti, pasciuti e non oppressi da grossolano nodrimento, dal quale assopito lo spirito spargerebbe la noia nella società nostra, nella quale anzi dopo il pranzo sembra rianimarsi la comune ilarità.
Allora è, che allestiti i cocchi e sellati i cavalli, viaggiamo unitamente ora ad una terra vicina, visitando le civili persone che vi alloggiano, ora in luoghi solitari di bella veduta, ovvero dove qualche curiosa sorgente d’acqua o qualch’altra naturale produzione degna di osservarsi c’invita. Queste geniali partite ci fanno sparire il tempo sino a sera, avvicinandosi la quale ce ne ritorniamo al nostro Eliso. Ivi la domenica si balla, e tutte le compagnie del vicinato vengono a passarvi quella sera. La piccola orchestra sta sulla loggia; nella gran sala è il ballo; e nelle due stanze libere a pianterreno, in una vi sono le tavole de’ giuochi, nell’altra una cena campestre, a cui chiunque vuole partecipa, togliendo, senza la formalità di sedere, da una mensa ben fornita di deliziosi cibi freddi e di squisite bottiglie quanto abbisogna. A mezza notte finisce regolarmente il ballo.
Le altre sere talvolta le passiamo colla musica: tre della nostra compagnia son buoni suonatori e formano un concerto a tre, eseguendo delle suonate a tre stromenti, delle quali appunto come di più facile esecuzione il marchese ha fatto una copiosa e scelta raccolta ne’ suoi viaggi, e la conserva legata in diversi volumi. Frattanto altri giuoca, o legge, o ascolta, o ragiona come piace. Talvolta per tema che l’uniformità non ci annoi, vari altri passatempi vi s’introducono; né v’è cosa che si reputi frivola presso di noi, quando serve all’importantissimo affare d’impiegar il tempo con piacere: perciò mille giuochi si sono messi in campo; mille scherzi innocenti, ora cadendo sopra l’uno, ora sopra l’altro, rallegrano la compagnia senz’avvilire l’amor proprio di alcuno. Così passa con una dolce allegria la sera; né altra maggior cura ha il marchese di quella di prevenire sempre il tedio e far sostituire una nuova occupazione a quella che proseguendo potrebbe illanguidire l’attenzione. Così viene l’ora della cena, dopo la quale ciascuno passa nella propria stanza.
La maldicenza e la irreligione sono le sole lingue proibite severamente in questa innocente nostra vita; tutto respira l’umanità e la vera virtù. La premura di renderci reciprocamente grato questo soggiorno è la passione che ci anima tutti a vicenda; in conclusione si vive così beatamente che i sultani dell’Asia, quand’anche fossero intimamente persuasi che cento milioni di uomini sono nati per essi, non credo che provino in vita loro il piacere di vivere come lo proviamo noi. Quello che sovranamente abbella tutto è il marchese, uomo che ha conosciuto tutte le corti e regni floridi d’Europa; uomo che ha avuta famigliarità cogli uomini più cospicui in ogni genere, e che da’ suoi viaggi e da’ suoi studi, ai quali per natura è stato sempre inclinato, ha cavata una quantità di tante notizie ed una sì fatta coltura e grazia di farne uso ch’io non saprei nominarne un altro di più gentile e interessante conversazione. Egli è uomo amabile, ma non debole; deciso, ma non ributtante. In questa sua campagna altri commensali non vi sono che i suoi amici; ed ha saputo sì bene farsi intendere su quest’articolo che alcuno non osa introdurvisi, se non è formalmente pregato da lui. Di tutti quelli che quivi cenano al ballo liberamente, un solo non ardirebbe presentarsi a partecipare della nostra vita ordinaria. Così questo vero saggio sa vivere nel mondo; sa goderlo senza esserne schiavo.
Mi sono trovato spesse volte in compagnie splendide in villa, non mai in una sì ben concertata e insieme così geniale come si è questa, dove per compimento di perfezione non provo il dispiacere di vedere il padrone di casa incomodarsi e comperare l’attuale magnificenza colla carestia futura, sentimento che mi ha amareggiato nel secreto del cuore ogni volta che mi sono trovato nel caso di averlo.
Il patrimonio del marchese è di dodici mila scudi all’anno; nei primi anni della gioventù gli ha spesi regolarmente in viaggiare; ritornato poscia nella patria, quattro mila soli scudi si è riservati pel suo mantenimento, e otto mila all’anno ne spese nella costruzione di quest’Eliso. Finito l’Eliso, altra distribuzione ha stabilita alla sua entrata: quattro mila scudi per la sua persona, mille scudi per le riparazioni dell’Eliso, due mila scudi per sollevare i poveri, mille scudi per aiutare e ricompensare gli uomini di merito che producono qualche buona cosa in qualunque genere, e i quattro mila scudi che rimangono servono a passare due mesi ogn’anno della vita che vi ho descritta, senza che mai alcuna di queste partite ecceda a danno dell’altra. Se vi dovessi dire come e con quali nobili maniere impieghi i mille scudi a premiare ora un letterato, ora un pittore, ora un artista, e quanto bene faccia alla sua patria con soli mille scudi annui, avrei soggetto per farvi una nuova lettera: vedreste s’è vero che un cittadino illuminato ha più influenza nel mutare una nazione che non ne abbiano i più gravi volgari Catoni. Ma tempo è di finirla: v’abbraccio e sono
Dall’Eliso, 5 ottobre 1764
P. [Pietro Verri]
Tentativo analitico su i contrabbandi
L’algebra non essendo che un metodo preciso e speditissimo di ragionare sulle quantità, non è alla sola geometria od alle altre scienze matematiche che si possa applicare, ma si può ad essa sottoporre tutto ciò che in qualche modo può crescere o diminuire, tutto ciò che ha relazioni paragonabili fra di loro. Quindi anche le scienze politiche possono fino ad un certo segno ammetterla. Esse trattano di debiti e crediti d’una nazione, di tributi, ec.; cose tutte che ammettono calcolo e nozione di quantità. Dissi fino ad un certo segno, perché i principii politici dipendendo in gran parte dal risultato di molte particolari volontà e da varissime passioni, le quali non possono con precisione determinarsi, ridicola sarebbe una politica tutta tessuta di ciffre e di calcoli, e più agli abitanti dell’isola di Laputa adattabile che ai nostri europei. Pure, siccome lo spazio che occuperò in questo foglio non è molto importante nell’universo, ed il tentativo può piacere ai lettori di un certo carattere, darò una leggera idea come si possano analiticamente considerare le scienze economiche.
Quando la regalìa esigge un tributo sulle mercanzie che entrano o escano, ella ordinariamente impone la pena della perdita della mercanzia sottoposta al tributo contro chi cercasse di sottrarvela. Il rischio dunque della regalìa è proporzionale al tributo, quello del mercante al valore della mercanzia. Se il tributo uguaglia il valore, i rischi sono uguali da una parte e dall’altra. Se il tributo è più forte del valore, sarà maggiore il rischio della regalìa di quello del mercante. Se il tributo è men forte del valore, rischia più il mercante che non la regalìa. Aggiungasi che se cresce il rischio del mercante in proporzione de’ custodi, sminuisce in proporzione de’ volumi. Questi principii sono così chiari che sarebbe pedanteria l’esporli analiticamente; ma può farsi una ricerca, che condur potrebbe a sciogliere in qualche modo l’importante problema per la bilancia d’uno Stato, cioè quanto debba valutarsi il contrabbando d’una data merce che entra o esce da uno Stato. Ripeto che quanto soggiungerò non è la soluzione del problema, la quale fin ad ora non mi si è affacciata alla mente; ma parmi che possa incamminarvi.
Si cerca per quanto valore di una data merce i mercanti dovrebbero defraudare la regalìa, cosicché anche perdendo il resto si trovassero per il guadagno del contrabbando collo stesso capitale di prima. Il determinare una tal quantità generalmente può servir di lume a construire una tariffa.
Sia u il valor intrinseco della merce; t il tributo; x la porzione richiesta di mercanzia; d la differenza tra il tributo ed il valore; sarà il totale del valore a tutto il tributo come la porzione richiesta al suo tributo corrispondente, cioè u · t : x · tx/u porzione di tributo corrispondente alla parte richiesta x. Avrassi per la condizione del problema l’equazione x + tx/u = u, e moltiplicando ux + tx = uu, e dividendo x = uu/u + t. Ma il tributo può essere uguale al valore, cioè t = u; maggiore del valore della quantità data d, cioè t = u + d; può essere minore della stessa quantità d, cioè t = u – d; sostituendo dunque nell’equazione generale x = uu/u + t alla quantità t il suo rispettivo valore, in ogni caso si avrà:
Quando t = u, allora x = uu/u + u = uu/2u = u/2.
Quando t = u + d, allora x = uu/u + u + d = uu/2u + d < u/2
Quando t = u – d, allora x = uu/u + u – d = uu/2u – d > u/2.
Supponendo nell’equazione ux+tx=uu indeterminata la t e la x, e costante la u, il luogo dell’equazione sarà ad una iperbola fra gli assintoti, di cui le abscisse t prese sull’assintoto ad una distanza u dall’angolo assintotico, più la medesima distanza, saranno alle ordinate x paralelle all’altro assintoto in ragione costante, cioè come il quadrato della potenza u. L’inspezione della figura, in chi la voglia costruire, rischiarerà tutti i differenti casi dell’equazione.
Da questo calcolo cavasi un teorema generale, che dati eguali volumi, egual custodia e la massima industria ne’ mercanti, il niso per bilanciarsi del tributo col contrabando sarà come il quadrato del valore della merce diviso per la somma del valore e del tributo.
Il vantaggio di questa ricerca per un costruttore di tariffe sarà quello di sapere quanto debba temere dai mercanti di contrabando anche dopo un certo numero di rappresaglie.
C. [Cesare Beccaria]
La coltivazione del lino
Nella nostra Italia la coltivazione del lino è conosciuta, e nella Lombardia principalmente; perciò non credo cosa affatto inutile l’inserire in questo foglio un pensiero spettante appunto la perfezione di questa parte della nostra agricoltura.
Il seme che si adopera nell’agricoltura contribuisce in gran parte a rendere il prodotto di buona o cattiva qualità. Questa proposizione è provata dalla sperienza di ogni più stupido contadino. Da ciò ne scaturisce naturalmente per conseguenza che anche il lino nato da un ottimo seme sarà più perfetto di quello che non lo sia il lino nato da un seme men buono.
I migliori lini della Francia, cioè quelli di Picardia, di Brettagna e della Normandia, sono prodotti dal seme di lino che ogni cinque anni almeno si fa venire dal mare Baltico, e singolarmente da Riga. I filamenti di quell’erba sono più lunghi, più sottili e più fibrosi d’ogn’altra sorta di lino; ma va ogni anno degenerando il seme, cosicché al quinto anno ha perduta tutta la naturale perfezione.
So che per un comune pregiudizio si crede che le belle tele di Harlem, quelle di Frisa, cioè delle migliori d’Olanda, e molte delle tele di Slesia, le quali si fanno spacciare per d’Olanda, sieno fatte non già di lino, ma bensì di canape. Chiunque abbia posto il piede nella Slesia, chiunque sia un po’ instrutto delle manifatture e produzioni dell’Olanda mi sarà testimonio che tutte le tele fine bianche che in quei paesi si tessono sono non già di canape ma di lino; né i fili del canape cred’io che possano mai filarsi sì sottilmente, né ridursi a tale candidezza da formarne una tela veramente fina.
Io vedo che alcuni terreni della Lombardia producono lini buoni naturalmente; e perché non potrò io sospettare che se quei terreni stessi fossero seminati co’ semi del Baltico produrrebbero lini di molto migliori? E chi mi proverà mai che fors’anco non si giungesse a tessere con lini nostri delle tele paragonabili a quelle della Germania e dell’Olanda?
Non sarebbe molto il dispendio di farne una prova; dalla parte di Venezia o di Genova facil cosa è il farci spedire dall’Olanda, ovvero da Riga, una mediocre quantità di seme di lino, e chiarircene seminando poche pertiche di terreno del migliore con esso. In fine d’un anno un buon regolatore de’ propri beni potrebbe agevolmente calcolare se vi si trovi vantaggio. Il prodotto d’una pertica sola, quando riesca buono per farne merletti, darà una somma capace da premiare largamente l’industria del tentativo; e quando a tal perfezione anche non giungesse, si avrà sempre un lino per lo meno eguale a quello che raccogliamo comunemente, e la perdita della prova non sarà di gran danno. Bisogna nell’agricoltura tentare sempre e non negligentare giammai veruna vista, a meno che non vi si affacci un’aperta assurdità: bisogna tentare a costo di vedere andar falliti venti progetti e riuscirne un solo; bisogna tentare, ma rischiar poco e consacrare alle prove una piccola porzione de’ nostri fondi, in guisa che riuscendo male non ce ne venga nocumento. Spero che fra i lettori del nostro foglio ve ne saranno alcuni che approveranno questa massima; e forse in mezzo alla varietà delle cose che si leggono nel nostro Caffè, chi sa che taluna non giovi essenzialmente alla società? Tale è almeno il fine che ci siamo proposto.
P. [Pietro Verri]
IL CAFFÈ )( Fogl. XVI )(
Di Giustiniano e delle sue leggi
La storia di Giustiniano è un motivo di più per accrescere il numero de’ pironisti. Tante e sì varie cose di lui scrivono Suida, Procopio e Agatia, che non è facile il rintracciare la verità fra varie storie che si contraddicono, e nessuna delle quali è provata apocrifa. Le diverse passioni ond’erano animati gli autori non ci hanno lasciato che un difforme ammasso di fatti e di dubitazioni, non essendo male nuovo della umanità che le grandi mutazioni negli Stati provino le maldicenze di coloro che amano ciecamente le cose passate, che odiano le novità senza esaminarle o che dai disordini presenti traggono le rendite loro. Il popolo forense di que’ tempi, a cui dovea recare gran copia di ricchezze l’incostanza del diritto cagionata dalla confusione delle leggi, non potea vedere di buon occhio ridotti in un solo libro due mila volumi d’antica giurisprudenza, tanti senati-consulti ed editti de’ pretori, che formavano il carico di molti cameli,[32] al dire d’Eunapio. In fatti simile impresa avea prima di Giustiniano incominciata Pompeo, essendo console, ma egli non la proseguì per timore delle dicerie.[33]
Ma come mai ritrovare il vero fra due storie sì diverse? Un erudito in foglio potrebbesi fare, lasciando ancora tutta e forse maggiore oscurità alla quistione. Perché mai Procopio adulò Giustiniano nelle prime sue storie De bello persico e De bello gothico e De aedificiis, per poi ritrattarsi nella Storia arcana? Certe latere ipse (dice egli in questa storia) diutius non potuissem, neque supplicio crudelissimo non interire isthaec, si palam, et in lucem venissent… Quin et aliis huius historiae libris nonnumquam gestorum silere causas coactus sum.[34] Se poi volete sapere perché egli scrisse questa storia segreta, ve lo dice egli verso il principio: Me vero ad eas res prodendas induxit, quod qui tyrannidem imposterum exercebunt facile sibi horum hominum exemplo persuadere poterunt, quae in ipsos etiam malefactorum maneat animadversio; deinde fortasse veriti, ne vita, moresque sui aeternae posterum memoriae tradantur, haud ita ad peccandum praecipites erunt.[35] Dopo immense lodi a lui altrove conferite, qui ce lo dipinge per un vero tiranno. Così segue egli: … religionis esse putavit, ut victa causa discederet, qui sacri nomine rem alienam occupasset, in eoque ius statuebat, ut sacerdotum adversarii tandem causa caderent. Ipse male parta aliorum bona sive de vita illi decessissent, sive superessent, templis addixit, ut sic et crimen pietate obtegeret, et numquam imposterum ad vexatos olim possessores facultates redirent, quin se infinitis caedibus praepostera hac pietate cruentavit.[36] Va più oltre Procopio e chiama questo imperadore e coelo immissa pernicies… semper populis perdendis intentus… nulla in re stabilis, praeterquam crudelitate, et studio pecuniae… cuius perpetuae vigiliae, labores, conatus in eo vertebantur ut atrocior in dies fieret subditorum calamitas.[37] A tali espressioni quand’anche si tolga quella porzione che forse accrebbe alla verità una privata inimicizia, pure non poco ci rimane per sospettare della infelicità di que’ tempi, in cui le storie eran false per due egualmente funeste cagioni: vivendo l’imperadore, per timore, ed egli morto, per odio.
Lascio non pertanto agli eruditi la cura di conciliare le contraddizioni che si ritrovano nelle storie di que’ tempi, essendo persuaso che in simili casi fugge la verità più che la si ricerca, e che rinascono nuovi dubbi e nuove erudizioni, le quali accrescano ben poco le cognizioni utili agli uomini. Pure, se i fatti accertati da vari storici possono darci un’idea del carattere di Giustiniano, la Palestina crudelmente desolata colla persecuzione de’ Samaritani senza aver fatto un proselita, la compilazione delle antiche leggi sì male eseguita, l’aver diviso il trono con Teodora, donna di teatro prostituita, il non esser stato presente in alcuna azione militare, sono tutte cose che scemar possono quell’alta idea che ha taluno di lui concepita.
Era a’ suoi tempi diviso in due partiti Costantinopoli, l’uno era de’ Verdi, l’altro de’ Turchini. Nato già prima da lungo tempo troviamo questo scisma ne’ teatri e ne’ circhi, dividendosi gli spettatori cogli applausi. Giustiniano si mischiava in questi ridicoli e faziosi affari, piccolezza d’animo incompatibile colla cura de’ grandi. Sconvolgevano tutta la città queste divisioni, e profittavano intanto i magnati del popolare tumulto.[38]
S’innalza questo imperadore fastoso col titolo di Triumphator semper Augustus, e chiama l’imprese militari del suo tempo suoi sudori guerrieri,[39] abbenché egli non sia mai stato in battaglia;[40] e le azioni sempre memorande di Belisario e di Narsete, che furono gli strumenti della sua gloria, ricevono una lode secondaria. I nomi de’ grandi non solo servono d’epoca, ma s’usurpano ben spesso la gloria delle imprese altrui, perché furono fatte a’ loro tempi; così siamo stati prodighi de’ nomi grande e divino ad alcuni grandi solo pel potere, a’ quali l’azzardo diede per contemporanei gli grandi uomini; e quelle vane leggende con cui comincia le sue Instituzioni quest’imperadore, cioè Caesar Flavius Iustinianus, Allemanicus, Gothicus, Francicus, Germanicus, Anticus, Alanicus, Vandalicus, Affricanus, Pius, Felix, Inclitus, ac Triumphator semper Augustus, sono un monumento del fasto e dell’enfasi asiatica, anziché d’una gloria da lui meritata.
L’estrema decadenza a cui fu ridotto il suo esercito è un gran motivo per credere infelice il suo regno, e le sue conquiste il frutto d’una passaggera grandezza. Siegue Procopio nella Storia arcana: Respublica eo devenerat, ut exercitus numero exiguus esset miles superstes extinctis emeritis praeter dignitatem in inferioribus detinebatur ordinibus; stipendia quam pro loco et gradu acciperet minora: damnis praeterea perquam multis aliis milites afficerentur ita compensatis periculis quae per sua corpora in praelio subirent.[41] Cattiva politica ancora fu quella ch’egli usò verso di Belisario, negandogli (fra gli altri insulti che fece a questo grand’uomo) gli onori trionfali quando ritornò vittorioso da’ Vandali e dal re Galimero.[42] Dovette Roma in parte la sua grandezza al fasto de’ trionfi, che lusingando l’ambizione de’ cittadini la faceano servire all’universale vantaggio. Senza ricompense o gloria v’è scarsezza di grandi uomini, né si tolgono i cittadini all’inerzia naturale che coll’esca d’un bene, sia egli reale o loro sembri tale per un fortunato pregiudizio.
Era già spento da molti secoli in Grecia ogni spirito di libertà, che anzi la schiavitù e l’avvilimento aveano depressi gli animi a segno che si vide la più stravagante desolazione dominare e sconvolgere Costantinopoli in occasione di un terremoto. Profittarono allora alcuni impostori del comune timore per ispacciare alcuni portenti, quasi che fosse per rovinare fra poco questo mondo; quindi si finsero alcuni inspirati dal Cielo, e giravano per la città predicendo orribili avvenimenti, impresa facile in simili occasioni. Alcuni ancora, mutando affatto il loro genere di vita, vollero menare duri e solitari giorni fra gli orrori delle montagne, lasciando le ricchezze e gli agi della vita civile, e quant’altro mai sembra dolcissimo a’ mortali.[43]
Tale a un di presso era lo spirito di que’ tempi, e tale il carattere di Giustiniano, se pure può ravvisarsi la verità oscurata or dall’adulazione, ora dall’odio. Ma poiché di fretta tai cose abbiam trascorse, alla riforma delle leggi consacriamo una breve e forse non inutile attenzione.
Servirà di prefazione a questi pochi periodi l’addimandare una grazia desiderata da tutti, accordata a pochi; e questa è che il lettore, spogliato d’ogni spirito di partito, voglia esser giudice imparziale.
Quest’ammasso di leggi, monumento d’una grand’opera mal eseguita, può paragonarsi alle rovine d’un grande ed informe palazzo; si può dire che non si fece che distruggere. Non solo bastava ridurre tanti volumi ad uno solo, bisognava fissare i principii generali. E perché mai raccogliere nelle Pandette diversi frammenti di Vulpiano e di Paolo? Perché così venerare alcune risposte a’ casi particolari a segno di volerle mandare alla posterità? Un legislatore, che nel formare un codice non si limita ai principii generali da’ quali dedurre tutte le conseguenze, per quanto si può, formerà una vasta biblioteca di, per lo meno, inutili volumi. So che il comprendere nelle leggi tutti i casi possibili non è concesso agli umani legislatori, ma so altresì che migliori saranno quelle leggi, che ne abbracciano la maggior parte possibile; né perché in una cosa non puossi avere la perfezione, che fu sempre sbandita dalle umane vicende, devesi trascurare di accostarvisi più che si può.
Io non sono al certo del parere di quegli che risguardano le leggi giustinianee con una stupida venerazione, la maggior parte de’ quali non le hanno neppure avute nelle mani, o se le hanno lette non le intesero in gran parte, ovvero dissimulano il loro interno disprezzo, perché profittano della comune idolatria per le leggi romane, diventando ricchi a spese dell’altrui cecità.
Triboniano, uomo molto avaro, secondo ne scrivono Suida, Armenopolo, Procopio, Agatia, fu incaricato della compilazione degl’infiniti senato-consulti, risposte de’ prudenti, costituzioni imperiali che avevano inondato l’impero dopo le leggi delle Dodici Tavole venute dalla Grecia. Il solo progetto di ridurre quest’informe massa in un volume fa vedere che non si pensava a fornire alla nazione leggi salutari. Era mutato il sistema di governo, la repubblica divenuta già monarchia degenerava in dispotismo, ed il complesso delle leggi fatte in sì differenti situazioni non poteva essere che un confuso ammasso di assurdità e di contraddizioni. Non avrebbero veduto gli occhi d’un saggio legislatore in quella sì estesa libidine di giurisprudenza che l’abuso del potere legislativo, ed un testimonio del decadimento e della tirannia.
Siavi un Triboniano a’ dì nostri incaricato di ridurre in compendio quanto scrissero dopo di Giustiniano tanti repetenti, consulenti e trattatisti, credete voi che si farebbe un buon complesso di leggi? Siamo nel medesimo caso in cui era l’Impero ne’ tempi che si riformò la giurisprudenza, e forse noi più abbisogniamo di riforma. Erano le antiche leggi sparse allora in due mila volumi,[44] ora lo sono al certo in numero maggiore;[45] al che si aggiunga che i nostri volumi di giurisprudenza, che sono quasi tutti in foglio, contengono un numero molto maggiore di versi e di lettere che non contenessero gli antichi, poiché non erano che una mediocre pezza di pergamena involuta in forma di cilindro, come ne avvanzano anche a’ dì nostri. Lavorarono a quest’opera per cinque anni diecisette delegati dall’imperadore: egli è ben difficile il ritrovare in un regno anche vasto diecisette legislatori.
In tale spazio di tempo non era possibile lo scegliere giudiziosamente alcuni buoni principii, naufraghi, dirò così, in un mare immenso d’ignoranza e di confusione. In fatti corrispose esattamente il pregio dell’opera alla cura che vi si adoperò; e le non rare contraddizioni che si ritrovano nelle leggi delle Pandette fra di esse; così pure nel Codice, che oltre alle contraddizioni che ha fra i suoi testi, contraddice ad alcune leggi delle Pandette, e queste alle Instituzioni; e le Novelle che al resto contraddicono, ed il ritrovarsi perfino dei testi contradditori a se medesimi, e tutte queste parti che l’una all’altra derogano e si collidono, bastano per lo meno a farci dubitare della sapienza di que’ legislatori. Frutti sono questi in gran parte delle antiche sette di Atteio e di Capitone, giurisconsulti divisi di parere, e che lasciarono dopo di loro uno scisma che abbandonava alla vanità ed alla ostinazione di partito un punto de’ più importanti alla pubblica tranquillità.
Si possono risguardare le Pandette come un ammasso di leggi dove regna or la ragione ed or l’opinione, e d’onde possono trarsi molti lumi e molte cognizioni per la formazione di un nuovo volume di leggi, sendovi sparsi di tempo in tempo de’ tratti di vera filosofia. Le Instituzioni pure sono l’unico ordinato codice di leggi romane; ma tal lode non può mai darsi al Codice giustinianeo, in cui sono raccolti gli editti degl’imperadori, cominciando da Adriano sino a Giustiniano. A quanta decadenza fosse giunta e sempre più v’inclinasse in questo intervallo la romana potenza, quanto la tirannia e ’l dispotismo avessero già avvilita ed oppressa quella nazione che i Tiberi, i Claudi, i Neroni, i Caligola ed altri simili mostri avea già tollerati e serviti, le storie ce l’insegnano; onde le leggi ancora furono conformi alla corruzione del governo, né più si videro adorne dell’antica maestà e spiranti il pubblico bene, ma noiosamente prolisse e già pregne di quel terribile disprezzo per gli uomini che crebbe all’immenso, sinché arrivossi a fare quel fatale paralogismo, che molti milioni d’uomini fossero destinati alla felicità di un solo. Da tale spirito distruttore fu dettata quella barbara legge degl’imperadori Arcadio ed Onorio contro i rei di lesa maestà. Quisquis cum militibus vel privatis, vel barbaris scelestam inierit factionem… vel… cogitaverit (eadem enim severitate voluntatem sceleris qua effectum puniri iura voluerunt) ipse quidem ut pote maiestatis reus gladio feriatur bonis eius omnibus fisco nostro addictis. Filii vero eius quibus vitam imperatoria specialiter lenitate concedimus (paterno enim deberent perire supplicio, in quibus paterni hoc est haereditarii criminis exempla metuuntur) a materna vel avita omnium etiam proximorum haereditate habeantur alieni, textamentis extraneorum nihil capiant, sint perpetuo egentes et pauperes; infamia eos paterna semper comitetur, ad nullos prorsus honores, ad nulla sacramenta perveniant, sint postremo tales, ut his perpetua egestate sordentibus, sit et mors solatium, et vita supplicium.[46] Tal legge sola basta a convincerci che in que’ tempi era stabilito un vero dispotismo, poiché ne’ moderati governi né tanto temonsi i ribelli, né sì crudelmente si puniscono. Quanto già fosse a’ tempi di Giustiniano radicato quel male a cui specialmente pare dalla natura destinata l’Asia, la tirannia m’intendo, il provano l’espressioni di una stravagante vanità che nelle sue leggi s’incontrano; e tali sono il comando di adorare la sua eternità,[47] il chiamarsi bocca divina[48] e divino oracolo.[49]
Costanti e generali principii di giustizia (che pur sono la base d’ogni util legge) non furono osservati in quest’opera, a cui ebbero la principal parte Triboniano e Teodora. Ciò c’insegna la Novella ottava, cap. I: Haec omnia (dice Giustiniano) apud nos cogitantes, et hic quoque participem consilii sumentes eam, quae a Deo data est nobis reverendissimam coniugem… sancimus etc. Erano venduti a denaro contante i suoi divini oracoli da Triboniano, che al dire di Procopio: justum sectabatur lucrum; singulis diebus leges aliquas aut antiquabat, aut condebat, prout ex usu esse videbat; ed altrove: verum hianti homo, et explicabili avaritiae unice serviebat, erantque apud illum jura venalia iamdiu legum nundinationi deditus, quotidie pretio refigebat alias, alias figebat prout erat ex usu poscentium.[50] Così parla un illustre scrittore contemporaneo, né senza stupore si possono sentire o leggere le apologie fatte a Triboniano in questi ultimi secoli, quasi che dopo più di mill’anni le cose si vedessero o sapessero meglio di coloro che le seppero, le videro e le conobbero.
Con questo metodo poteasi bensì arricchire il legislatore Triboniano e l’imperadore, e secondare le mire private di Teodora, ma non già fare un codice per la felicità della nazione. Eppure queste sacrosante leggi abbiamo già da lungo tempo adottate e venerate; ed un secolo fa non s’esponevano e leggevano nel manoscritto di Firenze che colle torcie accese, quasi idolatrando questa sovrumana sapienza.
Così maltrattano gli uomini gli oggetti più importanti della loro felicità, i cardini della società civile; e s’io giro colla mente il globo, trovo che le più grandi stravaganze e gli errori più bizzari s’aggirano in quelle classi di cose in cui sono più fatali. Così quest’animale ragionevole è il giuoco della fortuna, ed intanto che ragiona sulla cabala e sulla astrologia non pensa a fissare i limiti della fluttuante ancora proprietà de’ beni; e per colmo di miserie, più gli errori sono grandi, più sono venerati.
Furon perdute le leggi romane e sommerse in quel diluvio di Goti, di Vandali e di tant’altri popoli settentrionali che mutarono la faccia d’Europa, e che lungamente trattenuti nelle selve e ne’ covili del Nord, ritornarono verso di noi decaduto che fu l’Impero romano, le di cui armi vittoriose, poiché gli ebbero cacciati verso il Polo, gl’impedivano di rigurgitare. Nel duodecimo secolo, ai tempi di Lotario II imperadore, ritrovate in Amalfi, per quanto credesi, le Pandette, nacque in Italia con esse il furore de’ commenti e delle interpretazioni. Gran copia di dubbi e di questioni vennero coi paratitli, e colle glose, e coi trattati, e coi consigli; onde render facile il rapire l’altrui col favor delle leggi e difficile l’esser giurisconsulto. Tempi di barbarie eran quegli; le Crociate, ch’erano nel loro maggior vigore, avevano rovesciato l’Occidente contro l’Oriente; e le immense emigrazioni che spopolarono l’Europa la rendeano debole; tutto era disordine e fanatismo.
In questo stato di cose si sbandirono a poco a poco le leggi longobarde, gotiche, saliche e tutte le straniere portate da’ barbari, forse più disprezzate di quello che meritavano. S’introdusse la romana giurisprudenza, e con avida stupidità fu accolta; si credette aver fatta una riforma, quando non si fece che una mutazione. Cominciarono allora Irnerio, poi Accursio, poi Bartolo e Baldo e tant’altri celebri ignoranti ad inondare l’Italia con grossi volumi, e per nostra vergogna pur hanno de’ veneratori e ne sono fornite le biblioteche.
Il decadimento accompagnò le sottigliezze legali, e circondati di libri di giurisprudenza fummo senza leggi. Se il codice è chiaro, i commenti sono inutili o sono un abuso; s’egli è oscuro, i commenti sono tutt’al più un rimedio parziale; conviene rifonderlo o abolirlo. Questa costante verità ha pur veduta Giustiniano, o chi per lui scrisse l’Historia iuris, al titolo De confirmatione digestorum: tempestivum nobis videtur, et in praesenti sancire ut nemo neque eorum qui in praesenti iuris peritiam habent, neque qui postea fierent, audeat commentarios iisdem legibus adnectere nisi tantum si velit eas in graecam vocem transformare sub eodem ordine, eaque consequentia, sub qua et voce romana positae sunt. Et si quis forsitan per titulorum subtilitatem adnotare maluerint, et ea quae paratitla nuncupantur, componere; alias autem legum interpretationes, immo magis perversiones eos iactare non concedimus: ne verbositas eorum aliquid legibus nostris adferat ex confusione dedecus: Quod et in antiquis Edicti perpetui[51] commentatoribus factum est, qui opus moderate confectum huc atque illuc in diversas sententias producentes (contrahentes) in infinitum detraxerunt, ut pene omnis romana sanctio esset confusa. Quos si passi non sumus, quemadmodum posteritatis admittatur vana discordia? Si quid autem tale facere ausi fuerint, ipsi quidem falsitatis rei constituantur, volumina autem eorum omnimode corrumpentur, si quid vero, ut supra dictum est, ambiguum fuerit visum: hoc ad imperiale culmen referatur per iudices, et ex auctoritate augusta manifestetur, cui soli concessum est leges et condere et interpretari. Tali luminose verità ha ridette altrove lo stesso Giustiniano, che previde pure come, a titolo di equità, sarebbersi commentate le leggi, e perciò dispose inter aequitatem iusque interpositam interpretationem nobis solis et oportet, et licet inspicere.[52]
Potrebbesi addimandare perché quella sì profonda venerazione per le leggi romane solo s’astenesse dal rispettare le più salutari di tutte, e queste pur sì chiare non fossero osservate. Ma chi mirerà più da vicino le antinomie, le oscurità, il disordine delle leggi stesse vedrà ch’era proibire gli effetti, lasciandone le cagioni. Poiché non fuvi mai materia al mondo più feconda d’interpretazioni e che più inviti alle glose ed ai commenti, che questo caos di legislazione. E in fatti chi trascorreranne alcuna, massimamente di quelle delle Pandette, vedrà che l’intelligenza loro dipende in gran parte da una vasta erudizione delle cose romane, de’ riti magistrati, costumi della antichità; onde se in altra maniera non fossero state oscure, ciò solo bastava ad un infinito pascolo di commentatori. Intorno a che s’affaccia naturalmente una riflessione, cioè quanto sia assurdo l’avere noi leggi tali, l’intelligenza delle quali è riserbata a que’ pochi che a lunghi studi si consacrarono, scritte in lingua a noi forestiera, quasi che i sacrosanti oracoli della pubblica autorità, regolatori de’ beni e de’ cittadini, norma del lecito e non lecito, piuttosto che palesi ed intelligibili ad ognuno, poiché ognuno vi è obbligato, esser dovessero una scienza difficile e misteriosa, ignota al volgo profano.
Vennero in seguito il gius canonico, gli statuti particolari delle città, e parve allora che le nazioni sentissero il male, ma non osassero di rimediarvi che in parte; le quali leggi, tutte unite al resto, formarono un labirinto di giurisprudenza.
Malgrado tanti volumi, poche sono le leggi scritte, ed è sostituita la tradizione all’uso della stampa. Questa tradizione, chiamata pratica, è in mano di pochi; ella partecipa dell’incertezza comune, ed è conservata con una sorte di mistero sempre funesto ai progressi della ragione. Succede a’ dì nostri quello che si vide in Roma antica, quando il collegio de’ pontefici facea monopolio delle azioni dette actus legitimi, riserbandosi a loro la scienza delle formole e delle solennità dalle leggi prescritte.[53]
Una lunga consuetudine ha annullate molte leggi romane e municipali. Elleno sono inutilmente ne’ nostri codici. L’inosservanza delle leggi può talvolta esser un disordine, ma è bene spesso un niso che spinge la nazione al vero per un interno sentimento onde è animata; né oserei io credere che le buone leggi spiacciano generalmente. Se chiamiamo leggi cattive quelle che sono opposte al pubblico bene, egli è nell’ordine delle umane cose che essendo in contraddizione col ben essere di ciascheduno non sussistano lungo tempo in vigore. Le giuste sono quelle che cercano la più estesa utilità della nazione, e la giustizia cresce loro in ragione del numero de’ cittadini che ne sentano più benigni effetti. Né di tal classe saranno mai quelle che, premiando pochi, offendono molti. Ne paesi del Nord, che con sì rapidi progressi trascorsero l’intervallo che divide la oscurità della gloria, un saggio principe si prevalse dell’opra di due illustri giurisperiti per fare un codice: ha sbandita la cabala forense, tre piccoli volumi in ottavo stabiliscono la pubblica tranquillità. Immiteremo noi sì utile esempio? Dovette Pietro il Grande uccidere di sua mano molti suoi sudditi, ostinati a non radere la barba ed a portare le vesti sino alle calcagna. Una mutazione totale di sistema di giurisprudenza perché troverebbe minori ostacoli?
A. [Alessandro Verri]
IL CAFFÈ )( Fogl. XVII )(
Pensieri scritti da un buon uomo per instruzione di un buon giovine
L’umanità e l’eguaglianza ci proibiscono di amaramente disprezzare gli uomini, ma una giusta diffidenza ci deve render cauti in accordargli la nostra stima. Chi senza scelta l’accorda prova la propria imbecillità, e chi a nissuno la comparte, perché nissuno ne crede degno, mostra di non meritarla per se medesimo.
Non si possono impunemente disprezzare gli eguali; conviene alzarsi o colla forza o coll’ingegno dal comune livello. I conquistatori calpestano il genere umano. Alessandro e Bacco son fatti dei perché opprimevano gli uomini con molte miliaia di uomini; ma chi senza forza osa opprimerli, finisce al patibolo. Non molto diversi sono i principii che vagliono nella privata società: chi di tutti si fida può facilmente essere ingannato, e chi apertamente disprezza gli uomini, non essendo a loro superiore, li ferisce nel profondo del cuore, cioè nell’orgoglio che ha ciascuno, e fassi in ciascheduno un implacabil nemico. Ella è adunque meditazione degna di un uomo socievole quella che ha per oggetto il conoscere intimamente gli uomini ed il grado di stima che gli si compete. Un’esatta e fredda osservazione su di loro non è possibile di sempre fare, poiché bisognerebbe esser di null’altro occupato, come spettattore del genere umano, o aver sempre l’anima in una perfetta tranquillità, situazione più d’ogn’altra favorevole al retto giudizio: ciò non ostante il mettere a profitto i giornalieri avvenimenti, ed il farci, dirò così, una privata cronica de’ rapporti avuti cogli uomini, può fornirci dopo un dato spazio di tempo una metafisica sperimentale di quest’essere non mai abbastanza conosciuto. Seguendo una funesta esperienza dovremmo presuppore che gli uomini che non conosciamo, la probabilità è che siano mal onesti; ma quand’anche l’umana ragione ci conducesse alla scoperta di questa terribile verità, non è nostro interesse spingere sì oltre i nostri pensieri, poiché chi fosse persuaso che quasi tutti gli uomini sono cattivi, odiando ed il genere umano e quasi se stesso come sua porzione, vivrebbe miserabile misantropo fra la noia ed il rancore di un’inutile inimicizia.
Molti ostentano disprezzo per gli uomini, e pochi arrivano a risguardargli con quel disprezzo filosofico che non suppone odio contro di loro, ma bensì un interno conoscimento de’ loro difetti e della picciolezza della loro ragione. Intanto che un preteso saggio parla del genere umano e del volgo come di un gregge di pecore, egli non oserebbe farsi vedere da questo gregge con un abito indecente, e colui che ne’ suoi libretti insulta gli uomini cerca nel medesimo tempo i loro suffragi.
Ci facciamo schiavi in mille maniere. Quanto non serviamo noi alle mode, sieno elleno buone o incomode? Con qual ferreo scettro ci reggono le opinioni di pochi nel vitto nostro, e nel vestire, e sino ne’ nostri pensieri? Quel Seneca ipocrito, che tanto disprezzava le ricchezze e ’l fasto, arrossiva di scorrere Roma in una sdruscita carrozza.
Chi disprezza ed odia gli uomini si dimentica di essere della loro specie, e sovente è da paragonarsi a colui che miratosi la prima volta nello specchio trovossi enormemente ridicolo e deforme. Il riso di Democrito è un troppo grave insulto a tanti mali che opprimon l’umanità; e le nostre stesse pazzie sono sì grandi e crudeli che bisogna o ignorarle o non avervi meditato, per ritrovarle ridicole. Se non fossero inutili le lagrime de’ filosofi solitari, elleno sarebbero al certo un tributo più degno dell’umanità. Ovunque il guardo giri, non vedi che nazioni che distruggonsi per opinioni, per parole, per ambizione, per il desiderio di un bene che mai non acquistano. E inzuppata la terra di sangue innocente, e si contrastano gli uomini il terreno, quasi che non avessero spazio da occupare senza distruggersi! Egli è assistere ad una tragedia l’essere spettatore del genere umano; e v’è chi disse assai ragionevolmente che la storia degli uomini è la storia de’ loro delitti.
La gioventù, che ancora non conosce intimamente quello che vagliono gli uomini, è soggetta al rossore ed alla soggezione. Questi difetti, seppur meritano tal nome, aggiungono grazia e venustà, se non arrivano alla durezza ed inurbanità. Un giovine che ha la franchezza di un uomo dispiace, mal convenendo ad un imberbe mento e ad un aspetto ancora femminile il serio e ’l grave contegno de’ Seneca e de’ Catoni. Un giovine, per quante sieno le sue cognizioni ed il merito del suo cuore, non può a meno di essere, ne’ primi anni che va nel mondo, imbarazzato. S’egli sa le matematiche, la storia e la fisica, egli non sa gli usi del mondo, onde intanto ch’egli passa per un uomo presso Newton, può passare per un animale presso Marseille. Chi ha lo spirito delicato soffre più d’ogni altro la soggezione, perché volendo far buona figura nel mondo, egli è cauto nel parlare e nell’oprare insino a che abbia veduto quello che vi ci si deve fare. Nel tempo che s’impiega in questo esame s’è creduto facilmente uno sciocco. Quel timido silenzio, quella estrema cautela di gesti e di maniere che accompagnano questo tirocinio, fanno vedere un uomo mal sicuro di se stesso: e siccomeché è creduto sulla sua parola chi sa dire francamente: io sono un uomo di merito; così chi non dice che con voce tremante: io ho qualche merito, non è punto creduto. S’ottiene più facilmente la stima dal farsi vedere persuaso di meritarla che col solo diritto a conseguirla. Ma ben presto il velo cade agli occhi del filosofo, e gli si scuoprono quelle rispettate vanità che a primo aspetto si credettero importanti; e ti prepara fra poco a questa scoperta.
La soggezione è cagione dell’imbarazzo nelle maniere, e questo imbarazzo medesimo è cagione di nuova soggezione. Egli è uno stato ben crudele di un giovine pieno di talenti e di cognizioni, che si ritrova esser ridicolo per una riverenza un po’ sconcia o per una pettinatura antica. E chi vi perdona sì gran delitto di lesa decenza, siate pur voi il più saggio degli uomini?
La soggezione è come il timore, che la maggior parte delle volte accresce il pericolo mentre da lui si fugge. Uno sciocco, franco nelle sue maniere, che parla coraggiosamente e che dice il suo parere sopra ogni cosa con altrettanta franchezza quanta ignoranza, è rare volte trovato quello ch’egli è. Basta parlare francamente agli uomini per esser creduto; e se Maometto era meno impostore, gli Arabi non l’avrebbero creduto profeta. Chi dice cose grandi e vere con una voce mal sicura, corre gran rischio di non avere ascoltatori.
L’indiscrezione di taluni vecchi a questo riguardo è grande. Eglino mirano con occhio severo i giovani, né lor perdonano mai di avere più cognizioni d’essi; quasi che l’età e l’esperienza non fossero molte volte mezzi inutili per divenire più rispettabili, essi esiggono da’ giovani una ingiusta schiavitù per le loro opinioni. Decaduti nel corpo, e perduti que’ diritti che solo competono alla gioventù, sono gelosissimi del rispetto loro dovuto, e questo è quasi l’ultimo steccato in cui si racchiudono in mancanza d’altro alimento al loro amor proprio. In fatti, se perdendo la gioventù e tanti beni che l’accompagnano non si supplisse a sì amara perdita con altri piaceri di opinione, la vecchiezza sarebbe insopportabile. L’ambizione e la voglia di essere stimato vengono in sussidio della matura virilità e della vecchiezza, e contrabilanciano in buona parte i beni perduti col fiore dell’età.
Tu, o mio giovine, or meco considera che la soggezione non fa che male, perché ti fa imbarazzato e mal sicuro ne’ tuoi gesti e ne’ tuoi discorsi, il che rende facilmente ridicolo. Ma ti consola, che di rado avviene che abbiano tal difetto gli sciocchi; ardisco anzi dire ch’egli è un sintoma del merito. Quella tua estrema modestia e cautela ben fa vedere che hai l’anima sensibile, e che desideri di essere stimato e temi il ridicolo. Tali sentimenti non sono propri della sciocchezza, la quale, insensibile di sua natura, o sempre ride, o sempre è stupida, o di niente è colpita. Dissiperassi nello spazio di qualche mese quel magico incanto di tanti nuovi oggetti onde sei abbagliato, ed apprezzando gli uomini e le cose per quello che vagliono, stupirai di ritrovarle molto al dissotto di quel valore che la novità accresce a tutte le cose.
Il rossore fu sempre all’occhio dell’anatomico, ed agli occhi del filosofo un segno di un animo sincero e sensibile; non può arrossire se non se chi sente o il rimorso o il ridicolo, due gran persecutori del vizio e due principii di virtù.
La sicurezza di noi stessi s’acquista coll’uso del mondo; si rintuzza in noi la sensibilità alle minime differenze coll’uso giornaliero, e facendo il paragone degli altri uomini con noi, sovente vediamo che molto a torto eravamo persuasi della picciolezza della nostra ragione. Si crede un giovine che a lui mal convenga l’arrossire; ma come egli è un vezzo alle vergini, lo è egualmente a’ giovanetti. La modestia delle maniere abbellisce questa tenera età, e sarebbe tanto dispiacevole un vecchio vergognoso quanto un giovine sfacciato. Alla vecchiezza non ben s’unisce la timidità e la soggezione, perché è segno di stupidità e di avvilimento l’apprezzare a dismisura gli uomini, malgrado una lunga sperienza che apprender ci deve a darli il loro giusto valore; e se un lungo uso delle cose umane non rende un uomo libero e sicuro di sé, egli è certamente uno spirito che non si solleva dal comune livello. Sotto alle chiome canute può egualmente abitare un’anima sciocca come una sublime, e puossi con una lunga esperienza non altro acquistare che una sciocca confidenza di sapere. Molti esempi ci provano che decade lo spirito col corpo; perduto il vigore e la forza di quello, i pensieri sembrano partecipare della sua vecchiezza: quindi la forza della immaginazione si perde colla gioventù, e con essa le grandi passioni, solo atte a far grandi imprese. Quasi tutti gli uomini straordinari cominciarono le loro gesta dal fiore degli anni. Allora la natura è tutta in moto ed in fermento, ed è pronta a produrre grandi vizi, s’è mal diretta, e grandi virtù, se bene.
Qualunque tu sia, o giovine, che in faccia de’ vecchi t’impiccolisci, e credi superiorità d’ingegno quella che sovente non è che il tardo frutto di una lunga esperienza, sappi che questo istesso timore è un principio di virtù; egli è una stima del merito, una mordace invidia dell’altrui sapere; passioni atte ad ornarti in appresso di mille buone qualità. In somma tutti que’ difetti de’ giovani che hanno per origine la sensibilità non sono sì fatali come si credono comunemente, perché questa sensibilità istessa, ben diretta, produce gli uomini grandi; ma colui che nel fiore degli anni ha una fredda moderazione ed una timida prudenza, né mai si slancia e si trasporta dall’entusiasmo della virtù, è condannato ad esser sempre volgare. Si osserva che ne’ fanciulli è di cattivo presagio un prematuro giudizio ed una anticipata serietà, che dinota tardità di spirito o simulazione. La libertà, la follia, la sincerità grande e naturale sono sintomi di un’anima sensibile e vera, e da queste qualità ben impiegate possonsi avere grandi profitti. Nella gioventù ancora ha luogo il brio e la giocondità; e quanto volontieri sbandirei quel severo pedantismo che predica immaturamente la gravità e la senile prudenza! Guai a costoro che vorrebbero che il fuoco giovanile, fiamma produttrice di quell’estro divino di virtù, che ci solleva dal fango in cui siamo sepolti, fosse sopito o estinto da’ volgari precetti di un rigido stoicismo! Un giovine, e forse un uomo senza errori, mi è molto sospetto, e chi non è capace di aver difetti non è capace di avere umanamente grandi virtù. Vorrei che da queste riflessioni imparassi a conoscerti; vorrei che non t’avvilissi ai sardonici sorrisi de’ gravi ignoranti, che altrimenti non onorano lo spirito e la vivacità de’ pensieri; vorrei che udendo decidere da un prudente Catone, che ricuopre la sua dabbenagine col manto dell’impostura, osassi sottoporre all’esame della ragione tutte le proposizioni, decidendole per vere o per false, secondo il criterio della verità, criterio che puossi avere alli vent’anni quanto alli cento; vorrei che fossi persuaso che gli uomini più si stimano, piucché si vedono da lontano; ma più che con la mia penna, avrai con che disingannarti dall’esperienza istessa del mondo. Solo che tu sia ne’ primi mesi cauto ed attento, e che più ascolti di quello che sia ascoltato, più osservi di quello che sia osservato, tu avrai campo di fare la salutare infallibile scoperta, pubblicata sino 2794 anni fa, che infinita è la schiera degli stolti.
Ma guardati bene dal disprezzare que’ rispettabili uomini, che altro non perdettero cogli anni che i pregiudizi e gli errori, ed a’ quali l’età ha accresciuta la esperienza delle umane cose, avendone acquistato un ragionato conoscimento. Questi adorabili vecchi, che portano una robusta ragione sotto un corpo lacero negli affari della guerra e della pace, esiggono una sincera venerazione da qualunque buon cittadino. Questi amano per lo più la gioventù, né mirano in lei un oggetto d’invidia, ma si compiacciono quasi in lei di quello che essi furono, ed amano la docile ragione di quella età, che non essendo incallita nell’errore, se ne spoglia facilmente. In fatti, se v’è un vecchio che non pensi volgarmente, di chi può egli acquistarsi li suffragi e la stima, se non de’ giovani? Come oserà egli farsi nunzio della verità a que’ dispettosi talenti che corroborarono con più anni i paralogismi? La posterità sola rende giustizia al merito, perché ella giudica imparzialmente, e puossi chiamar posterità riguardo de’ vecchi la tenera gioventù, che nuda egualmente di sapienza e di errore, è atta a ricevere le grandi e semplici verità, che non arrivano che a’ cuori scevri dal dispotismo de’ pregiudizi. Se Socrate fosse stato giudicato dall’imberbe gioventù, non avrebbe bevuta la cicuta. La semplicità delle idee conduce al vero, perché ella si limita a meditare i pochi e chiari rapporti delle cose. L’abuso solo della facoltà ragionatrice, nata nell’aule e nelle università, ha aperto quel fatale vaso di Pandora d’onde sortirono le insulse sottigliezze e le fastose scioccherie, onde parlerebbe più volontieri il filosofo collo stupido selvaggio che coll’inconvertibile peripatetico, facendo meno di paralogismi un cane che un falso filosofo.
Devesi pure aver grande toleranza del mal umore onde si risentono i costumi della attrabilare vecchiezza; e come albergherà la gioia e la giocondità in un corpo mal sano e distrutto, e per quale indiscretezza esiggere che s’unischino alla gotta ed alla colica gli scherzi ed i motteggi della sana e ridente virilità? Ella è pure una inumanità, che non può cadere in un nobil cuore, il burlarsi della bruttezza e ridicola figura de’ vecchi rispettabili. Le qualità del loro animo e la loro vecchia probità ben ricompensano questi piccoli difetti, e la compassione vuole che non ci burliamo di que’ mali che ci possono accadere un giorno.
Gli usi della vita civile ci privano di mille piaceri, e la tirannia di questi ridicoli costumi s’è portata sino sulla virtù, in guisa tale che non possiamo essere alcuna volta onesti senza temere il motteggio. Quel ridicolo che spargesi nelle corrotte nazioni sullo spirito di patriotismo ritiene non pochi nella servile prudenza di non metter mano agli abusi, perché rispettati sono comunemente. E quanti piangono quasi di nascosto alla Zaire, perché temono gli scherni di un vicino che sbadiglia quand’egli è tutto in lagrime? Per timore del disprezzo ancora vedonsi tacere i grandi geni in faccia dell’ignoranza, perché tanta vergogna hanno i grandi uomini a dire e scrivere cose grandi e sublimi agli sciocchi, che non li ponno sentire, quanta ne avrebbe uno stupido di dire le sue scioccherie ad un uomo che crede grande. La distanza che li divide è immensa, e si risguardano l’un l’altro con un reciproco disprezzo, colla differenza che i saggi disprezzano ma non odiano gl’ignoranti, ma in questi talora s’uniscono questi due sentimenti.
Il vizio e la virtù hanno grandi obbligazioni al motteggio, ed è fra le cose che più possono su gli uomini, tanto per ritrarli dal male quanto per condurli al bene: egli prende più di mira la virtù che il vizio, essendo questo alle volte sì grande e sì deforme che non puossi renderlo ridicolo, dovecché l’entusiasmo della virtù gli è sempre vicino; fa un passo e vi arrivi. Pochi sono gli uomini trasportati verso il grande da una forza trionfatrice a cui resistere non possono, e questa classe di uomini corrono gran rischio di essere creduti pazzi e stravaganti dal volgo, e con questa espressione io comprendo gran parte del genere umano. Chi potesse indurirsi ai motteggi ed agli insipidi scherni, sì comuni in quel grande stuolo di oziosi che sente più il ridicolo che il grande, avrebbe di già guadagnata una insigne superiorità su gli uomini. Colui che non teme la morte può temere il ridicolo; e quel valoroso difensore della patria che in battaglia è prodigo del suo sangue volontariamente, non avrebbe il coraggio di mostrarsi in una assemblea vestito diversamente dall’uso comune. L’idolatria alle opinioni comuni è una sorgente di mille errori, a’ quali ci diamo in preda per mancanza di coraggio di paragonarle colla ragione. È perdonabile anche al filosofo il vestirsi, e l’avere una carrozza, ed una casa secondo gli usi de’ tempi ed alla moda, ma il vero è lo stesso in tutti i secoli ed in tutte le parti del globo, né si cangia colle rivoluzioni de’ tempi e della fortuna. Invariabile, egli non teme né l’esame, né gli assalti della maligna falsità, che può bene oscurare colle ali notturne la sua luce, ma non può estinguerla.
Ella è ben ridicola la piccola vanità con cui si serve alle opinioni ed usanze ricevute, ed il vedere come taluni si pascolano di quelle piccole idee che devono la loro esistenza all’ozio degli sfacendati. Sogliono taluni giudicare i filosofi all’abito ed agli inchini, né sono persuasi che sotto una parrucca mal concia possa alloggiare un’anima grande e pensatrice; ed è cosa più scandalosa il non avere l’abito alla moda di quello che sia essere piacevolmente mormoratore. Gli uomini grandi sono rare volte curanti di questi miserabili costumi; la vanità loro, cioè l’ambizione, è grande, le loro mire sono più alte, e sprezzano altrettanto i capricci degli uomini e le loro instabili opinioni quanto chi lor rimprovera di non apprezzarle. Concludi meco adunque, o mio giovine, che una ragionata non curanza del volgare degli uomini è utile e ci toglie mille incomodità della vita; se fia che ti si sollevi l’anima a questa filosofica libertà, allora mirerai ora ridendo, ora piangendo, le pazzie, le crudeltà degli uomini; vedrai che i grandi ingegni soltanto arrivano a torsi dalla schiavitù de’ pregiudizi; vedrai che i mediocri gli onorano e li mantengono, quasi che fosse una liturgia onde occupare il loro ozio e la loro ignoranza; e che l’uomo dabbene compiange gli errori del genere umano, lo ama, gli fa bene se può, non gli fa male anche potendo; ma che non comparte una cieca stima per esseri non mai conosciuti, e che la riserva alla probità, alla beneficenza, in somma alla virtù, che non toccò mai in retaggio alla moltitudine.
Tali sono i documenti indirizzati ad un giovine da uno di quegli uomini che stimano i talenti in qualunque età. Forse non vi è molto ordine o concatenazione fra di loro; ma non sono per questo meno ragionevoli, il che più importa. Anzi avviene che un certo ordine pedantesco, una certa forzata unione e lisciamento de’ periodi e di passaggi comuni ad ogni rettorico, tolgano l’energia delle cose. Se ti si presentano due idee importanti, benché diverse, perché cucirle malamente fra loro, per non esser tacciato di poco metodo? Le buone idee sono esseri sì preziosi che a costo d’ogni episodio io credo che si debbano scrivere; e chi ha il coraggio di rifiutare un buon pensiero in ossequio della lingua o dell’ordine, conviene ancora che abbia coraggio di essere mediocre, se pure già non lo è, quando fa lo svantaggioso cambiamento delle cose colle parole.
A. [Alessandro Verri]
Saggio d’aritmetica politica
Ogni mille uomini ve ne sono 750 capaci di lagnarsi; ve ne sono ducento capaci di ridere; ve ne sono quaranta capaci di non far male agli uomini di merito; ve ne sono otto capaci di onorare il merito; e due di merito. Qui resta pregato il benigno lettore a credere fermamente ch’egli ed io siamo veramente i due fra i mille.
Ogni mille uomini che dicano di essere ignoranti, non ve n’è nemmen uno che non lo sia; non ve n’è nemmen uno che creda veramente di esserlo.
Ogni mille uomini che accumulano denaro, ve ne sono ottocento trenta che soffrono tutta la lor vita i mali della povertà; ve ne sono cento quindici che fanno un po’ di bene agli altri prima di morire; ve ne sono cinquanta che possono goderlo con animo tranquillo, e cinque che l’impiegan bene.
Ogni mille donne che dicono d’essere brutte o vecchie, non ve n’è una che non lo dica per intendersi sostenere l’opposto.
Ogni mille letterati, ve ne sono novecento che lo fanno per cercar pane, fortuna e gloria; ve ne sono settanta che lo sono per assorbire le ore e non annoiarsi; ve ne sono venti che non sono gelosi dello ingegno altrui; e ve ne sono dieci che coltivano l’ingegno per rendere se stessi internamente migliori.
P. [Pietro Verri]
[Qual sia il miglior ingegno]
Il giudizio è un’operazione della mente per far bene, la quale sembra richiedersi non già una vivace volubilità d’idee, ma bensì una tranquilla pacatezza. Nel giudizio si devono contemplare gli oggetti da tutti i differenti punti da’ quali diversamente compaiono; si devono esaminare esattamente le relazioni che un oggetto ha coll’altro; una differenza, benché menoma, dimenticata ch’ella s’abbia, ci espone all’errore. Fralle qualità della mente umana, quella di rettamente giudicare è la prima di tutte, in quella guisa appunto che fralle proprietà dell’occhio la principale si è di veder bene gli oggetti e di distinguer bene la loro grandezza, la loro distanza e la proporzion loro; la vivacità, la bellezza dell’occhio sono realmente le qualità secondarie.
[Pietro Verri]
[Quai sieno gli uomini grandi]
Son molto inclinato a credere che tutti quegli uomini singolari, che per pubblico suffragio delle nazioni e dei secoli si chiamano grandi uomini ed eroi, non siano in realtà che grandi uomini del second’ordine; poiché qual è stato il principal motivo delle loro grandi azioni? L’amor della gloria. E che altro ella è mai questa gloria, che una chimerica riunione dei suffragi degli uomini in favor nostro? La chimera non ne impone ad un animo che abbia la robustezza di accostarvisi ed esaminarla da vicino. Un istante di felicità sulla bilancia del filosofo pesa più di un secolo di ricordanza presso i posteri. So benissimo che nelle più difficili imprese e laboriose l’eroe istesso non vi s’ingolfa che per amore della felicità; ma so ancora che ivi per ciò la cerca, perché mal ne conosce la vera indole. Se questo ragionamento regge, i grandi uomini veramente del primo ordine saranno stati quelli dei quali non sappiamo il nome.
[Pietro Verri]
[L’ambizione]
Chi pensa a far fortuna, lavori per liberarsi dagli ostacoli che potrebbero trattenerlo dal correre quando l’occasione si presenti; uomini ambiziosi, tocca a voi a star pronti per profittare del momento felice; ma il far nascere questo momento non dipende da voi. Rari son quegli uomini ai quali nel corso della vita non siasi presentata qualche fortunata occasione per migliorar la lor sorte; l’uomo indolente non vi si era preparato, e l’occasione passò vuota per lui; l’ambizioso era già all’ordine, e poté seguirla, e migliorò la sua sorte.
[Pietro Verri]
IL CAFFÈ )( Fogl. XVIII )(
[La medicina]
Amico Demetrio.
Dite agli scrittori del Caffè ch’io sono un giovane che sto per incamminarmi nella carriera di fare il medico, e che da molto tempo aspetto che scrivano qualche articolo sulla professione ch’io voglio intraprendere; essa ha molta influenza certamente sulla vita degli uomini, e merita che di essa si parli. Vi prego, amico Demetrio, fate sì che ne parlino una volta; ed avrei molto piacere se ne parlassero in guisa di farmi un piano del sistema che essi credon buono per riuscirvi felicemente. Addio.
V’è un sistema buono per farsi un buon medico, e v’è un sistema buono per farsi volgarmente stimare un buon medico; rare volte questi due sistemi possono eseguirsi dalla stessa persona. Un giovane deve scegliere fra queste due strade. Se avete nell’animo un generoso amore della verità e tale da ricompensarvi coi progressi che andrete facendo della contenzione che vi farà d’uopo usare per instruirvi; se preferite la stima degli uomini illuminati all’applauso volgare ed alle ricchezze che gli vanno compagne; se avete in somma di mira o la gloria o una dilettevole occupazione per voi nello studio della medicina, allora appigliatevi al sistema di formarvi un buon medico. Ma se all’incontro voi ricercate il pane e propostovi tal fine volete interporre i più brevi, comodi e più sicuri mezzi per ottenerlo, scegliete il sistema di farvi volgarmente stimare un buon medico.
Io do un’occhiata generale all’Europa, e dico che se prendiamo tutt’i medici europei in complesso, ella sarebbe cosa molto problematica il decidere se siano più gli uomini ammazzati o risanati dall’arte loro. Se prendiamo dunque la medicina non per quello che mi si dice che dovrebb’essere, ma per quello ch’ella è in effetto, ella è un’arte che non si può riporre fralle benefiche senza usare di molta indulgenza. Facil cosa è il comprendere ch’io in questo senso intendo colla parola medicina non la scienza per sé, ma la somma delle azioni che i medici in complesso esercitano su i corpi umani.
Se l’amor della scienza stessa vi porta alla medicina, riflettete al bel principio che la medicina altro non è che la fisica applicata al corpo umano, cioè a quella macchina la quale anche al dì d’oggi è molto imperfettamente conosciuta, e non lo sarà forse mai in tutta la sua estensione. Le parti nobili del corpo umano non potiamo noi vederle mai nell’esercizio loro, ma bensì inerti e già mutate da quel fenomeno insigne che chiamasi morte, per cui dallo stato di materia organizzata passa la spoglia umana a quello di semplice materia: né coll’aiuto de’ nostri sensi, benché assistiti da’ più perfetti stromenti ottici, possiamo noi ragionevolmente lusingarci di seguitare l’organizzazione sino ai minimi elementi da’ quali forse deriva il principio fisico del moto, della circolazione, della traspirazione, del nodrimento e di tant’altre riparazioni e perdite e modificazioni diverse di materia, che rendono mirabile egualmente che oscura l’indole di un corpo organizzato.
Che se sì denso è il velo che ci nasconde i principii per i quali vive, movesi, genera e si nutre un corpo posto in sanità, cioè un corpo posto in quello stato sul quale ci è lecito fare maggior numero di sperienze, poiché stato comune alla maggior parte degli uomini; quanto più dovete voi credere che siano oscuri i principii che guastano l’ordine della economia animale, e fanno passar l’uomo dallo stato di sanità a quello di malattia! Quello ch’io chiamo stato di sanità non è quello stato di perfetta sanità che non potrebbe trovarsi che in un corpo immortale; poiché se tutte le perdite nostre venissero risarcite per l’opera di visceri perfettamente sani, sarebbero le nostre perdite perfettamente risarcite: quindi non conosceremmo né la vecchiaia, né la morte naturale: chiamo dunque stato di sanità quello in cui nessun dolore, nessuna lassitudine, nessun fenomeno apparente ci avverte d’alcun disordine avvenuto nel sistema della organizzazione nostra.
V’è molto maggior differenza fra malattia e malattia di quella che non vi sia fra un corpo sano e un corpo sano. Dirò di più: forse non si sono vedute da Ipocrate a questa parte due malattie perfettamente eguali. Pare che le leggi universali colle quali è diretta la fisica sieno costanti e inviolabili; ma pare altresì che i fenomeni particolari, ossia le combinazioni de’ principii invariabili, sieno variabili all’infinito; e come forse da Ipocrate a questa parte non sono comparse sulla terra due figure d’uomini perfettamente simili; come forse da Ipocrate a questa parte non sono comparse sulla terra due foglie d’albero perfettamente simili; così per analogia facilmente può credersi che due malattie perfettamente simili non si sieno ancora date da che gli uomini hanno trovata l’arte di trasmettere alle generazioni venture i loro pensieri colla stabile testimonianza della scrittura. Cosa molto più facile è sempre il comprendere come una macchina ben costrutta eserciti le sue azioni, di quello che non lo sia il prevedere e definire tutte le cagioni straniere e intrinseche per le quali può essere interrotta ne’ suoi movimenti.
Da queste brevi riflessioni ne deduco una conseguenza; ed è che sempre sarà molto incerta e ne’ suoi principii e nella applicazione di essi principii la medicina; e che un filosofo che ne faccia la professione, adoperata che abbia la più scrupolosa diligenza ne’ casi particolari, avrà costantemente compagno un cauto dubbio ed un pirronismo ragionevole, che lo porterà sempre ad ommettere anzi che ad eccedere operando.[54] A questo termine proponetevi dal bel principio di giungere, e sappiate che quello che è stato detto forse troppo generalmente delle scienze tutte, cioè che le estremità loro si toccano, e che al principio e al termine egualmente trovasi l’ignoranza, ciò particolarmente è proprio della medicina, in cui quando siete mediocre vi credete a parte de’ secreti di natura, ma a misura che fate progressi e che esaminate con maggiore analisi le vostre nozioni, scema il numero de’ secreti svelati, e vi accostate all’ignoranza dotta, che resta al termine della carriera.
Cosa ridicola in verità si è il leggere alcuni autori di medicina, e specialmente di bottanica, anche accreditati; non v’è erba che non risani da qualche malore, non v’è malattia che non abbia più erbe prontissime a sradicarla: pare, leggendoli, che non vi sia ormai più maniera di morire, se non per gl’ignoranti. All’occasione poi vediamo l’effetto di tante pompose promesse.
La medicina è dunque un’arte di sua natura molto circoscritta e che merita il nome di conghietturale che le vien dato; ma s’ella non fa agli uomini tutto quel bene che se ne promette il volgo e che ne vanno proclamando i ciarlatani addottorati, pure in mano d’un illuminato e onesto uomo, ossia, in una parola sola, in mano d’un filosofo, ella è un’arte che non solamente serve a provare sin dove giunga l’industriosa ricerca dell’ingegno umano, ma serve ancora a recare solidi beneficii all’umanità, o prevenendo le malattie o risanandole.
Ma, per giungere a ciò fare, primieramente io ricercherò da un giovane la preparazione alle scienze, cioè una costante abituazione del suo intelletto di far l’analisi delle proprie idee, di definire esattamente ogni vocabolo, di tessere in somma quasi in catena ben costrutta i propri ragionamenti, cosicché il desiderio della verità sia in esso sempre più robusto della inerzia, alla quale forse più che ad altre cagioni dobbiamo attribuire la parte maggiore de’ falsi ragionamenti degli uomini. Se questa disposizione dell’animo, che i scolastici chiamano Logica, è il primo fondamento delle umane cognizioni, se questa è la sola scorta che può farci fare progressi nelle scienze tutte, a più ragione dev’ella essere indispensabile laddove si tratti d’una scienza di conghietture, dove l’ommissione d’un dato solo o d’una osservazione ci porta a conseguenze talvolta perfettamente opposte.
Una mente chiara, ragionatrice, vogliosa di fare agli uomini quel bene che può loro farsi colla medicina, conviene che sia in istato di ben comprendere i libri scritti in latino ed in francese. Ogni discreto lettore comprenderà benissimo ch’io col vocabolo latino non intendo la lingua de’ curiali o de’ scolastici, lingua che non intenderebbe né Cicerone, né Livio, né Tacito, se dovessero essere condannati a leggere le tante belle cose che con essa lingua intermedia fra la latina e l’italiana sono state scritte per la felicità, se non delle nazioni, almeno di alcuni pochi che mettevano a profitto la pubblica bontà. Conviene che un giovane che vuol farsi medico davvero intenda dunque la buona lingua latina, quale la scrissero molti eccellenti medici, e così dicasi della lingua francese.
Io non vi farò qui una lunga declamazione da pedante, per provarvi che per guarir le malattie e per ragionare in medicina sia necessaria la statica, l’idrostatica, la geometria, l’algebra e tutte le altre parti della matematica; molta impostura v’è certamente in sì fatti discorsi, i quali li ripetono alcuni poeti, li ripetono alcuni medici e persino alcuni curiali, quasi che le loro occupazioni esiggessero l’Enciclopedia; dirò bene che le cognizioni della fisica universale sono necessarie, poiché, come ho già accennato, la medicina è l’applicazione della fisica al corpo umano. Convien dunque che abbiate una idea di quello che gli uomini hanno osservato sulla natura del calore e del freddo, sulla dilatazione e condensazione de’ corpi, sull’intestino loro moto, sulle leggi del moto, sulle leggi della gravità, sulla vegetazione, sulla generazione e simili oggetti risguardanti la fisica. Nemmeno io esiggerò da voi che siate un perfetto bottanico, cosicché conosciate il numero, la famiglia e la proprietà d’ogni filo d’erba. Nemmeno esiggerò io da voi che siate un chimico, e che conosciate per nome e per figura tutti i sali alcali, tutti gli acidi e tutt’i caratteri mezzo arabi e mezzo gottici co’ quali si rendono venerande assaissime inezie. A me basta che affatto non siate digiuno di queste materie, e che sappiate all’occasione quai sieno gli autori migliori da consultarsi, per conoscere se accade qualche cosa fondatamente.
La notomia sì, che dovete saperla; ma dovete sapere la notomia ragionata e comparata, non già la sterile nomenclatura delle ossa, dei muscoli, dei tendini e delle altre parti che formano il corpo dell’uomo. Sieno otto o sieno quattro i muscoli dell’occhio, sieno sette o sieno cinque i muscoli del basso ventre, questo poco importa saperlo al medico; son questi oggetti che interessano la chirurgia o il disegno. Ma sapere come o per qual mirabile meccanismo il cibo nel ventricolo cangi natura, come frammisto al fiele prenda il colore dal chilo, come la parte più sottile filtrandosi per alcuni minutissimi canaletti giunga nella cisterna del Pequet a distillarsi in un latte puro, come questo frammisto al sangue ripari le perdite di esso sangue, da cui si fanno continue secrezioni; come queste secrezioni sieno sì diformi fra di loro, sebbene tutte emanate dallo stesso principio; ma il conoscere come circoli il sangue, qual sia il primo mobile che lo spinge; come non rigurgiti, né prenda mai un moto contrario, come per esso si riparino le perdite de’ muscoli, delle vene, delle arterie e persino delle ossa; come dallo stato d’un fluido passi una particella di esso sangue a quello d’un perfettissimo solido: queste sono le mire che convengono a un medico.
Poiché siate a questo segno disposto, e per la felice disposizione della mente e per le cognizioni delle lingue e per la notizia delle cose fisiche e per un ragionato sistema di notomia, allora consacratevi alla medicina, scegliete gli ottimi autori, ed ivi esaminando i loro sistemi e meditando sulle diverse sorti di malattie da essi esposte, su i fenomeni che le accompagnano, su i rimedi che giovano e sulle opinioni loro delle cagioni, instruitevi e approfittate dei lumi e della pratica di molti secoli.
Ridicola pretensione in vero si è quella di coloro i quali cercano di cuoprire la ignoranza loro nella teoria della medicina vantando la pratica in favor loro. Vastissima è pur troppo la serie dei disordini ai quali è soggetta la macchina del corpo umano, e in paragone di essa la vita di un uomo è un lampo passaggero. S’egli è vero che da Ipocrate a questa parte forse non si sono vedute due malattie esattamente simili, come potrà mai sperare un uomo solo che dopo alcuni pochi anni di proprie osservazioni le malattie che gli si presentino sieno continue repetizioni d’altre malattie da lui vedute, il che vorrebbe dire la voce pratica? Ipocrate era il decimonono medico di sua famiglia, e aggiungeva la propria pratica a quella di diciotto generazioni che gliela avevano trasmessa, e forse anco diciotto generazioni sarebbero state non bastanti a compilare gli Afforismi, se ad esse non si fossero aggiunte le innumerevoli tavolette appese al tempio d’Esculapio, contenenti l’esatta descrizione di una vastissima serie di malattie. Allora fu che dopo la sperienza di molti secoli e dopo una sterminata serie di casi raccolti, venne dato il distinguere quelle poche leggi universali che son comuni a molte malattie, e che infiniti diversi fenomeni somministrarono il filo per riascendere ad alcuni principii. Le osservazioni, le sperienze, e più forse i casi fortuiti e gli errori medesimi di molti secoli che vennero dopo, accrebbero il materiale della scienza; da tutto quest’ammasso ereditato dalle generazioni passate un buon medico cerca di dedurne la sua pratica, la quale diventa la pratica di più secoli, la pratica di molti uomini condensata in un uomo solo; e questa è la vera pratica rispettata dai saggi, da cui può sperarsi giovamento.
Come per diventare un pittor valente non bastano le osservazioni su i disegni, sulle statue, sulle pitture e su i bassi riglievi, ma vi vuole il nudo medesimo; così nella medicina conviene che il medico contragga una sorte d’abitudine cogli ammalati, la quale presentando a’ suoi sensi i sintomi diversi delle malattie con maggiore efficacia di quello che non lo possono fare le descrizioni o gl’intagli, lo renda più sicuro di se medesimo. Non vi consiglio però di prendervi questa per principale occupazione. La principale deve essere su i libri, e chi predica il contrario cerca di farvi un buon infermiere tutt’al più, non mai un buon medico; ma secondariamente unite alla speculazione tranquilla del vostro studio anche l’uso di esercitarla sugli ammalati.
Ma del polso che diremo noi? Oseremo noi in questo foglietto svelare gli arcani dell’arte ed esporci alla vendetta dei pseudo-medici, per dar materia di pensare ad alcuni pochi? La dimostrazione sarebb’ella capace di far fronte ad una opinione venerata per secoli e sostenuta dalle continue declamazioni di quanti vogliono parer medici, senza essersi presa la briga di diventarlo? Io voglio osarlo, e vuo’ scrivere una proposizione scandalosa, empia, nefanda, abominevole; ed eccola: la cognizione del polso val poco a illuminare un medico. Io vi comincio a dire che Ipocrate, e tutta la sua scuola, non ha mai fatto gran caso del polso; che l’osservazione sulla pulsazione dell’arteria si è cominciata a fare dai Chinesi, poscia gli Arabi la posero in credito, e questo credito andò forse per arte d’alcuni a tal segno crescendo, che finalmente alla pulsazione dell’arteria si vennero ad attribuire tali proprietà da renderla la verga divinatoria della medicina.[55]
Non pretendo io già di dire che la pulsazione dell’arteria non sia un fenomeno da osservarsi in ogni ammalato, come s’osserva il calor delle carni, il colore del volto, come s’osservano gli occhi, la lingua, la flessibilità delle viscere, la libertà della respirazione, le secrezioni del sangue e simili; dirò di più, che la pulsazione dell’arteria essendoci una guida per conoscere presso poco lo stato della circolazione del sangue, ella è un sintomo da osservarsi anche con particolare attenzione. Ma il pretendere colla pulsazione dell’arteria di distinguere una ad una le infinite malattie, il pretendere colla pulsazione dell’arteria di conoscere i progressi e le diverse vicende de’ mali del corpo umano, questo è un pretendere cosa di cui compare l’assurdità per poco che vi si rifletta.
Primieramente il moto del sangue con somma facilità si altera nel corpo umano coll’urto semplice d’una passione anche non forte; secondariamente riflettete che tutte le variazioni possibili ad accadere nella pulsazione dell’arteria si riducono a quattro elementi, e sono diversità di tempo, diversità di luogo, diversità di forza, diversità d’ondulazione. Quattro elementi non possono produrne più che ventiquattro combinazioni, come avrete veduto alla pagina 8 di questo foglio periodico; dunque il polso non potrebbe indicare tutt’al più che ventiquattro stati diversi del corpo umano, non mai la serie quasi infinita de’ stati pe’ quali realmente può passare. Ma direte, questi stati sono suscettibili di molte differenze di più o meno; va benissimo; ed io vi pregherò a dirmi se col semplice tatto (senza un esatto orologio alla mano che vi segni i minuti secondi, e i terzi, se fosse possibile) si possano definire le minime differenze? Vi domando se credete possibile che un polsista possa paragonare matematicamente la celerità o equi-distanza del polso della sera con quello della mattina? Vi domando se dopo il toccamento di tanti polsi, quanti ne esaminano i polsisti, sia sperabile questo esatto confronto? Gran bella scoperta ch’è stata quella del polso! Chi vuol farsi credere medico, sebbene non sappia render ragione della sua professione, sebbene sia un perfetto ignorante, s’appoggia alla perizia del polso, riclama un dono di natura intrinseco a lui di conoscere tutte le malattie dal polso; e il volgo gli perdona la sua ignoranza, si fida de’ suoi toccamenti, lo crede capace di risanare e lo paga abbondantemente. Se poi due o tre polsisti si conducono separatamente a visitare un ammalato, senza che si siano potuti fra di loro concertare, uno dirà che non v’è febbre, l’altro che v’è febbre; uno dirà che entra, l’altro che va in declinazione; del che rari sono gli uomini che non ne abbiano avuto più d’un esempio sotto gli occhi in vita loro; esempio il quale solo basterebbe a convincere.
Se meno si sostenesse l’opinione del polso, sarebbero costretti coloro che vogliono fare il medico ad instruirsi, e minore sarebbe il numero delle infelici vittime dell’ignoranza. Io per altro trovo cosa degna di riflessione il vedere come in molte città della nostra Italia si sottopponga ai più imparziali e rigidi sperimenti un uomo che cerchi d’essere maestro di cappella di qualche cattedrale, e si facciano rigorosi esami e disappassionati giudizi per eleggere il più armonico fra i concorrenti; e nessuna città, ch’io sappia, adoperi la metà di altrettante cautele avanti di permettere a un uomo di operare sulla vita dei cittadini. Io credo veramente che una distonazione sia un minor male nella repubblica di quello che non lo sia un omicidio.
Ritorniamo al proposito nostro. Se volete dunque essere buon medico, io v’ho in breve indicata la strada che a me pare la buona per diventar tale. Due avvertimenti mi rimangono ancora, e ve li dirò tosto; appartengono essi alla buona morale. Primieramente siate in guardia sopra voi medesimo, acciocché i frequenti spettacoli della notomia e l’abituazione di veder soffrire gli uomini non incallischino in voi quel dolce e benefico principio di sensibilità che produce la compassione, ossia il patimento de’ mali altrui. La maggior parte delle virtù umane viene da questa sorgente, ed ogni animo ben fatto deve procurare di mantenersela intatta e delicata più che sia possibile. In secondo luogo sovvengavi che gli ammalati sono uomini più deboli per lo più degli altri, i quali affidano alla vostra dottrina, e all’onestà vostra la loro vita e le loro debolezze; sovvengavi che se passando d’una visita all’altra voi vi faceste giuoco della debolezza altrui, e se faceste servire a rallegrare gli sfacendati i racconti di quanto vedete o udite nelle famiglie che in voi confidano, sovvengavi, dico, che voi sareste agli occhi vostri medesimi, non che a quelli d’ogni onorata persona, un vero infame uomo, un uomo indegno della stima d’ogni animo bennato, un mostro in somma da far ribrezzo a qualunque è capace di virtù. La secretezza e la discrezione sono due virtù particolarmente necessarie a un medico onorato.[56] Eccovi in somma additata la strada per diventare buon medico. Quando lo sarete, aspettatevi che il volgo de’ pretesi medici vi fugga, aspettatevi che disemini di voi che avete della teorica, ma non valete in pratica; aspettatevi di ottener poco lucro e molte persecuzioni; e cercatevi una di queste tre cose, che sono le sole colle quali potrete passare la vostra vita al coperto della cabala o un nome procuratovi colle opere stampate, o un sovrano che con tutta la sua forza vi protegga, ovvero l’oscurità d’una vita ritirata che vi celi ai morsi dell’invidia.
Se poi vi bastasse l’essere volgarmente creduto buon medico, fate il vostro giro alle scuole pubbliche, fatevi addottorare, mettetevi a correr le strade in seguito a qualche buon polsista, rompete molte scarpe, imparate a scrivere una ventina di ricette, imparate a mente una quarantina di parole greche, una trentina di afforismi d’Ipocrate, celebrate le virtù del polso, arricchite la lingua colla creazione di nuove frasi e parole nuove, ricevete le pensioni che vi verranno assegnate, e sopra tutto pregate il Cielo che i lumi della sana filosofia non continuino a fare i progressi che tutto dì vanno facendo in Europa.[57] Conchiudo il mio ragionamento con tre ottave tolte da un poema inedito d’un autore che pensava presso poco come penso io.
Oh genti! oh genti! oh voi, che avete in cura | De’ cittadini conservar la vita, | Aprite gli occhi. Oh quanti mai ne fura | Degli impostori medici l’aita! | Di quanti va nella magione oscura | L’alma sdegnosamente dipartita, | Perché affrettata vien l’ora fatale | Da un medico, che è medico stivale! | Poniti a letto, fossi anche un atleta, | Fossi anche un toro, fossi un elefante; | Dopo una settimana di dieta, | Tranguggia docilmente un buon purgante; | Indi la vena s’apra, e l’inquieta | Cantaride t’infonda un vessicante | Alle coscie, alle gambe due cauteri | Popolatori delli cimiteri. | Indi làsciati dare le copette, | Le sanguisughe e vari serviziali, | E nuovo sangue, e poi nuove ricette, | E intorno al letto medici e speziali; | E dimmi poscia ch’io non vaglio un ette | Se con tanti rimedi non t’ammali. | Fidati pur se vuoi; ma in questa forma | Passa la bella donna, e par che dorma.
P. [Pietro Verri]
IL CAFFÈ )( Fogl. XIX )(
Pensieri sullo spirito della letteratura d’Italia
Le idee e le opinioni degli uomini si cangiano con maggiore velocità di quello che non si cangino le lingue; forse perché ogni mutazione di un segno esteriore compare una real mutazione agli occhi d’ognuno; laddove le successioni delle diverse idee ed opinioni, facendosi per gradi insensibili, non vengono conosciute che da quei pochi pensatori sparsi nella massa del genere umano, i quali constituiscono una minima porzione della nostra specie. Sono più secoli dacché si usano le voci uomo dotto e uomo filosofo, e quasi in ogni secolo queste voci hanno rappresentato cose diverse, ed opposte talvolta l’una all’altra.
Al rinascimento delle lettere in Italia, mentre i Medici accolsero i Greci rifugiati dopo la presa di Costantinopoli, era gran filosofo colui il quale aveva letto Platone e che sapeva ridirne a mente alcuna definizione, avesse ella o non avesse significato. Chiunque sapeva leggere allora qualche pezzo dell’Iliade o dell’Ulissea, era un uomo dotto; chi poi giungeva a scrivere qualche servile imitazione di que’ antichi originali era dottissimo e talora divino per pubblica acclamazione. La poesia era allora sovranamente onorata in Italia, e ciò doveva fisicamente accadere per la singolare sensibilità che abbiamo all’armonia e per la vivacità della immaginazione, più popolare in Italia che forse in altra parte d’Europa, qualità entrambi immediatamente dipendenti, anzi che dall’educazione, dal grado di latitudine sotto cui siamo riposti. Un uomo dotto nel secolo decimo quinto doveva intendere il greco ed il latino; doveva credere agl’influssi delle stelle, e formarsene un sistema con cui predire gli avvenimenti, e dare la spiegazione de’ fenomeni. Tutte le idee chimeriche della magia contribuivano pure alla composizione dell’uomo dotto. Era poi onorato col titolo di filosofo allora colui che sapeva ben a mente le categorie d’Aristotele, che sapeva disputare sull’universale a parte rei, sulle quiddità, sul blictri e su altre sì fatte gravissime innezie e deliri dell’umana debolezza, la quale, gonfia di tante barbare parole, con ispido sopracciglio e con sucida dimenticanza della persona cercava di carpire dal volgo i suffragi ed acquistarsi un dispotico impero sulle menti degli uomini.
A queste opinioni altre ne successero nel secolo decimo sesto, e fu allora che tutti quasi gl’Italiani capaci di coltivar le lettere si slanciarono disperatamente o nel platonico mare dei sonetti e delle canzoni amorose, ovvero nello studio della grammatica italiana e della latina eloquenza. Non v’è quasi terra in Italia in cui non si sia composto un canzoniere, e non si siano lodate le trecce bionde di madonna, l’angelico viso o il castissimo e soavissimo sguardo di lei. Romanzi in ottava rima pieni di stregheria, di palagi incantanti, di cavalli volanti, di cavalieri che con una lancia scompigliavano un intero esercito, cose tutte in somma seducenti all’immaginazione, ma nemiche giurate del buon senso, piovettero allora da ogni parte; frattanto che i freddissimi e numerosi pedanti coniugando, declinando, compassando ogni frase, ogni parola, ogni periodo costringevano gl’ingegni a sacrificar la cura delle cose per quella dei segni che le rappresentano, ed a limitarsi a quelle idee sole che potevano esporsi con que’ torni di frase delle quali permettevano che si facesse uso. Uomo dotto significò dunque allora un’altra cosa, cioè significò un uomo che sapeva scrivere all’occasione una lettera o orazione latina con una lingua che chiamavano del secol d’oro, e che per lo più altro non recava all’animo che un armonioso suono di ben disposte voci. Vero è che alcuni osarono scrivere da uomini pensatori anche in que’ tempi; ma furono essi appunto i meno riputati, e taluni atrocemente esposti alle persecuzioni de’ loro contemporanei, per tal modo che anche al dì d’oggi non è possibile prudentemente il rendere l’onore che si vorrebbe al loro nome; né alcuni pochissimi in un secolo sono quelli da’ quali debba la storia prendere l’indole e la fisonomia, dirò così, d’un secolo intero. Uomo filosofo fu anche in que’ tempi quasi lo stesso che nel secolo precedente, se non che le scoperte che s’erano poco prima fatte sul globo che abitiamo, la navigazione resa più industriosa e più ardita eccitava in alcuni delle idee della storia naturale, della figura della terra, delle osservazioni celesti, e con esse alcune elementari idee della geometria. Venne sul fine di questo secolo il gran Galileo, l’onore della patria nostra, il gran precursore di Newton, quello di cui sarà glorioso il nome insin che gli uomini conserveranno l’usanza di pensare, quello perfine le di cui sventure saranno una macchia ed un obbrobrio eterno per il secolo in cui visse. Scosse egli il primo il giogo di quella scienza di vocaboli che tiranneggiava le menti degli uomini, e che senza né amare né cercare il vero ammantavasi del titolo di filosofia. Egli additò non solo, ma percorse gran parte di quella strada, che è la sola per cui le limitate facoltà degli uomini possono giungere a contemplare qualche parte degli arcani di natura. Il sistema planetario, le leggi della gravità, quelle de’ fluidi, la teoria della resistenza de’ solidi, una serie di verità geometriche, le leggi del moto, la perfezione degli stromenti ottici, l’arte d’interrogar la natura con una industriosa sperienza, sono tutti doni che da quella grand’anima furono o interamente o in parte fatti non dirò all’Italia od al suo secolo, ma all’uman genere ed alla posterità più rimota. Ma i Simplicii, ch’egli introduce ne’ suoi dialoghi erano tanti a’ suoi tempi, e tale era la possanza di essi, che per una quasi universale sedizione le luminose vie di questo grand’uomo furono dichiarate assurde, e pochi e paurosamente celati furono quelli che seguirono l’additato sentiero.
Nel secolo decimo settimo poi gl’Italiani, costanti alle parole e pur troppo sino all’ora trascuranti le idee, dopo avere per due secoli coniugate, declinate, e poste in tondi armoniosi giri le parole, passarono a riporre ogni loro attenzione principalmente sulla loro combinazione e sulla corrispondenza d’una coll’altra; da qui ne nacquero gl’infiniti freddurai che provavano che la donna è un danno, la moglie un maglio, la sposa una spesa; ed in que’ tempi si applaudiva a quei versi famosi:
Mi sferza e sforza ognor lo amaro amore
A servire, a servare a infida fede;
Miei danni donna cruda non mi crede,
Mi fere e fura, e di cure empie il core.
Lima chi l’ama, e chi la mira more;
Vuol ch’oltre agli altri vada chi non vede
Per merto a morte, e con un chiodo chiede
Darla a me, ch’ell’amò qual fiera un fiore.
E questa mecanica e puerile occupazione dilatò il suo impero per modo d’imbrattare la poesia non solo, ma le più gravi orazioni e politiche e sacre, le familiari lettere degli amici, e persino ogni socievole conversazione dove si volesse far pompa di non volgare talento. Allora gli acrostici, i bistici, gli equivoci, gli anagrammi diedero una gotica forma alla letteratura d’Italia; allora gl’Italiani capaci di qualche coltura si divisero in accademie, le quali si attribuirono le più strane divise, e ciascuno degli accademici volle diventare confratello de’ cavalli da maneggio, e come il Leggiadro galoppa, lo Spiritoso raddoppia, l’Ardente corvetta, l’Agile fa il passo-salto, il Superbo passeggia, così un altro Leggiadro recitava sonetti, un altro Spiritoso era eccellente nelle sestine, un altro Ardente si distingueva nelle terze rime, un altro Agile era professore di ottave, un altro Superbo faceva anacreontiche da far languire di dolcezza. Il titolo d’un letterato mediocremente conosciuto occupava una buona mezza pagina, cioè il signor Tal de’ Tali, fra gl’Indotti il Sottile, fra gli Affamati il Disinvolto, fra gli Spensierati l’Ottuso, e così avanti in infinito quante erano le patenti d’accademia che facevano il corredo delle lettere di que’ tempi; fanciullaggini che seriamente prendevansi da taluni, ma che erano l’oggetto della compassione dei pochi uomini veramente illuminati, e della disistima in cui le lettere d’Italia allora vennero tenute dall’estere nazioni.
S’introdusse poscia poco a poco lo spirito della filosofia nell’Europa; il gran Lord Verulam aveva eccitati gl’Inglesi a scuotere il giogo; l’immortale Galileo nella nostra Italia non minore spinta aveva data agl’ingegni; il primo aveva fatto il disegno, l’altro in parte aveva innalzato l’edificio. Comparve alla fine Des-Cartes, sublime e benemerito genio, di cui gli errori stessi sono degni di venerazione, tanto è l’ingegno e l’industria che dovunque trovansi nelle opere sue. Poco anch’egli fu felice nella sua patria, né potrebbe la Francia liberarsi dalla macchia d’aver lasciato profugo e inonorato morire fra i ghiacci di Svezia quest’illustre ristoratore della filosofia, se le generazioni che vennero dappoi non avessero cercato con ogni sforzo di riparare la vergognosa dimenticanza de’ loro antenati. Le vite de’ grand’uomini nati in secoli o fra nazioni incolte sono composte d’una successione di sventure: l’invidia, la gelosia, la cabala, la malignità, la detrazione, tutte gli attaccano da mille parti; ma gli scritti loro rimangono, e i germi di luminosa verità col tempo si schiudono, sinché comunicandosi per tradizione d’uno in un altro il loro genio, cresce il numero degli uomini illuminati, e cresce a segno di sforzar gl’ignoranti ostinati al silenzio, e di riparare con una fama tarda sì, ma sicura, ai torti che in prima furono fatti al merito. Così avvenne de’ scritti di quest’uomini nati per l’ammaestramento degli altri: nuovo aspetto prese la filosofia in tutta l’Europa, e sebbene il numero delle verità che in questo cambiamento si scopersero non sia molto vasto, il metodo di ragionare che s’introdusse fu la cagione de’ scoprimenti che si fecero dappoi e che si vanno facendo tuttavia. Si sostituirono allora, a dir vero, nuovi errori ai vecchi; ma gli errori vecchi avevano per base l’antica autorità, che più si avvanza e più cresce; e i nuovi errori avevano per base la ragione, la quale col proseguire ad esercitarsi li discopre. Ostinatissima guerra fecero le scuole a questo nuovo genere di filosofare, ma la ragione finalmente la vinse, e allora si chiamò filosofo un uomo il quale credeva di spiegare tutt’i fenomeni dell’universo coi soli due principii di materia e di moto. Si credette allora co’ vortici di aver trovata la cagione de’ moti de’ corpi celesti, colla materia sottile di spiegar la cagione della gravità, dell’ago magnetico e della luce; non restò un solo angolo delle cose naturali che un filosofo allora non credesse d’intendere e di potere altrui spiegare.
Verso que’ tempi medesimi altra idea si unì colle parole uomo dotto, e di tale ebbe il nome colui che molto fosse versato nella cronologia, nelle medaglie, nelle cronache, nelle pergamene antiche e nelle iscrizioni; e allora ad illustrare una lampade sepolcrale, ad illustrare un piedestallo, un tripode, una patera o simile oggetto si spesero anni e lustri, e si pubblicarono grossi tomi, i quali certamente non contribuirono molto all’avvanzamento delle cognizioni umane o alla gloria della patria nostra.
Ai dì nostri non può negarsi che molto non siasi migliorata la condizione degl’ingegni e nell’Italia e in tutta l’Europa. Il gran Newton ha svelato dimostrativamente il sistema nostro planetario; egli ha fatto conoscere una nuova forza, compagna indivisibile della materia, per cui reciprocamente s’attrae; egli ha scomposta la luce ne’ suoi principii, e ne ha dimostrate le proprietà; egli in somma ha aggiunto alla ragione, che Des-Cartes aveva già portata nella filosofia, l’analisi, sua fida scorta, per cui va ogni giorno più dilatando la sfera delle umane cognizioni. Cosicché al giorno d’oggi filosofo è colui che fa precedere l’esame all’opinione, che pesa gli oggetti indipendentemente dal sentimento altrui. Se a questo filosofo domandi cosa è materia, egli dubita di non aver dati per definirla, ed è tanto cauto nel determinarsi quanto erano corrivi a farlo quei che chiamavansi filosofi cinquant’anni sono.
Io qui non so contenermi che non faccia una breve, ma importante uscita dal mio soggetto, e sia per coloro i quali malignamente abusando del nome sacro di filosofo, credono di dimostrarsi tali manifestando non curanza e talvolta persino discredito delle più sublimi verità rivelatrici dell’Eterna Sapienza, verità le quali sono d’un primo ordine superiore ad ogni altra classe di cose, verità le quali vuole il dovere, l’interesse e la ragione egualmente che sieno da noi venerate. So che un sì grave argomento dev’essere trattato con quella maestà ch’io non so darvi, e che non si comporta colla natura d’un ameno foglio periodico, di cui lo scopo è soltanto di fomentare la curiosità per la lettura e indicare qua e là alcune verità del second’ordine; pure è bene avvertir di passaggio que’ tali, se ve ne sono, ch’essi col loro modo di parlare danno una prova di essere lontani dalla filosofia, cioè dall’amor del sapere, più assai di quello che non lo sia un perfetto ignorante, poiché un errore, ed un errore fondamentale quale è questo, è una quantità negativa del sapere. Chiunque poi ad ogni nuova proposizione, per sana ed ingenua ch’ella sia, cerca di trovarvi una nascosta incredulità, e proccura di denigrare il buon nome degli uomini illuminati con falso zelo di pietà e con una vera e reale invidia che lo rode nel fondo del cuore, quegli non è certamente né filosofo, né buon cristiano, né uomo d’onore.
Ma ritorniamo sulla strada, ed osserviamo che il titolo di uomo dotto realmente costa al dì d’oggi assai più di quello che non lo costava per l’addietro; onde la maggior parte di coloro che l’ottennero ne’ tempi trascorsi molto dovrebbero sudare ai dì nostri per ottenerlo di nuovo. Lo spirito filosofico s’è dilatato oltre i confini della fisica, egli regge ed anima l’eloquenza, la poesia, la storia, le bell’arti tutte in somma; il cuore umano ed i principii della sensibilità sono alfine più conosciuti di quello che in prima non lo erano, ed il senso della maggior parte degli Europei è reso molto più squisito e dilicato di quello che da lungo tempo non lo sia stato giammai.
Nell’Italia nostra però vi sono tuttavia gli aristotelici delle lettere, come vi furono della filosofia, e sono quei tenaci adoratori delle parole, i quali fissano tutti i loro sguardi sul conio d’una moneta, senza mai valutare la bontà intrinseca del metallo; e corron dietro, e preferiscono nel loro commercio un pezzo d’inutile rame ben improntato e liscio a un pezzo d’oro perfettissimo di cui l’impronto sia fatto con minor cura. Immergeteli in un mare di parole, sebben anche elleno non v’annunzino che idee inutili o volgarissime; ma sieno le parole ad una ad una trascelte e tutte insieme armoniosamente collocate ne’ loro periodi, sono essi al colmo della loro gioia. Mostrate loro una catena ben tessuta di ragionamenti utili, nuovi, ingegnosi, grandi ancora: se una voce, se un vocabolo, una sconciatura risuona al loro piccolissimo organo, ve la ributtano come cosa degna di nulla. Sono que’ tali come quel raccoglitore dei libri, il quale gli sceglieva sulla eleganza della rilegatura, rare volte osservandone il titolo, non che l’opera; e così preferiva le opere del celebre Gomez rilegate in vitello alla storia del presidente du Thou legata in pergamena.
Questi inesorabili parolai sono il più forte ostacolo che incontrano anche al dì d’oggi in Italia i talenti che sarebbero dalla natura altronde felicemente disposti per le lettere; essi co’ loro rigidi precetti impiccoliscono ed estinguono il genio de’ giovani nell’età appunto più atta a svilupparsi; essi colle eterne loro dicerie intimoriscono talmente i loro disgraziati alunni, che in vece di sollevarsi con un felice ardimento, scrivendo a quell’altezza a cui giunger possono le loro forze, con mano tremante servilmente si piegano alla scrupolosa imitazione di chi fa testo di lingua; e quel pittore, il quale nelle prime opere sue, se fosse stato libero, avrebbe prodotte molte bellezze e alcuni difetti, per migliorare poi sempre colla propria sperienza, s’agghiaccia colla pedanteria dell’imbecille e venerato suo maestro, e per troppo temere i difetti, non produce più né difetti né bellezze proprie, ma oscure e dispregevoli copie non mai capaci di dar un nome all’autore.
Questa disgrazia dell’Italia è provenuta, cred’io, da ciò che nell’Italia, quasi appena dopo il risorgimento delle lettere, si pretese di aver fissata la lingua, e si pretese di più di averla fissata con confini sì immobili che la lingua italiana della scrittura avrebbe dovuto avere tutta la rigidezza delle lingue morte, perdendo quel naturale tornio e quella pieghevolezza all’idee di ciascuno scrittore che forma il primario genio delle lingue vive. Io non pretendo già che debba esser lecito ad un pulito e colto scrittore il far uso di que’ vocaboli che sono talmente municipali d’una parte d’Italia, sì che nell’universale lingua italiana non sieno conosciuti; io non pretendo neppure che un pulito e colto scrittore ignori la grammatica della lingua in cui scrive, e macchi i suoi discorsi con frequenti errori o barbarismi; nemmeno pretendo che sia lodevole un perfetto libertinaggio di lingua, introducendo senza ragione ne’ scritti delle frasi o de’ modi di dire ignobili o forestieri al genio della lingua; io dico bensì che il merito della lingua è un puro merito secondario, ch’egli è un puro abbellimento del discorso; né può essere mai risguardato come un merito primario, se non se da coloro i quali non sanno far uso della miglior parte dell’uomo. Dico di più, che quando si sono voluti stabilire per cardini della lingua i Giambullari, i Capponi, i Montemagni, i Firenzuola, i Borghini, i Rossi, i Monaldi, i Cavalcanti, i Gelli, i Fazi degli Uberti, i Sacchetti, i Marignolli, i Cinoni, i Bronzini, gli Stradini e sì fatti oscurissimi scrittori, de’ quali l’Europa colta non legge neppur un solo, allora dico che s’è preteso di fare una risoluzione alquanto immatura, e che la lingua non si potrà mai chiamare stabilita sodamente insino a tanto che vari e vari valentuomini non l’abbiano piegata alle diverse loro idee, e resa versatile e maneggevole a ben dipingere e rappresentare tutt’i diversi oggetti che possono affacciarsi alla immaginazione d’un uomo superiore al volgo. Non credo di far torto a quei che non nomino, nominando due scrittori che abbiamo per sventura dell’Italia perduti, cioè il signor dottore Antonio Cocchi ed il signor conte Francesco Algarotti, i quali con diverso stile bensì, ma con un medesimo spirito di filosofia hanno arricchita la nostra lingua colle loro opere, e ci hanno lasciati libri pieni di idee grandi e nobili, adornate da uno stile che le rende ancor più leggiadre. Allor quando la nostra Italia in vari generi ne avrà prodotti altri ancora di simili, allora i nostri posteri avran ragione di vantarsi che la loro lingua abbia ricevuta una stabile forma.
Quando Orazio, l’incomparabile Orazio, onorava la lingua di Roma co’ suoi versi immortali, una turba di pedanti fremeva contro il nuovo autore, ed erano appunto costoro quella greggia servile d’imitatori che ad Orazio tanto sovente movevano ora il riso, ora la noia. Lo storico Livio accusavano essi di padovaneggiare nel suo stile; in ogni paese, al cominciare che fece il buon secolo, s’incontrarono tali ostacoli, ove più ed ove meno; e il gran Cornelio, il gran Moliere, che fecero ammirare le produzioni dell’ingegno umano sul teatro, innalzate forse al dissopra di quanto gli uomini avevan mai veduto prima d’essi, il gran Cornelio, il gran Moliere, essi pure hanno sparsi nelle loro opere dei difetti, o vogliam dire degli errori di lingua, né perciò son essi meno illustri o nella loro patria, o dovunque vi sia senso per la tragedia o per la commedia.
Un’altra cosa pure fa molto torto alla letteratura d’Italia, ed è il modo con cui fra gli scrittori si trattano le dispute letterarie. Chiunque osa scrivere dovrebbe mostrarsi uomo d’un ingegno e d’una coltura al dissopra del comune livello degli uomini; il mestiere d’un autore è d’illuminare la moltitudine, di comunicargli co’ suoi scritti le utili verità, di rendere gli uomini più saggi, più felici e più virtuosi, tre cose le quali realmente sono una cosa sola. Quale stima o quale deferenza dovranno avere gli uomini comuni per le lettere, se chi s’intrude in questa nobile professione la avvilisce con canaglieschi modi, e coll’usare delle più basse e facchinesche ingiurie, le quali appena meritano scusa qualora se ne ascolti uscire il suono da una bettola ripiena d’ubbriachi? Eppure cotesto è un vizio nostro ereditato; e dal tempo del Castelvetro a questa parte, rare volte son passati dieci anni in Italia senza che siasi dato alla ciurma de’ lettori l’obbrobrioso spettacolo di due, che usurpandosi il luminoso carattere di letterati, si prendono villanamente l’un l’altro pe’ capelli, e si rimescolano nel fango fralle fischiate e gli urli e lo schiammazzo d’un ozioso gregge d’insensati partigiani. Nell’Inghilterra, la parte che qui fanno cotali disonori delle lettere la fanno i galli, ed a quegli animali conviene assai più che non ad uomini il pungersi e lacerarsi l’un l’altro per divertimento degli spettatori.
Non mancarono a due insigni nostri letterati, al signor Lodovico Antonio Muratori ed al signor marchese Scipione Maffei, di simili scrittori frenetici, i quali se gli avventarono colle più vili e plebee contumelie, ma que’ geni superiori non interruppero per ciò il placido e maestoso corso della loro carriera, né vollero mai far l’onore ad una schiatta d’uomini tanto da loro distante di discendere e far rientrare quegl’insetti nella pozzanghera d’onde pretendevano alzarsi; gli uomini di lettere non farebbero mai nulla di grande, se si lasciassero distorre da’ loro oggetti ad ogni ragghio che ascoltano.
Quando però la disputa sia una urbana e pacifica ricerca della verità, la quale s’eserciti in modo da non far nascere cattiva opinione o della morale o della educazione di chi la sostiene; se il soggetto di essa è degno d’essere rischiarato, allora la disputa diventa una parte rispettabile della letteratura e contribuisce al progresso delle cognizioni degli uomini. Il signor La Motte così trattò la disputa con madama Dacier, ed il monarca autore del Philosophe bienfaisant così disputò col cittadino di Genevra. Il signor d’Alembert, nella disputa sul teatro, ha sostenuta pure la sua causa con quella nobile decenza che era degna di lui. La contumelia e il fiele scolastico sono uno sfogo di que’ sventurati scrittori i quali risvegliano alla mente la favola del serpente che rosica la lima. L’uomo di merito non odia che il vizio, disprezza i vili e compassiona quegli infelici, i quali amareggiati nel fondo del cuore per la non curanza in cui vengono tenuti, non hanno la forza di celare ne’ loro scritti il crudele sentimento che gli avvelena.
Da queste due cancrene, cioè dalla pedanteria de’ parolai e dalla scurrilità de’ spaventacchi dell’infima letteratura, sembra che a grandi passi vada liberandosi la nostra Italia: ogni giorno più va diminuendo il numero de’ loro fautori, e gli estremi loro sforzi sono una prova che lo spirito filosofico va facendo progressi grandi sulle ingiuste loro possessioni. A misura che saranno discreditati questi nemici degl’ingegni, l’Italia andrà distinguendosi fra le nazioni colte, e per poco che il Cielo le conceda pacifici giorni, tornerà forse un’altra volta a far rivolgere verso di lei lo sguardo ammiratore dell’Europa.
P. [Pietro Verri]
IL CAFFÈ )( Fogl. XX )(
Dialoghi dei morti
Dialogo I. Omero e Pitagora
Omero. E dunque vero, o Pitagora, che per aver felicemente trovata la dimostrazione d’un geometrico teorema, offeristi un’ecatombe ad Apolline?
Pitagora. Verissimo: e ti par egli strano per avventura?
Omero. A me certamente non è mai caduto in pensiero di farlo, per quanto sublimi e leggiadri versi m’abbia ispirato Apolline ne’ miei poemi: eppure non vuolsi, per mio avviso, colle bellezze de’ versi paragonare la nuda e sterile geometria.
Pitagora. Assai più belle e pregevoli che tu non credi sono le geometriche contemplazioni. La soave armonia dei versi lusinga l’orecchio, e la vivacità loro agita l’immaginazione; ma il piacere di conoscere il vero penetra e si trattiene e spazia nella più pura parte dell’intelletto, al quale, nato per la verità, nulla più grato riesce che il discoprirla. I geometrici studi formano la mente nostra, e l’avvezzano a sviluppare in se stessa e a svolgere i principii della scienza, e a dedurne con certo ordine i suoi giudizi. E perciò dovrebbono i giovani siffatti studi premettere per fondamento e base d’ogn’altro. E quando queste medesime sublimi teorie, che pascono e riempiono l’intelletto, vengono alla fisica esperienza ridotte dall’esperto geometra, sono d’innumerevoli vantaggi cagione alla umana società.
Omero. E non è forse utile agli uomini la poesia? Questo linguaggio degli dei, questa divina arte, la quale le magnanime azioni degli eroi celebrando e le triste opere de’ malvagi uomini spargendo d’infamia, quasi in fido specchio della umana vita ci rappresenta quanto imitare dobbiamo e quanto fuggire. Ben lo conobbe la savia Atene, la quale, siccome fummi da molti detto, con solenne decreto ordinò che nelle pubbliche adunanze si cantino i versi miei. E quando scese quaggiù il più valoroso principe che abbia avuto la Macedonia, venne con sollecita cura in traccia di me, e trovatomi, dopo mille onorevoli accoglienze, mi raccontò com’egli tenea sempre fra lo strepito dell’armi le opere mie con sé, e con sommo profitto leggevale, e aveale finalmente riposte in un gemmato vaso trovato fra le spoglie di Dario. Né la colta Grecia soltanto, ma i rimoti Indi e i re di Persia hannole in grandissimo pregio e venerazione.
Pitagora. Non nego io già che non possa essere la poetic’arte d’alcun vantaggio producitrice. Ma oltrecché rari sono i poeti che abbiano ornata la virtù, e non anzi co’ più vivi colori dipinto il vizio, i versi loro ammolliscono l’animo dei giovani, e men atti li rendono ai più severi studi e più gravi.
Omero. Ma questi gravi e severi studi finalmente pochissimi seguaci ebbero in ogni età, e florida è stata sempre la scola d’Apolline.
Pitagora. Argomento della falsa idea che hanno gli uomini del bello e dell’utile.
Dialogo II. Mitridate e Catone Uticense
Mitridate. Generoso invero e magnanimo fu il tuo consiglio, o Catone, di darti la morte, né le minaccie curando, né le promesse di Cesare.
Catone. Più grave assai della morte sarebbe a me stata la servitù, né la libertà io dovea ricevere da chi l’avea rapita alla patria. Il divin libro in cui Platone ragiona della immortalità dell’anima e della futura beata vita dei buoni mi confortò, e la mano mia nel gran cimento rinvigorì il desiderio di mostrarmi non indegno figlio di quella Roma che è stata, sopra ogn’altra città, feconda madre d’eroi.
Mitridate. Molti grand’uomini ha certamente prodotti la tua repubblica; ma io temo non l’amor della patria al pensier tuo li rappresenti più grandi ancor che non furono.
Catone. E qual altra nazione vantar può mai e l’incorrotta virtù de’ nostri Camilli, e Curi, e Fabrizi, e il militar consiglio e l’egregio valore de’ nostri Metelli, e de’ nostri Fabi e Scipioni?
Mitridate. Il rigido costume di quegli antichi cittadini di Roma io l’attribuirei anzi alla condizione de’ tempi loro, che a grandezza d’animo e a determinata virtù. Come potevano essi quelle delizie apprezzare che non avean gustate, ed esser avidi di quelle ricchezze che non conoscevano? E ben si vide quanto presto l’eredità del re Attalo e le conquiste asiatiche sbandirono da’ petti loro l’antica severità, e fecero scordare ai romani consoli i rustici tuguri, e ai dittatori l’aratro. E siccome potrebbe a questi, e con più ragione, opporre e un Pelopida, e un Focione, e un Aristide la Grecia, così potrebbe ai vostri duci e il suo Leonida, e il suo Temistocle, e il suo Epaminonda paragonare. E quella Cartagine che sparse tanto sangue romano, e il piccolo Regno di Ponto che vi ha per quarant’anni stancati, vanteran forse del pari e Annibale e Mitridate.
Catone. Ma la superior forza e l’invitto valor dei Romani tutta finalmente sentì e riconobbe la terra.
Mitridate. E tutta sentì e riconobbe la terra l’ingiustizia e la violenza dell’armi vostre. I fondatori della vostra repubblica diedero a lei principio colle rapine e col sangue; e questo spirito ne’ posteri loro trasfuso, l’Italia prima, e tutte poi devastò le straniere provincie: ed or con aperta violenza, ora con simulati pretesti e con apparente colore di protezione spogliati furono i popoli della natia libertà. Ma presero finalmente li dei delle oppresse nazioni vendetta. Questa superba repubblica sotto le armi di Cesare è già vicina a spirare.
Catone. La soverchia potenza e gl’intestini odi e le discordie han guasto il seme delle virtù latine. Né sarà maraviglia che senta poi anche la nostra repubblica il comune rivolgimento delle umane cose, le quali han tutte il lor principio, l’ingrandimento loro, la decadenza ed il fine.
Dialogo III. Corinna ed Elena
Corinna. Che mi vai sempre vantando, o Elena, quella tua bellezza, la quale, siccome cosa caduca e mortale, ha dovuto sentire i danni del tempo e della morte; mentre la fama del mio ingegno eternamente vive nella memoria degli uomini?
Elena. E non è forse eterno il mio nome ne’ versi di tanti insigni poeti che il celebrarono?
Corinna. Io celebrai me da me stessa, e nel cospetto di tutta la Grecia al suo lirico più illustre tolsi la palma co’ versi miei.
Elena. Io non voglio ora disputar teco su tal vittoria: ben ti dirò che assai più chiare e più sicure vittorie su gli uomini ottien la bellezza. Può ben l’ingegno e lo spirito in altrui risvegliare i freddi e languidi sentimenti d’ammirazione; ma la bellezza agita i cuori umani coi forti e vivi affetti d’amore. Ella tramanda e spira un segreto fascino e incanto, che rapidamente passando dagli occhi al core di lui trionfa. E ben sai tu come Paride, arbitro alla gran lite trascelto dai numi, i vari doni da Giunone e da Minerva offertigli disprezzando, diede il pomo alla dea della bellezza che aveagli in premio e mercede promessa la bella sposa di Menelao. Li dei medesimi, quando fra noi scendevano sazi del cielo, colle belle e leggiadre donne si ricreavano, non colle dotte e scienziate. Il gran padre de’ numi si è forse alcuna volta spogliato della sua maestà e cangiato in toro, in cigno, o in pioggia d’oro per qualche erudita fanciulla di Grecia, come egli ha fatto per Europa, per Leda e per Danae, donne a’ lor tempi famose per la bellezza?
Corinna. Inutile è adunque il dono dell’ingegno, anzi dell’animo, che a noi del pari che agli uomini fecer li dei: e paghe e contente d’esser quai simulacri vagheggiate, la miglior parte di noi lasceremo incolta e negletta? Io per me pregerommi sempre d’avere della felicità dell’ingegno con tanta mia gloria gareggiato con Pindaro.
Elena. Ed io sempre mi pregerò d’aver colla mia bellezza sconvolta l’Asia e l’Europa.
Dialogo IV. Platone e Diogene
Platone. Bella con tua pace, o Diogene, bella è la gloria: e un degno oggetto, anzi un chiarissimo argomento di un’anima immortale è quel vivissimo desiderio che in noi sentiamo d’acquistar nome, e d’essere eterni nella memoria de’ posteri.
Diogene. Per se medesima deesi cercar la virtù, la quale senza i vani applausi e la incerta fama del volgo, è per sé bella e di se stessa contenta.
Platone. Vero è che se potessero gli uomini nella propria luce e nella natia bellezza contemplar la virtù, un ardentissimo amore di sé risveglierebbe ne’ petti loro. Ma poiché un denso velo agli occhi mortali l’asconde in parte, nel qual è in se medesima bella, e pregevole si manifesta, non isdegna ella che sieno i bennati spiriti anche da quella gloria invitati che non proviene che dalla vera virtù. E chi non sa quanto possa ne’ cuori umani, e quanto alle magnanime imprese gli accenda, diretto dalla ragione l’amor della gloria? Questo rende men aspre le militari fatiche, anzi la stessa morte a’ nostri guerrieri; questo i veloci cursori e i robusti atleti rinvigorisce in Elide, in Pisa, in Olimpia: questo le belle arti ravviva, e regge all’industre artefice sui bronzi e i marmi e sulle spiranti tele la mano; questo agita con più vivo ardore il celeste foco dei poeti; e in questo troveran finalmente, con disappassionato animo se stessi considerando, il più forte promotore de’ loro studi i filosofi.
Diogene. Io fui sempre nemico del fasto e sprezzator della gloria.
Platone. Ma tu fosti del fasto nemico per un fasto maggiore, e la gloria sprezzasti per aver la gloria d’averla sprezzata.
Diogene. E che dirai del generoso rifiuto e della filosofica indifferenza colla quale accolsi il superbo Macedone?
Platone. Tu fosti allora, o Diogene, assai più superbo di lui.
Dialogo V. Seneca e Petronio
Seneca. Ogni qualvolta io vo pensando, o Petronio, a quei cinqu’anni, che con tanta gloria del nome suo e con tanta felicità dell’imperio regnò Nerone, d’un giusto sdegno m’accendo contro di te e di quanti col pravo esempio e colla sordida adulazione corrompeste i buoni semi, da me nell’animo suo sparsi e coltivati.
Petronio. Checché degli altri ne sia, a me certamente non deesi un tal rimprovero.
Seneca. Non eri tu, sopra gli altri, arbitro e ministro de’ suoi piaceri?
Petronio. Non già di quelle infami dissolutezze alle quali, non per mia colpa, s’abbandonò, ma di un fino ed erudito lusso e delle più delicate ed eleganti delizie. Non volli io già coll’assoluta privazion de’ piaceri svegliarne in core al giovinetto regnante più accesa la brama, né introdurre alle soglie reali la squallida filosofia del Portico.
Seneca. Pur non dovrebbono gl’institutori de’ principi insinuar negli animi loro l’amor del piacere, ma unicamente formarli cogli ottimi precetti della virtù.
Petronio. Ma convien renderla dolce ed amabile, né rappresentarla, qual tu facesti, fiera e selvatica. Vero è però che quasi bastandoti d’averla con sì forti colori dipinta ne’ libri tuoi, la riducesti coll’uso a te medesimo più mansueta ed agevole. Tu biasimasti le delizie, e l’antica frugalità celebrasti, fra i lauti conviti e la più splendida magnificenza; e in mezzo agl’immensi tesori da te raccolti, e colla più gelosa conservazion della vita ragionasti da grave filosofo di povertà e di morte. Altro dunque non fu la tua vantata severità che vanità e impostura. E chi non anteporrà, come io feci, alla impostura e vanità d’uno stoico la moderata filosofia d’un virtuoso epicureo?
Seneca. Se vero è ciò, e se tanto fosti ne’ tuoi costumi savio e moderato filosofo, perché sì poco lo fosti ne’ libri tuoi?
Petronio. E se tanto lo fosti tu, o Seneca, ne’ libri tuoi, perché sì poco ne’ tuoi costumi?
Dialogo VI. Carlo V e don Giovanni d’Austria
Carlo. Troppo immatura fu la tua morte, o figlio, e troppo ingrato a’ tuoi meriti Filippo II.
Don Giovanni. Assai più della mia, spiacemi la trista condizione del vostro imperio. Io per me mi vo confortando coll’interno testimonio dell’animo mio, colla memoria delle onorate azioni e coll’esempio dei Temistocli e degli Scipioni: tale è la malignità dell’invidia, tale è il destino della virtù.
Carlo. Io non credea certamente di lasciare un sì indegno successore di Carlo V.
Don Giovanni. Non ha quel crudele e sospettoso principe bastante forza a reggere sì vasta mole. Egli, rinchiuso nel suo gabinetto, si pasce dei vani e immaginari progetti d’una falsa politica, mentre gl’ingordi ministri, non che le ricchezze del nostro, van disperdendo i tesori del Nuovo Mondo.
Carlo. In quale stato son ora le cose di Fiandra?
Don Giovanni. In pessimo stato per noi. La fierezza del duca d’Alba ha inaspriti gli animi di quelle genti, e la recisa testa del conte d’Egmont ha renduto loro odioso il nome spagnolo. Colla clemenza e colla umanità si vincono i popoli, non colle stragi e col sangue. Ah, troppo improvido fu il vostro consiglio di scender dal trono prima che le sparse e dissipate membra d’un sì vasto imperio fossero da uniforme e concorde spirito animate, e sotto un medesimo capo unite e composte.
Carlo. A ciò m’indusse la stanca età, la quale dopo tante cure e tante fatiche, dimandavami alcuni anni di placida e riposata vita.
Don Giovanni. Ma ben sapete come debbono i regnanti il proprio riposo alla salvezza de’ sudditi.
Carlo. Pur non mancò chi quella risoluzion mia celebrasse col glorioso titolo di filosofica magnanimità.
Don Giovanni. E quando mancaron mai anche alle meno lodevoli azioni de’ principi gli adulatori? Ben sarà Carlo V ne’ futuri tempi proposto qual chiaro esempio da imitare nel governo di un regno, ma gli accorti principi non l’imiteran certamente nel rinunziarlo.
Dialogo VII. Augusto ed Orazio
Augusto. Accostati, o venosino, che anche quaggiù con piacere io riveggo uno di que’ felici ingegni che tanto il mio regno illustrarono.
Orazio. Ed io riveggo ben volontieri quel che con tanta cura protesse, e sotto alla benefica ombra reale accolse le buone arti e le Muse.
Augusto. Un tal esempio seguir dovrebbono tutti i regnanti.
Orazio. Né per il pregio solamente delle belle arti e delle auree lettere in sé, ma per il vantaggio ancora che al protettore ne torna. Danno i sublimi scrittori eterna vita al nome di un principe, e le vere virtù sue spargono di più chiara luce, e quelle sovente in lui fingono ch’egli non ebbe per avventura. Il che io dirò, con vostra pace, essere avvenuto di voi.
Augusto. E che? Ti sembro io forse non degno in tutto di quella fama in ch’è salito il mio nome?
Orazio. Non voglio oppormi io già al comune applauso che con quei pregi che in voi rilussero e con alcune lodevoli azioni vi meritaste: dicovi solo che senza le donate ville e il largo e cortese favore, onde amici vi rendeste i più colti ingegni del vostro secolo, sarebbe certamente la memoria vostra fra gli uomini assai men bella ch’ella non è. E in vero s’io vi considero prima di salire al trono, altro non trovo in voi che un barbaro e crudel promotore del triumvirato e della proscrizione; veggo le natie contrade sparse di stragi e di sangue; veggo la misera patria, contro le straniere forze dagli antichi nostri difesa, da un proprio figlio dilacerata ed oppressa.
Augusto. Cose, io nol nego, funeste e gravi a me stesso, ma necessarie. Da me richiedevale e l’invendicata ombra di Cesare e la condizione de’ tempi. Era già spento nel Senato e nel popolo l’antico spirito di libertà; né mal s’appose chi Bruto e Cassio chiamati avea gli ultimi de’ Romani. Deposto adunque il vano pensiero, due volte sortomi in core, di far rivivere la Repubblica, diedi a’ Romani quelle catene che già chiedevano, e sol presi ogni cura di renderle col giusto e mansueto impero men dure e pesanti. E così appunto io feci, e regnai felice in guerra, felice in pace, temuto da’ nemici e venerato da’ sudditi.
Orazio. Non mi negherete però che di sì prosperi successi gran parte non ne dobbiate alla cangiata costituzion delle cose, che preso aveano un placido corso, e al consiglio e al valore di que’ grand’uomini, alcuni de’ quali la dubbia mente vi dirigeano nel gabinetto, ed altri debellavano nelle battaglie i nemici, lasciando a voi l’onor del trionfo. Così pugnarono Irzio e Pansa per voi, così pugnò per voi Marc’Antonio, e così finalmente il medesimo Antonio colla regia amante dall’intrepido Agrippa fu vinto. La poca vostra fermezza d’animo e la poca militar disciplina fu la cagione per cui la decima legione, avvezza a combattere sotto il comando e coll’esempio di Cesare, alcuna volta mostrò sì aperto disprezzo di voi. E veramente assai più che per le fatiche di Marte, nato eravate per la dolce compagnia de’ poeti, e per gli amori delle gentili e brillanti dame, da voi con tanto ardor coltivati, non già per sapere, com’altri credea, i segreti de’ loro mariti, ma bensì perché vi piacevano.
Augusto. Quelle lodi che tu mi desti un tempo, me le ricambi ora con altrettanti rimproveri e colla oraziana mordacità.
Orazio. Non vi sdegnate, o signore. E se già vi piacquero le lodi, onde foste da me e dagli altri celebrato, e che tanto vi aggiunser di gloria, non increscavi ora d’intendere da un poeta la verità, quando né a voi gloria apporterebbe, né ai poeti vantaggio l’adulazione.
Dialogo VIII. Carlo XII re di Svezia e la contessa di Konigsmarck
Carlo. Voi certamente vi lusingate, o madama, che tanta bellezza e tante grazie aver dovessero un più felice successo, né creduto avreste che appena d’un fugace sguardo degnandovi, io mi partissi da voi.
Contessa. Io nol credea certamente: pure, nelle deluse mie speranze mi confortò il pensare che Carlo non temeva altri che me.
Carlo. Non è viltà negli eroi un siffatto timore. L’amore a tant’altri funesto, esserlo potea a me ancora, arrestando il prospero corso delle mie vittorie ed estinguendo, o scemando almeno, l’ardor guerriero che mi chiamava alla gloria.
Contessa. Meglio era forse per la patria vostra e per voi: che né essa vedute avrebbe esauste le sue ricchezze e giacente il commercio, e il fiore delle sue genti ai vani e temerari vostri disegni sacrificato; né voi, dopo la funesta giornata di Pultowa e l’infelice spedizione in Ukrania e le romanzesche imprese di Bender, sareste in Svezia tornato errante e ramingo, maggiori prove lasciando d’un folle ardire che d’eroismo. Eroi ci furono, e assai più grandi, e nel tempo stesso a una bella passione meno ritrosi, e delle gentili donne più amanti di voi.
Carlo. Ben so che in maggior pregio sarà presso di voi e un Annibale, che perdendo il frutto delle felici battaglie e dell’abbattuta Roma scordandosi, in molle ozio languì fra le delizie di Capua; e un Marc’Antonio, che dal vittorioso Augusto colla disperata regina vergognosamente fuggì.
Contessa. Tutte le cose, comecché ottime in sé, possono col meno retto uso in altrui danno rivolgersi. Se alcuni alle amorose catene troppo vilmente s’abbandonarono, fu colpa loro, non già d’amore. Sovvengavi, per lo contrario, di un Cesare, e lo vedrete di quella stessa regina fortunato amante e conquistator dell’imperio. Mirate un Luigi XIV, e lo troverete colle belle e leggiadre dame di Francia amoroso e brillante, e saggio del pari nel gabinetto e valoroso nel campo. Volgetevi finalmente a quel vostro emulo illustre, a quel creatore de’ Russi, e vi dirà quanto a lui fosse propizio l’amore e quanto egli debba alla magnanima eroina del Pruth. Che oltre la lusinghiera bellezza onde s’accende negli umani petti l’amore, abbiamo e animo e costumi e valore per meritarlo; e sovente da quei begli occhi, onde ricevono agli onorati sudori alleviamento e ristoro, apprendono anche il dover loro gli eroi. Se con un altro io ragionassi, delle amorose donne meno nemico, direi quanto il commercio loro affini il più rozzo intelletto, e i delicati sentimenti risvegli, e le altrui maniere ringentilisca. A voi dirò solo che quell’inumano genio e feroce che i barbari oggetti dell’armi ispirano ai conquistatori, è dalle amabili donne temperato e raddolcito in gran parte. E questo sarebbe di voi pure avvenuto: avrebbe l’amore la natural fierezza del vostro cor mitigata, né andrebbe forse quaggiù della crudeltà vostra dolendosi l’ombra sdegnosa del troppo per sua disavventura intrepido e generoso Patkul.
Carlo. Io m’immagino che vi sarete più volte scambievolmente confortati, egli della sua morte e voi del mio disprezzo.
Contessa. Insieme ne ragionammo alcuna volta: egli in voi condannò un ingiusto persecutore, io un selvatico abitatore del Nord.
C. [Giuseppe Colpani]
IL CAFFÈ )( Fogl. XXI )(
I giudizi popolari
Due avvocati e un giudice comparvero in questa causa. Il primo avvocato cominciò così a parlare in favore del popolo:
Non v’è razza d’uomini che più mi muova la indegnazione quanto quella d’alcuni, i quali per vendicarsi, come possono, del poco conto in cui sono tenuti dagli altri uomini, fanno eterne declamazioni contro l’umanità, e degradano la specie umana sino ai confini della bestialità, credendo d’aver essi soli il privilegio esclusivo della ragione. Pretensione si è questa la più ingiusta e la più ridicola che dare si possa; e per poco che il signor giudice si compiaccia di ascoltarmi, credo di potergli ad evidenza mostrare la verità del mio assunto. E primieramente, come la natura ha dotato ogni uomo di una data forza di musculi, così gli ha confidata una data porzion di ragione; altrimenti l’uomo non sarebbe più uomo, cioè animale ragionevole, come da tutti universalmente vien definito; ora, come inetta cosa sarebbe il dire che molti e molti uomini uniti non abbiano più forza a movere un peso che un uomo solo, così deve essere assurda e inetta l’opinione di coloro che sostenessero che molte porzioni di ragione radunate non sieno maggiori d’una porzion sola. Perciò vediamo i principi più sapienti proporre ne’ loro Consigli le più ardue e importanti deliberazioni della monarchia, acciocché tutta la ragione che in quegli uomini sta divisa, radunandosi insieme su un solo soggetto lo esamini, lo penetri con maggior forza, onde conoscerne la natura e i buoni o cattivi effetti che deve produrre. Da qui ne viene che le repubbliche anche piccole hanno potuto ottenere una prodigiosa superiorità sulle nazioni nemiche, come avvenne della Grecia coi Persiani e di Roma con buona parte dell’orbe conosciuto.
I grandi uomini hanno avuta tutti una grande opinione della ragionevolezza degli altri uomini; poiché i grandi uomini, essendo quelli i quali più avidamente hanno comperata la fama a costo di mille incomodi e pericoli, non avrebbero anteposta la fama, ossia l’opinione favorevole degli uomini, ai comodi fisici della vita tranquilla e privata se non avessero creduti giusti estimatori del merito quegli uomini stessi dai quali a sì caro prezzo mendicavano i suffragi.
Di più: l’ingiusto vantato disprezzo degli uomini è un seme dal quale nascono mille vizi nell’uomo, il quale disprezzando gli uomini non cura più la reputazione, cioè la riunione della opinione che essi hanno di lui, e così sciolto da questo potente vincolo si dà in preda ad ogni inclinazione, sottraendosi al più possente freno che sia fralle cose terrestri per contenere i vizi e le azioni più abbominevoli.
L’opinione ch’io sostengo favorevole al giudizio della umanità è quella che mi restringe ad indicare appena queste luminose ragioni, ben persuaso dell’accorgimento del signor giudice, per cui non fanno bisogno d’inutili esorazioni o di declamazioni ricercate, ma bensì della sola e nuda verità, la quale, accennata appena, entra nell’intelletto e l’obbliga a sentirne la forza. Io non mi servirò dunque dell’autorità delle scuole, le quali convengono che il consenso universale faccia morale evidenza, il che significa che l’opinione universale degli uomini non è soggetta a errare; non mi servirò d’infiniti esempi, che potrei citare delle storie, che fanno in favor mio; all’evidenza delle ragioni addotte aggiungerò soltanto l’autorità di Pomponio Secondo, autore di tragedie, il quale, secondo riferisce Plinio alla lettera 17 del libro settimo, dicere solebat ad populum provoco, atque ita ex populi assensu vel dissensu suam aut amici sententiam sequebatur, tanto egli stimava il popolo, tantum ille populo dabat. Aggiungerò l’autorità del padre della romana eloquenza, il quale al principio del secondo libro delle Tusculane, nos, dice, multitudinis iudicio probari volebamus: popularis est enim illa facultas, et effectus eloquentiae est audientium approbatio. Celebri sono gli esempi de’ due francesi Malherbe e Moliere, i quali prima di sottoporre al pubblico le opere loro consultavano le loro fantesche, e sul giudizio loro ritoccavano le produzioni del loro ingegno; mille altri simili fatti ci somministra la storia e di Apelle e di altri grandissimi uomini, che del giudizio popolare facevano tal uso da risguardarlo come la pietra di paragone del merito. Resta dunque chiaramente provato che e per ragione intrinseca, e per l’opinione de’ grandi uomini, e per il bene della repubblica, e per l’autorità ed esempio degl’ingegni più rinomati il giudizio del popolo è conforme alla ragione, ed è il vero tribunal competente del bello, del grande e del buono, come brevemente ho detto.
Poiché ebbe finita la esposizione delle sue ragioni il primo avvocato, il secondo così a dir prese contro il popolo:
La indegnazione che il mio avversario sente contro coloro che non fanno stima de’ giudizi popolari, può dirsi prodotta da quei medesimi principii ch’egli rimprovera a noi, cioè che godendo egli dell’aura della fortuna, e in conseguenza dei pubblici omaggi, i quali non mancano mai ai felici, ha pure un massimo interesse a sostenere il proprio merito sulla infallibilità della universale opinione; e chi contrasta codesta opinione può essere agli occhi suoi sospetto di quel delitto che di rado si perdona, cioè di mancare d’una stima sentita verso di lui. Qualunque siasi il principio onde emani questa vigorosa sua eloquenza, che dà il nome di ridicola alla opinione nostra, entriamo brevemente ad esaminare il merito della causa e la forza delle ragioni addotte.
Io non contrasterò al mio avversario che ogni uomo abbia una porzion di ragione, non già per la definizione allegata dell’animale ragionevole, che tali non sono gli uomini fatui, ma perché i fatui e i pazzi sono uomini esclusi dal calcolo del quale trattiamo, e formano un sì piccol numero nella umanità che appena è sensibile. Se ogni uomo nel giudicare si servisse imparzialmente della propria porzion di ragione, il giudizio di molti varrebbe certamente più del giudizio di pochi, come le braccia di molti muovono meglio un peso che le braccia di pochi; ma nel muovere il peso ognuno adopera la forza musculare che ha; nel giudicare degli oggetti non così ognuno adopera la forza del proprio intelletto. In ogni nazione un piccol numero si arroga il primato, e il giudizio di sei o sette è ripetuto come dall’eco da venti o trenta mila, i quali desinunt suum iudicium adhibere; id habent ratum quod ab eo quem probant iudicatum vident, come dice Cicerone, De natura deorum, lib. I. Ovvero come dice Plinio, lib. 5, cap. 1: Cum indagare vera pigeat, ignorantiae pudore mentiri non piget, haud alio fidei proniore lapsu quam ubi falsae rei gravis auctor existit; o come Seneca, De vita beata: Ad rumorem componimur optima rati ea quae magno assensu recepta sunt; non ad rationem, sed ad similitudinem vivimus.
Di tutte le fatiche quella ch’è più insopportabile all’uomo si è il far uso della ragione, e perciò vediamo la moltitudine in tutte le nazioni amare il vino, o l’oppio, o il tabacco, o qualunque altro licor forte o droga che assopisca e levi dalla tentazione di mettere in contenzioso moto il proprio spirito. In fatti ne’ Consigli, che crederemo noi mai che cerchino i principi illuminati? I monarchi e i conquistatori più celebri si sono sempre determinati da loro soli, e ne’ Consigli hanno confidato quanto confidano i minatori, che rompono una rupe sulla eventualità di ritrovarvi o ferro, o rame, o argento, o oro, o forse di gettare il tempo e la fatica. Ogni uomo ha le sue private passioni che lo disviano dal cercare la verità, e si determina ad opinare talvolta per venerazione a questo, ora per avversione al voto d’un altro; perciò Roma appunto ne’ grandi affari e ne’ pericoli importanti confidava la salvezza con un pien potere in mano o de’ consoli o d’un dittatore, e a questo sistema anzi che ad altro attribuir doveva la parte avversa la romana grandezza.
Che gli uomini grandi abbiano, cercando la fama, cercato in conseguenza la stima della moltitudine, è vero, non perché credessero ragionevole il popolare incostante giudizio, ma perché hanno conosciuto che la riverenza degli altri uomini verso di essi gli sottraeva dalle vessazioni loro, e gli metteva in caso di servirsene a migliorar la vita. Maometto, quell’illustre impostore, da una bassa e oscura fortuna è giunto al trono, alla gloria de’ primi conquistatori, ed ha armato il braccio a più di dugento mila e gli ha guidati a suo talento, poiché seppe rendersi venerabile agli occhi loro. Crederem noi che Maometto avesse stima del giudizio di quelli de’ quali con tante assurdità si prendeva giuoco? No certamente; gli uomini erano macchine agli occhi suoi, le quali a forza d’errori i più grossolani si lasciavano guidare da quell’avveduto arabo. Così dicasi d’Alessandro, che si fece credere figliuol di Giove, e di quasi tutti i conquistatori, i quali hanno stimato sì poco ragionevoli gli uomini a segno di soggiogarli colle favole le più ridicole, cogli oracoli e simili testimoni della umana debolezza!
L’accusa ingiusta che ci fa l’avversario, cioè che la opinione nostra induca a disprezzare la riputazione e a darsi in preda ad ogni vizio, merita risposta. Ricercare l’opinione favorevole del volgo ella è una necessità de’ più scellerati, i quali temendo che gli uomini illuminati, che sono il piccol numero, non gli conoscano, cercano a bilanciarsi col partito della moltitudine; ma chi ricerca l’opinione de’ pochi non può travviare dallo stretto sentiero della virtù. Quale speranza può mai avere un uomo di merito nella stima popolare? L’ostracismo è sempre pronto in ogni età, in ogni paese; e se il merito non è armato ed osa comparire, l’amor proprio del volgo si scaglia contro di esso, come contro un oggetto che umilia anche non volendo; perciò da Socrate sino a Secondat la vita de’ grandi uomini, di quelli cioè che per la virtù e per l’ampiezza delle cognizioni hanno fatto maggior onore all’umanità, è una compilazione di continui disastri, e dalla commedia delle Nubi sino all’Oracles des nouveaux philosophes l’invidia dei mediocri scrittori ha osato attaccare e lacerarne il nome, e le azioni di qualunque ha potuto valere più degli uomini comuni.
Ma tempo è ormai ch’io corrisponda alle citate autorità, ed al citato testo di Cicerone contraporrò quello che lo stesso oratore dice al libro 5 delle Tusculane: An quidquam stultius quam quos singulos sicut operarios barbarosque contemnas, eos aliquid putare esse universos? E quel che altrove, perorando in favore di Sesto Roscio: Sic est vulgus: ex veritate pauca, ex opinione multa aestimat. E finalmente nelle Tusculane, lib. 2: Est enim philosophia paucis contenta iudicibus, multitudinem consulto ipsa fugiens, eique ipsi et suspecta et invisa, ut vel si quis universam velit vituperare, secundo id populo possit facere. Pretenderà ora l’avversario che Cicerone sia per lui?
Ma legga egli Seneca, epistola 29: Nunquam volui populo placere, nam quae ego scio non probat populus, et quae probat populus ego nescio. Legga lo stesso Seneca, De vita beata: Argumentum pessimi turba est; ed altrove: Stat contra rationem defensor mali sui populus. Legga in somma tutti gli antichi sensati scrittori, e vedrà come la loro autorità confermi la opinione nostra, e sarà dalla evidenza costretto a confessare che il giudizio popolare non è mai stato il tribunal competente né del grande, né del bello, né del buono.
Così finì la breve sua arringa il secondo avvocato; e il giudice, che attentamente aveva ascoltati entrambi, così pronunciò:
Qualunque sia la lingua o l’autore che dica una ragione, la ragione medesima ha sempre egual peso; onde del numero delle autorità citate da ambe le parti non vogliamo tenerne conto.
Vero è che molte forze riunite producono effetto maggiore; vero è che gli uomini comuni non adoprano la forza della loro ragione per giudicare; ma vero è altresì che molti giudizi non devono darsi dalla ragione, ma bensì soltanto dal sentimento, il quale è comune a tutti gli uomini e da tutti si adopera. Chi assiste ad una rappresentazione teatrale non ride riflettendo se debba piangere o ridere, ma bensì sentendo puramente l’impressione pietosa o vivace della favola; perciò il giudice competente del teatro e dell’eloquenza è il popolo, e i poeti o gli oratori che lo ricusano son veri pedanti, che ignorano i principii del loro mestiere. La strada del cuore dell’uomo è comunemente aperta, la strada dell’intelletto non già, perciò tutti godono in vista d’una nobile azione, tutti inorridiscono in vista di un’azione indegna, ma pochi si scuotono a una verità grande, pochi deridono un grande errore.
Quel popolo di Roma, che fremendo applaudiva il coraggio di Regolo che ritornava a morire in Affrica, e che avrebbe insultato qualunque avesse osato di dirne male, quel popolo istesso bilanciava fra Catilina e Cicerone, incerto qual de’ due fosse il padre o l’inimico della patria. Nel primo caso basta avere sensibilità per decidere bene, nel secondo non basta, ma convien ragionare. La sensibilità essendo comune, la moltitudine decise bene; il raziocinio essendo non comune, la moltitudine si divise parte per la verità, parte per l’errore; e se raccoglieremo dalle storie e dagli esempi che abbiamo veduti in vita nostra, troveremo che per lo più l’errore ha il maggior numero de’ seguaci. Su questi principii fondiamo la sentenza nostra, e dichiariamo d’aver buono il giudizio volgare nella musica, nella pittura, nella poesia drammatica e in tutte le facoltà le quali hanno per fine primario il dilettare, giacché gli uomini devono giudicare essi medesimi della impressione che sentono; ma dichiariamo incompetente il giudizio del popolo in tutto ciò che per conoscersi richiede ragionamento, poiché questa è la facoltà umana ad esercitar la quale s’è sempre opposta una invincibile inerzia in tutti i secoli, e dove più, dove meno, presso tutte le nazioni.
P. [Pietro Verri]
[Descrizione d’una famiglia rustica]
Amico.
Sono cinque giorni che fuori mi trovo dalle mura della città, dentro queste la natura semplice e libera ne’ suoi moti non ama lasciarsi trovare. Se è possibile tra gli uomini trovare, o dirò meglio, sorprendere la bella natura sotto li dorati tetti delle città, no, ma tra le rozze e le semplici capanne, in mezzo agli assudati lavoratori delle campagne, ella è forzata rifugiarsi. E vero che l’affannoso interesse, che trae origine dalla sola proprietà, non v’ha forse spazio di questo pianeta sovra del quale esteso non abbia il tirannico suo imperio. Se a’ contadini si perdona l’interesse, avaro non già, ma figlio solo della mancanza di quel pane ch’essi medesimi a tutto il resto degli uomini prepararono, tutto il resto tra loro è semplicità e natura.
Queste sono le idee che muovono in questi dì il mio cerebro, o dirò più giustamente, tali furono le sensazioni che gli ameni oggetti, che nel silenzio della mia solitudine mi circondano, scossero nel mio spirito e delle più aggradevoli idee l’innaffiarono; così per gradi sento da me allontanarsi gl’inquieti melanconici pensieri, e ritornare la mia mente a quello stato di tranquillità che è l’unica meta delle mie cure e de’ miei studi.
Tutto ciò che qui mi circonda mi richiama il bello, il semplice, il naturale; tutto rinova in me le sensazioni le più aggradevoli ad ogni istante; tutto in somma m’invita a star lungo tempo lontano dalle dorate prigioni chiamate città.
La più squisita sensazione ho io l’altro ieri sperimentata all’entrare in un rustico albergo in mezzo ad una vasta campagna, dove aveva indirizzato il mio passeggio, onde bevere di un’acqua purissima che colà sapeva trovarsi, e che sani e robusti più che altrove mantiene chi vi fa stabile dimora. Ah, perché non ho potuto io in quel momento meco trasportare in quel villereccio abituro tutte le famiglie de’ miei concittadini, e trasfondere ne’ loro cuori guasti e impervertiti dall’interesse particolare, dall’invidia, dalla prepotenza, dall’inganno, o dall’odio, que’ dolci sentimenti che io provava in quel punto! Entrato nel recinto di quel rustico tetto, eccomi incontro due donne, una più attempata, ma che con una fisonomia ridente mostrava una salute non alterata né dalla mollezza, né dal dolore; l’altra, giovine ancora, con tratti robusti, e maniere naturali e non istudiate, mostrava la forza e il vigore della gioventù, cui lo sregolamento de’ soverchi piaceri od arte insana di difformarsi per parer bella non avevano fatto oltraggio; domando a bere della lor acqua, ed ecco immantinenti precipitato da un uomo, chiamato a questo effetto, un secchio di legno nel pozzo, e trattane un’acqua freschissima, che mi viene in un vase di terra cotta a vernice invetriata bianco quanto la neve portata. Frattanto che io bevo sedono le due donne su’ gradini che portano nella rustica cucina, con intorno sette fanciulli tra maschi e femmine, ed un bambino in braccio a ciascheduna; io m’accosto, accarezzo un fanciullo, ed ecco tutti fatti famigliari, assuefatti già a non temere alcuno, giacché non viddero ancora chi abbia tentato d’ingannarli o di fargli danno; tutti mi corrono intorno; chi mi prende per un lembo del vestito, chi per una mano, chi finge di nascondersi colle proprie mani e poi mi salta improvisamente incontro, e chi con mal articolati suoni, ma con voce e maniere innocenti, si sforza a gara di rispondere alle mie interrogazioni; in somma non conoscono niente in me da essi di differente, benché l’oro che risplende sulle mie vesti sia per essi un oggetto nuovo ed inviti le loro mani a toccarlo; in somma io sono un loro simile, un loro fratello. Accarezzo egualmente il bambino che sta tralle braccia della donna più giovane, lo invito co’ gesti e con parole a mangiare del latte, che in vase simile a quello che mi fu presentato con acqua teneva la medesima contadina in mano, il bambino mi guarda, ride, mi porge la tenera mano, poi guarda la madre, quasi consultando i suoi moti, ed essa struggevasi sul caro figlio in baci. Domando all’amorosa madre se tutti que’ figli, che le faceano corona eran suoi, ed ella con maniere non istudiate, ma schiette, mi risponde: E che dovrò avere io preso marito, per non aver figli? E vero, le risposi, avete ragione. E col mio pensiere continuai: e perché un mal concepito interesse e tanti altri disordini hanno posto ostacoli a così naturali sentimenti di tante madri cittadine? M’addrizzo alla più attempata, che già era in moto, e che senza imbarazzo e sempre ridente disponeva il parco vitto al resto di tutta la famiglia, che già vedevasi da lontano di ritorno dal lavoro; le domando quante famiglie e quante persone abitavano in quel recinto: ella mi dice che non erano in tutto che diciotto persone componenti una sola famiglia; mi rivolgo all’uomo che mi presentò da bere, gli chiamo del loro raccolto, de’ loro lavori e della loro agricoltura: egli frattanto che mi rispondeva con termini per altro onesti e non istudiati, continuava senza affettati torcimenti od inchini, che mai non seppe, a scuotere la polvere dalle spalle e dal cappello, riposando le affaticate membra su un duro sasso, ed a soddisfare ad una ad una le mie domande, onde intesi che comuni ed eguali erano tra tutti di quella famiglia la fatica, la gara e l’interesse. Allora fu che uscitomi dal petto mio malgrado un sospiro, non di dolore, ma per la forza di un vivissimo sentimento all’idea che tutto m’inebriava di piacere di trovarmi in mezzo all’innocenza, alla semplicità, alla concordia ed alla natura, che in parte almeno mostravasi sotto que’ rustici tetti; allora fu, dico, che rivoltomi a chi meco era venuto a passaggiare non potei lasciare di esclamare: ricche famiglie della città, i titoli, i comodi, l’abbondanza, quegl’in somma che chiamate beni, non bastano a stendere sulla vostra fronte quella serenità, quella pace, quella pura gioia che brilla su questi volti campestri! Ah, la virtù solo, la innocenza, la semplicità della vita possono concederla. Uomini artefatti, che vi siete fabbricati tanti carnefici quanti bisogni, quanto mai siete lontani per sino dall’ombra della felicità che regna in questa famiglia!
G. [Giuseppe Visconti]
Promemoria che serve a maggior spiegazione della rinuncia al Vocabolario della Crusca
Veramente quando riflettiamo a quell’orribile attentato contro il Vocabolario della Crusca di avervi rinunziato con tanta impertinenza e di esserci ribellati da un sì legittimo sovrano, che da tanto tempo ha acquistato il diritto di muovere le penne e le lingue a suo piacimento, non possiamo a meno di non stupirci di noi medesimi e di esclamare: come mai siamo noi giunti a tale eccesso? Eravamo noi matti quel benedetto giorno? Come ardire ciò che non ha mai neppure pensato nessuno grandissimo uomo, di rinunziare pubblicamente alla Crusca? Quale spirito di letterario libertinaggio non è egli mai questo? Ah sì, che finalmente la luce della verità ci ha percossi, e ritorniamo a metterci nel fortunato numero de’ fedelissimi sudditi di Francesco Ambra, di Bronzino, di Burchiello, di Gian-Maria Cecchi, di messer Cino da Pistoia, di Curzio Marignolli, del grande autore dell’esposizione del Pater noster, del Pitaffio di ser Brunetto, del Fiorenzuola, della Tavola Rotonda, e di tanti altri autori grandissimi di grandissime opere, che fanno a buona ragione il testo di lingua per essere veramente testi d’idee, e che forniti d’un insorpassabile ingegno abbondano d’espressioni le più felici fra le possibili, le più eleganti fra le possibili, le più esatte, vive e energiche fra le possibili, e perciò è di dovere che abbiano scettro, corona e trono, e quello che è più, obbedientissimi vassalli. Che se qualche idea moderna voglia esprimersi, egli è ben giusto che sia vestita all’antica, per quella gran ragione che gli uomini saggi non devono essere schiavi della moda.
Ma per sempre più dimostrare quanto sia sincero il nostro pentimento, noi ci sottoscriviamo alle decisioni della Crusca intorno alle questioni di lingua; per la qual cosa confessiamo col Vocabolario che la parola altrui non si deve usare nel caso retto, cheché ne dicano alcuni torbidi ingegni, che pretendono che Dante, Passavanti, Boccaccio e Dittamondo l’abbiano usato in caso retto. Intorno alla quale importantissima quistione scrisse il Manni alla lezione sesta, pag. 151, e diffusamente fa vedere che il Vocabolario ha ragione.
Così pure ci sottoscriviamo alla sentenza emanata dalla Crusca nella famosa lite sopra que’ versi del Petrarca al sonetto 93:
… ed ho sì avvezza
La mente a contemplar sola costei,
Ch’altro non vede, e ciò che non è Lei
Già per antica usanza odia e disprezza.
Seriamente si disputò come mai avesse usato il Petrarca quel lei nel caso retto. Ah poffare! un Petrarca reo di un errore di grammatica con tanto scandalo de’ buoni? Ma voi, saggi accademici, terminaste sì scandaloso scisma con un mezzo termine che farà epoca nella politica grammaticale. Nell’ultima edizione del Petrarca, fatta sotto i vostri auspici in Firenze, invece di quel pezzo di verso: e ciò che non è lei, si mise: e ciò che non è in lei, e così con la particola in messa con giudicio e con sodi fondamenti, fu fatta la tanto sospirata pace fra le potenze.
A queste ed altre inaspettabili decisioni noi ci sottomettiamo per renderci sempre meno indegni di quella clemenza che umilmente imploriamo. Che se avremo la sospirata sorte di essere ammessi nel grembo della valorosa Accademia, promettiamo in memoria d’una sì segnalata beneficenza di scrivere sempre corbellare con due ll, ed Accademia con due cc.
A. [Alessandro Verri]
IL CAFFÈ )( Fogl. XXII )(
Difesa delle donne
Infinite doglianze si fanno in Europa contro le donne; si detesta la loro vita oziosa, molle ed affatto inutile all’umana società. Le nobili si levano tardi alla mattina, che tutta impiegano alla pettiniera; nel dopo pranzo vanno al passeggio, cioè vedono passeggiare i loro cavalli che le strascinano al corso; e fatta sera passano ad annoiarsi al teatro; il giuoco riempie alcuni vuoti della giornata. Da qui nasce la pigrizia estrema, cui si danno in preda alcune, che le fissa eternamente sopra d’una sedia e le espone a tutti i mali che porta il difetto d’esercizio. Si lamentano esse di continuo; tutto loro dà fastidio, e coperto il viso d’oscure nuvole, portano per tutta la casa la tristezza ed il languore. Altre poi, cui la vivacità naturale toglie questa indolenza, vanno con un moto incessante scorrendo per tutti i quartieri della città, e si crederebbero vergognosamente dimenticate s’elleno per ogni dove non facessero bisbiglio e fracasso grande, e non fossero vedute a tutti i balli, a tutte le visite, a tutte le assemblee. Lo sposo, acquistando il nome di marito, pare che agli occhi di molte abbia perdute le qualità amabili di prima. Quindi con minore difficoltà se gli danno alcuni motivi d’inquietitudine, che recano un colpo mortale alla pace e concordia della famiglia. Alcune poi invece di vedere ed accogliere con piacere i propri figliuoli, e gloriarsi d’essere circondate da questi preziosi frutti del loro innocente amore, con maraviglia sorprendente si lasciano persuadere da un indegno pregiudizio a concepire l’opposto, e li tengono studiosamente da sé lontani. Le donne plebee, sempre costanti in fuggire diligentemente tutte le fatiche necessarie all’economia domestica, si trovano in ogni ora del giorno coi loro pargoletti in braccio a perder tempo civettando e confondendo la sfrontatezza con la vivacità; accoppiando le maniere più libere ad un’aria decisa la quale se fa l’ornamento d’un valoroso e imperterrito granatiere, è altresì agli occhi d’ogni ragionevole persona una macchia, e un disvezzo, e una disgrazia, dirò così, sul volto femminile, dove la dolcezza e la placida bontà devono animarne le fattezze, e renderne i tratti più toccanti. L’occupazione intorno la loro bellezza sembra quasi universale alle dame; né può ella ragionevolmente biasimarsi sin tanto che viene contenuta entro certi limiti. Ma cert’une a questo solo pensiero sacrificano ogni altra cura, e ciò è male. Altre poi, da che l’arte serve ad abbellire la natura, ne cavano una ridicola conseguenza, e tanti e tanti artifici ed ornati aggiungono, e moltiplicano, ed ammucchiano, sicché la naturale grazia ne resta gotticamente oppressa e seppellita.
Questo è il ritratto che si va producendo del sesso; ed in verità egli è ben somigliante all’originale; i colori esprimono il vero, il disegno è giustissimo, ma se poi si vuole passare col sesso medesimo a farne querela, sarebbe questa in parer mio irragionevole ed ingiusta. Con noi stessi bisogna lagnarsene, perché noi stessi loro additiamo questa tenebrosa strada e le costringiamo a battere questo fangoso sentiere.
Troppo negligentiamo l’educazione delle femmine nella loro fanciullezza, e come se queste fossero d’una spezie diversa da quella degli uomini, le abbandoniamo a se medesime in mezzo ad una truppa di frivolissimi giovinastri, senza soccorso, senza consiglio. Non si presenta loro mai alcun nobile oggetto in cui possano esercitare utilmente il loro talento. Si proibisce loro lo studio delle scienze e delle belle arti sotto pena d’essere ridicole; né giammai si dà loro una lezione al cuore di virtù e di forza. Nell’età più adulta guastiamo in esse perfino le buone disposizioni che la natura loro ha date; le diamo in preda alla mollezza ed alle false opinioni; diamo loro i lacci per impedire i voli del loro spirito, imprigioniamo loro il cuore, affinché non sentano l’attrazione della virtù. Da un sì stravagante procedere sono elleno determinate a non pensare ad altro che a coltivare i loro vezzi ed a lasciarsi dolcemente sedurre dalle inclinazioni lusinghiere. Dell’alienazione ch’esse hanno alle volte per i loro mariti, questi stessi sovente ne sono la cagione per mancanza di prudenza o di ritenutezza. Molti mariti si lasciano da principio condurre dalle medesime come fanciulli, e vogliono poi ripigliare intempestivamente un’autorità ch’essi hanno perduta per loro colpa. Altri uniscono bestiali trasporti, ed una volontaria mancanza del puro necessario e conveniente ad una tenerezza capricciosamente messa in campo, che una consorte irritata non sempre riceve di buona grazia. L’educazione dei figliuoli è comune ad ambidue i genitori, e non di rado succede che il padre, pieno d’una condiscendenza impropria, permette che i suoi figli, cacciati colà fra la feccia più vile de’ servi, imparino a mentire, ad usare termini indegni; e fatti insopportabili vadano poi a stordire la madre e mettere a rumore tutta la casa. Dovranno dunque tali mariti lagnarsi se le loro mogli non sono d’una natura angelica, e se manchino di compiacenza per un uomo irragionevole al quale sono legate? Se non mostrano tenerezza per que’ figliuoli che la meritano sì poco, e che starebbero meglio altrove che nella propria casa?
I vizi sono degli individui e non del sesso. Questo è fatto per essere la delizia della società, e se noi ci prendessimo la pena d’istruirgli la mente e presentargli idee più belle, di dirigergli il cuore ed elevarlo al di sopra dell’umile rango in cui giace, corrisponderebbe egli perfettamente ai nostri desideri, e perverrebbe a quella nobile meta alla quale fosse indirizzato. Gli uomini, incantati dalla beltà, sembra che non possano trovare nelle donne altra cosa di quella più pregievole. La beltà veramente è il più grazioso spettacolo che ci presenti la natura; ma questo spettacolo non è compiuto se manca qualche cosa all’anima. Quando la beltà medesima va unita ad un merito più sodo e permanente, si può dire ch’ella fa onore all’umanità. La virtù rende una femmina più bella; la beltà dal suo canto aggiunge un nuovo lustro alla virtù, che in certa maniera è individuata e resa visibile con tutte le sue attrattive nella persona d’una donna amabile e saggia. Questo sesso, dice Montagne, ha un ingegno pronto e di primo risalto; ed un profondo filosofo[58] gli attribuisce le grazie dell’immaginazione e del buon gusto. Or qual cosa non si deve alla grazia dell’immaginazione ed al buon gusto? Quella forma i poeti, gli oratori e gli eleganti scrittori, ed ha rese celebri tre nostre valorose donne milanesi in questo secolo. La prima, dotata degli amabili talenti della greca Saffo, ha ricreato e tuttora ricrea lo spirito colle più vive ed allegre immagini che può essere capace di delineare una delicata e tersa poesia. La seconda, esponendo con ammirabile chiarezza e facilità la più sublime geometria, appiana la strada alle scienze più profonde. La terza, non meno cara ad Apolline, ha unita la cultura di quanto le cognizioni umane nella storia, nella fisica, nell’accurato stile della propria lingua hanno di più certo e di più brillante, ed ha emulati i più dotti suoi concittadini senza rattristarli, se non se allora che un’immatura morte l’ha rapita.
Il gusto variamente è definito dagli autori; ma ciò ch’è certo si è che il buon gusto dipende da una certa aggiustatezza di mente e da sentimento delicatissimo del cuore. L’aggiustatezza di mente è un non so che di saggio e di abile, che conosce tutto ciò che gli conviene e che fa sentire in ciascheduna cosa la misura che si deve tenere. Questa ha rese capaci tante regine di governare vastissimi regni, e questa stessa può dettare a tutta la più bella metà dell’umano genere un tenore di vita innocente e regolare, piena di virtù per i loro domestici, di amorevolezza per i loro prossimi, di pace e concordia nella famiglia e di sollecitudine per i loro figliuoli; i quali trovando in seno della madre i testimoni d’una viva e giusta tenerezza, non mancheranno di corrisponderle colle loro grazie e con una pronta ubbidienza. Non ha la natura legame da paragonarsi a quelli che uniscono una madre amorosa ai figliuoli di tale tempra. Questo dolce impero, cimentato per mezzo dei beneficii e della riconoscenza, forma tutta la gloria e la felicità d’una madre saggia. Un buon discernimento farà capire a questa che, lungi di temere che i suoi vezzi possano essere scemati dalla moltitudine di essi, li troverà moltiplicati nella riproduzione delle proprie fattezze sopra un drappello di graziosissimi pargoletti che dolcemente le scherzeranno d’intorno. L’aggiustatezza di mente persuaderà alle donne che il maneggio e l’economia domestica sia di loro ragione; che il travaglio, essendo una necessità universale, conviene anche ad esse, di qualunque rango siano; che l’amore al medesimo mantiene tutte le virtù e fa onore al sesso ancor sul trono.[59] Il sedere ad un banco di cambio per dirigere le opportune corrispondenze, ed il presedere ad una manifattura non è fuori della sfera d’una mente ben regolata d’una cittadina. Vi sono molte arti, le quali essendo compatibili colla delicatezza e ritiratezza delle femmine, potrebbero essere comunemente esercitate dalle plebee senza pericolo che soffra alcun intacco la loro beltà.[60] Questo costume sarebbe d’un utile insigne allo Stato, perché si formerebbero esse da sé la loro dote, soccorrerebbero nelle occasioni il marito e la famiglia, e darebbero coraggio agli uomini di contrarre matrimoni.
Il delicatissimo sentimento del cuore scopre mille bellezze, e lo rende sensibile a mille dolcezze che sfuggono al volgo. Egli a guisa d’un microscopio ingrossa gli oggetti impercettibili agli altri. Egli è che porta al grado eroico le virtù, le quali congiunte colla beltà riescono di doppio utile, poiché hanno un sovrano potere sopra dell’uomo, che per una fortissima inclinazione verso la beltà medesima è spinto ad imitarle. Che esempi insigni non ci hanno date in ogni tempo le femmine nel culto della religione, nella difesa della virtù e nell’amore coniugale? Quella che particolarmente chiamasi virtù nelle donne, non credasi già una virtù molle e di riposo, perché non abbia a che fare per ordinario se non con passioni dolci e piacevoli. Sono queste più difficili a vincersi che le aspre e le terribili. Io stesso ho conosciuta una felice pastorella, che non ha guari ha dato a noi un insigne esempio di luminosa virtù. Nel tempo stesso che un crudele giovane la trucidava lentamente colla speranza d’indurla a’ suoi voleri, essa lo esortava a ravvedersi, gli porgeva la mano in segno di pace e gli pregava dal Cielo il perdono in ricompensa della corona del martirio che le donava.
Che l’amore coniugale sia nelle femmine virtuose più forte che negli uomini, la ragione e la sperienza abbastanza lo insegna.
Le sensazioni devono essere più vivaci nelle donne di quello che non lo siano negli uomini, e ciò per la maggiore delicatezza d’organizzazione; la immaginazione femminina, e quella finissima grazia ch’elleno naturalmente hanno sia raccontando, sia scrivendo, sì che vi dipingono gli oggetti al vivo, ne sono una prova bastante. Lo stile delle donne, per poco che sieno elleno dirozzate dalla educazione, in ogni lingua è composto di vezzi d’un tal genere che noi indarno cercheressimo di ritrovare. Da questo principio ne nasce che le passioni sieno anche più violente nelle donne, cosicché superano le nostre, se non nella durata, almeno nella intensione. Fra i mezzi umani atti a rintuzzare l’impeto d’una passione vi è quello di dividere la sensibilità dell’animo su molti oggetti che si bilancino. Così l’amore della gloria, l’ambizione, la cura del patrimonio, le scienze e simili, occupando parte de’ sentimenti dell’uomo, minore ne rimane da occuparsi per l’amore. L’amore è occupazione delle persone oziose, quindi le donne amano più fortemente e con più applicazione di spirito di quello ch’esse non sono amate. Il loro cuore rassomiglia a certi fiumi ristretti e serrati d’alte sponde che non hanno che una pendenza, per la quale liberamente possano scaricare le loro acque. Il pudore, il timore, la legge di Dio e quella del mondo sono i felici ostacoli che lo circondano da tutti i canti; non può uscire dal suo letto senza romperli, né romperli senza una violenza straordinaria. Allorché fra tanti impedimenti scorge una parte a cui rivolgersi, come lo è il consorte, vi scorre con minore riserva che non fa il cuore dell’uomo, similissimo a que’ fiumi vaghi che non hanno né sponda, né gran pendenza, e che nello stesso tempo trovano certi rigagnoli aperti per distraersi.
Alla ragione si accorda ancora la storia, che è la conservatrice della virtù, la depositaria dei bei originali e la rapportatrice dei grandi esempi. Io l’ho consultata in molti paesi e in molti secoli, e confesso che sempre mi ha presentata una schiera di femmine, che sono morte nella fedeltà e nell’amore dei loro mariti. Ma quando io ho dimandati a lei dei mariti d’eguale virtù, con vergogna del nostro sesso appena me ne ha potuto ella chiamar per nome alcuni. Fra le grandi eroine in questa virtù, una ce ne presenta lo Stato di Milano, non già in quei chiari secoli nei quali la lodata e ricompensata virtù rendea comuni in Italia le azioni eroiche, ma bensì nel secolo XII di nostra salute, secolo dei più oscuri che fossero giammai. Ella è Bianca de’ Rossi, cremonese, moglie di Giovanni Battista della Porta. Presa questa coll’armi alla mano, tutta molle di sudore e di sangue come un’amazone nella piccola città di Bassano, ch’ella difendea dopo la morte di suo marito che n’era governatore, si gettò di slancio da una finestra sul punto d’essere insultata da Azzolino, che se n’era invaghito. Ma poi ricondotta al barbaro, risanata che fu dalla caduta, fu esposta ad una violenza tirannica. Piena questa donna forte d’un’estrema confusione per una colpa non sua, si prevalse della prima libertà che poté avere per correre al sepolcro dell’amato marito. Entrata in esso si fece cadere sopra la pietra che lo copriva, e più ammirabile dell’antica e forse favolosa moglie di Collatino, seppellissi colle preziose reliquie d’uno sposo, a cui moriva fedele.
Ma non crediamo già che la sfera delle virtù eroiche delle femmine sia ristretta a ciò solo, e che non siano esse in altre virtù capacissime di superare gli uomini. Questa sfera comprende ancora quelle virtù che si vogliono tutte proprie d’un animo virile, come sono l’alta generosità ed il valore militare. L’alta generosità, a ben definirla, è una grandezza di coraggio o un’altezza di spirito, per la quale un animo elevato al di sopra dell’utile, del piacevole e del penoso si porta inviolabilmente e senza deviare in modo alcuno al dovere, che è laborioso, all’onesto, che è difficile. Se ad una femmina oltre del dovere e dell’onesto proprio del suo sesso avviene che si presentino altri doveri ed altri onesti, e se per arrivarvi è necessario lasciare un interesse certo, abbattere una fortuna già fatta, disprezzare i piaceri più lusinghieri, dare il proprio sangue, esporre la vita, che dovrà fare questa femmina ben educata e piena di nobili sentimenti? Non lascerà certamente di correre dietro alle luminose attrative di quest’eroiche virtù in mezzo di tutte le difficoltà, di tutti i spaventi. Ciò non potendosi fare senza d’un’alta generosità, bisogna concedere che le femmine possano esserne capaci.
Il valore militare non dimanda braccia d’acciaio né mani di ferro. Gli antichi eroi non erano statue di bronzo, né tutti aveano la complessione di quel famoso greco che non temeva contro le più grosse catene; anche al dì d’oggi uomini non seccati al sole, non induriti al gelo guadagnano le battaglie. La bellezza e la delicatezza delle membra non sono così timide né incompatibili col valore militare, come alcuni si persuadono. La Sagra Scrittura parla d’una colomba che punto non era meno terribile dell’aquile.[61] Si hanno degli spiriti generosi e delle anime forti in petto delle femmine delicate; delle mani vittoriose coperte di guanti profumati, nella maniera che alloggiano dei conquistatori sotto tende dipinte e coperte d’oro.
Per altro la delicatezza è in esse accidentale, ed a questo proposito osserva giudiziosamente Platone che se l’eccesso d’umidità, che stempra il loro vigore e le rende più molli degli uomini, fosse disseccato da un esercizio moderato, la loro complessione sarebbe ridotta ad un’uguaglianza più giusta ed esatta che la nostra: i loro corpi sarebbero più robusti e più agili, ed avrebbero il movimento più libero e di più lunga durata, nella guisa che le femmine degli sparvieri hanno il volo più veloce e quelle degli animali domestici soffrono più lungo tempo la fatica.
Il cuore è la parte più essenziale del valore. Egli è quello che incomincia tutti gli affari, che intraprende tutti i combattimenti, che va il primo sul campo e che ritorna l’ultimo. È necessario solamente che egli venga agitato da una forte passione, nella maniera che un acciaio, qualunque sia la durezza che abbia avuta dalla natura, non può diventare una spada per la guerra se non è prima lavorato ed aguzzato. La forza per se stessa resta materiale, immobile e senz’azione se non è stuzzicata, come dice il filosofo, dalla collera; ma da quella collera che è nobile, che forma i valorosi. Or egli è certo, per testimonio della Divina Sapienza[62] e dalla sperienza stessa, che questa collera è ben più viva nelle femmine che negli uomini, e per conseguenza se il costume loro ha tolto il valore acquistato, non ha tolto il valore naturale, e quel maggiore spirito di bile che è lo spirito guerriero, e l’ultima tintura dell’umore che forma i prodi. Gli esempi dati nei secoli a noi vicini e raccontati dalle storie moderne, d’un drappello di femmine italiane, cui la morte violenta e sanguinosa della madre, del marito e del padre, l’esposizione alle guerriere più terribili macchine ed al fuoco dei propri figli, e finalmente la sicura perdita della loro vita medesima non hanno punto impediti i nobili impeti della loro generosità e del loro militare valore, termineranno di convincere coloro che ripongono le femmine generose fra i mostri della natura, e credono che un cimiero ed una svolazzante piuma sopra del loro capo non formino un minore prodigio di quello che lo facessero nei secoli favolosi i serpenti sopra la testa di Medusa.
Recatasi una fanciulla di tenera età sopra la breccia per la quale voleano i Turchi portare il ferro ed il fuoco alla città d’Agria, come sua madre, ch’era nella fazione medesima e che portava sopra la testa un gran sasso, fu colpita e distesa morta da una palla di cannone, ella non comparve punto sorpresa di questo accidente, e non perdette né la sua risoluzione, né il suo posto: il di lei cuore non restò punto abbattuto da questo colpo, e senza cangiare colore in viso rammassò freddamente la pietra stessa tutta calda del materno sangue, la rotolò sopra dei primi che si avvanzarono. Uguale fu la generosità e l’ardire d’un’altra, che nella stessa città e nello stesso assedio combatteva fra sua madre e suo marito. Questo dopo un lungo ed ostinato combattimento venne ucciso al suo fianco, ed essendo la guerriera avvertita da sua madre a ritirarsi per fare gli ultimi doveri all’estinto consorte, Dio mi guardi (rispose l’intrepida) d’una pietà sì disordinata; è tempo di vendicarlo, e non di piangerlo; i funerali si faranno ben tosto, se noi viveremo, e se io dovrò morire, il mio corpo gli sarà una pietra sepolcrale abbastanza gloriosa, ed il mio sangue mischiato col suo gli farà più onore che le mie lagrime. Queste coraggiose parole furono seguite da un’azione ancora più coraggiosa. Gettò ella la sua spada, e dopo d’avere presa quella del marito, si spinse fieramente fra gli assalitori, ne uccise tre e mise in fuga il resto. Ciò fatto si caricò su le spalle il cadavere del marito per dargli sepoltura.
Regnando Maometto II, i Turchi, condotti dal bascià Solimano, discesero nell’isola di Solimene ed attaccarono Coccin, che n’è la capitale. Dopo vari assalti dati in diverse parti e coraggiosamente respinti, in fine o per artificio o per forza essi guadagnarono una porta, alla quale il combattimento fu più ostinato che mai, finatanto che il governatore della piazza vi perdette la vita. Stavasi allora la figlia del governatore medesimo, chiamata Marulla, su la muraglia con altre femmine, preparata per ben ricevere il nemico, ed a fare per il loro onore e per la loro religione più di quello che ordinariamente richiede il loro sesso. Questa, che avea gli occhi ed il cuore al combattimento, veduto il colpo che atterrò suo padre discende precipitosamente dalla muraglia e si produce alla porta. Ella penetra fra il ferro ed il fuoco perfino al cadavere di suo padre, prende la di lui spada ed il di lui scudo, e come se avesse con essi preso anche l’ardire del di lui cuore e la forza del di lui braccio, si caccia più oltre fra’ nemici; respinge gli uni, abbatte gli altri, e finalmente combatte con tanto coraggio che sostenuta da’ cittadini pone in fuga i Turchi, e li costringe a rimontare sopra le galere, che furono obbligati a ritirarsi lo stesso giorno, lasciando la libertà a Solimene e la vittoria a Marulla, che fu condotta in trionfo in mezzo agli applausi della città tutta e della flotta veneziana, che poco dopo comparve per soccorrere l’assediata città.
Ma perché vado io ricercando nelle storie esempi illustri delle femminili virtù? L’Augustissima Imperatrice Regina, cui ubbidiamo e per amore e per dovere, ci offerisce un compendio di tutte le più eminenti virtù, compendio tanto più efficace quanto più egli è luminoso e illustre agli occhi dell’universo. Siami permesso l’omettere le virtù proprie della Regina, la religione, la magnanimità, la forza, la indefessa cura, il provido consiglio, la incorrotta fede, la giustizia, e tutte le eccelse virtù pubbliche che rendono il di lei regno prezioso ai popoli soggetti e glorioso al mondo tutto; siami permesso citare le sole private virtù dell’Augusta Sovrana. Dove troveremo noi maggior clemenza e dolcezza accoppiata alla maestà, senza il fasto della suprema sua condizione? Dove una più tenera compassione e cura più materna per tutti i miseri? Dove una più tranquilla fermezza anche fra gli estremi pericoli, virtù tutte le quali avrebbero potuto formare un’eroina anche in una fortuna privata? Deliziosa è la pace, l’unione in quest’augustissima famiglia, ed impareggiabile è la sollecitudine per l’ottima educazione dei grandi principi che formano la nostra speranza. Qual dolce spettacolo per una madre teneramente amata, veder le proprie virtù riprodursi intorno al trono! Qual gloriosa ricompensa di una magnanima Principessa, che per le virtù sue cara allo Stato, cara all’augusto suo sposo, riceve le benedizioni de’ suoi popoli e l’amirazione dell’Europa! L’amore, la tenerezza, la benevolenza animano quella virtuosa corte. Felici i popoli che sono soggetti a tali regnanti, poiché il regnare altro non è che un paterno governo più esteso.
[Sebastiano Franci]
IL CAFFÈ)( Fogl. XXIII )(
Alcune riflessioni sulla opinione che il commercio deroghi alla nobiltà[63]
Vivimus ambitiosa paupertate… Iuven. Sat. III.
Sono tanti gli errori del genere umano, che ben di rado prendi la penna in mano che non te se ne affacci alcuno da confutare. Ma benché tal fatica riesca per lo più inutile, non pertanto lascia l’onest’uomo di ritrovarvi quel piacere che nasce dal sentimento della buona volontà. Una funesta esperienza ci convince che altrimenti per lo più non ricompensano gli uomini chi loro svela alcune verità, che per lo meno col non ascoltarlo. Tanto avrei io pure a temere se non fossi nato nel secolo decimo ottavo, in cui pare che l’uman genere vada sempre più rendendosi degno dell’addiettivo di ragionevole che ha saputo sì poco meritare ne’ secoli addietro. In questa luce di scienze, che sfavilla e cresce fra le colte nazioni d’Europa, in questa magnificenza della natura che contempliamo, divengono più dolci i costumi e la vita; s’è resa amabile per fine la un tempo noiosa sapienza, e si fa di giorno in giorno più facile quae sentias dicere, che a rara felicità de’ suoi tempi Tacito ascriveva. Poiché se io avessi osato neppure pensare a questa materia un secolo fa, quanti non mi avrebbero trattato da scandaloso e libertino in genere di nobiltà?
D’onde mai ebbe origine questa opinione che la mercatura deroghi alla nobiltà? È ella ragionevole? È ella utile? Conviene rispondere a tutti tre questi quesiti.
Questa idea che l’industria, le arti, il commercio sieno vili e sordide cose non può nascere che in una nazione che ponga la sua massima forza nell’armi, ed in cui ogni cittadino debba essere soldato. In tale nazione, che di barbari costumi dev’esser necessariamente, le arti sedentarie, l’industria, la mercatura sarebbero occupazioni opposte allo spirito del suo sistema. Perloché i Romani, che prima per necessità furono saccheggiatori, poi per instituzione guerrieri, dovettero avere a vile ogni arte, ogni mercatura, ed a quelle ed a questa fu abbandonata la più vil feccia de’ servi. D’onde ne venne che il nome di mercator era presso di loro come una nota d’infamia. Né questa opinione durò soltanto ne’ primi secoli, ma quantunque si sminuisse a poco a poco la sua forza in ragione del ripulimento de’ costumi, ella era tuttavia addottata da’ più rispettabili filosofi di quella Repubblica, e Cicerone avea certe dottrine in materia di commercio che non avrebbero molto applauso dagli uomini ragionevoli d’oggidì. Chiama egli illiberali e sordidi i guadagni di tutti quegli artigiani che non vendono le loro arti, ma le loro opere: sordidi ancora chiama que’ mercanti, che comprano le merci per poi rivenderle, poiché, dice egli, non possono essi profittare su delle medesime senza dir molte bugie; e perfine consiglia a’ più ricchi commercianti di accontentarsi di un discreto guadagno e di ritirarsi alle loro terre.[64] Dal che ben si conosce come pensassero in materia di commercio le menti regolatrici della Repubblica.
Da questo spirito nemico dell’industria furono dettate le leggi romane,[65] quelle leggi che abbiamo da lungo tempo addottate e venerate. Ma questa dottrina che la mercatura sia abietta e vile cosa, dovette perdere alquanto la sua forza in Italia allorquando succedettero all’antica parcità de’ Romani le ricchezze, ed il lusso, sinché riprese tutta la sua forza in que’ miseri tempi in cui un nembo di settentrionali si scagliò sull’Europa. Allora ogni arte che non fosse la militare dovette essere disprezzata, perché le armi erano la cosa più necessaria. Dovea lasciare l’agricoltore l’aratro per prendere in sua vece l’arco e l’asta. E chi avrebbe consigliate le arti e la pacifica industria? Quindi ne venne che i segni d’onore e di stima furono conferiti a’ più valorosi, e per acquistarli il guerreggiare era l’unico mezzo. In tal sistema di cose dovette per certo esser il mestiere della nobiltà, cioè de’ più ricchi ed onorati, quello dell’armi, né è da stupirsi se tutti gli onori furono accumulati su di una professione divenuta di prima necessità. Onde tutto ciò che distraesse i cittadini dalla guerra fu risguardato come una specie d’infamia. Ma come sono più lente nel mutarsi le opinioni e le leggi di quello che non lo siano le circostanze di una nazione, così le prime se ne rimangono per lo più indietro, per modo che un secolo non ha quelle leggi e quelle opinioni che lui sarebbero convenienti, ma bensì quelle del secolo, o di più secoli anteriori eziandio. Quindi è che se non sono paralelle le rivoluzioni che fanno queste tre cose, leggi, opinioni, circostanze in una qualunque nazione, succede che molte ruote della machina politica sono fuori di luogo. Seguendo questo giro delle umane vicende si credette ancora che fosse utile alla Repubblica che i nobili fossero solo destinati alla guerra, ancorché cessato ne fosse il bisogno. Il disprezzo per le pacifiche arti continuò, benché non continuassero le circostanze che lo aveano fatto nascere, ed i successori di quegli eroi che aveano difesa la patria si riposarono indolentemente su gli allori de’ loro antenati. Poiché essendo avvilita l’industria e l’armi solo onorate, cessato l’uso dell’armi altro non restò che il vivere oziosamente. Dalla ferocia de’ costumi alla tranquilla industria non è immediato il passaggio, che anzi fa d’uopo che l’irresoluzione e l’indolenza vi siano di mezzo.
Di tutte queste cose ce ne forniscono mille esempi gli antichi feudatari. Questi ognun sa che altro non erano che illustri guerrieri, che doveano unirsi colle loro truppe quando s’intimava il bando generale di guerra. Egli è naturale che arrivassero a quest’onore di essere feudatari col distinguersi nella guerra. Ora rimontando nella genealogia delle famiglie veramente nobili vi si ritrova un feudo; che anzi altro non è l’esser conte o marchese oggidì che l’esser feudatario di qualche terra o borgo. Ecco adunque come la nobiltà originariamente venga dall’armi.
Tale a presso a poco è l’origine della nobiltà, e tale l’origine altresì di questa opinione che la mercatura le deroghi.
La quale opinione quanto era salutare e giusta ne’ secoli in cui nacque, altrettanto è nociva e fuor di tempo oggidì. E tanto io non dubito di asserire, benché sappia di avere contro di me una rispettata autorità, cioè l’autore dello Spirito delle leggi. Parlando egli specialmente dello spirito della monarchia come opposto al commercio, dice che il permettere a’ nobili la mercatura sarebbe un distruggere la nobiltà senza recare alcun utile al commercio. La pratica di questo paese (parla della Francia) è savissima; i negozianti non vi sono nobili, ma possono divenirlo; essi hanno la speranza di diventare un giorno nobili… non hanno più sicura maniera d’alzarsi dalla loro professione che di ben farla, e di farla con fortuna, ciò che d’ordinario suppone qualche merito… l’acquisto che si può fare della nobiltà col danaro incoraggisce molti negozianti perché si mettino in istato di arrivarvi.[66] Al che io rispondo di passaggio che questo incentivo all’industria de’ commercianti sarebbe più grande e più utile se avendo essi di mira d’arrivare un giorno agli onori della nobiltà per mezzo delle ricchezze, vedessero altresì che loro sarebbe permesso di seguitare l’incamminato commercio e di percepirne tuttavia i grossi guadagni. Giacché ben pochi de’ ricchi mercanti vorrebbero comperare la parola di conte e di marchese o d’altra simile vanissima cosa col sagrificio d’un bene reale qual è un grosso commercio. Che se di questi vani mercanti si dassero, non sarebbe al certo utile alla repubblica che divenissero nobili, poiché è ben più utile un cittadino che accresca le ricchezze della nazione di quello che lo sia un nobile che non le accresce o per lo più le diminuisce.
Ma ritornando a quanto dice l’autore dello Spirito delle leggi, che i nobili intercetterebbero il commercio fra i mercanti e la plebe, con che pare che voglia dire che ridurrebbero a sé tutti i guadagni del commercio: non sono forse, io rispondo, i nobili, mercanti di grano, vino, seta, lino, lana e per fine di tutt’i prodotti delle loro terre; e hanno forse per questo il monopolio di tutti questi generi? E perché cred’egli che i nobili potrebbero far tanto di ruinare il commercio della nazione? Su che sarebbe fondata questa loro chimerica potenza? Forseché in uno Stato monarchico i più ricchi non sono i commercianti, come vediamo tutto dì? Non possono forse più questi che i nobili, dove si tratti di vendere e comperare? Io credo che con questo principio dovrebbe la politica impedire che un troppo ricco commerciante seguitasse a commerciare. Il che per certo sarebbe un dogma assai bizzarro.
E molto più mi pare mal fondato questo timore, che i nobili in una monarchia potrebbero a sé ridurre il commercio, quando considero che di lungo minore è quella porzione de’ nobili che può qualche cosa in una monarchia, di quello che non lo sia quella che può niente. Onde io dico che allora soltanto accaderebbe che i nobili riducessero a sé il commercio qualora essi avessero una grandissima potenza, ed in tal caso questa nazione non sarebbe più una monarchia, ma sì bene un’aristocrazia. Né io vedo questo pericolo, che i nobili intercettino il commercio fra i mercanti e la plebe, se esso ceto di nobili non abbia la facoltà legislatrice; né tal esempio s’è veduto, per mio avviso, in alcuna nazione che col permettere a’ nobili il commercio, essi l’abbiano a sé assorbito; perché, io il ridico, se potessero tanto, essi avrebbero anteriormente una gran potenza, più di quello che comporti lo spirito d’una monarchia. Che se in que’ governi medesimi in cui i nobili hanno la facoltà legislatrice, od almeno un’assai più grande potenza che nelle monarchie, come sono l’Olanda, l’Inghilterra e come ne abbiamo esempi in Italia, non s’è avverato che commerciando i nobili abbiano intercettato la mercatura fra i mercanti ed i plebei, od abbiano fatto ogni sorta di monopolio, come teme egli altrove,[67] a che ciò temere nelle monarchie, in cui è più circonscritta la potenza de’ nobili? Ma tali verità ha sentite esso medesimo autore dello Spirito delle leggi.
Il presidente Henault nel supplemento suo all’Abregé chronologique de l’histoire de France, opera insigne, a pag. 149 dice: Si vedrà che l’autore dello Spirito delle leggi lib. XX, cap. XIX, non si era abbastanza spiegato su di tal soggetto, onde ha più precisamente sviluppate le sue idee nella nuova edizione che sta per dare al pubblico e che m’ha fatta vedere. Quindi aggiunge: Si era a questo luogo della edizione dell’opera presente quando la morte ce lo ha tolto.
Fatto si è che questo falso timore concepito anche da rispettabili uomini, che del commercio concesso ai nobili possano essi abusarsi in pubblico svantaggio, è stato cagione di molti mali che seco strascina l’indolenza d’un numeroso corpo de’ cittadini.
Perché io dico che le leggi che nel presente sistema animassero i nobili a commerciare, ad altro non tenderebbero che a sostenere i nobili poveri ed a renderli utili alla patria, mentre che altrimenti meschini ed oziosi a nulla sarebbero utili. Essendoché quei nobili che sono ricchi e potenti, e che hanno molti ed ampi fondi non si darebbero l’incomodo di commerciare, il quale incomodo non è piccolo ne’ suoi principii. Ed è naturale che colui che di nulla ha bisogno non cerchi di arricchirsi colla industria. Laddove tanti poveri nobili che appena si strascinano seco una squallida nobiltà, di cui sono la vittima, riescirebbero cittadini utili a sé ed alla patria, e si porrebbero al partito della industria per alzarsi al livello de’ nobili potenti; onde questo ceto in vece di essere un ammasso d’oziosi, sarebbe un ammasso d’industriosi.
V’ha taluno che crede che la povertà de’ nobili sia un incentivo per rendergli utili alla patria, acciocché spinti dal bisogno s’impieghino in cariche militari, politiche e civili, e pare che tema che quando fossero comodi e ricchi non vi sarebbe chi in queste pur necessarie cariche s’impiegasse. Ma quand’anche non vi fosse il motivo della povertà che spingesse i nobili a ricercar delle cariche, lo sarà sempre uno grandissimo e sufficientissimo la sola esca dell’autorità, e di essere a parte in qualche maniera del governo. Il qual piacere è vivissimo al cuor d’ogni uomo che non cerca le ricchezze che come mezzi atti a mettere altrui nella sua dipendenza; sicché preferisce l’obbedienza degli uomini alle ricchezze, che anzi le considera come un mezzo atto ad ottenerla. Ed in fatti se penetreremo nel cuore di colui che coll’industria ammassa il denaro, non troveremo noi forse, analizzando questa sua passione, ch’egli oscuramente e confusamente altro non cerca che di riparare l’ingiurie degli uomini, e di alzarsi su di loro coll’insigne vantaggio delle ricchezze compratrici del potere? E chi cercherebbe d’arricchirsi se fosse persuaso di essere potente a segno di potere tutto ciò che vorrebbe? Per la qual cosa io sono di parere che il solo desiderio dell’autorità e dell’onore potrebbe indurre i nobili a cercare le cariche. Oltre di che m’è molto sospetto colui che è indotto a ricercare una carica pel solo desiderio di torsi ad una misera vita; questo motivo ha un impronto di bassezza che può accompagnarlo anche sulle sedie de’ magistrati. Laddove il desiderio d’onore e di autorità ha qualche cosa di nobile e di generoso, e contiene in sé l’amore della stima altrui, il qual sentimento è a meraviglia produttore di molte virtù necessarie ne’ magistrati, i quali se altro non curano che l’immediato acquisto di denaro, corrono gran rischio che questa passione dominante non lasci luogo ad altre più generose.
Ma d’uopo non è di mostrare più a lungo che è mal fondato quel timore che possano mancare nobili alle cariche, poiché al contrario queste mancano ai nobili. Conciosiaché l’esperienza ci convince che per quante sieno le cariche nel militare, o nella toga, od in qualunque altro civile impiego a cui abbiano accesso i nobili, convien pure che molti d’essi, anzi la maggior parte, ne rimangano oziosi. Da ciò ne nasce un gran male, cioè che tanti cittadini, che potrebbero essere utili alla patria, non lo sono, che anzi è molto se non siano nocivi. Poiché un corpo di uomini che tutto riceve dalla società, ed a lei nulla restituisce, non gli può essere che d’aggravio. Quindi è che il costume si corrompe coll’ozio, che lo spirito di patriotismo s’annienta e che l’inquieta attività di taluni, non avendo altro impiego, si rivolge al giuoco, alla licenza ed a qualunque altro dissipamento, e quindi è che riesce il ceto de’ nobili un popolo ozioso e gallonato. I quali danni assai crescono in que’ paesi in cui il corpo de’ nobili sia numeroso in maniera che costituisca una considerevol parte della nazione. Ma ciò che riesce ancora più fatale si è quando i nobili poveri, costretti a vivere nobilmente male ed essendo ognora punti dalla viva emulazione di non essere degli altri meno ricchi, procurano di essere in eguale equipaggio de’ più potenti per istrade e per mezzi d’arricchirsi che non sono punto nobili. In qualunque nazione la buona o cattiva morale, il rispetto o la disistima alla virtù hanno grandissima influenza alla sua felicità o miseria. Gli effetti della mancanza di morale son lenti, è vero, ma sordamente producono nella lunga rivoluzione di più secoli effetti tanto più grandi quanto irreparati, perché inaspettati; e dirò, quasi operano le cose morali per alluvione, come i fiumi. E grande credeano per certo l’influenza de’ costumi sulla pubblica felicità i Romani, presso de’ quali grandissima era la cura de’ costumi, mores, la qual parola presso di loro significava assai, come quegli che la pubblica disciplina attentamente conservavano. La corruzione del cuore umano è una malattia epidemica: se spenga negli uomini certi principii di morale, o se gli rintuzzi soltanto, può cambiare la faccia d’una nazione. Ma siccome che hanno parte nel formare le idee del volgo anche in una monarchia gli nobili (poiché quel rispetto, quella riverenza ch’egli dimostra s’estende sino al suo spirito, sicché egli conformi le sue opinioni a chi gli può far bene o male, come vi conforma le parole e gli atti esterni), così se mai in alcuna nazione ve ne fossero molti di questi, in cui la virtù, il patriotismo fossero spenti dall’ozio e dalla dissipazione, e forse anche la di cui morale fosse men che nobile, in tal caso, io dico che la plebe a poco a poco strascinata da questo cattivo esempio vi si conformerebbe, e che a poco a poco in essa ancora s’estinguerebbero molte idee morali. Se per pubblica fama per esempio non si credesse che i nobili poi siano esenti affatto da que’ vizi che suggeriscono i pressanti bisogni; se avessero anche dati autorizzati esempi di meno esatta giustizia; se per una certa prepotenza fossero non molto compassionevoli ai mali altrui; se il giuoco e la ghiottoneria occupassero quell’ozioso intervallo che gli divide il nascere dal morire; se molti, dico, di questi nobili si ritrovassero in una nazione, io credo che a poco a poco questa morale per una facile immitazione nell’uomo, ed autorizzata dal rispetto che s’ha per chi la professa, cadrebbe per una insensibil discesa nei domestici, poi negli artigiani, poi nella più povera plebe. Né qui vorrò io, dando troppa importanza al mio argomento, affettare orribili predizioni, né credere che veramente sia questo uno de’ maggiori mali della repubblica. Ve ne sono per avventura de’ più grandi, e di quelli che meritano più pronto riparo; ma soltanto io dico che per quanto lenti, per quanto insensibili fossero in una cotale nazione i cattivi effetti provenienti dall’ozio e da’ vizi de’ nobili, sarebbero tali che con un lungo tempo produrebbero grandissimi danni. Di che pure ce ne forniscono una non equivoca prova que’ miseri tempi in cui i nostri antenati s’erigevano in piccoli tiranni, in cui la frode, il veleno, gli stilletti, le insidie ed ogni sorta di prepotenza per fine caratterizzava la nobiltà più che la virtù, la beneficenza, i dolci costumi, l’umanità, il sapere, che pur esser non dovrebbero disgiunti da chi ha ottenuto a buona sorte una buona porzione de’ beni di quaggiù; cose tutte che la misera plebe intieramente occupata da’ bisogni fisici presenti ed instantanei non può professare; in que’ tempi, dico, s’era anche insinuata nel volgo quest’aria di tirannia, questa ferocia, sicché era data ad ogni sorta di crudeltà, di barbarie e di brutalità malgrado l’avvilimento, e la miseria in cui era sepolto.
In somma io mi ristringo a ciò che in una nazione in cui vi sia un ceto di nobili umani e saggi, in quella nazione, dico, anche la plebe a poco a poco diverrà saggia ed umana, e viceversa in una qualunque nazione in cui vi sia un ceto di nobili ozioso e che dia esempi d’ingiustizia, il popolo a poco a poco ne immiterà il cattivo costume. La qual proposizione io spero che da se stessa si dimostri.
Per la qual cosa io credo che non sia un oggetto indifferente per un saggio legislatore che buoni o no siano i costumi de’ nobili, poiché sono essi come il modello su cui vediamo che la maggior parte della nazione prende norma per i suoi. D’onde ne viene che non sarebbe conforme a questi principii che in una nazione qualunque la maggior parte de’ nobili siano oziosi, poiché come tali non sarebbero buoni cittadini.
Ma siccome che né la spada, né la toga, né qualunque altro officio civile bastano ad impiegare tutta la nobiltà, che anzi piccola è quella porzione che è impiegata e grande quella che è oziosa, da qui ne viene che bisognerebbe che il legislatore ritrovasse a questa superflua porzione un impiego utile alla patria; e questa superflua porzione io credo che in miglior modo non potrebbe occuparsi che nel commercio. Io dico questa superflua porzione, poiché credo che quelli che occupano cariche massime, se sono di quelle che esiggono molta parte del giorno e per arrivare alle quali vi fa d’uopo di lunghi studi e di un lungo tirocinio, questi tali dico non avrebbero né tempo, né voglia di darsi alla mercatura. Dal che ne siegue sempre più quanto ho già detto, cioè che è mal fondato il timore di que’ politici che temono che unendo il potere e l’autorità al commercio rovinerebbe la monarchia, mettendo nell’istesse mani l’autorità e le ricchezze, poiché appunto io credo che chi ha l’autorità in una monarchia non abbia tempo di acquistar molte ricchezze nel commercio. Per il che una legge che permetta a’ nobili la mercatura ella non farebbe altro che impiegare utilmente la più povera porzione di essa, toglierla all’inerzia ed alla indolenza per rivolgerla alla industria ed alla fatica, lasciando nel resto intatte le massime fondamentali di una monarchia, in cui i nobili non ponno esser potenti come in un governo aristocratico.
Ma dirà taluno, forse che in qualche paese la sapienza del governo non ha permesso a’ nobili la mercatura? E qual bene n’è da ciò venuto, se eglino non si risolvono ad eseguirla, se per un mal inteso decoro credono che sarebbe un macchiarsi d’infamia il divenir commerciante? Al che io rispondo che in fatto di pregiudizi e di opinioni non si mutano facilmente gli uomini; che le idee di nobiltà concepite in una data maniera per più generazioni non si mutano se non con un almeno egual tempo di contraria azione; che a creare nelle menti de’ nobili questi pregiudizi e queste opinioni ebbero la colpa que’ poco accorti legislatori che proibirono alla nobiltà di commerciare. Si ebbero per lungo tempo a vile i mercanti, le arti più utili e più necessarie furono chiamate sdegnosamente vili ed abiette, fu nominato il commercio sordido guadagno che imbrattava le mani, quelle mani che arricchiscono la patria e la fanno grande e rispettabile; furon esclusi dagli onori e da’ ceti più rispettabili i commercianti; e tutti questi falsi principii e queste fallaci idee di decoro, di purezza, di sangue furono inculcate dalle leggi, fomentate da’ costumi, ridette da uomini gravi e rispettati,
IL CAFFÈ )( Fogl. XXIV )(
e se ne sporcarono perfine i volumi, e divennero irrefragabili dottrine, ed ora ci avremo a stupire se tutto in un punto non si possono distruggere? Non è egli questo stupirsi degli effetti perché si dimenticano le cagioni? Dirò di più che bisogna accompagnare questi salutari editti con altre leggi salutari a tutto il commercio generalmente. Giacché se in qualunque paese in cui il commercio ritrovasse molt’inciampi nella legislazione si pretendesse che concedendo a’ nobili il commercio, essi dovessero attendervi seriamente, io credo che si sarebbe in un grande errore. Perché oltre a tutti que’ pregiudizi che abbiam detti, vi si opporrebbe ancora il difetto comune di legislazione. E tanto più in questa classe di legislazione, in cui non basta permettere, ed è stolta cosa il comandare che nasca commercio dove non v’è, ma bisogna adottare mezzi opportuni per ottenere tal fine. E certo lenta assai è nel nascere l’industria ne’ suoi principii, e vi bisogna di tutto il potere e la sapienza de’ sovrani per farla risorgere dove è spenta; né questa è l’opera di pochi anni. Imperocché più facile è il distruggere l’industria che il richiamarla, poiché l’uomo da sé è inerte ed ozioso se non lo stimola l’interesse, il guadagno, l’utile, la protezione per fine delle leggi e del governo; ed è di tal natura l’attività degli uomini, che vuol essere intrattenuta e lusingata, e ben custodita se ha da far lunga dimora su qualunque parte del globo. Che se per poco si cessa d’accarezzarla, dirò così, e di proteggerla, ella sen fugge, e invano ad alta voce la richiama il legislatore.
E molto più, per tutto ciò che si è detto, utile sarebbe per ogni verso che i nobili commerciassero, quanto che son essi nelle monarchie i principali possessori de’ fondi, di modo che son quasi tutti in loro mano. In una tale nazione in cui questa ipotesi s’avverasse, sarebbe, io credo, di un utile assai grande che i nobili commerciassero, qualora massimamente i generi prodotti dalle terre fossero di quelli che impiegare si possono in manifatture, come lane, lino, canape, seta, ec. Poiché se i possessori di tali fondi, anziché mandare fuori di paese o rivendere nel paese medesimo tali materie prime, le facessero lavorare essi medesimi per vendere tali manifatture o internamente o esternamente, in ogni caso utile assai ciò sarebbe alla repubblica. Poiché se vendonsi agli esteri queste materie prime, egli è certo che sarebbe meglio assai il venderle loro convertite in qualunque manifattura, poiché tirerebbesi tutto quel danaro di più che loro accrescerebbe la manifattura medesima; e se internamente le vendessero convertite in manifatture, si avrebbero esse manifatture a più buon mercato, perché le materie prime sarebbero di prima mano, laddove chi deve prendere da altri le materie prime per convertirle in manifatture deve vendere tanto più a caro prezzo esse manifatture quant’è il guadagno che ha fatto il venditore d’esse materie prime. Né alcuno mi negherà che in qualunque di queste ipotesi la nazione guadagni tanto per l’interno quanto per l’esterno commercio. Per la qual cosa mi par certo che abbiano commesso un non piccolo errore in politica que’ legislatori che proibirono di commerciare a’ possessori de’ fondi, poiché anzi questi dovrebbono più che altri essere incoraggiati alla mercatura. Avvegnacché non sarebbe egli utile che i possessori di canape, lino, seta e d’altri generi simili piuttosto che venderli li convertissero in manifatture; e molto più se tali generi si vendono a’ forestieri? E che risponderebbesi di ragionevole ad un selvaggio, che vedendo le spaziose pianure de’ campi, addimandasse di chi son esse queste squisite ricchezze che costano tanti sudori? Sarebbe egli soddisfatto dal sentirsi a dire: esse sono de’ conti e de’ marchesi? Tornerebbe forse a dirmi il selvaggio: conviene che facciano assai per la società, s’ella fa tanto per loro; al che io sarei imbarazzato a rispondere. In fatti strano assai mi pare che quel corpo di cittadini che possiede quasi tutta la superficie su cui passeggia la nazione sia quello che altro mestiere non abbia che di possederla.
Per la qual cosa io credo che dai prodotti appunto delle proprie terre dovrebbero cominciare i nobili il loro commercio, né ciò tutto ad un tratto, ma a poco a poco con una lenta esperienza, il che per certo non sembrerà difficile se non a chi trova difficile ogni cosa nuova; e questa mercatura troppo a torto si crederebbe derogare alla nobiltà del sangue, avvegnacché se si vendono i primi generi senza incorrere questa taccia, perché dirassi derogare al decoro il vendere questi primi generi convertiti in manifatture? Forse che non sono i nobili mercanti di vino, fromento, seta, lino e qualunque altro prodotto delle proprie terre, che debbano credersi macchiati da qualunque altro commercio?
Che se alcuno opponesse che qualora i possessori delle materie prime avessero essi ancora le manifatture di tali materie prime, toglierebbero la sussistenza a chi viveva su di questo secondario commercio, io rispondo: primo, che quei medesimi che inservivano a tali manifatture non si diminuirebbero punto, perché il travaglio non si avrebbe diminuito; secondo, che i compratori di tai materie quando non le potessero più avere dai possessori de’ fondi, cosa per altro non facile, comprerebbero essi medesimi fondi bastevoli per averne una sufficiente porzione, il che dividerebbe in molte mani i terreni, e per conseguenza crescerebbe l’agricoltura, che più fiorisce, più sono gli uomini che vi hanno parte e più sono i possessori de’ fondi medesimi. Poiché egli non è difficil il provare che più cerca che gli renda il suo terreno colui che ne ha poco di colui che ne ha molto; dal che ne viene che sempre è meglio che si dividano i terreni in molti possessori. Ma uopo non è forse di tanto sottilmente rispondere ad ogni ipotesi, poiché sarebbe un caso quasi impossibile quello che i possessori de’ primi generi in una qualunque nazione li convertissero essi tutti quanti in manifatture, in maniera che nulla lasciassero ad un secondario commercio di rivendita.
Perloché a me non pare impossibile cosa che comincino i nobili a darsi alla mercatura, facile assai loro essendo quanto io ho detto di sopra. E chi non ricavasse da’ suoi fondi generi convertibili in manifatture, potrebbe impiegare qualche capitale in qualche altro commercio, tirandone i frutti a proporzione, od in somma in qualunque altra delle tante maniere che vi sono di cominciare la mercatura.
Ma per ottenere il fine che i nobili commercino egli è assolutamente necessario che non siano esclusi i ricchi commercianti dai ceti rispettabili, e che non siano rigettati da que’ corpi in cui tutti s’affollano di entrare, come quegli che sono il seminario della autorità e degli onori. E perché avrassi ad avere per nobile colui i di cui antenati per tre o quattro generazioni mangiarono e bevettero il grano ed il vino delle loro terre senz’esser in nulla utili alla patria, ed avrassi da escludere da’ nobili colui che si arricchì con un grosso commercio? Quando il commercio è fatto in grande io non trovo nissuna differenza fra un possessore di terre ed un ricco mercante. Quello amministra le sue sostanze per mezzo de’ suoi agenti; questo per mezzo de’ suoi institori, in modo che altra differenza non passa dall’uno all’altro se non che il primo converta in danaro i propri prodotti delle terre una volta all’anno, laddove il secondo lo converte più volte, vale a dire che fa girare continuamente i suoi capitali, e perciò mantiene più numero di cittadini e fa più ricca la nazione, giacché tanto dipende la ricchezza dalla massa universale de’ metalli quanto dal loro moto di circolazione; per modo che in una nazione in cui la massa totale circolante sia mille e la velocità della circolazione cinquecento, ed in un’altra nazione sia seicento la massa totale ma la velocità di circolazione novecento, io dico che queste due nazioni sarebbero ricche ugualmente. Le quali idee, benché non comunemente credute, non sono perciò men vere.
Concessa adunque a’ nobili la mercatura, anzi animati ad intraprenderla, avrebbonsi a non escludere dal loro ceto i grossi mercanti. E qui fa d’uopo fare una gran distinzione fra il commercio al minuto ed il commercio all’ingrosso. Perché il secondo soltanto dovrebbe essere concesso alla nobiltà, né vi avrebbe ad essere ammesso se non se chi facesse commercio all’ingrosso; e per commercio all’ingrosso io non m’intendo tanto la grandezza de’ capitali che vi ci s’impiegano, quanto ch’egli venga fatto per via d’institori e di commessi, in guisa tale che il nobile principale non vi abbia che la superiore ispezione, né richiegga più di tempo l’attendervi che l’amministrare i terreni come oggidì. E ciò io dico non perché chiami vile, abietta e sordida ogni arte utile al pubblico, ma bensì perché i nobili in qualunque paese ove siano il seminario di cui cavinsi i cittadini inservienti alla spada, alla toga ed a qualunque officio civile, militare, politico; in tale paese, dico, conviene che la nobiltà abbia un’educazione, e che l’abbia con tutti i comodi. Per lo che s’ella al commercio di dettaglio discendesse, ed in ciò occupasse molta parte della vita, ne seguirebbe che le arti cavalleresche, gli studi ed ogni altra cosa che constituisce la educazione d’un nobile sarebbero iti; e laddove cercassi od il giurisconsulto, o ’l politico, o il militare, non vi troveresti che il piccolo mercante; ed i piccoli mercanti non ponno governare la repubblica. Ma qui molte altre cose verrebbero forse in acconcio di dire intorno alla nobiltà; in che debba ella consistere; quai privilegi debba avere; cosa debba chiamarsi nobiltà; s’ella, come è, sia necessaria in una monarchia; s’ella sia utile; se debba essere ereditaria; per qual via si dovesse divenir nobile; ed altre importanti disquisizioni che lascierò ch’altri intraprenda. Io parlo della nobiltà quale ella è a’ dì nostri, e tale quale ella è, io sono di parere, che dovrebbe commerciare.
Che se qualche nobile decaduto vi fosse, o qualche povero cadetto, egli al certo è una crudele e ridicola dottrina il pretendere che per non macchiare il suo puro sangue debba miseramente vivere nobile. A questo tale non solo il commercio all’ingrosso dovrebbe esser permesso, ma le arti ancora ed il commercio di dettaglio. Povertà e nobiltà non ponno stare assieme, vi vuole un certo censo per esser nobile. Intorno a che ritrovo assai saggio il costume d’Inghilterra, in cui i cadetti (siccome che sono assai poveri, perché tutti i stabili sono de’ primogeniti) vanno a cercare il vitto sotto i grossi commercianti. In tal guisa fra poco tempo eglino s’arricchiscono in modo che o essi medesimi o i primogeniti loro ritornano in istato di prendere il titolo di milordi, e così restituirsi alla primiera nobiltà; e questo intervallo, in cui fanno gl’institori alli grossi negozianti, le leggi suppongono che dorma la nobiltà, sicché quasi per diritto di postliminio, come dicono i giureconsulti, la nobiltà riacquistano. Questo costume pure di far dormire la nobiltà conservavasi nella Bretagna francese. Tal costume mi pare che sia ottimo per i poveri nobili, i quali nel presente sistema o devono languire nelle miserie o decadere per sempre; giacché egli convien pure che in questa continua rivoluzione delle umane vicende altri ricchissimi poveri diventino, ed altri miseri s’arricchiscano.
Laonde in quelle nazioni in cui il commercio a’ nobili è proibito, ed in cui per una inveterata opinione è cosa vile la mercatura, assai nobili vi sono, i quali benché estremamente poveri, si ridurrebbero piuttosto alla mendicità che darsi alla mercatura non già come principali, che tanto non possono, ma come inservienti ai principali. Arrossirebbero essi di esser al soldo d’un ricco commerciante di sangue non puro, si crederebbono svergognati e decaduti; per modo che crederebbono essi d’aver non solo ruinati se stessi, ma la loro famiglia spogliandola d’una prerogativa inutile, anzi gravosa. Sono, questi, veri martiri della nobiltà. Oltre a’ que’ costumi che ho sopraccennati di Bretagna e d’Inghilterra, v’ha un altro risorgimento in Francia per i nobili decaduti, e questo si è di lavorare i vetri. Quegli artigiani, che si chiamano verrotiers, devono esser nobili, onde questo è un onesto stabilimento per la nobiltà. Ivi eziandio fu per lungo tempo osservato il costume che il commercio derogasse alla nobiltà, ma con vari editti, particolarmente di Luigi XIII e Luigi XIV, è stato permesso a’ nobili la mercatura all’ingrosso. Ma non s’è ancora sradicata dalla nazione l’erronea opinione che il commercio deroghi alla nobiltà. Perché le leggi possono bensì comandare alle azioni umane, e con premi e con pene spingere o ritenere gli uomini, ma dove si tratti di opinioni fa d’uopo esempi, destrezza e tempo, e per togliere i pregiudizi bisogna che tal volta il legislatore discenda e tratti gli uomini come i fanciulli sorprendendoli, accarezzandoli, lusingandoli, finché rinonciano ai pregiudizi più coll’inganno che colla ragione. Conciossiacché amano tenacemente gli uomini le bizzarie del proprio intelletto, e resistono a chi gli urta di fronte come a tiranno, permodoché in questa guerra non si vince che fingendo di cedere, esercitando per istrade ignote al volgo la forza della legislazione.
Il che quando io considero, credo che di molto tempo vi sarà d’uopo prima che si sostituiscano idee più giuste di decoro e di nobiltà a quelle che oggidì si hanno. Questo decoro, questa purezza di sangue ha fatto in guisa che si siano creduti i nobili animali di più che uomo, e di una specie più perfetta del volgo. E questa falsa opinione ha pur prodotte per lo passato varie prepotenze ed ingiustizie, e de’ bizzari capricci; poiché è inerente alla natura umana il desiderio del dispotismo, che se lo fomenti cogli errori egli cresce da se medesimo a dismisura. Al qual male ha per buona sorte rimediato l’essere i principi cresciuti di forze. Ciò ha fatto che si raffrenò quest’intermediario dispotismo, di modo che ormai è uomo il nobile come è uomo il plebeo; né della purezza del sangue è privilegio l’impunità delle ingiurie, chiamata col curioso vocabolo di soddisfazione. L’accrescimento del potere de’ sovrani, che or fanno la felicità dell’Europa, ha assorbite e riunite in uno tutte quelle dissipate e minime forze; l’aggregato di queste anarchie ha costituito un tal potere che in faccia a lui s’è annichilata la piccola prepotenza. Onde su questo punto di vista egli è da desiderarsi da ogni buon cittadino che sempre più s’accresca il potere de’ sovrani, poiché crescerà con lui la pubblica tranquillità.
Questa falsa opinione, che la mercatura deroghi alla nobiltà, avendo ridotti i nobili ad esser poco più che oziosi smaltitori di pingui entrate, ha spenta in loro ogni pazienza di fatica ed ogni industria. Il qual amore all’ozio ed alla indolenza non ha recato piccolo danno all’agricoltura, che pur è il massimo fonte delle stabili ricchezze di una nazione. Poiché quando i possessori de’ fondi d’altro non sono occupati che de’ piaceri e del dissipamento, egli è forza che nulla pure si curino del come sieno i loro terreni coltivati. E quando i padroni non si studiano, non si industriano, non si danno daddovero a migliorare le loro terre, le cose vanno di per sé, e gli agricoltori e gli agenti ed i fittabili si contentano che sieno coltivati i campi come lo sono stati sin d’ora. Che se lo spirito d’industria animasse i padroni, cercherebbonsi i mezzi di migliorarla, laddove altro per lo più non cercasi se non se che l’entrata d’un anno sia come quella di un altro, se pur anche non la si lascia andare com’ella vuole indolentemente. E a dir vero date ad un industrioso mercante un fondo, datene un altro ad un nobile ozioso, ch’io dico che più sarà ben coltivato quello che questo. E molti di tai mali nascono in gran parte da quella idea bizzarra di decoro prodotta dall’ozio, per la quale idea molta parte della vita impiegasi in rispettate bagatelle, in offici, in correre qua e là senza disegno e senza fine. Da questa falsa idea di decoro n’è venuto che non s’ha il coraggio di decadere anche quando dovrebbesi pur decadere per necessità. Quindi ne viene che si rinuncia il più tardi che si può ad un fasto che eccede le forze della famiglia, sinché un fallimento vergognoso ed impunito non la rovini. I quai mali non sarebbero sì frequenti se vi fosse il mezzo del commercio, e se non si avesse a vile il fare il mercante, o qualunque altro onorato mestiere, quando non si può esser più onoratamente ozioso.
E tutti questi mali hanno la principale loro sorgente in questa idea, che il commercio deroghi alla nobiltà; e questa idea l’hanno creata nelle menti de’ nobili quelle leggi che proibirono il commercio e che cosa vile ed abbietta la nominarono. Le quali cose tutte io considerando, credo che grand’utile ne verrebbe ed a’ nobili medesimi ed al pubblico se essi ancora non isdegnassero di commerciare, comecché non manchi chi crederebbe che né l’una né l’altra di queste cose siano vere. Io sarò abbastanza contento d’avere esposte il più brevemente che ho saputo queste mie riflessioni, s’esse non già m’acquisteranno gli elogi, che forse non meritano, ma almeno la discrezione de’ disapprovatori. Poiché per quanto una verità sia ella utile a chi la si propone, s’ella urta certi pregiudizi, non la proponi senza taccia di novatore. Possano i miei scritti convincere qualche uomo ragionevole, e meritarmi questo nome.
A. [Alessandro Verri]
Storia naturale del caccao
Ogni ragionevole lettore al solo titolo di Storia naturale del caccao sarà persuaso che quanto sono per dire su questo argomento non è né può essere una invenzione della mia mente, ma deve per necessità essere una raccolta di notizie spettanti a questa droga, di cui altri prima di me ha scritto. Chiunque voglia dire che è tradotta, ricopiata o altro, come s’è detto della Storia del caffè, è padrone; gli scritti stampati sono come le facciate delle case, sulle quali chiunque passa per la strada è libero a dire il parer suo, e chiunque si determina a stampare le cose sue deve sottoscriversi a questo contratto. Credo che a buona parte de’ discreti nostri lettori non sarà discaro d’avere in questo foglio una idea d’una droga tanto familiare fra di noi, poiché gli autori che ne trattano non sono tanto comodi ad aversi quanto il nostro foglio.
V’è un errore volgare sulla indole del caffè, di che abbiamo parlato nel primo foglio, ed è di crederlo un legume. V’è un errore volgare sull’indole del caccao, ed è di crederlo una ghianda. I grani di caccao che veggiamo in Europa, de’ quali ci serviamo per formare il cioccolate, trovansi non già uno ad uno separatamente pendenti dai rami dell’albero, ma bensì ragruppati a guisa d’un grappolo, il quale sta involto in un bacello, ossia guscio, della figura presso poco d’un citriolo. Cotesti citrioli contengono per lo più venti, venticinque, trenta e persino trentacinque grani di caccao, tutti per entro disposti con maravigliosa simetria, come presso poco lo sono que’ del granato. Né que’ citrioli restano già appesi ai rami secondari dell’albero, come lo sono i frutti di Europa, ma bensì sono inerenti al gran tronco o ai rami primitivi, cosa la quale non è sì rara nelle piante d’America.
Quattro mesi a un di presso vi vogliono perché il frutto del caccao giunga alla maturezza, e se un guscio non per anco maturo venga spaccato, vi ritrovi fralle cellette, ove doveano esservi i grani, una materia bianchiccia e consistente, la quale trasmutasi poi in una mucillagine d’un acidetto soavissimo al palato, che fra gli ardori della state serve deliziosamente ad estinguer la sete.
Il cacaotiere, ossia l’albero del cacao, è una pianta di mediocre grandezza, le di cui foglie cadono a vicenda e si riproducono per modo ch’egli è sempre coperto di foglie, e sempre schiude, produce e matura il suo frutto. Con tutto ciò, la principale raccolta fassi due volte l’anno, cioè verso la fine di dicembre e circa la fine di giugno, e la prima è sempre più abbondante. Il prodotto che deriva dalla coltivazione di quest’albero altronde dilicatissimo è molto ragguardevole, poiché la fatica di venti soli schiavi mori può rendere cento mila libbre di caccao all’anno, le quali valutandole al prezzo che colà corre a circa dieci soldi milanesi la libbra, danno il prodotto di circa cinquanta mila annue lire milanesi, ossia tre mila trecento trentatré gigliati all’anno. Il cacaotiere si riproduce con que’ medesimi grani che ne vengono a noi, se non che appena distaccati dall’albero e rotto il bacello, si piantano, poiché altrimenti diseccandosi perdono ogni disposizione a vegetare. Il terreno poi in cui meglio riesce questa piantagione si è laddove la terra sia vergine, ossia laddove la terra da lungo tempo non sia stata coltivata ed abbia profondità molta, onde possano allungarsi liberamente le radici della pianta.
La parte interna de’ grani del caccao è bianchiccia allorché si colgono, ma con cinque o sei giorni di fermentazione che essi fanno radunati in mucchio perdono quell’umido sovverchio che li farebbe infracidire e prendono quel color bruno che conservano dappoi. I grani del caccao sono il frutto più oleoso che sinora siasi trovato al mondo, ed hanno ciò di proprio, che laddove tutt’i frutti contenenti particelle oleose, quali la noce, la mandorla, i pignocchi, le ulive, invecchiandosi rancidiscono, i grani del caccao maravigliosamente si conservano illesi da ogni corruzione.
La patria naturale del caccao sono le contrade d’America riposte fra i due tropici, e singolarmente il Messico, le provincie di Guatimala e di Nicaragua, lungo le sponde del Rio delle Amazoni sulla spiaggia di Caraca, cioè da Comana o Cordova persino a Cartagena o all’Isola d’Oro. Le piantagioni che altre volte v’erano di cacaotieri nella Martinica sono state quasi interamente distrutte, parte schiantate da’ furiosi venti e parte perché ivi vi si è trovato più conto a promovere le coltivazioni dello zucchero e del caffè. Dal Maragnan molto caccao viene ogni anno a Lisbona, ma di qualità assai inferiore a quello che si coltiva dalle colonie spagnuole.
Nell’anno 1520 hanno cominciato gli Spagnuoli a far uso del cioccolate, che era la bevanda quasi comune degl’infelici Messicani. L’olio, ossia butiro, del caccao è sanissimo ad usarsi, anzi è un rimedio, e se l’usanza delle antiche unzioni (molto salubri a preservare dai malori che ci cagionano le violenti mutazioni dell’atmosfera, ed a conservare la pieghevolezza e la forza ai muscoli) ritornasse, il butiro del caccao sarebbe certamente da preferirsi ad ogni altra pomata, poich’egli non lascia alla pelle né sudiciume né verun cattivo odore, il che non accade dell’altre pomate; e ben lo sanno molte dilicate donne, le quali per preservare la pelle del volto da quella secchezza da cui poi nasce l’increspamento, ne fanno uso con profitto.
Quest’è appunto quello ch’io credo sarà letto senza noia da quei ragionevoli e cortesi lettori del nostro foglio, i quali sanno che le descrizioni delle piante d’America non possono farsi in Milano senza prevalersi d’altre descrizioni, le quali si trovano sugli autori.
P. [Pietro Verri]
[Punti di vista]
Nella nostra gioventù vediamo gli uomini in carica molto da noi distanti; giunti che siamo alla maturità vediamo in carica coloro che, per esser nostri coetanei, abbiam conosciuti più da vicino. Con questo principio cred’io che possa spiegarsi d’onde venga l’errore comune di credere che: declina il mondo, e peggiorando invecchia.
IL CAFFÈ )( Fogl. XXV )(
Frammento sullo stile
Ecco alcune riflessioni, che credo interessanti e in parte nuove, su lo stile. Esse son fatte per quelle persone che amano le ricerche e che non rifiutano con disprezzo i tentativi. Forse un giorno faranno parte d’un’opera compiuta sulla natura dello stile e delle lingue, ove tutte le riflessioni sarebbero a suo luogo e giustificate con gli esempi. Chi le leggerà con genio di critica le getterà al fuoco; chi le leggerà per l’amor della cosa stessa non disprezzerà del tutto poche pagine di stampa, che lasciano ad ognuno il suo rango e le sue pretensioni.
Ogni discorso è una serie di parole, che corrisponde ad una serie d’idee; ogni discorso è una serie di suoni articolati. Dunque ogni differenza di stile consiste o nella diversità delle idee, o nella diversa e mecanica successione de’ suoni rappresentatori. La diversità delle idee consiste o nelle idee medesime, o nell’ordine con cui esse sono disposte, o nell’uno e nell’altro insieme. La diversità dell’ordine de’ suoni può essere relativa alle idee medesime per quella secreta analogia che passa fra le idee dipendenti dall’udito e quelle dipendenti dagli altri sensi, come la velocità, la lentezza, l’aspro, il dolce e simili circostanze comuni a molti sensi; la diversità de’ suoni può essere relativa alla disposizione ricevuta dall’uso comune, che chiamasi grammatica; può essere relativa alla maggiore o minore armonia con cui le parole si succedono scambievolmente.
Ogni discorso è composto d’idee principali e d’idee accessorie; chiamo idee principali quelle che sono solamente necessarie, acciocché dal loro paragone risultar possa la loro identità o diversità, cioè o la verità o la falsità. Una dimostrazione di geometria è tutta composta d’idee principali; chiamo idee accessorie quelle che ne aumentano la forza ed accrescono l’impressione di chi legge. Ogni discorso non semplicemente scientifico contiene più o meno di queste idee accessorie. La diversità dello stile non può consistere nella diversità delle idee principali, ma delle accessorie, se per diversità di stile intendasi l’arte di esprimere in diversa maniera la stessa cosa, cioè, per parlar con maggior precisione, l’arte di aggiungere diverse idee alle idee principali: lo stile di Archimede in questo senso non può essere diverso da quello di Newton.
Riflettasi che una serie complicata d’idee può sottodividersi in molte serie parziali, ciascheduna delle quali contenga delle idee principali rispetto a se medesima. Vi possono dunque essere differenti stili rinchiusi per così dire l’un dentro l’altro. In generale ogni semplice affermazione o negazione presa da sé non è stile, ma una serie di affermazioni o negazioni, tutte subordinate ad una principale affermazione o negazione, potendo essere diverse e diversamente disposte, possono formare lo stile.
Qualche volta l’idea principale non è espressa nel discorso, ma le idee accessorie la esprimono sufficientemente; qualche volta l’idea principale essendo complicata, e nel discorso espressa con tutte o parte delle sue componenti, potendovi essere scelta in queste circostanze, può esservi diversità di stile. Un’idea principale composta enunciata colla sua parola corrispondente non forma stile; enunciata per mezzo delle sue parti può ammettere stile, quando il raziocinio permetta la scelta indifferentemente di queste parti.
La poesia si esercita più a comporre che a disciogliere, versa più intorno alle somiglianze che alle differenze degli oggetti, e principalmente si occupa intorno alle impressioni forti sull’anima; ella scuote più che non rischiara, ufficio solo del lento ma sicuro esatto raziocinio. Ella non istanca giammai un solo senso con noiose uniformità, ma molti ne percuote, e più insieme. Ella risveglia più sensazioni insieme, per dir così in miniatura, mentre la presenza degli oggetti attuali le eccita in grande, e qualche volta con minor effetto, perché quantunque ciascuna delle sensazioni eccitate dalla poesia sia più piccola e più debole della sensazione grande, di cui ne è per dir così la miniatura, pure il prodotto di tutte insieme essendo proporzionale alla limitata facoltà di sentire dell’animo, supera l’effetto delle sensazioni grandi, che non possono tutte simultaneamente dall’attenzione abbracciarsi; anzi queste escludono per la vivacità loro quelle idee accessorie, che aumentano l’impressione di quelle. Questa è la ragione per cui le descrizioni poetiche danno qualche volta un piacere che, unito con quello di una felice imitazione, supera l’impressione dell’originale medesimo.
Da ciò si comprenderà facilmente un apparente paradosso, cioè che i teoremi più grandi, più generali e più fecondi, quantunque astratti, hanno un non so che di poetico più di quello che molti s’imaginino, e cagionano una certa patetica contentezza ed un fremito interno non molto dissimile dall’entusiasmo della poesia. Una folla d’idee accessorie si presenta sempre all’animo quando è occupato da grandi verità di qualunque genere esse si siano.
È meno la moltitudine che la scelta delle idee accessorie, che forma la bellezza dello stile. Gli uomini si rassomigliano tra di loro per la costanza delle passioni, e sono differenti assaissimo per la moltitudine degli usi e delle opinioni; le idee accessorie che dipendono da queste sono di una bellezza passaggiera e variabile; le idee che dipendono da quelli resistono di più al tempo trasformatore. Le prime possono crescere o diminuire di pregio secondo la passione dominante della nazione in cui si scrive; le seconde possono di piacevoli diventar noiose ed importune.
Lo stile è diffuso quando sono ripetute le medesime idee accessorie, o quando ve ne siano molte che pochissimo differiscano tra di loro. Lo stile è diffuso non tanto per la moltitudine, quanto per la poca importanza delle idee accessorie relativamente al soggetto principale.
Uno stile è conciso quando le idee principali accompagnate da poche accessorie, ma importanti, si succedono rapidamente, quando si destano più idee di quello che si esprimono con parole; lo stile è conciso e chiaro quando le idee espresse destano necessariamente le taciute; è oscuro quando di più idee taciute è incerta per il lettore la scelta.
Uno dei maggiori soccorsi per lo stile è l’uso delle metafore. Gli oggetti hanno molti lati ed aspetti per cui si assomigliano. Dunque ogni espressione di un rapporto comune tra due oggetti può servire ad esprimerli ambidue, cioè possono facilmente associarsi nell’intelletto ed eccitarsi scambievolmente. La metafora sarà buona, cioè associabile, naturale, ec., quando il lato simile dell’oggetto che somministra la metafora sarà tale che superi colla sua impressione ed impedisca il destarsi dei lati per cui l’oggetto differisce dall’altro che si vuol esprimere. La metafora sarà gigantesca, strana ec. quando sia talmente debole la somiglianza, o associata cogli altri lati differenti, o questi talmente numerosi, che si destino più tosto essi nell’animo di quello che lo faccia il rapporto comune.
Quanto più una nazione è selvaggia, tanto meno vede la differenza degli oggetti, dunque quanto più una nazione sarà selvaggia, tanto più le di lei metafore saranno ardite e forti, poiché vedrà meno disomiglianze che una nazione più colta, cioè più osservatrice. Avvertasi però che questa progressione avrà un limite, poiché i primi gradi di selvaggità di una nazione sono diversi gradi di stupidità. Da ciò vedasi quanto la lingua influisca su le opinioni degli uomini, e vicendevolmente queste su quella.
Il volgo si determina per lo più a considerare le differenze degli oggetti per la differenza delle parole. I limiti delle sue osservazioni si trovano nel suo vocabolario. Simili crede le cose che hanno una stessa voce, dissimili quelle che ne hanno una diversa. Dal dizionario dunque verbale di una nazione paragonato col reale, cioè con l’enciclopedia, potrebbe vedersi in qual classe di cognizioni abbondino le espressioni graduate, conoscersi in qual classe di cognizioni sia più avanzata, e però qual sia lo spirito e il fondo di pensare universale di quella. Dunque le cognizioni non si avvanzano molto in una nazione prima che le espressioni non siano perfezionate; e il secolo dell’espressioni precede sempre al secolo delle riflessioni. Qualche eccezione non nuoce alla teoria generale.
Da ciò può vedersi quanto sia limitata la pretensione di coloro che pretendono perfezionata la propria lingua e che vogliono fissarla con testi e con dizionari classici ed autorizzati. Quali catene al libero volo di una mente ardita, quali ceppi al progresso dello stile, che non è un ornamento, ma una parte considerabile della massa d’idee d’una nazione!
Per fissare una lingua è necessario che abbia tutte le espressioni opportune per esprimere qualunque idea, e le migliori espressioni possibili; è necessario che le irregolarità e le disanalogie di una lingua sieno levate; e di quale lingua può dimostrarsi aver simili perfezioni?
L’ordinario destino delle metafore, quando divengono comuni e familiari al popolo, cioè quando la necessità, sola cagione dei progressi che fa il volgo lasciato a se stesso, lo costringe ad usare di una espressione metaforica, è di perderne la qualità di metafora e diventar propria espressione dell’oggetto che rappresenta. La cagione di questo fenomeno è l’associazione perpetua dell’espressione metaforica coll’oggetto che non è il suo proprio. Questa è la cagione per cui lo stile cangia di natura colla successione de’ tempi, perché l’impressione che fa su gli animi non è più la medesima, e ci par languido e triviale ciò che secoli fa era vivace e sublime; ciò ch’era prima il rapporto di due idee non è che il segno di una sola. Tocca al sottile grammatico, o per dir meglio al profondo filosofo, di riascendere sovente dall’espressione che sembra propria alla di lei origine metaforica. Una tal ricerca conduce molto addentro nella cognizione delle origini e dello sviluppamento delle nostre idee e dei nostri errori, scienza che è veramente base e fondamento di tutte le altre, e delle quali racchiude in sé tutti i germi primitivi.
Quando un’idea ha molta affinità, o reale o apparente, con alcune altre, accade sovente che la di lei espressione passa successivamente ad esprimerle tutte; così pneuma, spirito, significò prima vento, poi fiato, indi anima, e poi una determinata qualità dell’anima medesima ec.
Gli uomini non cangiano che in proporzione dei bisogni che hanno; dunque si serviranno di una espressione, di una idea vicina per molto tempo avanti di formarne una nuova. Gli uomini sono animali copiatori e che si scostano il meno che sia possibile dai primi modelli. Sembra che il principio della minima azione, che occupa una gran parte del fisico, abbia molta estensione anche nel morale.
Dunque quando una lingua fa veloci cambiamenti, è un indizio certo di una rivoluzione nelle idee della nazione che la parla, e dall’indole del cangiamento della lingua si potrà argomentare il cangiamento nelle idee: così le lingue si raddolciscono col dispotismo, e colla libertà e colle guerre civili ritornano vigorose ed aspre.
Dalle metafore può ancora arguirsi la passione o il carattere dominante della nazione, se non il presente, almeno ciò ch’era una volta, perché le espressioni durano molto più delle cose espresse. Egli è conforme alla natura umana che le metafore saranno tolte da quelle immagini che più interessano e che sono più familiari alla nazione, e di queste faranno un uso continuo per esprimere altri oggetti; così le metafore, secondo sono prese o dai cibi, o dalla guerra, o dall’amore, indicheranno il genio particolare di una nazione.
La differenza degli stili nasce o dalla differenza delle passioni, o dalla differente struttura delle idee d’uno scrittore.
Una passione è un’impressione forte e costante della sensibilità tutta rivolta ad un medesimo oggetto; essa modifica e trasforma dentro di sé tutte le altre passioni minori che ne accrescono la forza.
Un sentimento è una passione in piccolo, che agita la mente di uno per più breve tempo e con minor forza di quello che lo faccia la passione. I suoi effetti sono proporzionatamente gli stessi. Durante il suo regno modifica e trasforma in se stesso tutti i sentimenti minori; vi saranno dunque, come nelle idee, sentimenti principali e sentimenti accessori. Questi sono quegli che accrescono forza allo stile appassionato. Le passioni e i sentimenti, che ne sono la miniatura, sono troppo uniformi nel loro oggetto, troppo costanti ne’ loro effetti, perché da sé sola se ne potesse soffrire lungo tempo la pittura senza ripetizione e senza noia. Sono dunque le passioni e i sentimenti accessori, quelli che le variano all’infinito e le modificano in mille maniere nel mondo poetico e reale, che formano la forza dello stile in questo genere.
Quando dicesi che lo scrittore deve essere appassionato di quella passione che pretende eccitare in noi, vuolsi significare che egli deve avere il sentimento, cioè la miniatura di quella passione; e questa è forse la posizione la più avvantaggiosa per bene esprimerla. Se egli fosse veramente appassionato, sarebbe più portato a soddisfare che a dipingere la sua passione. Egli allora è posto in quella giusta distanza per cui una parte della sua sensibilità può contemplar l’altra e sceglierne i tratti maestri e principali. Se egli fosse fortemente appassionato, attribuirebbe alla passione che dipinge quelle idee accessorie ch’egli ha e non quelle che dovrebbe avere nelle supposte circostanze. Le menti pittoresche in ogni genere acquistano l’abitudine di eccitar in sé sentimenti oppostissimi a loro piacere. Le circostanze della vita forniscono i primi saggi, e la facilità degli atti a divenire di mecanici volontari, e viceversa, è proporzionata alla ripetizione degli atti medesimi. Se l’impressione è ripetuta senza interrompimento, diventa passione e s’impadronisce della sensibilità, che esclude e trasforma ogni sentimento; se le impressioni sono variate ed interrotte, le facilità di eccitarsi saranno tanto maggiori quanto più numerosi e diversi saranno i passaggi di un sentimento in un altro. …
C. [Cesare Beccaria]
[Dell’onore che ottiensi dai veri uomini di lettere]
Scrittori del Caffè.
Rispondete a questa quistione: Perché mai gli uomini di lettere erano onorati ne’ tempi addietro, e lo sono sì poco ai tempi nostri?
Chi ci fa questo quesito dev’essere sicuramente professore di sonetti e canzoni, ovvero grammatico squisito, se mai però non fosse qualche valente antiquario. Quest’è la solita cantilena che ridicono coloro i quali, senza genio, senza ingegno e senza discernimento, vorrebbero aver parte nella repubblica delle lettere. Il corpo di essa repubblica è vasto assai, né vi fa bisogno d’altro che di volerlo per esservi compreso; ma due sono le classi de’ cittadini che compongono questa società sparsa sul globo: la prima classe è quella de’ pochi, i quali dalla natura felicemente disposti e dalla educazione preparati a coltivar le cognizioni umane, tratti da una spinta interna e da un amore del vero o della gloria, coltivano il sapere e comunicano talvolta al pubblico le idee che vanno rischiarando; la seconda classe è di que’ molti, i quali o per inerzia di preferire un mestiere sedentario ad uno più faticoso, ovvero per una vana lusinga di credere importanti quelle frivole cognizioni che per una sventurata educazione hanno preferite alle altre, prendon la penna in mano e vi sporcano fogli, quinterni e risme di carta noiosissimamente. La prima classe è dei nobili letterati, quei della seconda sono i letterati plebei. Ognuno comprenderà facilmente ch’io col nome di nobile non intendo in questo sito di parlare degli antenati, il merito de’ quali val poco dovunque, ma nulla affatto nella professione delle lettere.
Nel secolo decimottavo, in cui viviamo, non hanno certamente ragione i letterati davvero di lagnarsi, né so che realmente si lagnino. Il pubblico legge assai più di quello che non si sia mai letto forse dacché s’è inventata l’arte dello scrivere. Un libro non è più riservato a quelle sole caverne dove al pallido lume d’una lampada se ne stava un irsuto sapiente ne’ secoli scorsi, come un mostro della specie umana. Un libro è un mobile che si trova nelle stanze più elegantemente adornate; un libro trovasi sulle pettiniere delle più amabili dame; un libro perfine è letto per poco che l’autore abbia avuto talento di scriverlo.
Ora sì tosto che universalmente si legge, ogni autore che sappia scrivere, cioè che scriva cose che paghino della fatica di leggere, e che le scriva con ordine, con chiarezza e con grazia, ogni autore, dico, che sappia scrivere è sicuro di ottenere tosto o tardi la stima e la considerazione del pubblico. Tutto il difficile sta al bel principio che un giovane intrapprenda la carriera; allora certamente non avendo né credito né sperienza, incontra infiniti ostacoli a scrivere ed a stampare, e più forse ha del merito e più gli ostacoli sono ostinati; allora può darsi ancora che la prima opera per mancanza d’industria rimanga nell’oscurità per qualche tempo; ma passato che s’è una volta per questo stretto disgustoso, la strada s’appiana da se medesima. Io trovo che per un uomo che abbia una felice disposizione d’ingegno non v’è strada in cui possa più nobilmente soddisfare la propria ambizione quanto quella delle lettere; per essa non vi si richiedono offici di sorte alcuna; non vi si richiedono né le noie delle anticamere de’ grandi, né si devono digerire i freddi accoglimenti de’ protettori, né si deve temere e sperare con una crudelissima alternativa; l’uomo di testa passa la sua giornata a suo talento con geniali occupazioni, indi colle produzioni sue giunge a farsi un nome e un credito più o meno grande, è vero, ma certamente sempre superiore a quello che ottengono coloro i quali possono carpire le cariche col solo merito degli offici o della dissimulazione. Un marchese Scipione Maffei, un Lodovico Antonio Muratori, un conte Francesco Algarotti nella nostra Italia hanno a’ dì nostri goduto di tutta quella considerazione e di tutti que’ riguardi che possono solleticare di più l’amor proprio d’ogni uomo. Essi furono onorati da più d’un sovrano, ogni forestiero di qualche distinzione che passasse nelle città ove dimoravano si faceva una particolare cura di visitare e conoscere quegl’illustri scrittori, e certamente in paragone d’uno di essi nessun magistrato o giudice d’Italia pretenderà di occupare un posto luminoso nell’universo.
Celebre è il fatto di quel viaggiatore, che giunto alle barriere di Parigi, chiese ai gabellieri contezza dell’alloggio del signore di Fontenelle, e che non sapeva persuadersi come perfino i gabellieri non sapessero indicargli la casa d’un loro cittadino che faceva tanto onore alla sua patria. Chiunque sia un po’ instrutto delle novelle letterarie di Europa saprà quali testimonianze di stima e d’amicizia abbia ricevute il signor di Voltaire da due sovrani letterati e illustri protettori di chi coltiva le lettere. È noto a tutti il glorioso invito che una delle più grandi principesse ha fatto al signore D’Alembert. Il miglior poeta drammatico che abbia prodotto l’Italia già da molt’anni gode del più onorato e dolce destino alla corte imperiale. In somma ognuno che per poco sia iniziato nelle cose che risguardano l’attuale stato delle lettere d’Europa deve conoscere che non mai forse furono sì onorati gli uomini che hanno contribuito a rischiarare il pubblico ed a diffondere le utili verità quanto lo sono in questi tempi. Quasi tutti i sovrani che attualmente regnano in Europa accordano favori alle lettere.
Ma la plebe letteraria grida e smania e declama contro l’ingiustizia del secolo, contro il decadimento delle lettere, e perché i nostri proavi, appena usciti dalla barbarie, facevano gran conto de’ grammatici e de’ poeti e de’ lapidari, vorrebbero che anche nella piena luce di questo secolo accadesse altrettanto. Certamente che i Marsili Figini, i Pico della Mirandola e sì fatti astrologi e cabalisti aristotelici, se ai giorni nostri comparissero col puerile corredo di quella lingua che allora chiamavasi scienza, sarebbero poco onorati, e chi ad essi somiglia è nato troppo tardi per ricever corona. È comparso anni sono un libro in Italia, che è uno de’ più benemeriti libri che da molto tempo siansi fatti e sono alcune lettere di Virgilio all’Arcadia di Roma. Sin dal tempo del valoroso Tassoni qualche cosa s’era osato dire in Italia sulla poesia petrarchesca; ma alcune verità erano come bestemmie nella preoccupata mente de’ letterati d’Italia. L’autore delle Lettere di Virgilio dà un giusto valore alle cose ed agli originali, che ci eravamo proposti d’imitare eternamente sotto pena di risguardare come reo di lesa pedanteria chiunque osasse uscire dallo strettissimo giro stabilito. La maggior parte de’ lettori si sono scatenati contro la verità che veniva in quelle lettere annunziata e direi quasi dimostrata: pure delle ristampe di quel bel libro se ne sono fatte, e mi vado lusingando che sparsi qua e là ve ne siano molti di sediziosi, e che il regno de’ pedanti sia per durare più poco.
Sorge una disputa fra due o più oscuri scrittori per sapere qual fosse la patria d’Omero, di Plinio, del Tasso o che so io; ciascuno vi suda degli anni e partorisce un grosso tomo e lo fa stampare, e poi si lagna perché nessuno lo legga. Ma che vuol egli, che gli uomini s’annoino a leggere un ammasso disordinato di rottami d’erudizione, per cavarne poi una notizia la quale non contribuisce in nulla al bene di alcuno? Viene un altro, e vi scarabocchia egloghe, sonetti, eterne inezie in rima, le quali partono da un animo vuoto d’idee e non lasciano al lettore che il rimorso d’avere malamente speso il suo tempo; con qual titolo pretende egli alla stima de’ suoi contemporanei?
Scrivete, o giovani di talento, giovani animati da un sincero amore del vero e del bello, scrivete; scrivete cose che riscuotano dal letargo i vostri cittadini e gli spingano a leggere e a rendersi più colti; sferzate i ridicoli pregiudizi che incatenano gli uomini e gli allontanano dal ben fare; comunicate agli uomini le idee chiare, utili e ben disposte; cercate in somma di rendere migliori e nel cuore e nello spirito i vostri contemporanei, come fate sopra di voi medesimi, e allora siate sicuri che non vi mancheranno, coll’avvanzarvi nella carriera delle lettere, tutti i piaceri che s’ottengono colla distinzione e colla stima universale. Vi saranno sempre, è vero, in qualche angolo oscuro de’ pedanti che mal soffriranno di vedervi su questa strada, ma questi, a misura che farete progressi, anderanno sempre più occultandosi, sin tanto che resti ad essi tutta l’amarezza di dir male, ed a voi non giunga neppure il suono della loro voce. Più voi sarete colti e amabili ne’ vostri scritti, e più coloro spargeranno che mancate di profondare le vostre idee. L’interesse di chi non sa scriver bene è di sostenere che gli autori che più universalmente piacciono non sanno scriver bene.
Noi co’ nostri fogli ci siamo particolarmente proposti di combattere molte di quelle chimere che più s’oppongono ai progressi degl’ingegni italiani. La natura ha fatto di tutto perché noi fossimo distinti fralle più colte nazioni del mondo; ma forse la troppa dolcezza del carattere di noi Italiani ci ha fatti con somma facilità piegare l’un dopo l’altro al giudizio di alcuni pochi, i quali ci hanno voluto porre in ceppi, dirò così, l’anima, e ce ne hanno pedanteggiate le facoltà. Tempo è ormai che in una materia libera, qual è quella delle lettere, sia dato ad ognuno il sentire con proprio sentimento e il rendere le proprie idee quali si ricevono da’ sensi; et aperto vivere voto.
P. [Pietro Verri]
IL CAFFÈ )( Fogl. XXVI )(
Dell’ozio
Il giuoco, la maldicenza, la sfrenatezza de’ costumi sono conseguenze funeste dell’ozio. Il cuore umano ha un vero bisogno d’essere occupato in qualche oggetto che lo tolga dalla noia inseparabile compagna della indolenza. Quando manchiamo di un certo moto, che agiti l’animo e lo tolga da un letargo a lui naturale se è di nulla occupato, siamo in una incomoda situazione, che non ardirei chiamare propriamente vita, ma quasi vegetazione. L’esperienza ogni giorno più ci convince di questa verità, giacché vediamo che né l’abitare un superbo palazzo, né il possedere grandi ricchezze, né l’avere onori e dignità fa l’uomo felice, ma bensì l’avere nella maggior parte del tempo l’animo di vari e sempre piacevoli oggetti occupato. La mancanza di moto fa l’acque stagnanti e lorde e putride; così l’inerzia instupidisce ed infetta lo spirito. Quegli che hanno la mala ventura di far poco uso della facoltà di operare col corpo e collo spirito sono miserabili sfaccendati, che cercando in ogni parte qualche oggetto onde riempiere quel vuoto che hanno nella mente e nel cuore, sono molesti e molte volte infesti alla società, e sono a se stessi pena della loro infingardia. L’uomo ragionevole, dando alla religione, alla famiglia, a’ suoi impieghi, alla cultura del suo spirito tutta la giornata, passa assai più felicemente il suo tempo di colui che fra gli agi e le ricchezze non sa fare un’ora di parentesi alla noia che lo accompagna al sepolcro. La vita di costoro è un continuo sonno, e la vita degli operosi è una serie di buone azioni e di piaceri. Così il magistrato, il letterato, il mercante, l’artigiano trovano nelle loro fatiche i giorni brevi, intantoché un ricchissimo sfaccendato cava ad ogni momento l’oriuolo dalla sua tasca stupendosi della lunghezza del tempo e rimettendo sempre all’ora che vien dopo la briga della sua felicità.
L’industria ed il travaglio furono sempre i fondamenti della forza delle nazioni; e sono destinate alla schiavitù le infingarde ed oziose. Il dispotismo, già da tanto tempo in Asia stabilito, ha forse per cagione l’inerzia e l’aborrimento della fatica che il clima inspira a que’ popoli, ed anche discendendo al particolare servono i pigri agli operosi; poiché o ricchi o poveri ch’essi sieno, sono nell’altrui dipendenza; se ricchi per esser tolti dalla noia, se poveri perché non si alzeranno mai dalla loro miseria. Ma per lo più l’ozio è una conseguenza delle ricchezze, perché la povertà cogli incomodi che l’accompagnano troppo ci ferisce da vicino per poterla indolentemente sopportare. E se vediamo oziosi i mendici, lo sono o per esser fisicamente impotenti a sollevarsi dalla depressione, o perché ovunque si volgano vedono spenta ogni speranza di risorgimento; e questo è bene spesso difetto di legislazione, anziché difetto degli uomini; il che considerando dovrebbesi essere più umani con quella sì grande, sì disprezzata e sì infelice parte degli uomini chiamata volgo. I ricchi non sono né in l’uno, né in l’altro caso; onde più facile è loro l’esser oziosi; ma non meno infauste loro sono le conseguenze. Il giuoco occupa in taluno d’essi la maggior parte de’ loro ozi, e se per un momento vorranno meco riflettere sopra se medesimi, dovranno confessare che passano le notti e i giorni fra una speranza inquieta ed un mordace timore. Pochi fanno molte ricchezze col giuoco, e que’ pochi sono ricchi a spese di molti infelici, onde non v’è proporzione tra i contenti ed i mal contenti che fa il giuoco. È più probabile adunque d’esser nel numero de’ secondi; e se quegli ancora che hanno le loro fortune stabilite sul giuoco diranno il vero, dovranno confessare che il guadagno non gli ha ricompensati de’ loro timori e del tumulto interiore che prova chi espone gran parte, ed alcuna volta tutte le sue fortune, all’azardo. Puossi in oltre cambiare il danaro che al giuoco s’espone in mille onesti piaceri, oppure in una onorata ed utile industria; può un onest’uomo sollevare gli amici, i poveri, incoraggiare le arti e i cittadini meritevoli con quel danaro che consegna alla sorte: e questi sono piaceri per i cuori sensibili alla virtù; può coll’industria migliorare la sorte della famiglia e di se stesso, in vece di avere un giorno l’insuperabile rimorso di veder languire nella miseria gl’innocenti figli, vittime di una stolta passione, e di dovere arrossire in faccia ad una turba di queruli creditori.
Altri si tolgono dalla indolenza colla intemperanza, come unico oggetto a cui attaccarsi nella penuria di pensieri in cui sono, ed in fatti è ben naturale che chi ha le facoltà dell’anima torpide ed oziose debba adoperare quelle de’ sensi: ma grandissimi sono gl’inconvenienti della ghiottoneria. L’incomodo di una difficile digestione, mille mali che sopraggiungono fanno cadere la bilancia dalla parte del male, e puossi conchiudere e come medico e come uomo ragionevole che l’intemperanza è da fuggirsi.
Conchiudiamo dunque che siccome al corpo è utile un moderato moto, così una moderata attività è utile, anzi necessaria all’anima, e la tiene in una continua forza ed energia che la fa accorgere d’esistere piacevolmente; dico moderata, perché l’agitazione ed il tumulto dello spirito non si ponno chiamare stati di felicità: onde la vera contentezza del cuore sta fra i due estremi della inerzia e della troppa violenza del moto.
A. [Alessandro Verri]
Degl’influssi lunari
Vitruvio, lib. 2, ragionando della stagione opportuna al taglio degli alberi, determina quella in cui sono eglino aridi e secchi, o almeno presso che sceveri d’ogni umore; e perché dal fine dell’autunno sino alla primavera sono eglino tali, perciò prescrive il taglio in que’ mesi. Nella primavera la pianta s’impregna di nuovo umore, senza cui non potrebbe esser feconda: e questo sugo, sì giovevole al crescere della pianta, addiviene a lei fatale se si recida. Poiché essendo rinchiuso nel seno di lei, e privo di circolazione e di moto, ristagna e si volge in principio di corruzione. Quindi bisogna tagliar le piante nell’inverno. Potrà ciò farsi ancora nel fine dell’estate. Ma sempre il legno reciso nel verno sarà più solido, più denso e grave che nella state, e ciò per la natura del freddo e caldo, de’ quali uno costipa e rinserra i pori, l’altro gli rarefà e dilata. Vitruvio non fa menzione della Luna; osservò bensì, nel cap. 10 del lib. 1, che le piante dominate dal Sole rendono legni più sodi e pesanti che le altre. La stessa cosa s’è più volte osservata in Toscana nella stessa pianta, da cui in quella parte ch’è esposta al Sole si cavano tavole più solide che dall’altra. La ragione è perché colla forza del Sole svaporando la parte più volatile, sottile e acquosa della pianta, il rimanente del sugo nutrizio resta più denso. Questa ragione è quella per cui Montesquieu volle che ne’ paesi caldi si dovesse proibire il vino e ne’ freddi l’ubriachezza non fosse un vizio del clima. Anzi è quella per cui generalmente i legni de’ paesi caldi sono più duri e consistenti, come il legno santo, l’ebano e quegli altri legni de’ quali formavano le loro armi gli Americani.
Columella vuole che si recidano le piante negli ultimi dieci giorni della Luna. Vegezio dal 15° al 23° giorno della Luna tra il solstizio di estate e le calende di gennaio. Catone vuole che le piante fruttifere si taglino quando sono maturi i frutti, e le altre in ogni stagione. Teofrasto propone la notte avanti la nuova Luna di gennaio. Palladio, lib. XXXII, e Plinio, lib. XVIII, vogliono che si faccia il taglio quando la Luna incomincia a decrescere. Plinio, lib. XXI, prescrive il tempo dalla ventesima Luna all’ultima. Carlo Stefani, autore d’agricoltura assai lodato dal Montanari, al cap. 9 del lib. 5 si ride di tutte le osservazioni lunari nel piantare e nel tagliare: sebbene il Montanari, Astronomia convinta di falso, pag. 9, vi abbia dato qualche fede. Giorgio della Torre, De hist. plant., sostenne che nel Sole eravi la ragione sufficiente di tutti quanti i fenomeni della vegetazione. Dello stesso sentimento era De la Quintinie, che per molti anni ebbe cura de’ giardini reali. Vedi Chomel, Diction. oeconom. Pensava istessamente il Normand, che nello stesso impiego è succeduto al Quintinie, come pare da una sua lettera inserita al tomo I dello Spettacolo della natura. Reaumur in una dissertazione inserita agli Atti del 1722, e Buffon in molte altre inserite a quegli degli anni 39, 40, 41, 42, parlando dell’arte di dare solidità, durevolezza e peso al legno per servirsene negli edifizi e nelle navi, non parlano di Luna scema o crescente. L’autore de La theorie et pratique du jardinage prescrive che per seminare si scelga un tempo dolce, e che prometta tra poco la pioggia, senza badare a’ noviluni o pleniluni. Varrone nel cap. 37 accenna i punti lunari, ma parla più da copista che da osservatore, citando or Tremellio, or Teofrasto, ora altri. Teofrasto seguì Aristotile, Columella copiò da’ Cartaginesi, Greci e Latini. Palladio scrive solo da compilatore. Plinio, che stese la facoltà della Luna sopra le ostriche e le conchiglie, dice: ex lectione duum millium circiter voluminum ex exquisitis authoribus centum inclusimus 36 voluminibus. Paracelso ed Elmonzio credettero che la luce della Luna, condensata e raccolta, agisse sopra di noi. Montanari, in un libro che fu dei primi e principali che concorsero a liberarci da molti pregiudizi popolari, nel principio diede troppa fede a quel detto di Aristotile, lib. 4, cap. 5, De partibus animalium et eorum causis: Quod noctes in plenilunio sunt trepidiores propter lucem pleniorem. Volle comprovare con uno sperimento quel detto, asserendo che i raggi lunari raccolti con un gran specchio ustorio e fatti ferire in un termometro assai delicato di moto, si vide mostrar più gradi di calore, sebbene ne’ termometri d’aria non se ne veda alcun effetto sensibile. Il signor Giuseppe Averani e il Taglini aveano fatto l’esperienza a Firenze col grande specchio di Galleria e con un termometro d’aria. Hooke, de la Hire, Vilette, Tschirnaus ed altri, come attesta Musschenbroek, con specchi più grandi di quelli che mai poteva aver Montanari e con un termometro delicatissimo di Amontons e Farenheit, fecero l’esperienza senza trovare alcun effetto sensibile. Il più grande specchio di cui s’è servito de La Hire accrebbe 306 volte la densità al lume lunare. Per le esperienze di Bouguer, Essai d’optique sur la gradation de la lumiere, la densità del lume della Luna piena sul nostro globo è alla densità del lume solare come 1: 300000 in circa. È falso ancora quanto da quel principio ricavò Aristotile, e credettero poi ancor Plinio, Cicerone e molti altri, che i ricci, le ostriche e le conchiglie siano nel plenilunio polpute e grasse, e manchino col mancar della Luna. Molti che con lunga fatica si sono adoperati, nella serie di venti e trent’anni, in esaminare le midolle degli animali, hanno osservato che in qualunque giorno e stato della Luna si trovavan delle ossa piene di midollo e delle altre quasi vuote; e si scorgevan de’ testacci e delle ostriche altre morbide e pingui, altre scarne e magre, indifferentemente in ogni giorno della Luna. Vedasi Belgrado nella dissertazione Dell’influsso degli astri ne’ corpi terrestri, par. I, VI.
La lente della Galleria, che è dello Tschirnaus, è minore di quella di Parigi, essendo di circa un braccio di diametro, quando la parigina arriva circa a tre piedi. Il marchese Ginori, avendo fatto travagliare da’ suoi contadini una lente di vetro d’Inghilterra maggiore di quella di Galleria, osservò più volte che mai non si era potuto produrre alcun effetto nel termometro. Il Montanari, in un tempo in cui il gusto delle sperienze non era tanto raffinato, poteva essersi facilmente ingannato, perché qualunque piccol alito nell’avvicinarsi al termometro può fare qualche variazione, bisognando aver la cautela di avvicinarsi con un cartone di riparo.
Una difficoltà si potrebbe cavare da’ fisici e buoni principii esposti dal Mead in un libro intitolato De imperio Solis et Lunae in corpora humana, in cui sono raccolte le più strane cose dette da’ medici, e sino l’esempio di quella donna, che essendo rotonda e ben formata di viso ne’ pleniluni, avea la disgrazia che incominciando a scemar la Luna, il naso, gli occhi e la bocca le andavano da una parte. Osservò egli nella prima parte che gli animali avendo bisogno per respirare di un’aria determinatamente densa e pesante, e ne’ pleniluni essendo minore la gravità dell’aria, una minore di lei quantità col proprio peso scenderà ne’ polmoni, e sarà minore la respirazione e gli effetti che ne dipendono. Quanto alle conseguenze che da questi principii ricava l’autore, vedasi lo stesso Belgrado, § VII della stessa dissertazione, dove raccolte le osservazioni de’ medici, fece vedere che molti essendo i mali che hanno de’ periodi certi e determinati, tutti i periodi si devono riportare al principio de’ mali medesimi, non ad alcuna fase della Luna. Quanto alla ragion fisica, certamente se la diversa azione della Luna nelle diverse fasi, e la gravità dell’aria o cresciuta o diminuita influisce negli animali, influirebbe ancora ne’ vegetabili, che secondo le osservazioni di Hales respirano una non piccola quantità d’aria. Ma il fatto sta che come il termometro, così il barometro non dà alcuna variazione ancor minima, come prima d’ogn’altro avvertì il Ramazzini, Ephem. barom. Mutin., an.1699, pag. 19. Mead pensò di combinare l’azione sensibile della Luna sull’atmosfera coll’invariabilità de’ barometri, dicendo che alzandosi l’aria in un luogo ed abbassandosi in un altro, l’altezza del mercurio ancora ora dovea crescere, ora scemare; né vi può essere alcuna osservazione certa. Daniele Bernoulli, Traité sur le flux et reflux de la mer, chap. IV, num. XIV, avendo trovato co’ propri calcoli che la variazione ne’ barometri poteva essere di venti linee in circa, per conciliare i fenomeni colla teoria pensò che l’aria per ragione della sua elasticità dovesse talmente distribuire le proprie forze, che prescindendo dalle improvvise alterazioni nate da’ venti, dal calore e da altre cagioni istantanee, dovesse premere ugualmente qualunque punto della superficie terrestre, cioè che l’altezza del mercurio dovesse essere la stessa dappertutto. Alembert, Dissert. sur la cause generale des vents, num. 36, avendo fatte varie riflessioni in questa teoria di Bernoulli, scoprì ancora benissimo l’errore di calcolo che lo condusse a quel risultato, che è di aver supposte tra loro equilibrate non solo le colonne dell’aria e dell’acqua, ma ancora le solide della terra, che non possono ubbidire alle forze lunari. Egli poi nel numero antecedente calcolò la totale variazione che nel barometro può nascere dalle forze del Sole supposto immobile, e la trovò di 709039404/6878200.129985 parti d’un pollice di mercurio, e però, congiungendovi ancora la forza della Luna, non può mai essere sensibile.
Resta a vedersi se i venti cagionati dalla Luna potessero in qualche modo influire nella vegetazione delle piante. Non v’è dubbio che nell’aria deve eccitarsi un flusso e riflusso simile a quello del mare. Ma il flusso dell’aria è poco sensibile. Noi non conosciamo alcun vento che corrisponda alle fasi della Luna. Il vento orientale generale, che soffia sotto la zona torrida sino a 30° o 32° di latitudine, provenendo dalla sola dilatazione fatta nell’aria dal Sole in que’ luoghi a’ quali è perpendicolare, muta le sue direzioni secondo che il Sole si discosta dall’equatore verso qualcuno de’ tropici, e avvicinandosi al tropico di Cancro il vento del nord-est, che soffia ne’ luoghi boreali, s’accosta più all’est, e il sud-est, che soffia nelle australi, partecipa più del sud. Neppure i venti periodici, che chiamano alises o moussons, s’accordano col periodo della Luna. Tra le isole di Madagascar e Giava dal maggio al novembre spira il sud-est, dal novembre al maggio il nord-ovest. Alembert trovò che per forza del Sole deve nascere un vento orientale (num. 48). Bouguer osservò che le variazioni del barometro sotto la zona torrida sono assai piccole, e al livello del mare non mai eccedono due linee o al più tre, e a Quito non ne eccedono una. Goudin osservò che ogni giorno in un’ora determinata avviene una di queste variazioni, che da Bouguer si attribuisce alla dilatazione dell’atmosfera.
La forza del Sole è alla forza di gravità d’una particella terrestre nella Terra, come 1:12868200. Prop. 36, lib. 3, Newton.
X. [Paolo Frisi]
Le osservazioni degli influssi lunari che abbiam pubblicate contenevano nell’originale la dimostrazione della proporzione fra la luce del Sole e la luce della Luna sparsa sulla Terra. Noi abbiam creduto bastante il porvi il risultato semplicemente, per essere intelligibili anche ai lettori non geometri. Pare che la vanità degli uomini sia il vero principio che presso tutte le nazioni dell’universo ha accreditate le opinioni astrologiche e la influenza delle stelle su ’l fisico e sul morale d’un uomo; e certamente che non può esser discaro a quel piccolissimo vivente che chiamasi uomo l’immaginarsi che il gran pianeta Giove si prenda una seria briga del suo cervello, che Marte protegga la sua milza, Saturno il polmone, e così dicendo, che ogni parte del suo tenuissimo corpo abbia gli auspici d’una qualche stella. Vi sono alcuni ragionatori i quali si sono fatto studio di palesare le picciole cagioni de’ grandi avvenimenti; ciò non produce in verità molta consolazione agli uomini ambiziosi. Ma il far dipendere i minimi avvenimenti dal moto universale del sistema planetario, e il persuadere all’uomo che prima di tagliarsi le ugne o i capelli sia bene consultar l’attual posizione delle sfere, deve certamente solleticar l’amor proprio di chiunque sia felice e ignorante, a segno di persuaderselo. Ma se da un’altra parte diamo uno sguardo ai mali che produce alla società intera questa pregiudicata opinione, che non lascia tutt’ora d’avere i suoi oscuri partigiani malgrado i progressi che l’umana ragione ha fatto in questo secolo, troveremo ch’ella è occupazione degna d’un ottimo cittadino e d’un uomo amante del bene degli uomini il disingannarli da questi fecciosi avvanzi dell’antica barbarie. L’agricoltura sopra modo soffre i danni da sì fatti pregiudizi, e molte volte il raccolto sì nella seta che ne’ grani va male, perciocché invece di consultar la stagione e l’aria o serena od umida, invece di osservar le meteore, le quali hanno una fisica e non piciola influenza a far ben nascere e schiudere i prodotti dell’agricoltura, moltissime volte si fanno le operazioni camperecce fuori di tempo, per ubbidire ai sognati influssi della Luna. Di ciò scrisse assai bene l’autore del poema sul Bacco da seta, allorché disse nel secondo canto:
Né ti curar se la notturna dea
Mostri fastosa dall’argenteo carro
Con piena luce la sua faccia intera;
Che poca è sua virtute, e poco vale
Nelle cose mortali il non suo lume.
Ma sì fatte opinioni acciò più validamente sieno combattute, convien che ciò si faccia principalmente in que’ libri che più si diffondono fralle mani del popolo, cioè negli almanacchi. Questi almanacchi sono coloro appunto i quali coltivano nella facile turba le chimere dell’astrologia giudiziaria, e da qui ne nascono molti errori nella coltura delle terre e de’ giardini, e persino talvolta dei delitti per la seduzione delle cabale colle quali lusingano di fare acquistar ricchezza. Il rimedio più naturale al disordine che questi celebri autori mantengono nella società si è che un uomo ragionevole non isdegni di scrivere egli medesimo qualche almanacco più ragionevole degli altri. Né vi deve essere in verità chi tema di degradarsi, facendo un lavoro che non ha sdegnato di fare il gran Leibnitz e il dottore Swift. Non v’è oggetto che possa dirsi frivolo sì tosto ch’egli abbia influenza a migliorare gli uomini o a toglierli da un errore.
P. [Pietro Verri]
[Lettera d’un freddista]
Scrittori del Caffè.
Poiché vedo le mire vostre dirette principalmente al ben pubblico ed a combattere gli errori volgari, io credo opportuno di comunicarvi alcune riflessioni, le quali con miglior ragione potrei anche chiamare sensazioni, che attualmente mi occupano dacché son giunto in questa vostra patria. Sappiate dunque ch’io ho passato questi ultimi dieci anni nel Nord, viaggiando per quasi tutte le più rinomate città che vi sono, ed appena saran tre mesi ch’io son di ritorno. Scrittori del Caffè, che ne dite del freddo che si soffre generalmente da’ vostri paesani? S’io devo dirvela, nella maggior parte delle case ove convien ritrovarmi io mi sento morire. Se ne eccettuo una trentina al più di famiglie, le quali sono persuase che le sensazioni dolorose è meglio non averle che averle, le altre lasciano che il Sole le guardi dal Capricorno senza prendersene briga, e tremano, e si rannicchiano, e lasciano diventare il naso e la faccia porporina, e soffrono delle piaghe ai piedi, alle mani, e pare che non siano essi che soffrono. Se pur anche ciò accadesse per la povertà della nazione, ne vedrei il perché; ma tutti que’ tremori, tutti que’ rannicchiamenti, tutti que’ nasi insorbettati, tutte quelle piaghe si vedono e nascono in appartamenti dove la seta e l’oro adornano con lusso, e dove per giungere convien passare per una lunga trafila di servitori e di stanze. Scrittori del Caffè, perché non parlate di questa pazzia? In mezzo a una galleria di pitture, in mezzo ai damaschi, ai velluti, alle dorature, soffrire mille volte più freddo che non ne soffra il più miserabile contadino ne’ contorni di Pietroburgo! Sparecchiate que’ mobili, vendeteli, ricevetemi in una stanza meno addobbata, ma ricevetemi in una stanza di cui l’ambiente tepido sia capace di contenere un uomo senza ch’egli abbia dolore. Un bel quadro mi piace; un morbido e ricco sedile sta bene; molta officiosità conviene: ma prima delle magnificenze, prima delle espressioni, fa d’uopo premettere la sicurezza dai mali; e quando mi ricevete per tormentarmi col freddo, io vi protesto che nessun buon officio vi discolpa dalla offesa ospitalità. Se bastasse parlare italiano per aver il clima d’Italia, andrebbe bene che anche in Lombardia si vivesse come in Toscana, come in Roma, come a Napoli; ma il vostro cielo non è il cielo d’Italia, Lombardi miei; e dove vien molta neve, e dove gela molto, non va già bene l’architettura toscana e la maniera di vivere nell’inverno del rimanente dell’Italia. Il vostro clima s’assomiglia assai al clima di Germania, dunque ragion vuole che profittiate ancor voi altri dell’industria colla quale ivi si fa nascere la primavera nelle stanze in mezzo agli orrori dell’inverno; né mi stiate a dire che le stuffe facciano male, che sieno mal sane. Io vi dirò che più di cinquanta milioni d’uomini in Europa vivono l’inverno nelle stuffe, e questi cinquanta milioni d’uomini sono figli d’un’altra cinquantina di milioni d’uomini nati e vissuti nelle stuffe, e così andate rimontando sino ai tempi di Arminio, e più in là se volete. Io vi dirò che nel verno molti muoiono di freddo, e che di morti di freddo se ne trovano quasi tutti gli anni anche qui fra di voi, o nelle carceri, o nelle strade, ma che di caldo nessuno è morto, ch’io sappia; io vi dirò che il freddo è il compagno della sterilità e della morte. E voi, signori del Caffè, aggiungete delle buone ragioni fisiche in difesa di questa causa, che saprete ritrovarvele meglio di me, che v’assicuro avrete fatta un’azione da… Per dieci, non ne posso più… la penna non regge nelle mani… Vado a mettermi a letto per liberarmi da questo tormento. Ivi starò come la lumaca sino a maggio. Scrivete, che il Ciel vi salvi.
P. [Pietro Verri]
IL CAFFÈ )( Fogl. XXVII )(
Delle poste
La prima menzione che nelle storie si faccia d’un principio di regolamento simile alle poste si è circa 2300 anni fa sotto Ciro il Grande, re di Persia, principe glorioso per le sue vittorie ed ancora più per il mirabile ordine che stabilì nell’allora vastissimo Impero di Persia steso per tutta l’Asia, che perciò per più di 200 anni ancora sussistette unicamente, malgrado gli errori e le imprudenze de’ suoi successori.
Questo gran principe conobbe ottimamente gl’inconvenienti della grandezza d’uno Stato, e vide quanto difficile fosse lo scansarli. In fatti perché uno Stato sia ugualmente forte crescendo in grandezza, bisogna che la celerità sempre cresca in ragione della grandezza, e che vi sia un costante rapporto tra la prontezza colla quale può essere attaccato e quella necessaria a rendere vano ogni attacco: onde la grandezza d’un principe non consiste tanto nella facilità ch’egli ha a conquistare, quanto nella difficoltà che v’è a potere contro di esso operare con effetto, e nella immobilità di sua condizione. Giudicò egli perciò ottima cosa il procurare la più pronta comunicazione tra la capitale e le parti estreme del suo regno, e questo per mezzo di corrieri, di modo da potere tutto tosto sapere affine di rimediarvi. Fece a questo fine fabbricare delle stalle lontane l’una dall’altra per tanto spazio quanto può correre un cavallo in un giorno senza stancarsi, e ad ognuna pose de’ deputati che ricevessero le lettere e gli ordini per subito o alla capitale, o da essa ai confini spedirli per mezzo di uomini e di cavalli sempre pronti alla corsa, i quali né la notte, né pioggie o nevi mai dall’intrappreso corso ritardavano.[68]
Il conosciuto avvantaggio di questo regolamento lo rese durevole in Persia. Artaserse, che dopo Cambise succedette a Ciro il Grande, per mezzo di tali corrieri addimandati in Persia astandi, comunicò prestissimamente il suo matrimonio per tutto il regno, intimando perciò generali feste.[69] Serse parimente avvisò della rotta ricevuta a Salamina col mezzo de’ corrieri, che erano anche allora collo stesso ordine da Ciro introdotto spediti, secondo che si vede in Erodoto, e ciò con tanta celerità si faceva, che egli dice: his nunciis nihil pernicius transcurrisse in rebus humanis.[70]
Al tempo finalmente di Dario, che fu poi da Alessandro spogliato del trono, quanto desiderato fosse e gelosamente riguardato come importantissimo l’ordine delle poste si può conoscere dalla qualità delle persone che alla testa di tale dipartimento erano destinate. Basta il sapere che Dario stesso, innanzi d’essere re, ne aveva avuta la direzione sotto due re, Ocho ed Arse.[71]
Egli è vero che tali corrieri erano solo destinati a mantenere la comunicazione sugli affari che riguardavano lo Stato, e che principalmente la salute pubblica avevano per oggetto. Ma può egli essere che tra questi stretti confini fosse per tanto tempo rinchiuso un sì giovevole modo di estendere le proprie cognizioni? La curiosità, quell’insaziabile bisogno di cognizioni, poteva ella permettere a’ ministri abili di lasciare quasi affatto inutile la tanto vasta strada ad una universale e comoda comunicazione? Se è lecito il conghietturare e paragonare ciò che di poi tra’ Romani avvenne, e ciò che vediamo tuttodì accadere, forza è convenire che anche a’ molti privati si sarà esteso il frutto di questa istituzione. Gli uomini sono sempre simili a loro stessi quando passioni simili in simili circostanze gli agitano. Ecco la disgrazia d’avere de’ storici inesatti, d’avere degli storici che solo del grosso de’ fatti si curano, senza entrare in que’ dettagli che sul costume e sulle arti e sulle scienze possono portar lume. Ciò che v’è di sicuro si è che i Persiani furono una nazione ottimamente regolata, le di cui leggi non erano solamente destinate a mantenere la pace, come lo sono universalmente, ma di più pareano fatte per rendere anche gli uomini virtuosi, come Senofonte a gran ragione lo ammira;[72] e un commercio florido, e le arti[73] portate al sommo di perfezione (come li tanto celebri avvanzi della rinomata Persepoli lo provano invincibilmente) ed un governo mirabile sono una prova d’una estesa e grande comunicazione. Troppo sono da noi lontani que’ tempi per poterne di più con maggior certezza fissare.
La Grecia, paese di poi tanto florido, era prima divisa in tante piccole monarchie,[74] poi in altrettante piccole repubbliche, che tra di loro né commercio, né per conseguenza comunicazione alcuna avevano, ma bensì erano in un quasi continuo stato di guerra vicendevole, senza che le terre fossero punto coltivate o conosciute le arti.[75] In seguito diverse colonie venute d’Egitto e di Fenicia avendo insegnata l’agricoltura e le arti, lo spirito di fierezza scemò a segno che Anfittione (non già il re d’Atene, ma bensì quello delle Termopile)[76] potette poi proporre e formare il famoso Consiglio, affine di più strettamente unire tra di loro i Greci co’ sacri nodi dell’amicizia, ed interessargli a travagliare di concerto contro i nemici comuni e rendersi formidabili. Deve a ciò in gran parte la Grecia quella riputazione e quella grandezza alla quale salì di poi, ritardata in parte dal sempre vivo desiderio di signoreggiare e da una eccessiva ambizione, che sempre tra que’ piccoli Stati si mantenne; in parte dal disprezzo nel quale fu ivi per lungo tempo tenuto il commercio, con cui ciascuno credeva d’avvilirsi, disprezzo che fu poi in Isparta dalle costituzioni fondamentali autorizzato.
Egli è chiaro che in un tal paese, e piccolo come era la Grecia, dove tanto divisi e sì diversi erano gl’interessi e principii dominanti, nissun regolamento simile a quello di Persia poteva aversi, giacché al solo bisogno si devono le migliori leggi ed i migliori stabilimenti. Ciò non ostante troppo erano accorti i Greci per non sentirne l’utile, che anzi altro modo alle circostanze loro comodissimo all’istesso fine adoperarono e per privato e per pubblico servigio; e ciò prevalendosi de’ schiavi e di uomini principalmente al corso destinatisi, de’ quali la velocità era maravigliosa. Si chiamavano essi hemerodromi: Hemerodromos vocant Graeci ingens uno die spatium emetientes, secondo che scrive, definendoli, Livio,[77] e dovevano essere molto comuni, come pare che si raccolga da Cornelio Nipote,[78] onde pronti con piccolo utile al comodo de’ privati, tra’ quali perciò agevolissima doveva essere la comunicazione, ed in certa maniera costante. Erano essi pure all’occasione di guerra principalmente adoperati a pubblico vantaggio, o per osservare il nemico ed avvisarne i movimenti, come utilmente lo praticarono gli Ateniesi, che per questo solo salvarono la propria città dall’eccidio che Filippo, re di Macedonia, loro preparava in vendetta di Calcide da’ Romani presa e rovinata,[79] ovvero per ottenere soccorso da’ collegati in occasione di attacco, come fecero gli stessi Ateniesi per mezzo di un certo Filippide, che nella guerra di Persia terminata allora colla celebre vittoria di Maratona, da essi riportata sotto la condotta di Milziade, mandato a Lacedemone fece in due dì 1140 stadi,[80] cioè miglia romane 142.[81] Più sorprendente ancora si è la velocità colla quale Filonide, uno de’ corridori d’Alessandro il Grande, e con lui uno spartano, da Sicione ad Eli si portarono in un dì, facendo stadi 1200 , cioè miglia 150.[82] Diversi altri esempi di tali corridori greci vi sono appresso Plinio ed altri antichi scrittori.
Forse che tali fatti sono così singolari, che sembreranno a molti da mettere tra ’l numero de’ monumenti della credulità o della mala fede degli antichi scrittori, principalmente trattandosi di cose lontane dal tempo de’ scrittori che ne hanno parlato, ed in particolare di Plinio. Basta però l’avvertire ciò che lo stesso Plinio racconta de’ suoi tempi: nunc quidem, dic’egli,[83] in circo quosdam 160000 passuum tolerare non ignoramus; nuperque Fonteio, et Vipstano Coss. annis novem genitum puerum a meridie ad vesperam 45000 passuum cucurrisse; ciò che quantunque oltre modo maraviglioso sembri, pure non può ammettere eccezione. Abbiamo tuttodì sott’occhio i bambini, che da una generale inazione passano ai moti i più rapidi ed i più sorprendenti, e ciò per una lunga abituazione. È questo un fenomeno, che quantunque comune, non lascia d’essere maraviglioso. Ad Ispahan vi sono de’ corridori di professione detti charters, che fanno comunemente 36 leghe in 14 o 15 ore. Ci assicurano pure i viaggiatori che li Hottentotti superano nel corso i leoni, e che i selvaggi vanno alla caccia dell’orignale, ed inseguisconlo, quantunque veloce sia al pari d’un cervo, con tanta celerità che lo straccano e lo arrivano.[84] Un mastro di posta di Stilton fece nel 1745, correndo continuamente a cavallo, 215 miglia inglesi in ore 11 e mezza.[85] Questi ed altri infiniti fatti singolarissimi sarebbe temerità il mettere in dubbio, a meno di non volere tutta distruggere la fede della storia anche de’ nostri tempi. Non ne dovremmo noi piuttosto concludere non potersi giudicare della impossibilità di una cosa avanti d’averne fissati i limiti? E come mai determinarli, come mai definire fin dove l’abitudine possa portare le nostre forze ed aumentarle? Ma di questo abbastanza per ora, e de’ Greci, l’istoria privata de’ quali è troppo oscura per potere su d’essa argomentare chiaramente e senza conghietture.
Passiamo a’ Romani, popolo che una unione di fortunate circostanze concorse a rendere grande e possente. Arivatone al governo Augusto, temendo le incursioni de’ barbari, giustamente amico d’una bella pace, pensò egli pure ad un regolamento molto simile a quello già da Ciro il Grande praticato in Persia, ad un sistema di poste. Il governo puramente militare di Roma fece sempre nella sola forza fisica, non negli avvantaggi di condotta e di regolamento, consistere i principii della sua grandezza. Verso i soli ultimi tempi della Repubblica, allorquando le grandi passioni preparavano i grandi sconvolgimenti e le grandi rivoluzioni, pare che nuovi bisogni facessero almeno tra’ privati eccitare le prime idee di posta. Livio[86] racconta che T. Sempronio Gracco, per dispositos equos, con una celerità incredibile, giunse da Anfissa a Pello; siccome pure Cesare scrive che della sua vittoria furono portate nuove a Messina per dispositos equos.[87] Se ciò con privati mezzi e per solo privato comodo fosse in prima fatto, o altrimente, il silenzio degli scrittori non lascia luogo a deciderlo. È però costante che le ricchezze, le arti ed un ripulimento, che allontanavano dalla rigida osservanza delle antiche leggi, non più buone per uomini tanto mutati, dovevano similmente tra i principali de’ Romani eccitare nuovi bisogni e quel raffinamento che il popolo, nemico delle contribuzioni, non avrebbe mai acconsentito di sopportare, perché rare erano le necessarie occasioni onde ragionevolmente un durevole peso si potesse tollerare. D’altra parte il prodigioso numero de’ schiavi, principalmente numidi, con cavalli i più rinomati pel corso anche al dì d’oggi, davano luogo a’ privati[88] di supplire a ciò che le circostanze di governo non somministravano altrimente.
Augusto adunque pensò ad essere presto e sicuramente informato di quello che in ogni provincia accadesse. Dispose egli per questo a poche distanze sulle strade militari de’ giovani destinati al corso: indi de’ cocchi, de’ quali per un rapido corso già fatto uso avevano nella stessa maniera Mitridate,[89] Catone[90] e Giulio Cesare.[91] Ciò parve ad esso più comodo, perché così potevano interrogarsi quegli stessi che partivano dal luogo d’onde le lettere venivano, e secondo che alle circostanze convenisse, con maggior sicurezza provedervi.[92]
Egli è molto difficile l’assicurare se sotto a’ seguenti imperatori, troppo cattivi principi, tale savio regolamento con buon ordine sussistesse. Sappiamo però che Icelo, liberto di Galba, in sette dì da Roma portossi sino in mezzo alla Spagna, per consolarlo colla nuova della morte di Nerone. Nella vita dello stesso Galba, appresso Plutarco, ciò pure sembra che in un altro luogo si scopra durevole; ed oltrecciò molto di poi dalle medaglie di Nerva chiaramente la durata continua di tali poste pare che si possa raccogliere.[93] Se ciò sia sufficiente a supporre non interrotto l’ordine da Augusto posto, io non ardisco definirlo.
Vennero finalmente i bei tempi di Traiano, d’Adriano e d’Antonino Pio, principi nati per l’onore dell’umanità e per la felicità de’ loro sudditi. Pensarono essi per la sicurezza de’ popoli alle poste, e lo fecero di tale maniera che ben si può scorgere quanto al sistema d’oggidì si accostassero, col fissare de’ cavalli ed altri animali che sempre in luoghi determinati stassero, tolta così a’ magistrati delle provincie la noia continua di cercargli e fargli ad ogni occasione somministrare.[94] A tale nuova spesa fu destinata nuova gabella, che Antonino Pio allegerì[95] e che infine Severo, per obbligarsi i sudditi e rendersi benevolo, tolse, dall’erario supplendovi.[96] Nulla di più sino a’ tempi di Costantino il Grande ci somministra la storia.
È da questo imperatore che incominciano le leggi del Codice teodosiano, sotto il titolo De cursu publico unite eccellentemente, dal Gottofreddo illustrate. Molte leggi ancora vi sono su questo stesso soggetto nel titolo De curiosis.[97] Le leggi di questi titoli sono dettate tutte di modo che non si può dubitare che molto i privati profittassero di queste poste, e sino forse da’ tempi di Traiano. Applicossi Costantino, e li seguenti imperatori, alle più minute cose perché fosse ben regolato questo dipartimento delle poste. Chiaramente vi si distinguono due sorti di corso publico: altra co’ cavalli per presto correre; altra con muli e buoi per trasportare soldati e le contribuzioni dalle provincie, ovvero condurre pesi per comodo de’ privati a’ quali da’ principi fosse permesso il servirsi di questa vantaggiosa istituzione. Vi sono de’ regolamenti sulla maniera di servirsi degli animali al corso destinati, sul numero d’adoperarne ad ogni cocchio o carro e sul determinato peso da imporvisi. Era proibito lo sviare dalle strade pubbliche e correre su d’altre strade, abusando così della permissione dal principe ottenuta a danno delle provincie, i magistrati delle quali, in vista d’essa, erano tenuti a far somministrare il bisognevole ad un ulterior corso. Quantunque fosse lecito l’impetrare per sé la facoltà d’essere fornito d’animali per potere così prestamente viaggiare, ed il prendere un compagno a piacere, pure non si poteva cederla interamente ad altri senza servirsene per sé ancora. Vi si limita finalmente il numero di cinque cocchi o carri da potersi da un luogo ad un altro spedire in un dì, numero poi accresciuto sino al solo numero di sei da Teodosio il Grande, sebbene, come Procopio attesta, vi fossero in ogni posta (mansio) quaranta cavalli fissi.[98] Alla direzione di tali poste erano preposti i così detti curiosi, che per ogni provincia sparsi, erano principalmente incaricati d’osservare tutto ciò che succedesse, per subito darne avviso. Per questo molte leggi vi sono che loro accordano de’ privilegi sull’uso delle poste.
Col tempo però s’erano questi curiosi arrogata tanta autorità che chiunque loro piacesse facevano imprigionare, e tali e tante estorsioni anche verso chi correva le poste facevano, che quantunque loro per sovrana indulgenza fosse accordato qualche guadagno, nondimeno con molte leggi dovette la loro avarizia ed una eccessiva licenza frenarsi, ed in fine per tutte le ragioni il loro officio ad un anno di durata ridursi, affinché tali pessimi uomini con rapine e scelleratezze non rendessero più tormentoso e terribile un tale impiego, quale lo era il loro lungi dagli occhi del principe. Fu finalmente tale la loro autorità e tale l’abuso della direzione delle poste, che per eccessivo desiderio di guadagno tanto male regolarono, che Giuliano dovette pensare ad una grande riforma per questo solo.[99]
Tutte queste disposizioni, che io ho appena toccate, ma che ne’ citati luoghi del Codice teodosiano sono con ogni esattezza esposte, fanno sentire abbastanza che lungi dalla capitale duravano ancora tra’ sudditi e tra’ popoli confinanti i grandi semi di quella virtù, che quantunque frutto della barbarie e d’una incolta vita, erano nondimeno soli atti a formare de’ conquistatori. Era questa la strada per cui erano saliti i Romani: dovevano quindi in altri temerla, mancandone essi.
Le leggi del Codice teodosiano vanno sino al principio del quinto secolo. L’Impero di poi vieppiù diviso nissuna memoria ci somministra della durata delle poste. Rivoluzioni continue, guerre aspre portate nel cuore dell’Impero avevano tutto sconvolto, di modo che quasi il solo credito molto tempo sostenne un corpo affatto indebolito.
I re d’Italia, tra’ quali Teodorico, principe di grandi qualità, non dimenticarono già le poste, che ancora verso il fine del quinto secolo duravano. Da Cassiodoro[100] si raccoglie che molta cura se ne prese Teodorico, che solo è dalla folla di piccoli scrittori o negligentato o disprezzato perché di nazione goto e capo d’una nazione barbara, quasi che la virtù fosse attaccata al solo clima. Il luogo che la posterità dà agli uomini è sempre dal capriccio di chi giudica dipendente; ed in tutto v’è sempre qualche fatalità che decide della riputazione. Felici quelli, il nome de’ quali non urta qualche ricevuto pregiudizio.
Dal secolo quinto sino al decimo quinto, nel quale Luigi XI, re di Francia, ristabilì le poste per quella sola parte che riguarda il corso veloce, appena v’è menzione che Carlo Magno a questo pure pensasse.[101] Fece Luigi XI questo di più, che a chiunque de’ particolari piacesse, fosse lecito servirsi mediante un dato prezzo da pagarsi per ogni cavallo che venisse adoperato. Furono allora per la prima volta addimandate poste[102] ed a portare e ricevere lettere impiegato con sommo vantaggio de’ privati ancora un tale regolamento. Lungo tempo nella sola Francia si godette di questo vantaggio, che con un ordine grandissimo era mantenuto durevole. Sotto Luigi XII, Gilberto di Chaveau in tre soli giorni così correndo portò da Milano ad Amboise al suo re lettere importantissime.[103] Si stese di poi quest’uso, e dall’occasione dell’elezione all’impero di Carlo V si vede che era già per tutta la Germania, e per parte dell’Italia e per la Francia, comune.[104] Lo è poi per tutta l’Europa divenuto comune, e forse anche per questo è tanto decisa la superiorità d’essa su tutto il resto del mondo.
Anche da quest’abbozzo che ho voluto far sulle poste vedesi osservata la legge universale. Le cose ne’ suoi principii sono sempre difettose, e l’uso e il vantaggio loro poco esteso: né deve sembrare così strano che le cose le più praticabili e le più facili siano per lo più le meno conosciute, se si rifletta che dappertutto gli uomini cercano l’utile nelle difficoltà, e le più facili cose come inutili abbandonano per allontanarsi da se stessi, e perdersi poi tra ’l maraviglioso e l’impossibile. Se mai ad alcuno dispiacesse che io fin qui mi sia servito della parola poste, io lo prego ad avvertire che una stessa idea o ancora confusa o benissimo determinata può ammettere la stessa parola, la quale significherà più o meno in ragione di ciò a cui la si farà corrispondere.
Dalle poste a tanta perfezione portate come ora lo sono, io ho detto che forse dipende in parte la superiorità dell’Europa sul resto del mondo. Non può fare difficoltà qualche esempio di paese, ove le poste sebbene ottimamente regolate lasciano ciò non ostante l’antico sistema, e niente servono a cangiarlo o migliorarlo. Alle volte una buona disposizione diviene inutile, perché opposta all’intero sistema delle leggi, che in certo modo la opprime e ne impedisce ogni buon effetto. Il disordine o universale o particolare, quante volte non fa reazione a que’ principii che possono influire su d’una nazione per perfezionarla? La sola riforma di tale principio tosto o tardi influir deve a qualche felice rivoluzione, giacché sin tanto che i vecchi principii dominano gli animi ne’ paesi corrotti, si rimonta troppo lentamente al bene.
Il commercio tanto innoltrato, i costumi ripuliti e le scienze che tanta strada hanno in poco tempo fatta fare all’umano ingegno nel mondo intelligibile, le arti ad un raffinamento grandissimo spinte e dalle scienze aiutate sono in gran parte effetti di quella rapida e prestissima comunicazione che colle poste si può avere. Le scoperte hanno il loro secolo, e non si fanno che quando la catena delle idee, fortunatamente spinta ad un punto, fa in un certo modo schiudere da ogni parte le stesse verità. Le leggi del moto in uno stesso tempo trovate dal Wallis, dal Wren e dall’Huyguens; il calcolo differenziale trovato in Inghilterra ed in Germania e tanti altri esempi ne sono una prova di fatto. Perciò allora vedonsi i più grandi progressi quando in uno stesso tempo maggiori forze riunite mirano allo stesso fine. Felice il secolo, felice il paese, nel quale questo spirito d’applicazione più si diffonde. L’industria eccitata da una lodevole emulazione tutto avvanza, e del pari alle scienze vanno e le arti e il commercio, e per conseguenza i costumi. Le poste da’ limiti d’una città, d’una provincia, d’un regno con una prestezza grandissima fanno sole dappertutto spargere le nuove verità, ad esse sole quel fermento d’idee si deve che tanto accellera le invenzioni a vantaggio dell’umanità ed all’onore del secolo.
Noi ammiriamo le antiche nazioni su ciò che d’esse restato ci è: su’ nostri avvanzi saremo da’ nostri nipoti giudicati nella medesima guisa. Quanto più gloriosi rende i Medi Palmira per il fine discernimento col quale erano quelli immortali sepolcri travagliati; quanto più ammirabile rende la finezza degli avvanzi di Persepoli l’industria de’ Persiani; quanto illustri rende i Greci il loro paese, nel quale tante bellissime opere furono compiute; altrettanto più compassione fa l’Egitto, in cui ad un punto parvero fissate le arti tutte. Quelle immense piramidi, monumenti d’un sicuro dispotismo e d’un lusso che estreme ricchezze autorizzavano, altro non sono che un ammasso di marmi, senza che per altro sieno considerabili. I stretti limiti delle loro cognizioni, la loro ridicola superstizione non faranno stupore a chi consideri l’odio che avevano verso i forastieri e gli ostacoli che ad ogni comunicazione anche interna frapponevano gli impieghi ereditari ed una stabilità che in tutto affettavano, senza pensare che la comunicazione, il commercio e la libertà di operare avevano i Persiani ed i Greci resi così floridi.
N.N. [Luigi Lambertenghi]
IL CAFFÈ )( Fogl. XXVIII )(
Gli studi utili
Uno de’ più forti ostacoli che incontrano i giovani di talento sul bel principio della loro carriera si è o la disapprovazione, o il disprezzo, o il ridicolo delle persone colle quali devono conversare, e talvolta perfino de’ loro congiunti. Gli uomini perdendo la gioventù perdono i vantaggi fisici della loro esistenza; pochi sono coloro i quali, coltivando o colle scienze o colla abituale riflessione le facoltà del loro animo, compensino coll’accrescimento delle qualità morali il deperimento delle fisiche; e questi pochi soltanto possono mirare senza un segreto sentimento d’invidia un giovane, il quale cerca a distinguersi coltivando il suo spirito; ma la maggior parte degli uomini giunti ad una certa età mirano i giovani come altrettanti esseri intrusi su questa terra, di cui il dominio sia già devoluto ad essi per anteriorità di possedimento; né risparmiano l’occasione di umiliarli, di scoraggiarli, in somma di vessarli, per modo che anzi che resistere a sì forti opposizioni abbandonano la maggior parte quella strada che un felice genio li portava a correre; e poco a poco s’addormentano in braccio a quell’inerzia che forma i cittadini inutili d’ogni paese.
Altri distolgono i giovani dal proseguimento de’ loro studi con buona intenzione, ma spinti da alcuni pregiudizi succhiati col latte, la guarigione de’ quali non potrebbe ottenersi senza qualche contenzione di ragionamento, facoltà la quale non viene mai logorata dalla moltitudine. Il dovere d’ogni persona che sappia scrivere in guisa da poter esser letto è di sparger la luce sugli errori più perniciosi alle società; ed io sarei ben felice se potessi quella porzione che occupo di questi fogli impiegarla utilmente, e accrescere ai giovani ben disposti lena e coraggio per farsi uomini di merito, e persuadere agli uomini fatti e pregiudicati questa grande verità, che l’uomo non riesce che per quella strada per cui il naturale genio lo spinge; che ogni onesta applicazione d’un giovane è lodevole; che il biasimo ed il ridicolo non lo merita che la dappocaggine e la spensieratezza; e che finalmente tutte le traversie che s’oppongono ai giovani inclinati ad una più che ad un’altra scienza od arte, ad altro non conducono che a rendergli oziosi per lo meno, scostumati talora, e non rare volte obbrobriosi a sé ed alla famiglia.
Un giovane ha una forte inclinazione per le belle lettere, un altro per la fisica, un altro per le matematiche, e ciascheduno conformemente al naturale talento cerca d’innoltrarsi in queste diverse classi di cognizioni, e v’impiega i suoi pensieri e il suo tempo. Studi inutili, gridano i seniori, studi inutili; belle chimere, belle cognizioni, se volete, per ornamento, ma studi inutili.
Quai saranno gli studi utili, domando io: quei che fruttano più denaro? Sì, mi risponde taluno. Fate insegnare a quel giovine, replicherò io dunque, fategli insegnare a ben giuocare all’ombre o al pichetto: questa scienza ben appresa è più utile di qualunque altra che si possa imparare dai libri; il vostro giovine avrà un patrimonio assai più sicuro d’ogni altro, e col solo suo talento potrà vivere in ogni parte colta d’Europa. Altre scienze ancora più utili potrei nominarvi, le quali non s’imparano nelle biblioteche; ma voglio lasciar qualche cosa da fare anche alla immaginazione de’ miei lettori.
Le scienze utili, dicono alcuni più colti, non vogliamo noi assolutamente misurarle dal solo lucro che recano a chi le esercita; scienze utili chiamiamo quelle che servono all’immediato bene delle società. A questi risponderò primieramente che dunque la scienza più utile di tutte è la scienza dell’aratro e della marra; indi la scienza de’ muratori viene in secondo luogo; poi la scienza de’ tessitori del panno; poi la scienza di chi fa candele, e così andiamo avanti per modo che avanti di giugnere alla scienza de’ libri avremo trascorse almeno duecento scienze utili da preferirsi.
Tutte le umane scienze altro non sono che un lusso della condizione dell’uomo socievole; le società dei selvaggi sussistono senza veruna sorte di scienze, ma questo lusso di ragione è quello appunto che distingue le nazioni rozze dalle incivilite; questo lusso è quello che rende i costumi più dolci e umani; che provede a infiniti bisogni e che nobilita, dirò così, la nostra specie. Chi dice dunque che una tal scienza non è utile perché il mondo potrebbe sussistere senza di essa, accusa quella scienza d’una assoluta superfluità, che è comune a tutte le altre.
Gli uomini volgari conoscono che il guadagnar una lite è una cosa utile, che il guarire una malattia è una cosa utile: quindi concludono che la scienza delle leggi, la scienza della medicina sono scienze utili; ma gli uomini volgari non conoscono quell’intima e dilicata connessione che hanno tutte le scienze fra di loro; né sanno che di scienze al mondo non ve n’è che una sola, che si chiama la scoperta della verità, e che di qualunque genere sieno le verità, sono elleno sempre utili agli uomini, e sono, nella universale coltura in cui trovasi l’Europa in questo secolo, gloriose per lo meno a quella nazione in cui più se ne scoprono.
La legge e la medicina sono due scienze che ben maneggiate possono essere utili all’uman genere. La prima è quasi interamente fattizia, e quanto più ella è ben fatta tanto minore è il bisogno che la società ha di chi la professi; la seconda si appoggia sull’osservazione della natura, ed ella deve essere dovunque difficile a ben apprendersi; ma un soverchio numero o di leggisti o di medici cesserebbe sempre d’essere utile ad una società, poiché tutti que’ cittadini che vi si applicassero oltre il bisogno della società o dovrebbero essere cittadini oziosi, ovvero dovrebbero fomentar le liti e le cabale, e le malattie protrarre in lungo per essere occupati, le quali occupazioni non sarebbero certamente degne del nome di studi utili.
Forse quel primo che stroffinò un pezzo d’acciaio ad una calamita e che attentamente osservò la direzione di quel pezzo d’acciaio verso una parte del cielo meritò i rimproveri o il sorriso de’ gravemente ignoranti suoi contemporanei; ma quella puerile occupazione era quella appunto che doveva insegnare agli uomini a navigare nel mezzo dell’oceano; e forse allor quando il gran Galileo col cannocchiale da lui ritrovato osservava le stelle medicee, alcuni magistrati avran creduto di avere occupazioni assai più interessanti delle sue; eppure l’occupazione del Galileo ha cagionata la rettificazione della geografia, ed ha salvato dal naufragio infinite navi col metodo delle longitudini. Forse Arvèo, occupato ad osservare con un microscopio il mesenterio d’una rana, sembrò un uomo assorbito da fanciullesca curiosità, e quel microscopio in mano d’Arvèo discoperse la circolazione del sangue sconosciuta agli antichi.
So che le matematiche, quanto sono facili a schiudere le verità anche meno sperate e più sublimi, altrettanto sono elleno avare nel somministrarcene di utili immediatamente; ma lo spirito geometrico è uno spirito che si diffonde su tutte le scienze e su tutte le arti, e le perfeziona e le adorna in guisa che in quella nazione dove più esso s’estenda, più devono essere perfette nel loro genere tutte le cose che vi si fanno. Ascende questo spirito rischiaratore sulle cattedre degli oratori e li rende metodici, esatti e precisi; si diffonde sulla classe dei giudici e gli addestra a paragonare i fatti, ad analizzare le probabilità ed a ben decidersi; discende nelle officine persino degli artefici, e suggerisce loro i metodi più brevi, più sicuri, più industriosi per perfezionare i loro lavori. In fatti ognuno potrà chiarirsi colla sperienza che tutte le manifatture le migliori all’uso e le più esatte ci vengono da nazioni fra le quali regna lo spirito geometrico; e che all’incontro, dove esso non regni, tutto partecipa di quella rozzezza e di quella inesattezza che caratterizza le nazioni incolte.
Le cognizioni poi della fisica grandissima influenza hanno a perfezionare tutte le manifatture e i comodi della vita; di più, rendono, per così dire, più dilicato e fino il gusto in ogni cosa. L’arte de’ tintori deve tutt’i suoi avvanzamenti alla fisica; la farmaceutica, tanto interessante il nostro ben essere, dalla medesima pure riceve lume; in somma lo spirito della buona fisica si adatta a tutte le cose che servono all’uso dell’uomo, ed ivi sono sempre più eleganti e più comode dove quella scienza abbia fatti maggiori progressi.
Il breve giro d’un discorso non mi dà campo di addurre più copiosi esempi, né di far vedere ad uno ad uno i minutissimi anelli di quella catena che unisce le cognizioni tutte degli uomini per modo sì, che non è possibile che una nazione sia perfezionata in un’arte o scienza qualunque essendo nella perfetta ignoranza di un’altra; pure quest’è una di quelle verità delle quali la sperienza e de’ presenti e de’ passati secoli può convincere anche indipendentemente dalle ragioni intrinseche, le quali non si sviluppano che agli occhi de’ pochi ragionatori.
Ciò posto, dunque, se per utilità s’intenda una necessità fisica senza di cui la società non potrebbe sussistere, nessuna scienza sarà da dirsi utile; se poi per utilità s’intenda quello che il vero valore della voce importa, cioè attitudine a far del bene, ogni scienza deve chiamarsi utile, poiché ogni scoperta di verità è realmente un bene; un bene che talvolta produce le felici conseguenze con una immediata azione, e talvolta le produce con una lunga ed insensibile. Se dunque le scienze le risguardiamo per la influenza che esse hanno sulla massa universale di una nazione, le scienze sono tutte utili; e la ripetuta distinzione di scienze utili e di scienze non utili è una vera e provata chimera, venutaci dai tempi dell’antica barbarie per tradizione e contrastata da ogni sana ragione.
Non pretendo io perciò di dire che ogni giovane debba, unicamente consultando il proprio genio, abbandonarvisi senza prendersi verun pensiero del tempo avvenire o delle particolari circostanze nelle quali si trova. I doveri del proprio stato voglion essere i più preziosi di ogni altro all’uomo onesto; e la dolce lusinga di potere un giorno consolare e soccorrere la vecchiezza rispettabile d’un amoroso padre, d’una affettuosa madre, ha sempre più forza su un cuore ben fatto di quello che non ne abbia verun altro motivo; son belle le scienze, ma più bella infinitamente è la virtù; un’anima capace di sentirne la dolce emozione è un’anima grande, e incomparabilmente più grande di qualunque uomo per dotto che sia, se per disgrazia non abbia di simili sentimenti. Quello ch’io pretendo di dire si è che, a meno che una vera necessità non ci costringa a farlo, noi non dobbiamo mai distogliere o scoraggiare i giovani, i quali per un naturale talento si dispongono a coltivare qualunque scienza od arte; e che qualora lo facciamo, ci esponiamo ad esser rei di aver forse cambiato un cittadino illustre e benemerito in uno sfaccendato oscuro, il quale inquieterà nella sua gioventù colla scostumatezza, annoierà nella età virile colle lassitudini e co’ sbadigli, e farà arrabbiare nella vecchiaia i posteri col suo mal umore.
Quasi ogni uomo, se avesse trovati aiuti e non ostacoli ne’ suoi verd’anni, sarebbe riuscito buono in qualche genere; ma quel giardiniere che vorrebbe coglier dai gelsomini le noci, e le castagne dalle rose, renderà sempre sterile il terreno confidatogli. So che alcuni pochi, agitati da un estro vincitore, malgrado gli ostacoli seppero resistere e giungere alla celebrità; più di due terzi degli uomini più illustri in ogni genere dovettero combattere al principio della loro carriera; ma non tutti gli uomini capaci di far bene hanno quell’elasticità e fermezza di fibra che non si contorce e modella anche ad una continuata pressione, che anzi la maggior parte vi si piega; ma questa nuova forma basta bensì a toglierle la inclinazione primigenia, non già ad infonderne un’altra.
La maggior parte di que’ cittadini i quali s’annoiano nel letargo dell’ozio, se una buona educazione gli avesse assistiti, se la stima de’ loro contemporanei avesse servito loro di sprone, sarebbero meno infelici in qualche ora del giorno la quale impiegassero a leggere o a pensare; la società di essi sarebbe più colta, più amabile, meno ingiuriosa agli assenti e meno grave a chi ne partecipa; avrebbero essi qualche cognizione della fisica, qualche gusto delle belle arti: saprebbero trovare l’anima e la bella natura nella musica, nella pittura e nella poesia; e negando o accordando gli applausi a chi bene o male le esercita, contribuirebbero ai progressi di quest’arti. L’artigiano dovendo vendere i suoi lavori a persone più colte e che più intimamente ne possono giudicare, sarebbe costretto a raffinare la sua industria, i famigliari, per quell’universale principio d’imitazione inerente all’uomo, dirozzerebbero sempre più le loro maniere, e così dalla coltura di quei che non devono avere inquietitudine per il loro sostentamento scende per un insensibile pendio l’universale ripulimento su tutta una nazione.
Ma se in genere di scienze vogliamo fare i difficili, e tollerarle piuttosto che accoglierle e invitarle; se pretendiamo che ogni scienza ci presenti la patente e ci spieghi immediatamente a che essa è utile, prima di darle accesso nella nostra casa e permetterla ai figli nostri; non potremo mai lusingarci di contribuire dal canto nostro al bene della nostra patria, né d’avere la mente illuminata d’un buon cittadino.
Cosa strana per altro che ne’ capricci delle mode nessuno osi interrogare a che sono elleno utili, e che tanto austeramente si giudichi delle scienze! Nessuno domanda a che sia utile quella polve bianca con cui ci incanutiamo i capelli; nessuno domanda a che sia utile quel pezzo di merletto che ci copre mezza la mano e parte della gola; nessuno domanda a che sia utile quell’oro e quell’argento che sopra imponiamo al vestito; né v’è persino chi domandi a cosa sia utile quella carrozzetta, quello schioppettino, quella gabbietta e tanti arnesi di Liliput che pendono al nostro oriuolo e rendono sonoro il nostro passo; e si pretende d’impedire l’acquisto di una serie di verità se non si prova a quale immediato utile elleno servono?
Osservo che uno dei soggetti sui quali, generalmente parlando, gli uomini mostrano minore equità ne’ loro giudizi sono le scienze e le lettere. Un briccone fallisce dolosamente; un altro briccone uccide un buon cittadino: gli uomini ne parlano per due o tre giorni, e poi tutto si dimentica. Ma se un uomo, e molto più se un giovine, ardisce di fare un libro, il qual libro non ripeta le comuni opinioni degli altri libri: chi sussurra da una parte, chi dall’altra; gli piovono addosso i critici, i satirici, gl’invidiosi. Raccogliete i voti della moltitudine, rare volte li troverete dalla parte della ragione; eppure un libro che non sovverta i principii della società, che non offenda la morale, è certamente un mal minore in ogni caso d’un fallimento o d’un assassinio.
Non frapponiamo argini a quel felice fermento degl’ingegni che dà vita alla coltura delle nazioni e dei secoli, gli errori medesimi, purché siano un tentativo, sono un bene, servono essi di occasione perché altri pensi sul medesimo soggetto, e combattendo l’errore lo rischiari: trahat sua quemque voluptas nelle scienze; lasciamo che i giovani seguano la loro stella, e purché s’occupino e restino in moto con occupazioni per sé non cattive, godiamo della loro inclinazione; non perdiamo un bene per correr dietro a una chimera da noi creduta l’ottimo: l’ozio ed il torpore sono de’ massimi mali da temersi in un giovine.
P. [Pietro Verri]
I beni della insensibilità. Racconto antico
V’era ne’ tempi antichi un buon uomo per nome Damone. Costui, nato con mediocri talenti nulla eccedenti il senso comune, fornito di bastevoli beni di fortuna, indolente, tranquillo, placidamente insensibile agli umani avvenimenti, godeasi una vita priva egualmente de’ vivaci piaceri prodotti da un temperamento delicato come di que’ dispiaceri che accompagnano una troppo fina sensibilità. A nulla attaccato con veementi passioni, né l’accendevano a sdegno i vizi degli uomini, né lo commoveano le virtù loro; in somma era in quel mezzo che alcuni a torto onorano col nome di virtù, e che altro non è realmente che una venerata mediocrità d’ingegno ed un indeciso carattere, che non fa nulla di male come di bene, egualmente inetto a fare con energia l’uno o l’altro. Fiorivano in que’ tempi in Grecia Sofocle ed Euripide, le tragedie loro ripullivano quella nazione e ne esercitavano la vivace sensibilità. Il nostro Damone andava anch’egli a questi spettacoli, ma mentre tutto l’uditorio era in lagrime gli riusciva il più delle volte di sbadigliare. Che cosa è ella mai questa, dicea fra sé, che tutti costoro piangono e sono afflitti vedendo or l’uno or l’altro di questi attori a declamare, e che io nulla mi sento agitare e da nessun sentimento m’accorgo di esser mosso? E mi par bene che costoro piangano e si corruccino, ma il fanno con una certa mescolanza di piacere ch’io non saprei spiegare, poiché quando escono di costì, benché abbian lagrimato tutti quanti per lung’ora, pure lodano la tragedia che gli ha attristati ed applaudono all’autore, forz’è che qualche ignoto piacere vi si asconda se più sono frequentate quelle rappresentazioni che più gli fanno lagrimare.
Queste ed altre riflessioni già da lungo tempo facea fra sé, e volea pure provare che razza di piacere fosse codesta sensibilità, che gli parea il più strano fenomeno del mondo. Andossene egli al tempio di Giove, ed: Oh tu, disse, padre de’ mortali che mi ascolti, dammi io te ne prego un temperamento come quello di Filotete, fa’ che pur io possa avere un’anima sensibile, che certo ella è al dir di tanti savi il più bel dono che possa farci il Cielo. Ascoltò quelle preci il padre degli dei, ed esaudillo. Ecco il torpido, l’insensibile, l’indolente Damone cangiato in un uomo che sente, che si commove alla virtù ed a’ mali altrui. Già quella stupida fronte e quegli occhi inanimati e tardi son fatti pronti e languidamente vivaci; più non sorride indolentemente, più non vedi in quella faccia le tracce della primiera stupidità, son vivi i tratti, leggiadri i contorni, e vi leggi in fronte il buono, il sensibile, il virtuoso cittadino. Qual non rimase Filotete qualor s’accorse di sì strano cangiamento in Damone? Unite le anime loro da virtù vicendevole, strinsero la più soda, la più sincera d’ogni benivolenza. Infelice Damone, qual dono fatale chiedesti agli dei! Muore Filotete, ti sembra estinta la natura, ti sgorga dagli occhi per la prima volta il pianto, tu perdesti la più cara porzione dell’universo, tu non ritrovi pace, la sua immagine ti si affaccia ad ogni passo, la fronte abbattuta, gli occhi molli di pianto tu passeggi come uno stolto le vie d’Atene! Pure il tempo lentamente rintuzza il tuo dolore, e dopo sei mesi d’infelice vita né pur ricuperi in parte il perduto riposo, che sei creato arconte. Or non sei tu quel giudice indolente che tranquillamente vede le lagrime delle vedove desolate e degli affammati pupilli, tu fremi alla prepotenza de’ grandi, i mali pubblici sono i tuoi, buon cittadino e virtuoso ed incorrotto proteggi i miseri, compiangi le loro sventure e con essi le dividi. Movono guerra ad Atene i Cretesi. Alcuni de’ congiunti di Damone son condotti in schiavitù. Chi può dire quali sieno le smanie di quel benefico e virtuoso cuore? Magistrato e soldato a un tempo, egli si mette a capo di un drapello e va contro dell’inimico come un forsennato per togliere i suoi dalla catena. Gli riesce di riaverli, e vien ferito mortalmente. I suoi più cari gli stanno d’intorno nella sua tenda, egli legge su’ loro volti quella tristezza che li divora, e più sente il peso della loro compassione che il dolore della propria ferita. Pur egli a poco a poco ricupera la sanità. Ma già Atene è ridotta agli estremi. La guerra ha desolate le campagne, son cresciuti i tributi, tutto spira miseria e desolazione. Non sono popolate le strade che di miseri, che gli chiedono un tozzo di pane ch’egli non ha. Ahi quanti oggetti terribili per il cuor sensibile di Damone! Ei vede tanti mali, è colpito nel fondo del cuore, il zelo e l’amor della patria son fatti inutili. Allora rientrato in se stesso Damone: Ahi, disse, che chiesi io mai al Cielo! Qual pena maggiore potea egli impormi per una sì sventata domanda?
Ma il padre degli dei, commosso a pietà di quest’infelice, restituillo alla primiera indolenza. I Cretesi assediarono con più vigore Atene, essa fu saccheggiata; Damone lasciò la patria in abbandono, portò seco quanto più poté ed andossene a Corinto. Ivi gli fu data la nuova, mentre che cenava, che i suoi amici e congiunti erano stati uccisi, che la moglie ed i figli erano stati condotti in schiavitù: si ristette egli alquanto pensoso, poi proseguì a cenare, né più parlò di amici, di moglie, di figliuoli, di patria per tutto il resto de’ tranquilli giorni che visse nella sua indolenza.
A. [Alessandro Verri]
[Ai lettori]
Gli autori del Caffè propongono il premio di un esemplare del Menocchio rilegato in marocchino, ovvero di quattro esemplari del Bobadilia rilegati all’olandese, a scelta di chiunque nel termine di due mesi prossimi, contando dalla pubblicazione del presente, avrà risposto adequatamente ai seguenti quesiti.
Il Frammento sugli odori è preso dal libro … a pag. …
Il Tempio dell’Ignoranza è preso dal libro … a pag. …
Gli Elementi del commercio sono presi dal libro … a pag. …
La Rinunzia alla Crusca dal libro … a pag. …
La Commedia dal libro … a pag. …
La Coltivazione del tabacco dal libro … a pag. …
Il Dialogo sull’agricoltura dal libro … a pag. …
Le Riverenze dal libro … a pag. …
Le Osservazioni meteorologiche dal libro … a pag. …
Il Discorso sulla felicità dei Romani dal libro … a pag. …
Chiunque risponderà adequatamente, indicando e autore e pagina, riceverà il premio suddetto dalle mani del nostro Demetrio, presso cui sta in deposito. Chiunque poi risponderà a parte de’ dieci quesiti pure adequatamente, avrà a proporzione la corrispondente parte del premio.
A noi pare che le cose che scriviamo bene o male sieno cose veramente nostre; se questo parere nostro fosse una illusione, si può fare la spesa del Menocchio e del Bobadilia per illuminarci; e sarà un degno trofeo da riporre nella biblioteca del vincitore quello che proponiamo.
V’è chi ci accusa di non dire cose nuove; a noi pare che diverse qua e là se ne vadano da noi scrivendo; ma bisogna che que’ tali abbiano la compiacenza di scrivere una mezza pagina di cose veramente nuove del loro, la quale ci potrà servire d’esemplare per trovare tante scoperte assolutamente nuove da riempierne le ducentottantotto pagine le quali comporranno il totale del nostro Caffè al fine dell’anno. Mille cose buone vi sono, le quali, benché non siano nuove, pure sta bene che si dicano; per esempio s’io dicessi che le anime piccole possano bensì pronunziare con enfasi le parole il grande, il bello, ma ne’ loro affetti non hanno mai altro che il piccolo e il noioso, io direi una proposizione molto vera, e che non è male il ripeterla di quando in quando, poiché se non v’è da sperar molto nelle conversioni degli uomini, non si deve però disperare affatto.
IL CAFFÈ )( Fogl. XXIX )(
Sulla spensieratezza nella privata economia
L’argomento sul quale io vuo’ parlare in questo foglio è tale, che e per l’importanza sua e per la vastità potrebbe a ragione somministrare materia ad un’opera intera. Io però considero che l’opera, fatta ch’ella fosse, verisimilmente non sarebbe letta che da coloro i quali meno ne hanno bisogno, laddove un breve foglio, che altro più non domanda che una mezz’ora ogni dieci giorni, se non altro per allontanare la noia, forse può ottenere un’occhiata anche da chi vive spensieratamente; e il fine d’ogni onesto scrittore dev’essere sempre (come altra volta pure ho detto, e come non si ridirà mai abbastanza) di giovare il più essenzialmente che si può agli uomini. A questo fine onorato che ci siamo principalmente proposto attribuiamo noi la benevolenza e la parzialità con cui quest’opera nostra viene generalmente accolta.
Gli enormi mali che nascono nelle famiglie per la spensieratezza nella privata economia sono bastantemente noti al primo rivolgervi il pensiero che ciascun faccia. L’ingiustizia e le maledizioni de’ creditori, l’inquietitudine della miseria a cui si corre in braccio, il decadimento de’ figli, la mancanza della loro educazione, il crudele contrasto che deve fare ne’ loro animi un giorno la memoria e il desiderio del passato fasto colla inopia attuale, contrasto terribile a soffrirsi e produttore d’infinite iniquità, un abisso in somma di disordini e di calamità, li quali inviluppano e la famiglia propria e quelle de’ traditi creditori, vengono in conseguenza d’aver trascurata la domestica economia. Che se anche questa spensieratezza trovisi presso d’un uomo isolato, i comodi della vita, che vanno scemandosi più che s’invecchia, cioè più che ne cresce il bisogno, devono amareggiare per modo gli ultimi anni della sua vita, sì che, paragonando i pochi piaceri della magnificenza divorati frettolosamente nella gioventù co’ lunghi rammarichi che rimangono a soffrire negli ultimi anni, fanno provare quando non v’è più rimedio d’aver malamente provveduto al proprio ben essere.
Non oserò io qui parlare di que’ doveri che dipendono da’ motivi sovraumani, dai quali viene vietato un cotal abuso delle ricchezze. Noi ci limitiamo a venerare gli oggetti sublimi in ogni nostro scritto, né crediamo quest’opera periodica degna di trattarli. Devono esser eglino i primi che diriggano la nostra vita; ma noi circonscriviamo i nostri discorsi entro i confini d’una morale pratica filosofia.
Il principal fine di quella rovinosa spensieratezza che fa dileguare i patrimoni anche più vasti è l’amore di distinguersi fra gli altri cittadini, e di mostrarsi colla profusione e col fasto più possenti o più magnanimi di essi. Ma questa possanza e questa magnanimità nostra, se non ha per base un fondo di beni corrispondente alla scena che vogliamo rappresentare su questo teatro, non si riduce che ad una vera illusione, che acceca quell’uomo solo che va in rovina, ed eccita una inumana derisione nel cuore della moltitudine ed una compassione più ragionevole in quello de’ pochi saggi. Sono que’ spensierati come i cacciatori raccontano delle quaglie, le quali ascondendo nella terra il lor capo, credono da nessuno esser vedute per ciò ch’esse nessuno vedono. I cittadini, dove più dove meno, si conoscon l’un l’altro, e presso poco universalmente si sanno le facoltà d’ognuno; né chi ha crediti conserva con un profondo secreto gli arcani, sicché non se ne lagni e non ne ragioni per tal modo che lo spensierato circondato da parasiti e da qualche imbecille o scaltrito confidente, mentre crede di mostrarsi poderoso di beni e signorile d’animo, viene anzi universalmente disprezzato come un uomo che si lascia andare in rovina, o come un uomo che ha la bassezza d’usurpar l’altrui e di tradire la buona fede per provare la nobiltà de’ suoi pensieri.
Se coloro i quali si caricano d’un fasto superiore alle loro forze potessero ascoltare quello che d’essi dice la città, e quel che dicono quei medesimi che più loro stanno al fianco, e come edera tenace li circondano e vi ficcano le radici nel tronco e s’alimentano col loro sugo; se potessero ascoltare la disistima, la indifferenza e molte volte ancora la maldicenza con cui corrispondono alle loro profusioni, certamente vedrebbero che il fine che s’erano proposti non l’ottengono; ma che anzi n’ottengono uno perfettamente contrario. Alcuna volta e non di rado è accaduto che di sì triste verità si sieno scoperte da quegl’incauti medesimi che ne erano la vittima; e allora le esclamazioni contro la tradita amicizia s’intesero senza fine, quasi che potesse essere amicizia fra due, uno de’ quali cerca di far servire l’altro al proprio fasto; quasi che fosse capace di amicizia chi vive profittando del disordine altrui; quasi che gli amici si comprassero! Un uomo onesto, beneficato o da un vano o da uno stolido, può e deve aver gratitudine per lui; ma l’amicizia, avendo per base il nobile sentimento del merito, non può darsi se non fra due che vicendevolmente si abbiano in pregio; ora il numero degli onesti uomini essendo per disgrazia il minore, deve anzi far maraviglia dovunque la gratitudine per beneficii profusi senza esame e senza scelta si ritrovi; né l’amicizia d’un uomo ragionevole può mai sperarsi che nasca con questi mezzi, i quali altro non provano che un vizio o una dappocaggine in chi gli adopera.
Crasso lagnavasi con Roscio perché, dopo averlo per due anni avuto alle laute sue cene, gli contrastasse il comando d’una provincia. Voi anzi dovreste aver rimorso, gli rispose Roscio, disputando a me questa carica, a me che, per compiere il fastoso numero dei cinquanta commensali vostri, ho potuto per due anni abbassarmi a vivere nella caterva de’ parasiti ingenui e libertini che sedeva alle vostre cene. Tale fu la risposta di Roscio, il quale naturalmente doveva avere assai più amicizia col cuoco di Crasso anzi che con Crasso medesimo. In fatti e chi mai può aver nell’animo nemmeno riconoscenza per chi facendoci suo commensale non pensa a farci una distinzione, né a darci preferenza con un disegno meditato, ma soltanto a riempiere il numero de’ sedili già preparati pel convito? Chi mai può trovarsi lusingato nell’amor proprio per aver parte ad una universale e indistinta dilapidazione d’un patrimonio? Il saggio mal soffre d’essere attaccato al carro di trionfo d’uno spensierato; e l’uomo capace di sentimenti sente ribrezzo a pascersi della rovina altrui.
Di tutte le profusioni, a parer mio, la più stolida è quella del convito. So che la società si anima e si fomenta mirabilmente colla reciproca comunicazione della mensa; sembra che ivi la famigliarità si accresca, e con tal mezzo vediamo i cittadini meno forestieri l’uno coll’altro ne’ paesi dove tal costume è più universalmente ricevuto; ma le cene e i conviti che producono questi beni della vita e questa reciproca fratellanza fra i cittadini non son già quelle numerose e di fasto nelle quali altro più non iscorgesi che la profusione del convitatore e l’avidità o il tedio de’ convitati; ma bensì quelle alle quali presiede una reciproca brama d’esser grato, e dove l’amicizia e la scelta animano la società a cui una ben intesa ma non rovinosa mensa serve d’occasione.
Gli uomini riposti in dignità devono per decenza del loro carattere dare di tempo in tempo di tali fastosi conviti; e questo spettacolo vien risguardato dall’uomo ragionevole che lo dà come un incomodo del proprio stato; e dall’uomo ragionevole che vi partecipa come un cerimoniale contrassegno d’onore, non mai come un giorno in cui si prepari a giocondamente pranzare. Ma chi senza necessità profonde per questa strada, non lascia altro vestigio della sua rovina che il macellaio e il pizzicagnolo arricchiti, e tre o quattro bricconi gallonati a sue spese; laddove una sontuosa galleria, un magnifico palagio, una rinomata biblioteca restando almeno fra le rovine, puossi, compiangendo la sproporzione del patrimonio colle idee, avere una sorta di dispiacere che le forze fossero sì limitate d’un uomo capace d’idee grandi.
Se coloro i quali hanno ottenuto in retaggio un pingue patrimonio possedessero la difficil arte di ben goderlo, quanto non potrebbero eglino migliorare la loro condizione! Quante virtù, quante nobili qualità, le quali rimangono sterili e celate da quella implacabile necessità che limita i patrimoni ristretti, non potrebbero mai risplendere nella più chiara luce e lasciare un glorioso nome dopo una gloriosa vita per le pubbliche e private beneficenze! Quanti giovani e uomini di talento da togliersi da quell’angustia domestica che s’oppone a’ progressi d’ogni bell’arte, e con una liberale sì, ma giudiziosa protezione, da crearsi uomini eccellenti! Quanto più nobile e magnanima cosa è il poter dire: il tal generoso cittadino ha dato alla patria il tale architetto, sollevandolo sin da’ primi anni dalla mendicità in cui avrebbe dovuto vivere forse servilmente tutta la vita, e l’ha assistito, e gli ha dati maestri, e lo ha fatto viaggiare a sue spese, e lo ha formato in somma uno de’ più celebri uomini che abbia l’Italia nell’architettura; il tal tempio, il tal palagio, che onorano la nostra città, saranno un eterno monumento ai posteri e del talento dell’artefice e della beneficenza del mecenate! Se a questi potrà aggiungersi il tal eccellente pittore, il tale scultore, intagliatore ec., tutti assistiti, consolati, soccorsi, protetti in somma dal benefico cittadino, qual vita o qual memoria più benedetta può esser mai, e più adorata di questa in ogni tempo e presso d’ogni colta nazione?
Felice quella città, in cui trovasi unito nella stessa persona un vivo e illuminato amore del merito ad un vasto patrimonio; la sua casa diventa l’asilo di tutti que’ ottimi cittadini che o già fanno o promettono onore alla lor patria; ivi ritrovano grata ospitalità tutti gl’ingegni i quali coltivano con amore qualunque parte della vasta serie delle umane cognizioni, dalla più sublime astronomia sino all’ultima delle bell’arti; egli assiste e col consiglio e coll’opera i giovani ancora incerti; egli dà lena ed emulazione con una rischiarata protezione ai timidi; egli sa che gl’ingegni non volgari e vigorosi a segno di spiccare qualche felice slancio al di là del comune livello hanno per lo più ne’ primi anni una sorta di rigidezza nell’animo che mal si piega alle comuni maniere; e gli spinge talvolta a certi irregolari modi di agire che il volgo sott’altro aspetto non vede che sotto quello del ridicolo o dell’imprudenza; e il retto conoscitore ravvisa come difetti bensì, ma che provano un fondo di ottime qualità, non altramente che un esperto minatore da una terra sterile e ingrata che incontra riconosce l’oro che ivi deve trovarsi vicino. Da tai lumi assistito, il ricco amatore del merito vedesi circondato dalla più colta e rispettabile compagnia, di cui egli è l’anima e il promotore.
Qual uso non hanno fatto nell’Irlanda in quest’ultimi anni delle ricchezze loro alcuni illustri cittadini di Dublino, fra i quali merita distinta lode il signor Samuele Madden, colla erezione dell’Accademia d’agricoltura, commercio e manifatture, accaduta non sono molt’anni, ed a cui l’illustre benefico signor Madden ha in sua porzione assegnato più di 500 zecchini annui di sua rendita?[105] Questa benemerita associazione, la quale distribuisce premi annui a chi più siasi distinto o nell’avvanzamento dell’agricoltura o nella perfezione delle arti, ha fatto nascere nella sua patria le più belle tele che al dì d’oggi trovinsi nel Nord. La Reale Società di Londra è pure opera in origine di privati cittadini. L’Accademia Reale or ora eretta in Torino è pure essa una società originariamente progettata da alcuni illustri privati, de’ quali il merito ha ottenuta poi la reale protezione, sotto l’ombra di cui l’Europa vede nel fiore degli anni de’ grandi geni, ed uno singolarmente, che nelle più sublimi ricerche dello spirito umano sembra ormai innalzato a quella prima classe che gli assicura un nome presso la più rimota posterità.
Or quanto diversa sarebbe la gloria di chi, avendo superfluo di ricchezza, invece di ricercarla da una schiera di parasiti, a sì fatti oggetti rivolgesse la nobile ambizione! Qual cosa vi può esser mai che innalzi un privato al rango d’un sovrano quanto di simili giudiciose beneficenze? Ma giudiciose appunto devono essere queste beneficenze, poiché l’onore e la stima, qualora vengono accordate all’ipocrisia del merito, anzi che al vero merito, ossia qualora, o per brighe, o per riguardi, o per debolezza di non resistere alla importunità, s’accordi la distinzione e il premio a chi più lo sollecita (cosa che rare volte s’induce a fare l’uomo di vero merito, opponendosi a ciò o la modestia o un sentimento nobile del proprio valore), allora, dico, le ricompense medesime e le distinzioni diventano un mezzo efficacissimo per opprimere i buoni ingegni ed avvilirli sempre più. Lodovico XIV, che ha dato il nome al quarto secolo illustre negli annali del genere umano, cercava ei medesimo gli uomini di merito e preveniva le loro suppliche. Viviani ricevette nella Toscana i doni di quel monarca prima ch’egli osasse nemmeno pensare a chiedere il real suo favore. Il merito giammai non va unito colla importunità o colla sfrontatezza.
Ma troppo mi svia la moltiplicità degli oggetti che mi si affacciano alla mente, e ragion vuole ch’io alla brevità sacrifichi molte idee accessorie, che pure vi vorrebbero aver luogo, per ritornare al principale soggetto di cui ho preso a scrivere. L’uomo spensierato nella domestica economia è come quell’uomo dipintoci dalla favola, il quale alzatosi la mattina da letto e sentendosi soddisfatto il sonno, portò al mercato il letto o lo contrattò, senza prevedere che fra poche ore sarebbe ritornata la sera e con essa nuovo bisogno del sonno. Chiunque spende in un giorno più di quello che realmente gli fruttino i suoi beni in quel giorno, o deve aver risparmiato già ne’ giorni antecedenti delle sue entrate, ovvero deve risparmiare ne’ giorni che verranno. Chiunque spende in un anno più della sua entrata deve o ripararlo con risparmio, ovvero sbilanciare la famiglia, poi rovinarsi. Ognuno sa questa verità. Ma se ognuno prima d’impegnarsi in un dispendio superiore alle sue forze vi riflettesse, e conoscesse che se in quest’anno dieci, che ha d’entrata, non bastano a’ suoi capricci, e voglia spenderne due di più dovrà l’anno venturo o fare che otto di entrata bastino ai capricci (cosa più difficile a farsi con otto che con dieci), ovvero decidersi per la totale propria rovina: crederem noi che con questa ragionevole prevenzione cederebbe alle lusinghe che dapprincipio lo fanno scapitare? Crederem noi che in vista dei mali e delle angoscie estreme d’una meritata e non aspettata povertà, e forse anco in vista della ignominia d’una fede mancata ai creditori, potrebbe aver forza il piacere di caricarsi molte vesti di dorature non proprie, ma carpite dalla bottega d’un incauto mercante; di far trottare le ricche frangie tolte a credito e cucite sugli abiti dei ben sudati e mal pagati lacchè; di aprire una prodiga mensa ad una stolida turba di uomini, i quali, anzi che d’animali ragionevoli, meritano talvolta il titolo di lambicchi digeritori e distillatori di chilo? Io nol credo già, anzi mi par dimostrabile che la maggior parte de’ mali che devastano l’uman genere sieno i mali che si fanno gli uomini da loro medesimi, per non adoperare la parte migliore di essi, cioè quella che accozzando le idee ricevute dagli oggetti, e paragonandole ed esaminandole, ci dispone a formarne un retto giudicio, e a prevedere l’avvenire di quella strada per cui imprendiamo a correre, cioè quell’uso divinatorio che fa della ragione il saggio, il quale non aspetta il disordine ma lo previene.
Dovunque più pensano gli uomini, ivi sono i minori mali; ed uno de’ massimi beni che fanno al mondo le scienze si è quello di scuotere colla emulazione e colla curiosità gli uomini da quel letargo a cui per una naturale inerzia s’abbandonano, e riporre in moto l’animo loro ad avvezzarli a pensare; facoltà la quale se ben s’eserciti sugli oggetti delle scienze, forma gli uomini illustri; se ben s’eserciti su tutti gli oggetti che circondano l’uomo posto in società, forma il vero saggio.
Ho conosciuto un uomo di senno, il quale avendo sortito dalla natura un animo disinteressato, e forse anche al di là de’ confini del disinteresse inclinato a spendere, per porre un giusto limite a questa inclinazione pericolosa, divideva la sua entrata in dodici parti eguali, ed ogni mese ne prendeva una per suo uso; poiché lo sbilancio in tal guisa se gli manifestava più sollecitamente, né poteva lasciar correre tanta prodigalità in pochi giorni, che pregiudicasse notabilmente a tutto l’anno. L’uomo di senno deve distendere le annue sue rendite sullo spazio di trecento sessanta e più giorni; né deve dimenticarsi mai di paragonare quello che gli avanza di tempo colla somma del denaro che vuol conservare. L’uomo di senno deve di più conservarsi costantemente un discreto sussidio a parte per provvedere a tutti i casi; così egli si mantiene nella perfetta osservanza della giustizia in ogni contratto; ei gode di tutti i vantaggi che accompagnano la puntualità; ei trova tutto il credito presso chi deve aver a fare con lui; ei vive nella maggior indipendenza possibile in cui un uomo può trovarsi, qualunque sia il sistema sotto cui vive; egli perfine è capace di soccorrere un amico o un infelice all’occasione; e siffatti piaceri sono per verità assai più durevoli e puri di quello che non lo sia lo sfarzo di farci credere quello che ognuno sa che non siamo.
Non v’è vizio più sordido dell’avarizia; non v’è cosa che più convenga all’uomo ragionevole nell’aspetto della decenza e di quella eleganza proporzionata alla sua condizione che deve mostrare e nella persona propria e in ogni oggetto che lo circondi o gli appartenga; non v’è qualità umana dell’animo che più lo innalzi quanto la vera liberalità: ma questa per esser tale deve non eccedere le forze di chi la esercita; la scelta e il modo col quale si fanno i beneficii servono mirabilmente o a dar loro od a scemarne il pregio; e l’uomo che ha veramente giudizio è colui il quale sa godere de’ piaceri attuali senza pregiudicare ai piaceri a venire.
P. [Pietro Verri]
[Ai lettori]
Ci vengono indirizzate diverse lettere, le quali noi volontieri consegniamo al pubblico; e sono le seguenti.
Scrittori del Caffè.
Affé di mio, che passar buono non possovi quel vostro gli autori di lingua malmenare, e che po’ po’, scrittori miei, mi fareste da’ gangheri uscire. Villani, Casa, Caro mai sempre furono per maestri dello stile considerati: che sgangherata loica è mai la vostra! Oppenione tengo fermissima che questo svarion madornale vedrete tosto che le traveggole dagli occhi vi sian tolte, giacché né voi sète per anco cisposi vegliardi, sicché di vostro cambiamento disperar debba, né ottusa la mente credovi, per modo onde pan per focaccia o lucciole per lanterne prender vi aggradi.
Autori del foglio.
Io sono un signore che ho sei cavalli, due belle carrozze, tre cocchieri, due servitori, un lacchè, tre mila scudi d’entrata, che non pago i miei debiti, che non so cosa fare della mia vita; però mi diverto qualche volta al dopo-pranzo a leggere qualche brochure francese, e mi piacciono i letterati, perché mi fanno ridere; se volete la mia amicizia, io son pronto a concedervela, con che però non iscriviate più su il commercio della nobiltà, come avete fatto; perché né mio padre, né mio avolo, né il mio bisavo hanno mai fatta una simile corbelleria; né io voglio essere disturbato nel mio quieto vivere. Vivere e lasciar vivere è un bel proverbio.
Autori del Caffè.
I vostri fogli li leggo, e tratto tratto v’è del buono; ma se foste un po’ più sodi, e che trattaste seriamente le materie, senza frammescolarvi tante cosuzze da ridere, mi piacerebbero molto più.
Compositori del Caffè.
Un incognito vi dà un parere da amico. Io lodo molto i vostri fogli, e ne ho letto alcuno; ma per dirvela ogni giorno più andate diventando seri; vi vuole qualche cosa di più ameno, qualche cosa che risvegli, e allora sarò contento pienamente di voi.
Scrittori del foglio.
Vorrei che ne’ vostri scritti toccaste un po’ più il costume di quello che non fate; le cognizioni delle lettere sono una buona cosa, ma non è fatta per la moltitudine, laddove che ogni uomo ha i suoi costumi, e molto vasto è il campo da coltivarsi. Vi do questo suggerimento perché vorrei che il vostro foglio mi piacesse ancora di più.
Caffettieri.
Quel vostro tartassare il costume non mi quadra; ognuno deve spendere i suoi quattrini come vuole, pensare e parlare come gli torna comodo e vivere a suo talento, senza che c’entri né il caffè, né il the a disturbargli la pace. Gli scritti sono fatti per le scienze, scrivete di scienza, che va bene; ma lasciate vivere gli uomini come vogliono. Questo avviso ve lo do perché vorrei che il foglio vostro fosse senza difetti. Addio.
Signori del Caffè.
Il foglio va bene, e mi rallegro dell’accoglimento che trovate presso il pubblico; ma se i pezzi che v’inserite fossero un po’ più brevi e variati, credetemi, trovereste ancora che piacerebbe più.
Amici miei.
Se vi fisserete per massima di fare che ogni foglio contenga un discorso solo, senza tante spezzature, e un discorso più lungo e più dottrinale, vedrete che avrete più approvazione. Ve lo suggerisco per buon cuore. State sani.
Questi diversi suggerimenti hanno primieramente il merito di essere brevi, e perciò ne ringraziamo gli autori, ai quali anche promettiamo di volerci seriamente occupare per renderli contenti de’ nostri lavori e consolarli tutti.
In vista di ciò, ognuno de’ nostri lettori potrà formarsi un’idea dello stato di chi intraprenda a scrivere; e certamente ogni lettore conoscerà facilmente quanto sia più comoda e facil cosa il leggere un foglio stampato e darne il suo giudizio, che non il prepararlo per la stampa ed ascoltarne i vari giudizi. È stata sin ora nostra cura di variare le materie in guisa che in ogni foglio vi si trovasse qualche porzione di serio ragionamento e qualch’altra porzione di cose giocose; e da questa norma non ci allontaneremo nemmeno in avvenire, sempre pronti a ricevere gli avvisi di sì fatti corrispondenti ed a farne tutto il caso ch’essi meritano.
IL CAFFÈ )( Fogl. XXX )(
Anecdoto chinese
Convien dire, amici, che le idee e le opinioni chinesi sieno tanto diverse dalle idee ed opinioni nostre, quanto lo sono il colore ed i lineamenti del volto de’ rispettivi abitatori. Leggeva l’altro dì la traduzione d’un certo libro chinese intitolato Lungya, titolo che nel nostro linguaggio equivalerebbe a quello di Conferenze. Contiene questo le principali azioni e sentimenti del gran Con-fut-ze e de’ suoi discepoli, stati raccolti e commentati da uno di que’ letterati, e che noi chiamare con ragione potressimo Anecdoti chinesi o con-fut-zesi. Sono tutti egualmente autentici, sublimi ed interessanti, ed a differenza di moltissimi altri che si conservano scrupolosamente fra noi, meritavano certamente d’essere tramandati alla posterità. Malgrado però la prevenzione per quel grand’uomo e legislatore, e malgrado ch’io procurassi di starmi ben bene in guardia contro i giudizi, che dettar talvolta mi potessero gli usi del mio paese, convien ch’io il dica, uno ne incontrai, che mi parve assai singolare, e mi fé molto dubitare della bontà e della sussistenza de’ suoi principii. Eccovelo fedelmente ricopiato dal manoscritto statomi confidato da certo viaggiatore, che ben lo credo degno delle vostre riflessioni.
Nel tempo che Con-fut-ze governava qual viceré una delle principali provincie del Regno di Zù (presentemente Xantung) morì nella capitale un uomo assai ricco per nome Chiug-y, al quale (non lasciando dopo di sé né figli, né nipoti, né parenti entro un certo grado) cadde in pensiero di disporre per testamento della pingue sua eredità a benefizio delle povere famiglie del suo quartiere, incaricando a’ deputati da lui costituiti all’amministrazione della sostanza che ogni settimana dovessero far distribuire a quelle che riconoscessero avere i necessari requisiti tanto riso, farina e legumi quanto bastasse per il di loro sostentamento. Fece gran fracasso nella città questa disposizione, e non saziavasi il volgo d’alzar fino alle stelle una sì saggia, sì salutare, sì pia risoluzione. Il solo viceré, Con-fut-ze solo, che non s’arrestava all’apparenza delle cose, e ben prevedeva le pessime conseguenze che ne sarebbono venute se si fosse lasciato un libero corso ad una simile introduzione, contro la comune aspettazione avvocò a sé la cognizione di detto testamento, e dopo maturo esame lo dichiarò con un ragionato editto nullo e di nessun vigore, come contrario ad un’antica legge del regno, la quale, per impedire il politico ristagno, proibiva a qualunque società che non fosse una famiglia di poter far acquisto di beni stabili: legge che fino a quel giorno non erasi da’ tribunali chinesi estesa che alle sole compre; quasi che non fossero egualmente reali e veri acquisti que’ che si facevano per via di testamenti, e non ne fossero egualmente perniciosi, sebben più tardi e lenti, gli effetti. E poiché, come si disse di sopra, non esistevano parenti entro un certo grado, applicò egli col detto editto la metà della sostanza agli artefici e fabbricatori d’una nuova manifattura di porcellane, da lui di fresco introdotta con grand’utile di quel distretto, e l’altra metà al pubblico, che oltre agli ordinari tributi soffriva un notabile annuo sopracarico pe’ debiti da’ quali era sommamente aggravato.
Di fatti, siegue il commentatore, se non v’ha male più difficile a sradicare di quello che porti l’apparenza e l’opinione di bene, e se i pregiudizi volgari sono sempre difficili a distruggersi, tutto che contrari alla stessa umanità, quanto sarebbe mai stata contagiosa e pericolosa l’aura di questi applausi popolari presso coloro che o si lasciano abbagliare da uno spirito di poca rischiarata compassione, o credono di protrarre una mal intesa ambizione al di là de’ confini prescritti dalla natura? E qual funesto abuso non sarebbesi potuto fare di questo pubblico fermento e falsa opinione, inducendo scaltramente i più deboli a disporre de’ loro beni a pregiudizio de’ loro congiunti, e per oggetti, quanto all’interesse di alcuni, vantaggiosi, altrettanto al vero spirito della società perniciosi ed opposti? Alle quali considerazioni e riflessioni questo pure si potrebbe aggiungere, che la facilità agli amministratori di queste sostanze d’abusare del prodotto, o rivolgendolo a proprio profitto od a fini molto diversi da quelli voluti da’ testatori, avrebbe forse servito per facilitare ed accellerare la corrutela de’ costumi della nazione.
Ma si prescinda da tutto questo: non è egli vero che se si levi agli uomini l’emulazione ed il bisogno voi li vedete tosto precipitati in una totale indolenza e privi d’ogni principio d’attività e d’industria? Essa va sempre del pari colla difficoltà di procacciarsi una sussistenza; e perciò vediamo gli abitatori de’ paesi freddi, montuosi ed ingrati molto più industriosi e dediti al travaglio di que’ de’ paesi caldi e naturalmente fertili ed abbondanti. Non è già che la natura abbia inegualmente distribuito il dono dell’industria, ma perché vuol essere la necessità che lo faccia schiudere e sviluppare.
Pur troppo per se stesso tende l’uomo all’inerzia, ed havvene pur troppo di sì vili che aman meglio accattarsi il pane che di guadagnarselo con una onorata fatica. Chi dunque soccorre gli uomini quando o per malore, o per l’età, o per qualunque altra cagione non possono per se stessi procurarsi un sostentamento, serve alla di loro conservazione e fa cosa molto utile e virtuosa; poiché io non son già del parere di coloro che vorrebbono che in luogo di fabbricar ospitali si cercasse di rendere tutti i cittadini sì agiati che nessuno ne avesse bisogno: cosa da desiderarsi piuttosto che da sperarsi; ma chi procura ai cittadini una sussistenza gratuita ed indipendente dalla fatica rende agli uomini stessi ed alla sua patria un molto cattivo servigio col fomentare l’ozio e l’indolenza, e collo sminuire in proporzione la massa del travaglio della nazione, nella quale poi in sostanza consiste tutta la vera ricchezza d’uno Stato.
E che ciò sia veramente, figurisi per un momento un popolo, il quale contasse entro i propri confini tante miniere, e sì abbondanti d’oro e d’argento, che non avesse ciascun individuo che a volerne per procacciarsene. Che diverrebbe alla fine di questa nazione? Potendo ella sussistere senza travaglio col provvedersi dal forastiero di quanto fosse necessario alla vita, al piacere ed al lusso, si spopolarebbono poco a poco le campagne, l’agricoltura, l’arti e le manifatture andrebbono in abbandono, di modo che per necessaria conseguenza tutto l’oro delle miniere andrebbe di mano in mano a colare in potere ed in profitto delle altre nazioni; dal che ne verrebbe che mancando finalmente col tempo e per qualch’altro accidente il prodotto delle miniere, la miseria e la spopolazione succederebbe all’indolenza ed alla ricchezza immaginaria de’ metalli, e da uno stato in apparenza florido e vigoroso passerebbe di slancio ad un’estrema debolezza ed abbattimento. Or questi appunto sono, sebbene più in grande, i perniciosi effetti della precaria sussistenza che procurerebbono agli uomini queste istituzioni. Di fatti e qual è quell’artefice che (con grave pregiudizio delle manifatture) o non cercasse un accrescimento di salario, o non abbandonasse, o non rallentasse il suo travaglio in proporzione di quel ch’egli potesse ritrarne pel proprio sostentamento? Ch’egli non lo riassumerà, certamente l’esperienza lo fa vedere qualora anche i primi soccorsi gli venissero a mancare; ed ecco per conseguenza come per prevenire la povertà noi verressimo così a moltiplicarla. L’esempio dell’isola a noi vicina (naturalmente il Giappone), nella quale si soffrono e dove pur troppo la miseria e la mendicità assediano alle porte, nelle strade e perfino ne’ tempii, ce ne può bastantemente convincere.
La povertà, o dirò meglio la mendicità, è un insetto che s’attacca alla ricchezza e si moltiplica in proporzione della sussistenza ch’ella trova mettendola a contribuzione, di modo che io sono di costante parere che se si potessero in un giorno solo togliere dal commercio tutti i poveri d’una città coll’assicurarne la sussistenza, questo non servirebbe che per far luogo ad un egual numero che fra non molto sottentrerebbe a rimpiazzare i primi.
Lungi dunque dal procurare agli uomini questa gratuita sussistenza, le massime d’una sana politica consigliano piuttosto di non toglierli dalla necessità di vivere colla fatica, e di lasciar sempre loro un incessante sprone all’industria. Il riempiere i granai de’ particolari e dispensarli dal travaglio non è quel che convenga, e basta il tener loro l’abbondanza talmente in vista che per vivere la fatica sia sempre necessaria, non mai inutile.
Né sembri contraditorio a quanto fin qui si disse l’aver Con-fut-ze applicata in seguito la metà della sostanza agli operai della nuova fabbrica, poiché se nel primo caso, come abbiam visto, sarebbe stato un mettere il premio all’ozio, all’indolenza e conseguentemente alla miseria, tutt’all’opposto nel caso nostro egli è un proporlo all’attività ed alla fatica, costringendo, per dir così, a divenire artefice per godere di questo partaggio, e mettendo al tempo stesso il padrone della fabbrica in grado di sminuire piuttosto che di accrescere i salari colla sicurezza degli indiretti vantaggi a quella annessi; ciò che in certa maniera verrebbe altresì ad opporsi ai cattivi effetti del soverchio accrescimento de’ metalli, che accrescendo in proporzione il prezzo d’ogni cosa, mette le nazioni più povere in istato di escluderci col buon mercato della di loro concorrenza.
Siccome poi non basta ad uno Stato d’avere nel proprio seno un popolo attivo ed industrioso, quando all’attività ed all’industria manchi il necessario incoraggimento pel difetto d’una proporzionata consumazione, ciò che d’ordinario succede o per la cattiva ed ineguale distribuzione de’ carichi, o molto più perché i carichi stessi eccedono la proporzione della massa circolante, quinci fu che per riparare in qualche parte anche a questo ultimo inconveniente applicò egli in seguito, come si disse, l’altra metà di detta sostanza ad estinzione de’ pubblici debiti, che formavano una gran parte delle eccessive gravezze che si pagavano da quella provincia. Non v’ha dubbio di fatti che se un pubblico ha grossi debiti, il sopracarico che ne risente e che opprime il proprietario de’ fondi si comunica indispensabilmente al coltivatore ed all’artefice, che vedonsi miseramente languire, laddove quando un pubblico non è sbilanciato, l’agevolezza del primo si spande egualmente su tutti gli altri, la circolazione s’accresce, il commercio interno ed esterno prende un nuovo vigore, che sostiene e ravviva l’ arti e le manifatture. Qual miglior maniera adunque a chi desideri il pubblico bene e di promoverlo efficacemente, che quella di disporre piuttosto delle proprie sostanze a sconto dei debiti della sua patria? Qual cosa più degna d’un uomo cittadino? Quai tempi, quai circostanze più bisognose che una massima sì nobile, sì giusta prenda piede nell’animo di molti? E perché non seguiremo noi quanto la ragione consiglia ed il nostro gran legislatore e maestro ci additò coll’esempio? Se ciò succede, noi vedremo crescere l’industria e popolarsi i borghi e le campagne, invece di veder moltiplicate le razze degli uomini inutili: che quel governo deve dirsi il migliore dove ve n’abbia e soffra il minor numero.
Fin qui il commentatore chinese, il quale a dirvela schietta, parmi quando lo leggo che tanto dica delle ragioni belle e buone, e quasi mi persuada; ma quando poi vedo la maggior parte degli uomini co’ quali vivo dire, pensare ed operare tutt’all’opposto, allora, io non saprei, mi lascio nuovamente trasportare dalla corrente e torno a dubitare.
S. [Pietro Secchi]
I tre seccatori
L’occupazione di scrivere, e singolarmente di scrivere un’opera periodica, pare molto geniale e graziosa, e certamente v’è qualche cosa che non è volgare nel piacere di vedersi in un regolato carteggio colla specie umana, vedere che un buon numero di persone crede le cose che scrivete degne dell’incomodo di leggerle, poter comunicare ai vostri cittadini con somma facilità le idee che vi occorre di comunicar loro, addossarsi una certa qual magistratura di ragione che sottrae la vostra vita e i pensieri vostri dalla oscurità, ottenere in somma l’approvazione di quei che più si stimano e qualche meschina cicalata da qualche rettile scrittore, contrassegni tutti di buon augurio. Chiunque da quest’aspetto mirerà l’occupazione nostra, dovrà persuadersi che realmente abbiamo trovato il modo di passar bene molte ore della nostra vita, e ve l’accordo. Ma le cose di questo mondo hanno sempre due manichi, diceva un antico filosofo, e, per dirla, aveva molta ragione. Ogni situazione ha le sue traversie, e gli scrittori del Caffè hanno anch’essi le lor buone seccature quanto ogni altro essere di questo mondo; e se io questa mattina ho dovuto soffrirne alcune in grazia de’ miei lettori, ogni ragion vuole ch’io non trattenga quel ch’è d’altri, e le trasmetta a’ miei lettori sane e intatte quali mi sono state confidate.
Questa mattina dunque era il solo tempo che mi rimaneva per riempiere questo foglio, l’editore me ne faceva istanza, io lo aveva già promesso, ed aveva già incominciate alcune righe su un argomento che mi costava fatica. Appena un mezzo quarto d’ora era trascorso dacché aveva intrapreso a scrivere, che mi vien detto che un certo abate aveva somma premura di parlarmi. L’urbanità non consente di ricusare gli abati che hanno somma premura. Venga il signor abate. Eccoti il signor abate lindo, fresco, bel parrucchino, bella riverenza, il qual comincia a domandarmi come io stia di salute. To’ to’, diss’io fra me stesso, che sia un medico costui? Poi, la cosa parendomi troppo strana, gli chiesi del suo nome. Sono il Tal de’ Tali. Benissimo; in che posso obbedire il signor Tal de’ Tali? Il piacere, mi rispose, di conoscere personalmente uno de’ scrittori del Caffè mi ha condotto da lei. Oh per dieci, che bel foglio! Le assicuro ch’io non le potrei ben ridire quanto mi piaccia! Quante belle cose ha detto del Goldoni, ma sopratutto quel bel titolo di probocomico che le ha dato, mi piace estremamente. Probocomico! Non si poteva dir meglio: il nostro probocomico! Signor Tal de’ Tali, gli diss’io, le sono veramente molto obbligato per l’ufficio gentile ch’ella vuol far meco, ma egualmente dispiacemi che Vossignoria trovi sì ben adattato un vocabolo trascorso per puro errore di stampa: protocomico dovea dire, cioè primo comico dell’Italia, giacché questa lode ben si merita fralle altre il nostro signor Goldoni; ma probocomico, dandolo per distintivo al signor Goldoni, sarebbe stata un’offesa agli altri scrittori comici, i quali se non sono da paragonarsi a lui a parer mio nell’arte del teatro, possono nulladimeno pretendere il titolo di probità al pari d’ogni altro… Ma pure quel probocomico io lo credea, soggiunse l’abate… Signor no, gli diss’io, pare a lei che tornasse a conto di grecheggiar in tal guisa con due parole ambo italiane per dire probocomico? Signor abate, la maggior parte de’ nostri lettori ha inteso sin da che si distribuì quel foglio quinto che v’era errore di stampa; così quel nodaro in vece di notaio, così alcuni altri, i quali sono sempre inevitabili quando gli autori sono lontani delle miglia dalla stamperia. Benissimo, soggiunse l’abate, ella dice bene. E di novità di mondo non ne abbiamo nessuna? Nessuna ch’io sappia. Abbiamo una bella stagione per verità. Bella assai veramente. E il signore se ne sta sempre così la mattina in sua casa, sempre allo studio, sempre faticando? E Vossignoria, signor Tal de’ Tali, la mattina se ne va sempre in giro a visitar le persone? Non vorrei esserle di disturbo. Oh di disturbo! non è possibile, ma veramente ho qualche cosa da fare. Giacché dunque non son di disturbo, mi sarà permesso profittare del vantaggio che ho di essere seco. Oh padrone… Oh signore… In verità… L’assicuro… Son così obbligato… Tanto gentile… Anzi lei… Vossignoria dunque, a quel che vedo, vive il verno nella stuffa? Signor sì, com’ella vede. E non ne soffre? Non signore. E può scrivere e pensare in quest’ambiente? Signor sì, alla meglio. Per altro il calore è assai sensibile. Io feci motto al servitore perché accrescesse il fuoco, e frattanto ripetei due o tre volte inutilmente al signor abate che avevo qualche lavoro per le mani da sbrigare. Il calor crebbe, io vidi dopo un’ora le vaghe luci del signor Tal de’ Tali brillanti come quelle d’un ubbriaco, e il bel color porporino del suo volto accrescersi per gradi: vedrem, dicea fra me stesso, chi di noi due la vince. Finalmente dopo una serie d’inezie non ne poté più, e congedossi maravigliatissimo come io regga ad un’aria sì calda.
Appena fui solo, che benedissi e padre e madre e tutti gli ascendenti miei che mi hanno trasmesso in corpo un sangue che somiglia un poco a quello delle salamandre e che regge al caldo più degli altri. Ripresi la penna e le interrotte idee… Eccoti un nuovo annunzio. Il figlio del legnaiuolo di casa che ha una grazia da chiedermi, che prega, che supplica, che in due parole si sbriga. Povero uomo, sarà qualche bisogno, qualche occasione da far del bene; venga il figlio del legnaiuolo. Signore, convien sapere che mio padre Giacomo, che ha fatto il tetto della tal casa, e le finestre della tale stanza, e così Giacomo non ha voluto l’anno passato essere assistente della Confraternità de’ legnaiuoli, perché Steffano suo cognato aveva detto che nell’amministrazione delle limosine della Confraternità volevasi mettere un nuovo regolamento, e perciò Lucia sua moglie, che viene ad essere poi mia zia, perché è moglie del fratello di mio padre, e così Giacomo non ha voluto essere assistente. In questo mentre Antonio, che era fratello di Lucia, perché avendo saputa la gran bontà di Vossignoria… Con questo limpido ragionamento proseguì per un mezzo quarto d’ora senza ch’io potessi intendere che diamine si volesse dire. In fine, dopo molta fatica, il risultato di tutta questa bella spedizione era che il padre di costui era prefetto della Confraternità, che si dovea fare un officio generale de’ morti, e che voleva ch’io gli facessi l’onore, la grazia, la gloria di fargli un sonetto per i morti legnaiuoli. Figuratevi, son già alcuni anni ch’io non faccio più il cigno, e mi pare che a far la parte da uomo sul teatro di questa vita sia abbastanza. E poi salire in Elicona per i legnaiuoli! E poi fare un sonetto! Via, fanciul mio, prendi questo scudo, vanne dal Tale, digli da mia parte che ti faccia un sonetto colla coda, saluta tuo padre e sta con Dio. Ma signore… noi volevamo aver qualche cosa del suo; perché il priore e l’assistente… per far vedere che almeno se serviamo la casa, potiamo far capitale della protezione… Lasciami in pace, fanciullo, per amor del Cielo, credimi che dandoti uno scudo ti do maggior prova di benevolenza che se ti dassi un sonetto. Addio… Sono mortificato… E perché mortificato! Va, quando tu pigli moglie ti darò una dote, lascia fare; non sei contento? Poiché così ella vuole… Addio, addio; raccomanda a tuo padre che si sbrighi a portarmi il mio armario.
Lodato il Cielo, eccomi liberato anche dal sonetto: rimangono due ore, e in queste due ore voglio assolutamente star solo a terminare il mio foglio. Mentre sto facendo questo bel proposito… Signore, è qui un italiano venuto da Germania, che ha commissione del Tale di visitarlo. Il Tale è mio intimo amico! Non vuo’ differire ad averne sue nuove. Venga l’italiano. Servitor divotissimo. Padron mio. Io ho ordine dal signor Tale di visitare Vossignoria. Che fa il mio rispettabile, il mio caro amico? Bene. Gli chiedo de’ suoi affari, della sua famiglia, e sin qui andò bene, se non che mi ferì l’orecchio il pasticcio che il mio italiano faceva intrudendo le parole o le frasi tedesche nella lingua nostra. Gots Tausend! Che caldo fa in questa stanza! A proposito; m’è stato detto che Vossignoria è un uomo studiato. Oh Vossignoria non creda a queste ciarle, gli rispos’io, sono un uomo come gli altri, so leggere e scrivere, e qualche volta mi diverto con qualche libro. Che libri ha letto lei? Le dirò, ho letto il Caloandro fedele, ho letto Guerin Meschino e la Frusta Letteraria. Buone cose, buone cose, oh mi rallegro: anch’io in mia gioventù mi son dilettato molto di studio, e particolarmente di magia bianca. Bravissimo, bello studio la magia bianca! Oh bello assai. Per esempio, come farebbe Vossignoria a far andar per aria un uovo senza toccarlo? Il problema per verità è difficile. Problema! No, non c’entra problema, non fa bisogno di nessuna droga; dirò io: faccia un buco nell’uovo, poi prenda un cannellino e succi tutto l’uovo, sicché non ne rimanga che il guscio: intende? Intendo benissimo. Bene; poi prenda una spugna, e la mattina di buon’ora vada in un prato, e giri la spugna sull’erba: Vossignoria sa bene cos’è la ruggiada? Sì, sì, so cos’è. Bene, la ruggiada entra nella spugna, intende? Ottimamente. Bene, quando la spugna sia bene inzuppata di ruggiada, faccia entrar quella ruggiada nell’uovo e riempiuto ch’ei sia ne turi il foro con un po’ di cera, intende? Intendo. Esponga quel uovo ai raggi del sole, i raggi del sole attragon la ruggiada, e non potendo la ruggiada uscir dall’uovo, perché l’uovo è chiuso… intende? Vada pure. Bene, non potendo la ruggiada uscir dall’uovo, perché l’uovo è chiuso, innalza il sole l’uovo poco a poco a vista d’occhio… E l’ovo va a fare una frittata nel sole, non è vero?, diss’io. Non so poi dove vada a finire, ma so che va in aria e l’ho veduto più volte. Vossignoria l’ha veduto? Signor sì, io, io l’ho veduto, e fatto più volte. Me ne rallegro assai, soggiunsi io; ma dica, di grazia, e Vossignoria, dopo aver fatti sì prodigiosi progressi nella magia bianca, s’è poi arrestato sul più bello in tal guisa, e non ha pensato seriamente a volare? A volare io non ho pensato, perché mi pare cosa impossibile. Adagio, signore, ripresi io, possibilissimo. Vossignoria a digiuno si beva due o tre pinte di ruggiada, intende? Indi col suo bel ventre scoperto si presenti ai raggi del sole, intende? Il ventre essendo chiuso, e la ruggiada dovendo salire, si sentirà tratto in alto per l’ombilico dal sole istesso, e con un po’ d’industria potrà trasportarsi dove vuole per l’aria, intende? Oh oh, curiosa cosa! mi soggiunse l’italiano; mi pare che Vossignoria abbia studiato poco assai. Se gliel’ho detto sin dal principio ch’io so leggere e scrivere, e non pretendo di più, intende? Vossignoria perché replica quell’intende? Pare che voglia dir ch’io parli male. Vossignoria ha preso il cioccolatte questa mattina? Signor no. Eh; il cioccolatte al signore! E così verso l’ora del pranzo prese egli il suo cioccolatte, e se ne andò quando al Ciel piacque, lasciandomi il capo pieno di seccature potentissime, le quali, ora che le ho consegnate al mio caro lettore, mi sento assai sollevato.
Da questa sincera relazione ognuno potrà intendere facilmente che anche il mestiere di scrittore del Caffè ha i suoi mali, e che gli oziosi sono un flagello continuo di chi coltiva le lettere, qualora non si determini robustamente a rompere ogni lega con essi, a costo di lasciar dire tutto il male che sanno e possono, cosa che non manca mai in simil caso.
P. [Pietro Verri]
IL CAFFÈ )( Fogl. XXXI )(
[Estratto del Trattato astronomico del signor de La Lande]
Quantunque l’istituto de’ fogli nostri non sia di annunziare le novelle della repubblica delle lettere, né di dare gli estratti dei libri che compaiono alla luce; con tutto ciò, per una volta ci facciamo lecito di trasgredire le leggi prescritteci. Il viaggio d’Italia che il celebre signor de La Lande sta per fare e il merito dell’opera ch’egli ultimamente ha data alle stampe faranno ricevere di buon grado la notizia che siamo per darne, e speriamo che sia per dare tanto piacere ai lettori nostri, quanto lo ha dato a noi, la lettura di questo breve estratto trasmessoci da uno de’ più ragguardevoli letterati d’Europa. Il titolo del libro è il seguente:
Trattato compito d’astronomia teorica e pratica, che contiene delle nuove tavole astronomiche, due volumi in 4° di più di 800 pagine per uno, con 36 tavole in taglio dolce di Monsieur de La Lande, Consigliere del Re, Lettore Reale di matematica, Censor Reale, membro dell’Accademia Reale delle Scienze di Parigi, della Società Reale di Londra, dell’Accademia delle Arti stabilita in Inghilterra, della Accademia Reale di Petersburg, dell’Accademia Reale delle Scienze e Belle Lettere di Prussia, di quella di Gottinga, dell’Istituto di Bologna, delle Accademie di Lione, di Roano, di Digion, di Caen, di Auxerre. A Parigi per Desaint e Saillant 1764.
L’astronomia è forse la sola scienza di cui non si ha ancora verun trattato compito. La Francia, l’Inghilterra, l’Alemagna non hanno prodotto fin ora che libri puramente elementari o delle opere particolari su alcune parti di questa scienza. Monsieur de La Lande ha intrapreso di trattare l’astronomia in tutta la sua estensione, senza trascurare alcuna delle parti di questa vasta scienza, e in maniera di dispensare i curiosi da ogni altro libro d’astronomia.
Si legge alla testa del primo volume una prefazione lunghissima, destinata a far conoscere il piano di tutta l’opera e la maniera con cui deve essere letta da quelli che vogliono intraprendere uno studio serio della astronomia. Vi si vede in appresso un dettaglio curioso sulla preminenza e i vantaggi della astronomia, sulli differenti oggetti a’ quali essa si applica, sulla stima che ne hanno avuta i più gran principi, sugli onori resi agli astronomi celebri. Vi si trovano gli elogi che i più gran filosofi e i poeti più famosi hanno dati a questa scienza; gli stabilimenti che hanno servito a’ suoi progressi, il catalogo di tutti gli osservatorii che hanno esistito o che esistono attualmente. Questa prefazione finisce col catalogo de’ valori o prezzi de’ canocchiali, telescopi, quadranti o altri stromenti di astronomia che si lavorano in Francia e in Inghilterra.
Il corpo dell’opera è diviso in ventiquattro libri, independentemente dalle tavole astronomiche: il primo libro contiene gli elementi della sfera, o i primi principii dell’astronomia spiegati in una maniera altrettanto nuova quanto luminosa. Monsieur de La Lande suppone una persona che per la prima volta in una bella notte alza gli occhi al cielo per contemplarne lo spettacolo; cerca quali saranno i primi oggetti che faranno impressione negli occhi dello spettatore, i primi astri ch’egli noterà, i primi fenomeni che se gli presenteranno. Monsieur de La Lande parte di là per isviluppare a poco a poco le prime conseguenze che un uomo di spirito può tirare da ciò che ha veduto; segue al fine le traccie di que’ primi pastori della Caldea che furono i primi inventori dell’astronomia, e conducendo il suo lettore a passo a passo, l’aiuta a scoprire tutto quello che gli antichi osservatori non riconobbero che dopo più secoli di osservazioni; fa vedere la necessità d’immaginare alcuni circoli, alcune figure nel cielo, di dar loro de’ nomi, di rappresentarli su i globi e sulle sfere, e di far uso di questi istromenti.
Il secondo libro contiene l’origine dell’astronomia e i suoi progressi presso tutti i popoli del mondo, l’istoria degli astronomi i più famosi, come d’Ipparco, Tolomeo, Copernico, Ticone, Keplero, Cassini, Flamestedio, Ugenio, de la Caille ec., la loro vita, le loro scoperte, le loro opere e il catalogo di tutti gli astronomi che son vissuti e sono morti fino all’anno 1764.
Il terzo libro è una descrizione del cielo stellato e delle costellazioni: vi si vedono i diversi nomi di ogni costellazione, l’origine di questi nomi, il numero delle stelle che compongono ciascuna di esse, i passi de’ poeti che ne hanno parlato. Monsieur de La Lande dà un metodo facile per conoscere ancora senza maestro, senza globi, senza figure o carte celesti tutte le costellazioni, partendo da quella d’Orione, che è la più rimarchevole di tutte. Questo libro si termina col dettaglio di tutte le stelle nuove, variabili, doppie, nebulose, o che hanno alcuna cosa di singolare.
Il quarto libro contiene i fondamenti essenziali di tutta l’astronomia, o le ricerche principali da cui tutte le altre dipendono, come sono la determinazione esatta del luogo del Sole e di una stella, l’osservazione degli equinozi e de’ solstizi, la misura del tempo, il calcolo dell’astronomia sferica, cioè a dire del levare e del tramontare degli astri, de’ lor passaggi pel meridiano, alfine di tutto ciò che appartiene all’astronomia in generale, e che è necessario per l’intelligenza de’ trattati seguenti.
Il quinto libro tratta de’ sistemi di Tolomeo, di Ticone, di Copernico. Monsieur de La Lande dimostra l’evidenza di questo, e risponde a settantasette argomenti del padre Riccioli contro il moto della Terra.
Il sesto libro contiene l’astronomia planetaria, la maniera con cui sono state trovate le rivoluzioni de’ cinque pianeti, la figura delle loro orbite, le loro distanze, i loro diametri e tutti gli elementi de’ cinque pianeti, cioè a dire di Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno, co’ risultati de’ differenti autori.
Il settimo libro tratta del moto della Luna, delle sue fasi, delle sue inegualità, delle tavole che ne sono fatte, di tutte le circostanze che sono particolari a questo pianeta.
L’ottavo libro contiene la spiegazione del calendario antico e moderno, degli anni, de’ cicli, de’ periodi, delle epoche, della cronologia e dell’uso che vi si fa della astronomia.
Il nono libro tratta delle parallassi e di tutti i calcoli che ne dipendono, per esempio de’ metodi curiosi co’ quali si determina la distanza de’ pianeti: vi si dimostra che la Luna è a 90 mila leghe da noi, il Sole a 33 milioni ec.
Il decimo libro contiene il calcolo degli ecclissi della Luna, degli ecclissi del Sole, degli ecclissi delle stelle, tutti i metodi che si sono immaginati per predirli esattamente sono dettagliati in questo libro, e monsieur de La Lande dà un nuovo metodo più semplice e più esatto di tutti quelli che si avevano fino ad ora.
L’undecimo libro comincia il secondo volume dell’opera. Questo è un trattato compito de’ passaggi di Mercurio e di Venere sotto il Sole, de’ calcoli che se ne sono fatti, delle conseguenze che se ne tirano: vi si vede sopratutto l’importanza del passaggio di Venere sotto il Sole, che si aspetta per l’anno 1769 e che deve insegnarci con una precisione più grande che non si è avuta fin ora la distanza del Sole e di tutti i pianeti dalla Terra.
Il duodecimo libro ha per oggetto la refrazione astronomica, o lo storcimento de’ raggi della luce nel passare per l’atmosfera, effetto che influisce su tutte le osservazioni astronomiche.
Il decimoterzo libro è una descrizione ampissima e sommamente dettagliata di tutti gli istromenti di astronomia che sono impiegati attualmente ne’ più famosi osservatorii dell’Europa, cannocchiali, telescopi, quadranti, sestanti, settori, micrometri, istrumenti de’ passaggi, machine parallatiche, eliometri ec.; vi si vedono le loro dimensioni e le lor figure intagliate a taglio dolce.
Il decimoquarto libro contiene l’uso e la verificazione di tutti gli strumenti, cioè a dire la maniera di osservare tutte le sorte di fenomeni celesti, tutte le attenzioni che deve usarvi l’osservatore il più esatto: questo finalmente è un trattato d’astronomia pratica, fatto da un osservatore assiduo. Vi era da gran tempo il lamento del non esservi assolutamente nulla di scritto in questo genere.
Il decimo quinto libro tratta della grandezza della Terra, della figura e della sua compressione: vi si vede l’istoria di tutti i viaggi famosi che l’Accademia ha fatti fare e di tutti i volumi che sono stati pubblicati su questa materia da monsieur de la Condamine, monsieur Bouguer, monsieur de Maupertuis, dal padre Boscovich, da monsieur Clairaut, da monsieur Cassini, da monsieur de la Caille.
Il decimo sesto libro racchiude la teoria de’ movimenti apparenti che si scorgono nelle stelle fisse a motivo della precessione degli equinozi e della parallassi del grand’orbe: vi si vede l’effetto delle attrazioni de’ pianeti che mutano l’orbita della Terra, la diminuzione della obliquità della ecclitica e i movimenti straordinari che hanno avuti diverse stelle per cagioni particolari.
Il decimo settimo libro è un trattato della aberrazione e della mutazione, che sono inegualianze apparenti, nuovamente scoperte nelle stelle fisse.
Il decimo ottavo libro è l’astronomia de’ satelliti, o l’istoria de’ pianeti che girano intorno a Giove e Saturno, de’ lor movimenti, delle loro inegualità, delle loro ecclissi, delle lor tavole. Questa teoria non era ancora stata spiegata in alcun libro di astronomia.
Il decimo nono libro contiene la scienza delle comete. Monsieur de La Lande vi tratta della lor natura, delle loro apparizioni, delle loro orbite; vi dà la maniera di calcolare i loro movimenti, l’istoria di tutte quelle che hanno avuta alcuna cosa di rimarcabile, il catalogo di tutti gli elementi di quelle che sono cognite e le tavole necessarie per farne il calcolo e predirne il ritorno.
Il ventesimo libro tratta della rotazione di tutti i pianeti intorno al loro asse, del loro disco apparente, delle loro figure, delle lor macchie; vi si vede la maniera di determinare l’equator solare, di predire le fasi dell’anello di Saturno, di calcolare e di osservare la librazione della Luna, oggetti che non sono ancora trattati in alcun libro d’astronomia in una maniera che soddisfaccia.
Il ventesimo primo libro è un compendio delle sezioni coniche, del calcolo delle serie, del calcolo differenziale e integrale relativamente all’astronomia, essendo i libri ordinari che trattano di questi differenti oggetti insufficienti per l’uso di questa scienza e sopra tutto pel calcolo delle attrazioni celesti.
Il ventesimo secondo libro, uno de’ più importanti e de’ più diffusi di tutta l’opera, contiene la teoria dell’attrazione universale, la dimostrazione di questa legge, le inegualità che ne risultano. Non vi era ancora nulla di scritto su questa materia che fosse elementare e chiaro. Monsieur de La Lande ha messo il famoso problema de’ tre corpi alla portata di tutti, e perfino anche quello della precessione degli equinozi dedotta dalla attrazione, che si risguarda ancora come il più difficile di tutti, sul quale lo stesso Newton aveva sbagliato, e che forma ancora oggetto di contesa fra’ geometri.
Il ventesimo terzo libro contiene la trigonometria sferica, e perfino le dimostrazioni di trigonometria rettilinea, che non sono ne’ libri ordinari: vi si trovano pure le analogie differenziali, che sono di un grandissimo uso nella astronomia, e che per la maggior parte non erano dimostrate in alcun autore.
Il ventesimo quarto e ultimo libro è destinato pel calcolo astronomico propriamente detto: vi si impara a calcolare i movimenti celesti dalle osservazioni, a costruirne delle tavole astronomiche, a far uso di queste tavole; vi si trova la notizia de’ logaritmi, delle interpollazioni; il calcolo delle opposizioni, delle congiunzioni, de’ luoghi de’ pianeti dedotti dall’osservazione. Finalmente monsieur de La Lande vi ha aggiunte le tavole del Sole di monsieur de la Caille e quelle della Luna di monsieur Mayer, le migliori che si abbiano, alle quali egli ha fatto delle aggiunte che le rendono ancora più perfette.
È facile a vedere, dalla esposizione che noi abbiamo fatto delle materie contenute in questi ventiquattro libri, che non vi manca niente di tutto quello che si può desiderare per formar un trattato compito di astronomia. Noi finiremo coll’avvertire che questo è il frutto di quindici anni che monsieur de La Lande ha consacrato alle matematiche e specialmente alla astronomia. Fin dall’anno 1751 l’autore fu scelto dall’Accademia delle Scienze per andar a Berlino a fare delle osservazioni astronomiche, affine di determinare la distanza della Luna dalla Terra. L’anno 1759 fu scelto per comporre l’opera che l’Accademia delle Scienze pubblica ogni anno col titolo di Connoissance des mouvemens celestes: ciò basta per far conoscere l’autore.
Tale è l’estratto che abbiam creduto bene di comunicare ai lettori del nostro foglio, molti de’ quali avranno il piacere di conoscere personalmente fra poco il chiarissimo autore di quest’opera, la quale certamente resterà come un’opera classica e di grande utilità pubblica. I primi tre libri sono intelligibili ad ognuno, e piaceranno anche a chi non sia punto geometra né analista; il secondo e il terzo massimamente sono pieni d’erudizione, e tutta l’opera è corredata con immensa ricchezza di citazioni de’ migliori scrittori e della storia esatta di tutte le scoperte più interessanti. I geometri poi e gli astronomi vi troveranno bellissime notizie, metodi eccellenti e calcoli anche sublimi.
Questa uscita però, che abbiamo ora per la prima volta fatta dal proposito nostro, non dia già a credere ad alcuno che siamo noi inclinati a trasmutare il nostro foglio in un foglio novelliere letterario: noi non daremo che ben di rado, e per cagioni straordinarie, di sì fatti estratti, giacché né i La Lande sono frequenti in Europa, né dalle stampe escono sovente opere di tal natura, né gli autori che le producono intraprendono il viaggio d’Italia.
[Ruggero Boscovich]
[Lettera d’un medico polsista]
Allo scrittore P. del Caffè
Io son medico polsista; tocco dugento polsi al giorno, e ricevo due mila scudi l’anno in ricompensa de’ miei toccamenti. Quel giorno appunto in cui pubblicaste il discorso contro i polsisti ho acquistati tre clienti di più. La mia rendita è tanto più stabile quanto ch’ella ha per cauzione gli errori degli uomini. La vostra briga è tanto più difficile quanto che avete per avversari tutti coloro ai quali vorreste far del bene. Giudicate, scrittore P.: l’animal ragionevole in questo caso siete voi o lo sono io? Sin che gli uomini saranno deboli mentre sono ammalati, ossia sinché gli uomini saranno uomini, avranno tutta la docilità per chi farà sperar loro la guarigione; tutte le ragioni avranno sempre minor forza di quel principio inerente all’uomo medesimo. Questo è un pezzo d’erudizione che potreste riporre nel Caffè.
Il signor dottor Anonimo è servito. Ecco riposto nel Caffè il biglietto che mi ha trasmesso. Il signor polsista ha più buon senso di che non ne abbiano la maggior parte de’ suoi compagni: il ragionamento ch’egli fa è giustissimo a considerarlo sotto un aspetto solo. Se la commedia che noi uomini rappresentiamo su questo globo non dovesse consistere in altro che nel profittare de’ mali e delle debolezze altrui, il signor polsista avrebbe ragione, e seco lui avrebbero pur ragione tutti i curiali che rovinano i patrimoni, tutti que’ che contraggon debiti per fallire, tutti i ladri, e domestici e di strada; in una parola, non vi sarebber più principii né di religione, né di morale, né d’onestà. Due mila scudi l’anno sono un bene; ma la vergogna di guadagnarli con un mestiere o inutile o pernicioso alla società è un male. Tacio le ragioni superiori. Resta a bilanciare qual sia maggiore, se il bene o il male; e questa decisione dipende dal senso di ciascheduno. Se io dovessi fare il medico farei ogni sforzo per radunare in me tutte quelle cognizioni le quali potessero rendermi capace da sollevar dai malori gli uomini che si fidassero di me; e quel poco che io mi procacciassi col mio sapere, me lo goderei come un onorato frutto del mio talento, senza rimorsi e senza vergognarmi della mia professione in faccia a chi che sia. Chi pensa altrimenti forse ne riceverà maggior lucro; ma questo lucro deve pagarlo colla continua inquietudine di essere smascherato, colla continua sollecitudine di nascondere la propria ignoranza, colla fuga attentissima delle occasioni in cui debbasi incontrare un medico veramente tale; in somma con rimorsi, con amarezze e con un fascio di sventurate sensazioni, le quali non son mai ben pagate, qualunque sia la somma del danaro che producono. Io non ho nessuna vergogna nel dir delle verità e nello scriverle. Gl’impostori hanno sempre un crudelissimo disprezzo di loro medesimi nel fondo del cuore. L’animal ragionevole dunque credo che lo son io.
P. [Pietro Verri]
Un ignorante agli scrittori del Caffè
Io non so, per grazia del Cielo, né leggere né scrivere, ma senza saper leggere e senza saper scrivere, so però dire il fatto mio all’occasione, e se ciò sia ne giudicherete voi medesimi scrittori del Caffè alla lettura di questa carta scarabocchiata da un dottore in legge, ma composta da me, acciocché venga alle vostre mani. Voi vedete, scrittori del Caffè, ch’io al bel principio mi chiamo un ignorante; questo vi serva di prova ch’io non pretendo di fare il ciarlatano in faccia di nessuno, che dico bianco il bianco e dico nero quello che è nero, e se vi farete riflessione, forse troverete che questa mia ingenuità può meritare più stima di quella che non ne meriti l’arte di parlar con una penna d’oca.
Io adunque sono, come ho già protestato, un ignorante, cioè un uomo che non sa nulla di tutto quello ch’è stato detto, fatto o pensato dagli uomini. Il mondo è cominciato per me quarant’anni sono, desidero che termini più tardi che sia possibile, né mi curo di saper le pazzie degli uomini, le quali presso poco saranno state per lo passato sul gusto di quelle che posso vedere attualmente sotto gli occhi. Non mi curo de’ fatti altrui, e certamente i fatti degli uomini morti e seppelliti miliaia d’anni sono non mi incomoderò mai a ricercarli.
Ora che v’ho fatta la dichiarazione del mio carattere, vi devo mostrare per qual ragione io, che de’ fatti altrui non mi prendo briga, pure spenda uno scudo con questo signor dottore, acciocché scriva a voi i miei sentimenti. Sappiate dunque che per quella ragione per cui non m’impaccio nelle cose d’altri, per la medesima nemmeno soffro che altri s’impacci delle cose mie; e siccome ho inteso raccontare che voi nel vostro foglietto andate spargendo delle massime contrarie alla libertà d’essere ignorante, e cercate di fare che gli altri ridano di noi, e vorreste pure acquistarvi una indebita superiorità a spese nostre; così sono costretto a fare la generosità d’uno scudo al detto signor dottore che scrive le mie buone ragioni che ho da dirvi, acciocché voi altri scrittori del Caffè facciate una volta giudizio, e stando ne’ limiti della ragione, lasciate vivere in pace il genere umano come torna comodo a ciascuno.
Non sono molti giorni che in una conversazione si parlava di commercio (maledetto commercio, al dì d’oggi dappertutto se ne parla!). Io dunque dissi che per far fiorire il commercio vi vuol altro che de’ bei ragionamenti, vi vogliono quattrini. Un certo quondam prese a contrastare la mia proposizione, e sostenne che il commercio produce i quattrini, non i quattrini il commercio, sostenne che i molti quattrini sono un impedimento al commercio, sostenne… oh quante cose che sostenne! La mia proposizione l’aveva già detta in vita mia quarantanove volte, ed era passata per buona, ora l’ho detta per la cinquantesima volta, e tutta la compagnia si è fatta le beffe di me, ed ha approvata l’opinione di quel quondam. Quel quondam ho poi saputo che legge i fogli del Caffè.
Ieri si parlava d’ un medico. Io ho detto ch’egli poteva esser bravo medico in teorica, ma che in pratica non valeva un zero. Questa proposizione è chiara come il sole, ognuno l’ha sempre potuta dire, e certamente l’ho sempre intesa ripetere da tutti gli uomini savi. Un certo quidam: Sì, sì, disse la porta del tempio dell’Ignoranza, e si pose a sorridere, e gli altri fecero lo stesso; ed io rimasi di stucco, e seppi poi che voi altri nel Caffè avete posto in ridicolo questa opinione.
Altre volte dacché avete pubblicato quel vostro Caffè ho dovuto udire chi diceva bene del lusso, chi diceva male dei fidecommessi, chi si rideva di quel grand’uomo di Giustiniano e di Baldo e di Bartolo, chi sosteneva che in Milano ogni quattro giorni ne piove uno: in somma non si sa più come vivere in pace e dire buonamente il fatto proprio, che dappertutto andate diseminando mille opinioni, o scrittori del Caffè, che mi fanno venir la bile, e oltre allo scudo che devo per voi spendere col signor dottore, temo che ne dovrò spendere un altro col medico e collo speziale per liberarmene.
I medici non dicon male degli ammalati, i curiali non dicon male de’ litiganti; non vedo ragione perché gli uomini di lettere non facciano lo stesso con noi, tanto più poi quanto che l’ammalato crede d’aver bisogno del medico, il litigante crede d’aver bisogno del curiale, noi non crediamo d’aver bisogno dei letterati, e potiamo far loro de’ brutti scherzi. Fate giudizio. Schiavo, scrittori del Caffè.
P. [Pietro Verri]
[Opinione che debbesi tenere delle cognizioni proprie]
Io sono l’uomo più ignorante di tutti: è una proposizione questa che non la può dire con verità che un solo uomo al mondo; e quel solo che la potrebbe dire con verità non la può pensare. Chi si serve dunque di questa proposizione, dice lo stesso che umilissimo, divotissimo ed obbligatissimo servitore. Io sono l’uomo più illuminato di tutti: è una proposizione questa che non la può dire con verità che un solo uomo al mondo; e se la dicesse prima che gli altri uomini l’abbian detto, forse avrebbe le sassate. Vi sono degli uomini più ignoranti di me, vi sono degli uomini più colti di me: questa è la proposizione che devono pensare e dire tutti gli uomini dell’universo, trattine due. Se i nostri studi sono ben diretti, a misura che vi ci applichiamo, il numero dei più colti di noi va diminuendo; se i nostri studi sono mal diretti, a misura che vi ci applichiamo, il numero dei più colti di noi va crescendo. Un bambino appena nato è in uno stato di mezzo fra l’uomo ben dotto e l’uomo malamente dotto, poiché fra la verità e l’errore può dirsi che vi sia di mezzo il zero. Ogni nozione umana è sempre incerta, se non è stata preceduta dal dubbio, poi dall’esame, e il più delle volte da quella stessa traffila non ne ricavi che la probabilità. La dimostrazione non s’estende al di là della convenienza o disconvenienza delle idee. Se cerchi dalle scienze il pane, ti compiango; se cerchi dalle scienze una distrazione alla noia, ti lodo; se cerchi dalle scienze i mezzi di renderti migliore, ti onoro. Poco conoscerai le cagioni, e certamente meno di quel che gli uomini credono di conoscerle, a misura che la tua mente farà progressi. Le scienze conducono a stabilire i limiti dell’intelletto umano, e a determinare quai ricerche vi si contenghino e quali ne sian fuori.
IL CAFFÈ )( Fogl. XXXII )(
Dissertazione sugli orologi
Se non v’è cosa che all’uomo selvaggio sembri più inutile e ridicola quanto la misura del tempo, non v’è però cosa più interessante per l’uomo che vive nella società. Quegli, non d’altro occupato che degli oggetti presenti, a null’altro s’applica che alla attuale sua felicità; la fame e la sete sono ordinariamente i soli motivi che lo tolgono da quella perfetta indolenza in cui passa gran parte della sua vita, e che ben vale le frivole clamorose occupazioni dell’uomo socievole e gl’ingegnosi deliri del filosofo. Tranquillo d’animo, sano e robusto di corpo, scevero dalle passioni più violente, dopo aver saziato il puro naturale bisogno non si logora lo stomaco con cibi alterati o soverchi, né fa un fatale dispendio di spiriti nel pensare.[106] Le pochissime sue idee si succedono lentamente, né vengono di frequente eccitate dalla varia interessante mutazione degli oggetti esterni. Il tempo, che noi non sentiamo che per la più o meno pronta successione delle nostre idee, è talmente impiegato da’ selvaggi, che appena ne possono sentire il corso; lo stesso accade anche all’uomo socievole, quando ei sia seriamente affacendato; coloro, per lo contrario, che non sapendo esistere che fuori di loro medesimi, portano da una conversazione nell’altra la insopportabile noia e la faticosa loro indolenza; coloro che non hanno la moderazione del selvaggio, né i bisogni del povero, né le rissorse del letterato; que’ che ripongono il dovere d’un buon cittadino nell’esattezza di ricambiarsi le visite, d’accrescere uffici ad uffici, pe’ quali convien che dividano ad iscrupolo i minuti d’un oriuolo, che loro è indispensabile; questi devono con tanto maggior sollecitudine ricercare una giusta distribuzione d’ore, quanto che gli orologi loro porgono un inesausto campo di discorrere, e così supplire alla sterilità della loro mente.
Per fortuna l’arte di far macchine che dividano e segnino costantemente il tempo ha ricevuto dall’industria de’ moderni tutta quella perfezione di ch’ella sembra capace; poiché senza annoverare gli oriuoli rinchiusi in orecchini o in anelli,[107] e que’ che suonano non le ore sole, ma i minuti, o ad ogn’ora un delicato concerto, e que’ che marcano i giorni del mese, le feste, il giro de’ pianeti,[108] e ciò con singolare maestria, siasi per la giustezza o sia per il lavorio esteriore; senza, dico, annoverar tutto ciò e rapportare gli orologi più insigni dell’Europa,[109] parmi che ’l ritrovato dello svegliarino o dell’oriuolo a ripetizione meriti ’l più grande applauso che qualunque altra invenzione. Felice scoperta (diceva un autore[110] meno giustamente degli orologi solari), che determina il cominciamento e la durata de’ travagli dell’uomo, gli richiama in ordine gli avvenimenti passati e dirigge i suoi progetti per l’avvenire. Per la qual cosa, non disse male[111] chi asserì che se a qualche accademia di selvaggi (che per loro fortuna sanno felicemente ed onestamente vivere senza pur sapere cosa sia un’accademia o a che giovi) fosse capitato un oriuolo di repetizione, que’ dottori non avrebbero mancato d’insegnare darsi l’anima degli oriuoli, siccome quella delle bestie.
Non potevasi però dire lo stesso degli orologi degli antichi, i quali noi abbiamo in ciò come in moltissime altre cose superati coll’aiuto di molti più secoli d’osservazioni, e più ancora coll’aiuto della sagacità ed industria de’ nostri artefici. Per confermazione di ciò basti lo scorrere brevemente sui progressi che appresso le più colte nazioni ha fatto il metodo di dividere il tempo.
Osserviamo la Cina, quell’impero sì anticamente vasto e pertanto più antico, dove nacquero di buon’ora tutte le scienze, ma dove lo spirito di quella nazione non permise loro di perfezionarsi, e vedremo la divisione del giorno asserirsi dall’Ovai-Ki introdotta sotto l’imperatore Ti-hoang successore di Tiene-hoang; vedremo[112] che sotto l’imperatore Cho-hao eravi già uno stromento che marcava le ore; troveremo che ’l padre Gaubil gesuita, il primo matematico alcuni anni sono dell’Imperador della Cina,[113] ci assicura essere stato ivi in uso l’orologio solare più di 2000 anni addietro, ed antichissima esservi la divisione del giorno in ore. Ma qual fede darassi al racconto dell’Ovai-Ki, che ricorre a’ tempi e nomina imperadori che noi Europei chiamiamo favolosi? A qual perfezione fu ella portata la sì vecchia scoperta che ci riferisce il padre Gaubil? Recente però o antica siasi la divisione del giorno o l’orologio solare presso i Cinesi, era molto irregolare l’una e molto imperfetto l’altro quando v’approdarono i Gesuiti, che loro hanno, colla maniera di distrugger facilmente gli uomini per mezzo dell’artiglieria e con altri nostri lodevolissimi usi, insegnata l’esatta misura del tempo.
Gli Egizi non mancarono di fautori che loro attribuirono l’invenzione della misura dell’ombra solare, o siasi della meridiana, che è il primo passo a farsi per ritrovare l’orologio solare. Poiché trascurati anche coloro che dalla voce Horus, che appresso gli Egizi significava il Sole, ne cavano esserne essi stati gl’inventori, e que’ che rapportano la divisione del giorno in 12 ore ad un’osservazione d’Ermete Trimegisto d’un animale sacro al dio Serape, che orinava 12 volte al giorno,[114] e venendo agli
eruditi ragionatori, monsieur Goguet[115] è di parere ch’essi, i primi nella più rimota antichità, misurarono la differente lunghezza dell’ombra del meriggio con que’ stili o gnomoni[116] che la natura loro somministrava, come colle piante, cogli edifizi; quindi pensa ch’essi molto anticamente, cioè sotto il regno di Sesostri, 1640 anni circa avanti l’era volgare, abbiano ritrovati i gnomoni artificiali. Quel che sembrami strano si è che pretende che a ciò destinassero i loro obelischi, siccome usavasi al Perù, dove servivasi dell’ombra delle colonne per osservare i solstizi e gli equinozi. Mi sembra non vi fosse bisogno di tagliar pezzi di sassi sì enormi, com’erano gli obelischi, per trovar la lunghezza dell’ombra, che potevasi ben osservare colle piante e con ogn’altra cosa più comoda. Forsi dopo avere per un ridicolo fasto innalzate quelle inutili moli, se ne prevalsero col misurarne l’ombra; ma è cosa assai stravagante a mio avviso il volere che a ciò fossero destinate, massimamente quando per tal effetto era molto impropria la loro forma; e quand’anche gli Egizi v’avessero di poi aggiunto sulla cima degli obelischi una gran palla, perché le osservazioni dell’ombra fossero più esatte, come decise essersi da essi praticato l’Accademia francese delle Iscrizioni,[117] e come sotto Augusto usò Manlio nell’obelisco da lui innalzato in Campo Marzio,[118] non per questo deducesi doversi gli obelischi alla premura di misurare l’ombra del Sole.[119]
I Caldei anch’essi hanno niente meno valide ragioni all’onore di queste scoperte. Eglino, i quali vantavansi d’aver fatte osservazioni celesti per uno sterminato numero di secoli, e che certamente insegnarono a’ Greci e forse ancora agli Egizi quelle scarse e fallacci cognizioni che formavano la loro astronomia, e que’ principii di ragione che costituivano tutta la lor filosofia, hanno probabilmente i primi diviso il giorno, prendendone per principio il nascer del Sole, e fabbricati orologi solari.[120] Erodoto,[121] benché greco, dice espressamente i Greci aver imparato da’ Babilonesi il Polo, il gnomone e le dodici parti del giorno, comeché non assegni il tempo in cui feronsi queste scoperte.
Quanto può aversi di certo si è che l’orologio solare fu quasi due secoli prima conosciuto dagli Ebrei che da’ Greci, leggendosi nella Sacra Scrittura[122] che il re Achaz, padre del re Ezechia, ne fece delineare uno in Gerusalemme in luogo esposto alla vista del popolo: ritrovato che deve Achaz avere appreso da Theglath-Phalasar re d’Assiria, di cui era amico stretto.[123]
Malgrado tutto ciò, eccoti Plinio,[124] e sulla fede di lui molti autori, fra’ quali Polidoro Virgilio,[125] che sostengono doversi l’invenzione degl’orologi solari ad Anassimene di Mileto, che fiorì circa 560 anni avanti l’era volgare, e ’l primo d’essi essere da lui stato fabbricato in Sparta. Dopo Plinio venne Diogene Laerzio[126] a raccontarci doversi gli orologi a Sole ad Anassimandro maestro d’Anassimene; benché Anassimandro sia vissuto circa due secoli dopo che Achaz aveva posto l’orologio in Gerusalemme; e tutto che Erodoto, che scriveva soli 100 anni dopo Anassimandro, dovesse averne notizie più certe.
Né soltanto dubitossi dell’epoca degli orologi solari, ma insorsero molte quistioni sul loro uso, e furono agitate fra Salmasio[127] e l’eruditissimo padre Petavio.[128] Salmasio, con altri autori, taccia liberamente come falso il racconto di Plinio e di Diogene Laerzio. Vuole molto posteriore l’epoca degli orologi solari,[129] e pretende non ad altro aver essi servito anticamente che a disegnare il tempo de’ solstizi e degli equinozi, né avere i Greci avuta cognizione alcuna della divisione del giorno in ore che poco prima d’Alessandro il Grande, né tanto i Greci quanto i Romani ne’ primi quattro secoli aver diviso il giorno che in due parti, l’aurora e la sera, a cui indi s’aggiunse il meriggio, che i Romani seppero più giustamente determinare per mezzo d’un raggio solare che passava fra la tribuna delle arringhe ed un luogo chiamato greco-stasis.[130] Egli si studia in fine di per suadere che qual ora gli antichi concertavano di trovarsi ad un dato tempo alle pubbliche feste o in altri luoghi, solevano individuarlo colla lunghezza dell’ombra del loro corpo misurata co’ piedi, in modo che tanti piedi d’ombra fino al mezzo giorno o tanti dal meriggio alla sera venivano ad indicare lo stesso che tante ore di Sole sorto dall’orizzonte o tendente al tramontare.
Il padre Petavio s’oppone a Salmasio, ed incalzalo con termini sì pungenti e vili che scuoprono lo spirito contenzioso di partito: indegni termini d’un uomo colto, se non forsi quando gli mancassero ragioni. Egli sostiene essere stato noto agli antichi il partimento del giorno in ore, che non si raccogliessero già dall’ombra del corpo, ma sì bene da quella gettata da’ gnomoni, quale non occorreva misurare co’ piedi propri, poiché ell’era già marcata e distinta in piedi. Al qual proposito, oltre le molte ragioni, adduce il detto di Prassagora, uno degli attori d’una comedia d’Aristofane, che visse 400 anni avanti l’era comune: Tibi vero curae erit, quando decempedalis erit horologii umbra, unctam ad coenam proficisci. Pare in somma che Salmasio abbia torto contro Petavio, comeché sia probabile la misura dell’ombra del corpo umano aver preceduto la misura dell’ombra de’ gnomoni.
Comunque siasi, i Romani non conobbero altr’orologio solare che la fortuita meridiana già mentovata fino a dodeci anni prima della guerra di Pirro; e benché Censorino[131] confessi non saper esso trovar l’epoca dell’uso degli orologi, pure Plinio[132] attesta Lucio Papirio averne fatto delineare il primo in faccia al tempio di Quirino. Quale orologio conviene credere fosse molto imperfetto, perché l’anno di Roma 477 il console Valerio Messala ne rapportò uno da Sicilia, che fece dimenticare quello di Papirio, di cui se ne fé uso per soli 30 anni. Doveva ben essere grossolana l’ignoranza de’ Romani per credere che potesse essere regolare in Roma un solare orologio trasportato dalla Sicilia. Ignoranza però che non impedì che ’l popolo romano non fosse un seminario d’eroi e di conquistatori, la virtù e ’l coraggio de’ quali nasceva non dalla coltura delle scienze, ma dalla stessa loro legislazione. Vicino all’orologio di Valerio Messala ne fece disegnare un altro Marcio Filippo; ma siccome dubitavasi dell’esattezza di essi, Augusto, coll’opera del matematico Manlio, fece innalzare in Campo Marzio un obelisco, che Plinio[133] dice aver avuto l’altezza di 116 piedi, benché Montucla[134] ed altri non gliene assegnino che 70. Sulla cima di questo eravi posta una palla, per osservarne più giustamente l’ombra che al meriggio s’estendeva sopra una linea orizzontale, le cui varie divisioni, secondo la diversità delle stagioni, erano segnate con lamine di bronzo. Quest’obelisco, dice Plinio, o perché siasi mutato l’aspetto del cielo o della terra, o per qualche tremuoto, o per l’enormità del peso, poco durò nella sua perfezione, poiché a’ suoi tempi erano già trent’anni che a nulla più serviva. È però verisimile che tali orologi non segnassero che imperfettamente il corso del Sole,[135] poiché al principio del sesto secolo dell’era volgare l’invenzione dell’orologio solare e l’esatta distribuzione dell’ore era riputata ammirabile, a segno di dirsi che avrebbe fatta invidia alle stelle.[136]
Ma non era la sola esattezza che a questi orologi mancasse. Il più era che per essi non potevansi dividere in tempi eguali le notti ed i giorni nuvolosi; e benché alcuni v’avessero posto rimedio col fabbricare certe macchine, per cui ad ogni dato tempo lasciavano cadere in un vaso un sassolino, pure erasi ancora molto lungi da una regolare distribuzione del tempo; tanto più che essendosi i bisogni degli uomini aumentati a misura che essi divennero più instrutti, bisognava ritrovare divisioni del tempo più picciole e più regolari.
Ctesibio Alessandrino fu il primo che ritrovò la clessidra,[137] ossia orologio a acqua, che poi Scipione Nasica il Censore portò a Roma 120 anni avanti l’era volgare.[138] La clessidra era una macchina dove l’acqua cadeva insensibilmente da un picciol buco d’un vaso in un altro, in cui, alzandosi poco a poco, innalzava parimente un pezzo di sovero, su cui eravi qualche figurina che con una verga mostrava le diverse ore segnate su d’una colonnetta.[139] Ella era presso a poco simile a’ nostri polverini, ne’ quali la quantità della minutissima sabbia caduta nell’inferiore ampolla di vetro misura egualmente il tempo. Vitruvio descrive una clessidra, in cui l’acqua cadente faceva girare delle ruote dentate con molta giustezza, muovere delle figurine e suonar le trombe. Altre poi se ne fabbricarono con vari e più complicati ingegni. Quella però che merita la preferenza, e che oltre l’esattezza ha l’avantaggio di non fare alcun rumore, e perciò più comoda per gli ammalati che il pendulo, si è l’inventata dal padre Vailly benedettino l’anno 1690, ed in Italia nel medesimo tempo dal padre Martinelli.[140] Ella consiste in un picciol tamburro d’ottone internamente diviso in sette, o più o meno, cellette eguali; la porzione d’acqua che v’è dentro cade da una celletta nell’altra per mezzo d’uno stretto pertugio, fa girare il tamburro, che discendendo per una cordicella ravvolta intorno ai perni dello stesso tamburro, o co’ perni segna le ore, o fa girare l’ago che le indica sul quadrante.[141] Simili ingegnosissimi orologi trovò il cavaliere di Serviere, la cui descrizione trovasi nel suo gabinetto.[142]
L’orologio solare e quel d’acqua furono in uso dappoi fino a che inventossi l’orologio a contrappeso, ed indi quello con molle. È d’uopo dire che molti tentativi abbiano preceduta e preparata questa scoperta, e che in principio, come suol sempre avvenire, fosse per la sua rozzezza poco utile, poi siasene dilatato l’uso a misura della perfezione che andava acquistando, poiché non si sa precisamente chi siane stato l’inventore. Almeno Polidoro Virgilio[143] e Guidon Pancirolio,[144] diligenti investigatori de’ nomi degli inventori, assicurano non sapersi rinvenire chi il primo abbia fabbricati gli orologi usuali.
Alcuni storici però[145] assegnano il ritrovatore d’essi, altri de’ quali dicono l’oriuolo a contrappeso essere stato l’anno dell’era volgare 850 portato in Francia da Pacifico arcidiacono di Verona, che ne fu l’inventore. Fatto che se fosse vero, confermerebbe sempre più ciò che a gloria dell’antica Italia ed a confusione de’ moderni Italiani fu detto, quasi tutte le belle arti aver avuta la loro origine in Italia, e di là essere state trapiantate ed a tutto studio coltivate ed a meraviglia perfezionate in Francia ed in Inghilterra.
Altri vogliono che l’inventore ne sia stato, alla fine del secolo decimo, Gerberto monaco di Fleury, fatto pontefice col nome di Silvestro secondo.[146] Tale era ne’ passati secoli l’ignoranza, e la compagna sua indivisibile la credulità, che per questo ritrovato e per altre sue scoperte Gerberto fu accusato di magia. Pareva allora impossibile una produzione nuova senza l’intervento del diavolo. D’esso Gerberto dice Guglielmo Marlot:[147] Admirabile horologium fabricavit per instrumentum diabolica arte inventum, quo principis animum facile devinxerat. Strano non dirò già abuso, ma non uso e disprezzo della ragione umana! Quel che raccogliesi di più certo si è che avanti tal tempo i monaci, per essere risvegliati alle diverse ore di notte per i loro uffici, destinavano chi osservasse il moto delle stelle, o nelle notti nuvolose recitasse una tal misura di salmi che consumasse il tempo stabilito allo svegliamento.[148] Ciò non ostante la prima o più sicura menzione che in Italia siasi fatta degli oriuoli è negli annali di Bologna l’anno 1356. Ivi è marcato essersi posto in quel tempo un oriuolo nella pubblica torre con campana che suonava le ore; e questo, scrive l’autore d’essi annali, fu ’l primo orologio che cominciasse mai a suonare per lo Comune di Bologna.[149]
Questi oriuoli erano ben lungi dalla perfezione a cui i nostri sono ridotti, che anzi, rozzi, incomodi, irregolari, dovevano piuttosto far sentire l’imperizia de’ loro artefici che l’utilità del ritrovato. Il grande Galileo, l’onore della ingrata sua patria l’Italia, colla sublimità del suo ingegno e collo stendere le feconde sue mire arrivò a dare all’arte di partire il tempo la maggior possibile esattezza, che doveva poi condurre i suoi posteri a meglio conoscere, oltre il tempo, lo stato ancora del cielo e la figura della Terra. Egli trovò il primo che ’l pendulo era atto a misurare colle sue oscillazioni le minime sensibili porzioni di tempo, ed avanti l’anno 1639 se ne servì per le osservazioni astronomiche. Questo grand’uomo pensava ancora ad adattare il pendulo agli orologi. Ma questa idea, non eseguita da esso, fu messa in opera da Vicenzo suo figlio, che l’anno 1649[150] ne fece la sperienza in Venezia.
Huighens, che s’attribuisce questa scoperta,[151] la perfezionò in gran parte. Egli procurò d’adattare i penduli per la navigazione, e di dar loro tale giustezza che resistessero alle forti ondulazioni de’ vascelli e disegnassero la situazione in cui un bastimento trovasi: egli insegnò di porre il pendulo fra due laminette cicloidali, perché le sue oscillazioni fossero equabili; egli per questo effetto esaminò qual linea dovessero descrivere i penduli, e loro assegnò la cicloide; sforzossi poi di rimediare all’inconveniente dell’arrestarsi, o almeno ritardarsi il moto degli oriuoli nel rimontarli, e negli orologi a molla tolse la corda e la lumaca, applicandovi in vece una ruota dentata al tamburro, in modo che per montar l’oriuolo
IL CAFFÈ )( Fogl. XXXIII )(
non facciasi che avvolgere intorno a se medesima la molla già spiegata col tirarla per il centro; negli orologi a contrappeso v’aggiunse due carrucole, o girelle, sicché nel montarli seguita il contrappeso ad agire ed a muovere le ruote,[152] e se non gli fu fatto d’usurparsi l’invenzione dello spiraglio, fatta dall’abate di Haute-feuille l’anno 1674, almeno la migliorò.[153]
Pretese Huighens che siccome agli oriuoli a molla si era tolta la cordicella e sostituitovi una catenella, anche questa si dovesse levare, come sopra accennai; pure trovossi che la forza dell’elaterio della molla essendo massima in principio, minima dopo un dato spandimento, v’era una sensibilissima differenza di celerità di moto; per il che, abbandonato il parere di Huighens, s’usò che quel perno su cui era avvilupata la catenella fosse fatto in modo di cono, e perciò detto lumaca, che colla sua figura compensa la diversità dell’elaterio.[154]
Gl’Inglesi hanno di molto contribuito alla perfezione di quest’arte, perché, oltre all’essersi in Inghilterra ritrovato quel sì utile stromento di tagliar le ruote con non minor facilità che esattezza, fu il dottore Hook, inglese, che inventò le mostre, ed alla cicloide d’Huighens, sottoposta a molti inconvenienti, sostituì l’uso di far descrivere al pendulo archi più piccoli, che rendono uniforme il moto dell’oriuolo;[155] e fu un certo Barlow, inglese, il primo fabbricatore dell’orologio a ripetizione l’anno 1676, ultimamente migliorato da monsieur Thiout, quale ha trovato il mezzo di far che l’oriuolo a ripetizione non suoni che quando si vuole. Ne’ penduli ottennesi in tal maniera la misura del tempo più esatta ed uniforme che fosse possibile, ed assicurossi agli oriuoli portatili tutta la giustezza ed avvantaggi compatibili colla piccolezza della mole;[156] questi, qual ora vogliansi provare se siano giusti, devonsi, secondo il consiglio di Sully,[157] appena montati aggiustare e conformare con un giusto pendolo, poi, tenutili sospesi vicino ad esso, confrontarli ogni quattro ore, per iscoprire se tanto in principio quanto in fine delle venti quattr’ore siano uniformi; più ancora, dopo averli rimontati, si posino sopra d’un piano per altre ventiquattr’ore, ed in fine osservisi se la mostra ha conservato l’equabile suo moto; il che se trovasi, si può ragionevolmente conghietturare la bontà della mostra.
Ecco come i tentativi degli antichi ci hanno preparati e disposti i progressi che noi abbiamo fatto nella cognizione del cielo e nella misura del tempo. Ora la gnomonica[158] s’è resa universale ed adattabile a qualunque piano od aspetto, s’è estesa fino al fare orologi d’ombra della Luna, e col vario apparente moto delle stelle fisse possonsi ritrovare l’ore della notte; sonosi fabbricate clessidre giuste ed ingegnosissime. Gli oriuoli a peso ed a molle sono tanto esatti quanto può l’uomo sperare di renderli, ed oltre a ciò ci mostrano con varie ruote moventisi il giro de’ pianeti;[159] e la scoperta del Galileo produsse le osservazioni delli Huighens, la Hire, le Roi, le Paute e del più recente di tutti, l’ingegnoso Berthoud.[160]
Quello nondimeno che all’inquieto e torbido europeo mancava ancora, per poter più sicuramente varcare gl’immensi mari che lo dividono da climi più fecondi e da nazioni da esso rese stromento infelice della sua rapacità, avarizia e lusso, si era il trovare un pendulo atto a misurare giustamente le longitudini in mare. L’importanza di questo problema per il bene del commercio maritimo e il salvamento degli uomini che vi si consacrano determinò i monarchi non meno che i matematici e gli artefici ad affrettarne la scoperta. La Spagna, la Francia e l’Inghilterra proposero de’ premi per ciò. Infine la scoperta fecesi dove doveva aspettarsi, e per l’interesse più pressante di quella nazione e per i lumi sparsivi. Giovanni Harrison, inglese, fabbricò ultimamente un pendulo atto a determinare le longitudini; l’esperienze confermarono questo ritrovato, e l’industrioso travaglio dell’artefice, il cui primo mestiero era di falegname, ricevette quella ricompensa di gloria e d’oro che conveniva distribuirsi da una nazione ragionatrice.[161]
Perché però possasi servire dell’orologio, è evidente che convien fissare un punto d’onde s’abbia a partire nella misura della giornata; altrimenti se ciascuno a sua voglia fissasse quel punto che più gli piace, l’orologio sarebbe inutile nel commercio degli uomini, come inutile sarebbe il dono della lingua, se ciaschedun uomo si fabbricasse un linguaggio a suo talento. Tutte le nazioni si sono accordate nel misurare il tempo col moto del Sole, ch’è il più sensibile; ma diverso è il principio che nel giornaliero apparente giro del Sole si sono scielto. Era ben naturale che i più antichi osservatori del cielo sciegliessero per principio delle loro misure il punto più visibile che vi fosse; che gli osservatori più istrutti prendessero il punto più costante e sicuro; che perfine la scelta dell’altre nazioni, regolata dall’azzardo, cadesse su qualche punto che né fosse il più sensibile, né il più costante. Perciò i Caldei, ed a loro imitazione gli Ebrei, cominciarono a contar l’ore dallo spuntar del Sole, siccome ancora oggi fanno gli abitanti dell’isole di Maiorca e Minorca, che hanno ricevuto tal uso dalla più lontana antichità. Dividevano gli antichi il tempo fra ’l nascere e ’l tramontar del Sole in dodeci ore, che perciò eran disuguali, in modo che per disegnare un’ora corta dicevano un’ora d’inverno. Tali ore chiamansi antiche o giudaiche; dal partire poi che fecero gli Ebrei queste dodici ore in sole quattro parti, ne nacquero le ore canoniche.
Gli Egizi, gli astronomi e la maggior parte delle nazioni europee hanno scelto in vece il meriggio. I Romani, il cui giorno naturale era il tempo in cui il Sole si fermava sul loro orizzonte, partivano in dodici ore il giorno ed in altrettante la notte; ma il loro giorno civile incominciava dalla sesta ora della notte, cioè computavasi da una mezza notte all’altra.
Gli antichi Ateniesi, gli antichi Boemi ed i moderni Italiani non so come si sono appigliati al tramontar del Sole. Vedansi in nota gli autori d’onde ho cavate le succintamente rapportate notizie.[162]
Io qui non faccio alcuna differenza da que’ che incominciano le ventiquattr’ore del giorno dalla mezza notte, e que’ che vogliono piuttosto cominciarle al mezzo dì. Il risultato sì degli uni che degli altri è lo stesso, né v’è diversità che di termini. Resta dunque a vedere qual epoca debba anteporsi, se quella de’ Caldei, o la più comune, o l’italiana.
Convien però riflettere che io suppongo gli orologi esattissimi, siansi que’ di contrappeso, benché appena montati il peso maggiore operi solo e contro il suo contrappeso e contro un lungo tratto della fune che gli unisce, e dappoi il peso maggiore unito al peso della fune operi contro il solo contrappeso; siansi que’ di molle, benché secondo la diversa disposizione dell’aria, più o meno sieno elastiche, e difficilissimamente osservisi il giusto rapporto tra la molla, la lumaca, lo spiraglio e tutti gli altri ingegni, e benché nel montarli interrompasi alquanto il moto d’essi, e perciò abbiano necessariamente a ritardare.[163] Questi inconvenienti, che pur sono considerabili, mi conviene trascurare, perché di quella ineguaglianza io vuo’ parlare che non già dalla struttura dell’orologio procede, ma sì bene dalla maniera di regolarlo.
E siccome dal moto del Sole, considerato in vari tempi, regolansi gli orologi, e d’altra parte temerei d’essere più oscuro se volessi esporre la divisione della giornata supposto il moto della Terra, mi farò lecito l’esprimermi col volgo, e parlare alcuna volta del moto apparente del Sole come se fosse vero; altrimenti que’ soli per avventura m’intenderebbono che non han bisogno d’imparare da me ciò che sono per dire. Questa si è la cagione per cui soggiungo alcune diffinizioni della sfera, che per altro dovrebbono esser comunissime.
Il Sole col suo moto diurno da oriente in occidente descrive una linea che noi chiamiamo equatore, ugualmente per tutto distante dai due Poli. Egli però non vi gira esattamente che al tempo degli equinozi, ma se ne allontana gradi 23 1/2, o per dir meglio gradi 23,28’ da una parte, ed altrettanto dall’altra. Viene egli innalzandosi verso noi, portandoci la state, e l’ultimo giro che descrive meno obliquo per noi, chiamasi il tropico del Cancro. Inclina poi al Polo antartico quando è il nostro inverno, e ’l giro che vi descrive più lontano da noi e dall’equatore dicesi tropico di Capricorno. Una linea, su cui s’immagini il Sole farvi sempre il suo apparente corso, è l’eclittica. Per concepir cosa sia meridiano, fingasi un gran cerchio che suppongasi passare dal Polo e dal nostro zenit, o punto perpendicolare sulla nostra testa. Questo cerchio va a tagliare l’equatore e l’eclittica; quando il Sole arriva a passare su questo tal cerchio, allora è meriggio per noi. Linea meridiana dicesi quella linea retta su alcun punto della quale gettasi dal Sole l’estremità dell’ombra del gnomone, o ’l raggio solare in una camera nel punto preciso del meriggio.
È evidentissimo non a’ soli astronomi, ma ancora a chiunque dotato d’un po’ di buon senso vuol pensarvi, non esservi ragione alcuna risguardo alla giustezza d’anteporre l’orologio italiano al caldeo. Il volgo che vede sempre arrivare la sera alle ventiquattr’ore, e venir chiaro ora ad un’ora, ora ad un’altra, si crede il tramontar del Sole essere un punto inalterabile; per lo contrario lo spuntare esser vario ed incostante. Né io qui m’estenderò col addurne le convincenti prove, perché io scrivo per chi abbia qualche elementare notizia della sfera; e chi non l’avesse, o credami sulla mia parola, o se ne informi, o non perda il tempo leggendo il mio discorso. Altronde ciò vedrassi più chiaro nel confronto ch’io son per fare tra l’instabilità del mezzo dì e quella della sera. Dirò solo che, poiché il giorno piuttosto che la notte suol destinarsi agli affari, pare più ragionevole il cominciare la divisione dal principio d’esso che dalla fine, perché tutto l’anno, ad una data ora, potrebbero determinarsi le pubbliche funzioni; cosa che noi non possiamo fare prendendo cominciamento dalla sera. Una sola riflessione però fammi posporre l’orologio caldeo all’italiano, e questa è che le azioni più importanti per noi nazione colta, polita, civile, ben accostumata, cioè le veglie, le conversazioni, il giuoco soglionsi destinare al principio della notte, non servendo la mattina ad altro che alle vili occupazioni dell’ultima feccia del popolo.
Potrei qui supporre quanto per se stesso è chiarissimo, cioè che de’ due orologi, l’italiano e l’oltremontano, uno per lo meno dev’essere fallace; ma poiché ciò fummi da alcuni contrastato, a questi io dico che, perché l’orologio sia giusto, deve il suo ago in un dato tempo equabilmente scorrere su tutto quel circolo, e là ritornare d’ond’era partito. Dati adunque due oriuoli giusti, e messi i loro aghi su d’uno stesso punto, ambidue gli aghi sempre dovranno segnare la stess’ora; e se io metterò un ago tre ore avanti dell’altro, sempre dovravvi essere la differenza delle tre ore; e se io farò che un ago segni le ore dodici, e nell’altro orologio adatterò l’ago diametralmente opposto, cioè alle sei, sempre questi due aghi saranno diametralmente opposti e segneranno costantemente il tempo con sei ore di diversità. Gli aghi dunque degli orologi italiano ed oltremontano dovranno quella distanza e relazione fra di loro conservare che ebbero quando furon mossi, o sieno essi apposti a due orologi, o siano in un solo oriuolo regolati da due perni, o attaccati ambi due ad un perno solo, il che è lo stesso. Ciò posto, prendansi due oriuoli verso la metà di ottobre; uno d’essi si regoli all’italiana, all’oltremontana l’altro. Siccome allora il meriggio è alle nostre ore diciotto, seguirà che allor quando l’oriuolo all’italiana indicherà le sei ore, o come vogliasi le diciotto, l’altro orologio segnerà appunto le dodici. Che avverrà di questi due oriuoli verso la metà di giugno, allorché mezzo dì arriva circa alle nostre ore sedici? Il loro movimento sarà sempre stato equabile, e ne’ medesimi tempi avranno compiuti i loro giri, sicché saravvi dall’uno all’altro la stessa differenza di sei ore: eppure il mezzo giorno d’allora ha, per così dire, anticipato di due ore, onde quando all’orologio italiano sono dodici ore, non v’essendo in giugno che quattr’ore per arrivare al mezzo giorno, di quattr’ore dovrebbero gli aghi essere tra loro distanti. Lo stesso dicasi se i due oriuoli si accomodino li 21 giugno, in modo che l’oltremontano segni dodici ore, e l’italiano 15 3/4; alli 21 dicembre l’oltramontano segnerà al mezzo dì ore 12 giuste, e l’italiano, che dovrebbe segnare ore 19 1/4 perché a tal ora è mezzo dì al solstizio di dicembre, segnerà nuovamente ore 15 3/4, avendo sempre gli aghi conservato il rapporto di lontananza d’ore 3 3/4. Converrà dunque dire che uno de’ due punti fissati non sia invariabile, ma che o ’l meriggio da giugno a dicembre abbia anticipato, o ritardato abbia il tramontar del Sole. Esaminiamo ora qual de’ due sia più vario dell’altro, e per maggior chiarezza confrontiamo primamente l’oriuolo oltramontano col mezzo giorno.
Per giorno di ventiquattr’ore noi Italiani intendiamo disegnare il tempo che il Sole consuma a scorrere tutto ’l cerchio che apparentemente descrive intorno la Terra, e nominatamente il tempo che ’l Sole impiega a ritornare a nascondersi a noi. Per giorno intende l’oltremontano il tempo che ’l Sole impiega partendo da un dato meridiano a ritornarvi.
Non solamente gira il Sole intorno la Terra, ma vi girano ancora le stelle fisse, che sono poi tanti soli più lontani. Queste fisse non hanno a’ nostr’occhi che un moto equabile progressivo; e ciò nel sistema o sia ipotesi copernicana, perché la Terra rispetto alla fissa è come se rimanesse nel centro del sistema planetario e non avesse alcun moto proprio intorno al Sole, ma solamente si rivolgesse equabilmente intorno al proprio asse. Le fisse impiegano sempre a far il giro apparente intorno alla Terra ore 23.56’.4’’, cioè ore ventitré, cinquantasei minuti primi e quattro minuti secondi.[164] Lo stesso succederebbe rispetto al Sole, se la Terra non avesse il moto annuo, per cui pare che ’l Sole si muova da occidente in oriente annualmente, come nello spazio d’un giorno, per il moto diurno della Terra da occidente in oriente, sembra che il Sole si muova da oriente in occidente. Combinando questi due moti, i giorni considerati da un appulso all’altro del Sole al meridiano sono più lunghi del tempo del ritorno della fissa al meridiano, e sono più lunghi precisamente di quel tempo che si ricerca perché passi sotto ’l meridiano quell’arco dell’eclittica per cui il Sole col suo moto apparente è ritroceduto dall’occidente in oriente nel tempo della rivoluzione d’una fissa. In somma la fissa ha il suo apparente movimento progressivo sempre equabile. Il Sole, per la ragione detta di sopra, oltre il moto progressivo ne ha un apparente retrogrado. Onde per arrivare al termine a cui è giunta la fissa, cioè al meridiano, gli resta a correre tutto quello spazio di più per cui è ritornato indietro. Per esempio sianvi due uccelli, che in un’ora facciano sessanta miglia. Uno di questi uccelli vada sempre avanzandosi senza ostacolo; l’altro incontri un forte vento, che ad ogni miglio che fa lo spinga indietro la sessantesima parte d’un miglio; avverrà che ’l primo uccello in un’ora avrà trascorse le sessanta miglia, l’altro non ne avrà scorso che cinquantanove, e non arriverà al termine che in un’ora e poco più d’un minuto, cioè in un’ora e 1’ 1’’ 1’’’ 1’’’’ 1’’’’’ 1’’’’’’ 1/59’’’’’’ ec.;[165] o bisognerà che impieghi la forza di scorrere volando sessant’un miglia, perché in un’ora possa averne scorse sessanta. Nel primo uccello possiamo riconoscere una fissa, nel secondo il Sole.
Se ’l moto apparente del Sole o ’l moto vero della Terra fossero equabili, e l’orbita vera della Terra ossia l’apparente del Sole fossero nel piano dell’equatore, il tempo della rivoluzione del Sole sarebbe maggiore del tempo della rivoluzione della fissa d’una costante quantità, che sarebbe sempre la stessa in tutti i tempi dell’anno; ma dall’allontanarsi che fa il Sole dall’equatore di gradi 23 1/2 per ogni parte, ossia dal muoversi ch’egli fa sull’eclittica, e dall’esser il piano di questa inclinato al piano dell’equatore di gradi 23 1/2 circa, ne nasce che archi uguali dell’eclittica non corrispondono ad archi eguali dell’equatore, se non nel tempo de’ solstizi; ma nel tempo degli equinozi, tirando al piano dell’equatore due perpendicolari dalle due estremità dell’arco descritto in un giorno dal Sole col moto apparente annuo, l’arco dell’equatore compreso tra le due perpendicolari verrà ad essere minore dell’arco dell’eclittica che gli è inclinata. Così l’eccesso del tempo della rivoluzione del Sole sopra quello della rivoluzione d’una fissa sarà maggiore ne’ solstizi che negli equinozi.
Perché poi il moto vero della Terra o ’l moto apparente del Sole è disuguale, e descrivonsi dalla Terra intorno al Sole aie proporzionali a’ tempi ed uguali in tempi eguali, ne nasce la velocità della Terra esser maggiore quanto è minore la distanza dal Sole, cioè la massima nel solstizio d’inverno e la minima nel solstizio d’estate,[166] mentre d’inverno il Sole è più vicino alla Terra che nell’estate di circa un millione di leghe, come raccogliesi dall’essere d’inverno il suo diametro apparente maggiore di quel che sia nell’estate di minuti 1’.4’’.35’’’ di grado. Quindi dall’equinozio di primavera a quello d’autunno vi sono circa otto giorni di più che dall’equinozio d’autunno a quello di primavera.[167]
Per la disuguaglianza del moto vero della Terra e del moto apparente del Sole, l’eccesso del tempo della rivoluzione del Sole sopra il tempo della rivoluzione delle fisse sarà maggiore dopo ’l solstizio d’inverno che dopo il solstizio d’estate.
Combinando tutt’e due le cagioni, cioè l’inclinazione dell’eclittica all’equatore e la disuguaglianza del moto della Terra, l’eccesso del tempo della rivoluzione del Sole sopra il tempo della rivoluzione d’una fissa sarà il massimo nel solstizio d’inverno, minore nel solstizio d’estate, e ’l minimo negli equinozi.
Però computando i giorni da un mezzo giorno all’altro, sarà il giorno lunghissimo nel solstizio d’inverno, più corto nel solstizio d’estate e cortissimo nel tempo degli equinozi. Quindi i mesi di novembre e dicembre, presi insieme, sono più lunghi di 37 minuti che que’ di settembre ed ottobre, benché vi sia egualmente 61 giorni dalle due parti. I giorni medi tra i più lunghi ed i più corti sono agli 11 febbraio, 15 maggio, 25 luglio e primo di novembre.
Un oriuolo esattissimo, il cui ago sia nel giorno 1 di novembre sul punto o, oppure segni le ore 12 al vero mezzo dì, seguitando a muoversi senz’alterazione, agli 11 febbraio segnerà il mezzo giorno, minuti 31 circa, o incirca una mezz’ora prima che sia; cioè indicherà il mezzo giorno quando veramente dovrebbon’essere ore 11 2/4. Dunque dal 1 novembre agli 11
IL CAFFÈ )( Fogl. XXXIV )(
febbraio da un mezzo giorno all’altro v’è sempre più di 24 ore, ed i giorni più lunghi dell’anno sono verso il solstizio d’inverno; poiché il Sole allora impiega ventiquattr’ore e mezzo minuto, o ore 24.0’.30’’ da un punto all’altro dello stesso meridiano; d’onde nasce che la massima differenza dell’orologio regolato col mezzo dì è che in tre mesi ritarda una mezz’ora, e da un giorno all’altro la massima differenza è d’un mezzo minuto.[168]
Un oriuolo aggiustato col vero meriggio agli 11 febbraio, seguitando a muoversi regolarmente fino alli 15 maggio, l’orologio segnerà il mezzo dì quando sarà già passato di minuti 18’.48’’, cioè allora sarà il vero mezzo giorno quando sull’orologio saranno ore 11.41’.12’’, cioè allora da un mezzo dì all’altro vi sarà meno d’ore 24; e verso li 25 marzo vi sarà differenza da un giorno all’altro di minuti 0’.19’’.
Alli 15 maggio un oriuolo messo col vero meriggio, muovendosi fino a’ 25 luglio, segnerà il mezzo dì quando non sarà ancora arrivato e vi mancheranno dieci minuti; cioè allora da un mezzo giorno all’altro vi sarà più di 24 ore, e verso il solstizio di giugno vi sarà differenza da un giorno all’altro di minuti 0’.13’’.
L’orologio regolato col mezzo dì alli 25 luglio, al primo di novembre segnerà il mezzo giorno quando sarà già passato di minuti 22’.5’’, cioè allora sarà il vero meriggio quando l’oriuolo indicherà ore 11.37’.55’’; cioè allora da un meriggio all’altro vi sarà meno d’ore 24; e la maggior differenza in questo tempo da un giorno all’altro sarà verso li 20 novembre, ed allora un giorno sarà più corto dell’altro di 0’.21’’.
Dunque dal 1 novembre alli 11 febbraio il mezzo dì ritarda minuti 30’ circa.
Dagli 11 febbraio alli 15 maggio avanza minuti 18’ circa.
Dalli 15 maggio alli 25 luglio ritarda minuti 10’ circa.
Dalli 25 luglio al 1 di novembre avanza circa minuti 22’.
Vedesi da ciò che l’oriuolo all’oltremontana varia bensì nelle diverse stagioni, ma le sue variazioni si compensano l’una coll’altra, ed alla fine dell’anno l’orologio tornerà a segnare giusto il mezzo dì.
In oltre il Sole propriamente sembra descrivere una spirale intorno la Terra, ed essendo esso nel solstizio d’inverno più vicino alla Terra di circa un millione di leghe francesi che nel solstizio d’estate, i circoli diurni che descrive dal solstizio d’inverno a quello d’estate si vanno sempre più dilatando, e dal solstizio d’estate a quello d’inverno vannosi ristringendo. Ciò fa che dal solstizio d’inverno a quello d’estate è più breve l’arco che deve il Sole scorrere dal nascer suo al mezzo dì che dal meriggio al tramontare; e per la stessa ragione dal solstizio d’estate a quello d’inverno v’è più di strada, o dicasi di tempo, dal nascer al mezzo giorno che dal mezzo dì al tramontare. Questa differenza non è gran fatto sensibile; ma da qui ancora ne deriva alla fine sbaglio negli oriuoli, che noi sempre accusiamo d’irregolarità, bench’essa debbasi quasi sempre imputare alla varietà de’ moti della Terra.
Abbiamo veduto il giro della Terra non essere equabile, poiché la Terra non descrive un cerchio intorno al Sole, ma sì bene un’elissi, e la massima differenza dell’oriuolo dal Sole essere di minuti 30 3/4 circa. Per rimediare a quest’inconveniente, s’è conformato il moto degli orologi a quel della Terra, seguendo il suo moto medio o più uniforme, cioè prendendo un mezzo fra le ineguaglianze del suo movimento; o per esprimermi più chiaro, l’oriuolo oltremontano suolsi regolare non già sull’esattissimo punto del meriggio, ma su un tempo medio; e siccome il Sole in alcuni punti accelera l’apparente suo moto, lo ritarda in altri, fingesi dagli astronomi un Sole che alla fine dell’anno faccia tutta la rivoluzion solare, ma sempre con moto equabile. Col giro immaginario di questo Sole regolano essi il corso de’ loro oriuoli, che in tal maniera non anticipano sul mezzo dì che di minuti 14’.44’’, e non ritardano che di 16’.9’’.
Per non lasciare a chi non è matematico cosa alcuna a desiderare, son venuto in parere di qui inserire il risultato d’una tavola detta dell’equazione dell’orologio, che indichi la differenza del tempo vero al tempo medio, coll’aiuto della quale si sappia come regolare un oriuolo perché segni esattamente il tempo medio. Ma perché l’annue rivoluzioni solari non si terminano tutte in un dato tempo, ed alcuni anni perciò sono più corti degli altri, benché d’una picciolissima quantità, non si può pertanto costruire una giusta tavola universale. Vedo in fatti che monsieur Berthoud[169] pone quattro differenti tavole d’equazione, una per gli anni bisesti, la seconda per il primo anno che succede al bisestile, la terza per il secondo anno in appresso al bisesto, la quarta per l’anno che precede il bisestile. Vedo in oltre che lo stesso monsieur Berthoud nell’articolo dell’Enciclopedia: Equation, Horlogerie,[170] prescrive una tavola differente senza fissare l’anno in cui abbia a servire. Vedo che monsieur Maraldi[171] fornisce tavole differenti da tutte quelle di monsieur Berthoud. Vedo che monsieur de la Lande, successore del Maraldi,[172] ne dà una dissimile da tutte le altre. E rifletto in fine tutte queste differenze non montare che a pochi minuti secondi, cioè non arrivare alla metà d’una sessantesima parte d’un’ora. Perciò stimo meglio servirmi della tavola inserita nell’Enciclopedia, esponendola in un modo più facile a concepirsi. Se v’è sbaglio, non sarà sensibile che a chi si serve d’un esattissimo pendulo per gli usi astronomici, e non è a tal sorta d’uomini che io qui parlo. Solamente aggiungo che la massima differenza della tavola di monsieur de la Lande per l’anno 1765 dal moto vero del Sole al moto medio è agli 11 febbraio di minuti 14’.40’’ che l’oriuolo anticipa sul meriggio, e alli 2 novembre che ritarda di minuti 16’.9’’, ritardo che dev’esser precisamente tale per tutto quasi il secolo 18°. Simili a un dipresso sono le tavole di monsieur Berthoud nel suo Essai sur l’horlogerie.
L’oriuolo adunque il giorno primo di gennaio segni quando è mezzo giorno ore 0, min. 3’.39’’. Li due gennaio l’orologio anticipi sul mezzo dì min. 4’.28’’. Li 10 febbraio l’orologio anticipi di 14’.43’’. Gli 11 febbraio anticipi di 14’.44’’; a’ 12 anticipi di 14’.43’’. Li 21 marzo anticipi di soli 7’.14’’. Li 13 d’aprile anticipi di 0’.21’’. Li 14 anticipi di 0’.6’’. Li 15 l’orologio segni il mezzo dì quando è già passato di 0’.9’’, e vada sempre ritardando sul mezzo giorno in modo che i giorni 14 e 15 maggio segni al meriggio ore 11.55’.56’’. Vada poi scemando il ritardo dell’oriuolo fino a’ 15 giugno, nel qual giorno al meriggio marchi ore 11.59’.55’’. Indi cominci di nuovo ad anticipare sul moto del Sole in maniera che il giorno 16 giugno anticipi sul giorno 15 di 13’’, cioè segni 8’’ più del vero meriggio. A’ 21 giugno anticipi di 1’.13’’. L’oriuolo anticipi semprepiù sul moto vero del Sole sino a che li 25 e 26 luglio anticipi di 5’.56’’. Quest’anticipazione ritardi fino alli 30 agosto, ed allora anticipi di soli 0’.10’’; poi cominci a ritardare sicché al meriggio delli 31 agosto segni ore 11.59’.52’’. Al meriggio de’ 23 settembre indichi ore 11.52’.6’’. Seguiti poi a ritardare, ed i giorni 31 ottobre, primo e secondo di novembre segni ore 11.43’.51’’. Il ritardo decresca in modo ch’al meriggio de’ 23 dicembre noti ore 11.59’.56’’, ed il giorno 24 dicembre ricominci ad anticipare sul mezzo dì 26’’.
Vedasi da questa tavola d’equazione il meriggio vero accordarsi col meriggio segnato dall’oriuolo quattro volte l’anno, cioè li 13 aprile, 15 giugno, 31 agosto, 23 dicembre; vedasi in oltre che dopo l’equinozio di marzo per alcuni giorni il Sole ritarda d’un giorno all’altro di 19’’; che dalli 15 alli 21 giugno v’è differenza nel moto del Sole d’un giorno all’altro di 13’’; che all’equinozio di settembre il Sole avanza da un giorno all’altro min. 0’.21’’; che dalli 18 alli 28 dicembre il moto del Sole varia da un giorno all’altro di 30’’. Vedesi per fine che l’oriuolo oltremontano gli 11 febbraio avanza di 14’ .44’’; ritarda li 15 maggio di 4’.4’’; avanza li 25 luglio di 5’.56’’; ritarda il primo di novembre 16’.9’’.
Allor quando dico che l’oriuolo avanza o ritarda, intendasi il Sole avanzare o ritardare la quantità indicata.
Converrà dunque in principio allentare o affrettare il moto degli oriuoli, poiché dopo esser disposti un giorno colla tavola, segnino poi costantemente, come ho di sopra accennato, cioè regolarmente scorra l’oriuolo tre minuti primi, cinquantasei secondi per compiere le 24 ore sopra l’arrivo d’una fissa allo stesso meridiano.
L’ultimo sforzo della mecanica era certamente quello di formar oriuoli così regolarmente irregolari che s’adattassero al vario incostante moto del Sole. Come mai potevasi ottenere una tal macchina, supposte le tante cagioni già rapportate delle instabili differenze da un giorno all’altro? Pure a che non giunge mai la sagace industria d’artefici ostinatamente determinati dalla gloria e da’ premi dovuti a’ ritrovatori d’ordigni utili per la società? Fino dall’anno 1699 rapporta Sully[173] essersi ritrovato un tale oriuolo, che chiamasi d’equazione, nel gabinetto di Carlo II, re di Spagna. Indi il padre Alessandro[174] l’anno seguente insegnò il metodo di construire un pendulo che sempre segnasse il vero moto del Sole. Questa macchina fu trovata di troppo difficile esecuzione, perché troppo complicata. Il signor de Rivaz ne suggerì un’altra meno esatta, ma più facile. Altre ne espone monsieur Thiout, e dopo esso monsieur Dauthiau, le Roi e l’ingegnoso monsieur Berthoud fabbricarono orologi d’equazione, ne’ quali l’esattezza componesi col numero e varietà degli ordigni necessari.[175]
Passiamo ora ad esaminare l’oriuolo italiano e dipoi ne faremo il paragone coll’oltremontano.
Noi nel solstizio d’estate a’ 21 giugno abbiamo il meriggio alle ore 15 3/4. Nel solstizio d’inverno a’ 22 dicembre è alle ore 19 1/4. La differenza dall’ora del meriggio d’estate a quella d’inverno, cioè in sei mesi, è d’ore 3 1/2.
S’è veduto la massima differenza dell’oltremontano regolato col meriggio non ascendere che ad una mezz’ora nello spazio di circa tre mesi, novembre, dicembre e gennaio, quale viene compensata in gran parte dalli 18 minuti, somma del ritardo dell’orologio dagli 11 febbraio alli 15 maggio; onde da novembre alla metà di maggio sbaglia l’oriuolo oltremontano di minuti 12 .
Ne’ sei mesi circa dagli 11 febbraio alli 25 luglio sbaglia di minuti 8.
Ne’ sei mesi circa dalli 15 maggio al primo novembre sbaglia minuti 12.
Ne’ sei mesi circa dalli 25 luglio agli 11 febbraio sbaglia minuti 8.
Dunque il massimo sbaglio dell’orologio oltremontano in sei mesi è di minuti 12. Dunque la differenza dall’oltremontano all’italiano in tempi eguali è come minuti 12 a ore 3 e mezzo, o come 12 a 210, o come 2 a 35; e il massimo sbaglio dell’oriuolo oltremontano in tre mesi è al massimo sbaglio dell’italiano in sei come uno a sette.
Ma siccome l’oriuolo oltremontano si regola nel tempo medio, e di tre in tre mesi segna il meriggio col Sole, ne segue che lo sbaglio delle ore 3 1/2 dell’oriuolo italiano in sei mesi gli è tutto imputabile; benché poi lo sbaglio massimo dell’oriuolo oltremontano sia per esempio il dì primo di novembre di minuti 16; e così lo sbaglio dell’oltremontano allo sbaglio dell’italiano sia come 1 a 14.
In fatti per conoscere lo sbaglio dell’italiano basta prendere la differenza della lunghezza de’ giorni e dividerla per metà, una delle quali metà non contasi, perché cade sul nascer del Sole, l’altra metà indicherà la variazione del tramontare. Ne’ nostri giorni più lunghi sta il Sole sul nostro orizzonte ore 15 1/2; ne’ più corti 8 1/2, trascurate le menome differenze per rifrazione od altro. Dalle 8 1/2 alle 15 1/2 vi sono ore 7, la cui metà spetta al tramontare. Alla qual somma s’aggiunga la differenza della durata de’ crepuscoli, giacché noi regoliamo l’oriuolo non al tramontar del Sole, ma ad un’incerta oscurità.
La succennata differenza d’ore 3 1/2 nasce perché il Sole tramonta da un giorno all’altro in diversi punti dell’orizzonte, e l’arco descritto dal Sole sopra l’orizzonte si muta da un giorno all’altro. La differenza di questi archi diurni è massima negli equinozi, quando il Sole muta sensibilmente declinazione da un giorno all’altro, è minima ne’ solstizi, quando il Sole, andando paralello a’ tropici, la sua declinazione è minima.
Quest’anno nel solstizio di giugno il giorno in Milano, cioè all’elevazione di Polo di gradi 45.25’, sarà lungo ore 16.31’, trascurati nel computo i rotti.
Dal giorno di questo solstizio a dieci giorni dopo, il dì si farà più corto di minuti 2’.24’’, ed il mezzo dì del moto medio avanzerà sul moto vero di minuti 3’.7’’, cioè dal giorno in cui accaderà il solstizio di giugno al dì seguente il giorno diminuirà insensibilmente, e ’l mezzo dì del moto medio avanzerà sul moto vero secondi 13’’.
Nel solstizio di dicembre il giorno sarà lungo ore 7.29’, trascurati come sopra i rotti. Dal giorno di questo solstizio a dieci giorni dopo, il dì crescerà minuti 3’.12’’, ed il mezzo giorno del moto medio avanzerà sul moto vero minuti 3’.45’’, cioè dal giorno di questo solstizio al dì seguente il giorno crescerà insensibilmente, ed il mezzo dì del moto medio avanzerà sul moto vero secondi 30’’.
Dal giorno dell’equinozio di marzo al giorno dopo, il dì crescerà minuti 3’.16’’, e il mezzo dì del moto medio ritarderà sul moto vero secondi 18’’.
Dal giorno dell’equinozio di settembre al dì seguente, il giorno diminuirà minuti 5’.12’’, ed il mezzo dì del moto medio ritarderà sul moto vero secondi 20’’.
Tutto ciò è computato per il meridiano e per la latitudine di Milano in quest’anno 1765.[176]
Dunque in quest’anno regolando in Milano col Sole due oriuoli egualmente giusti, uno all’italiana, l’altro all’oltremontana, sarà la media loro differenza dal moto diurno della Terra, cioè la media diurna differenza dell’oltremontano alla media diurna dell’italiano, come 17 2/3’’ a 254’’. Cioè il medio sbaglio dell’oriuolo oltremontano da un giorno all’altro è di minuti secondi 17 2/3’’; e il medio sbaglio dell’orologio italiano da un giorno all’altro è di minuti secondi 254’’.
Apparirà molto più sensibile la grande instabilità dell’oriuolo italiano, se ritengasi il già detto, che essa tutta dipende dalla lunghezza degli archi diurni, e che questa varia sempre, onde sempre deve variare l’ora del tramontar del Sole; e riflettasi in oltre che lo scorrere che fa il Sole su questi moltissimi archi sì ineguali niente toglie alla giustezza del mezzogiorno; poiché se ’l Sole, approssimandosi la state, deve fare un giro lungo quanto l’arco diurno del giorno passato, e di più deve scorrere un altro pezzetto d’arco per arrivare al suo occaso, perché s’innalza sopra di noi, ne viene che il tramontar del Sole non seguirà che dopo il tempo necessario a passare quel resto d’arco diurno, maggiore dell’arco diurno del giorno passato. Risguardo poi al meriggio, nulla importa che il Sole scorra su archi diurni più o meno lunghi, poiché allora egualmente sarà meriggio, quando è nel piano del meridiano, che rade e taglia tutti gli archi e li divide in due parti eguali, corti o lunghi ch’essi siano.
Noi allora solo vediamo il Sole quando è sopra il nostro orizzonte. Se il Sole si ferma poco tempo sopra d’esso, o sia se l’arco che vi descrive è piccolo, sparisce presto da noi. Ma se l’arco diurno è più lungo, cioè se il Sole si trattiene molto sul nostro orizzonte, allora il giorno è più lungo. L’orizzonte degli abitatori della zona torrida taglia egualmente tutt’i circoli diurni che il Sole descrive dal tropico del Cancro a quel di Capricorno; onde per essi il Sole, che loro è sopra a perpendicolo, descrive in tutto l’anno archi eguali; i loro giorni e le loro notti dunque sono sempre eguali, cioè di 12 ore; cioè il Sole nasce e tramonta presso a poco all’istess’ora, ed ivi l’orologio italiano non avrebbe che gl’inconvenienti dell’oltremontano.
Noi che riceviamo il Sole obliquo, e che siamo lontani dall’equatore gradi 45 5/12, ossia minuti 25’,[177] abbiamo un orizzonte che stendesi di là dal Polo artico e ristringesi verso l’antartico, e però diversamente taglia i circoli diurni, rimanendo il Sole d’inverno sul nostro orizzonte 7 ore meno che non faccia d’estate. I Groenlandesi, i Samoiedi, i Lapponi al cerchio polare, che sono distanti dall’equatore 66 gradi, e vicini al Polo di 24 gradi, hanno un orizzonte più inclinato all’equatore, e che sì diversamente taglia gli archi diurni, che essi non vedono il Sole nel solstizio d’inverno per lo spazio di 24 ore, e nel solstizio d’estate lo vedono 24 ore di seguito, cioè per 24 ore il Sole non tramonta mai, ma gira loro all’intorno. Sotto il Polo l’orizzonte è lo stesso equatore; onde per tutto il tempo che passa dall’equinozio di primavera a quello d’autunno, cioè per i sei mesi che il Sole fa il suo giro di qua dall’equatore verso il tropico di Cancro, loro sempre è visibile.
Ora prendiamo un poco questo nostro orologio italiano, che pur potrebbe passare sotto l’equatore, e trasportiamolo al cerchio polare. Come lo regolaremo noi, volendo che segni giusto il tramontar del Sole, che sta ivi nascosto per 24 ore e per altrettante è visibile? Come ce ne potremo noi servire vicino al Polo con un giorno di quasi sei mesi? Quanto più dunque ci scostiamo dalla zona torrida, tanto più instabile riesce il tramontar del Sole, ed inutile l’uso dell’orologio italiano. All’incontro l’oltremontano è sempre eguale così sotto la zona torrida come vicino al polo, siasi l’artico o l’antartico; poiché, o vedasi il Sole per 12 ore come sotto l’equatore, o per quindici e mezzo come in Lombardia, o per ventiquattr’ore come al cerchio polare, o per quasi sei mesi come vicino al polo, o per altrettanto tempo stiasi egli nascosto sotto l’orizzonte, sempre però egli fa il suo giro apparente, e sempre impiega quel tempo che di sopra accennammo a compiere il suo corso ed a ritornare al meridiano d’ond’era partito.
Sembrami d’avere dimostrati gli avvantaggi dell’oriuolo oltremontano e la variazione dell’italiano con quella maggior chiarezza che possasi avere dove trattasi d’astronomia. Ora abbandono la sfera, e mi faccio a considerare qual delle due maniere di misurar il tempo abbia più comodi, anche nel caso che fossero egualmente esatte.
Ho di sopra paragonata l’epoca della misura del tempo a’ linguaggi. Ora richiamo di bel nuovo questo paragone, ed interrogo: se tutti gli Europei, eccettuatane solo una nazione, si servissero d’un medesimo linguaggio, non sarebbe ella irragionevol cosa il rigettarlo e l’ostinarci a servirci d’un altro, il quale, quantunque fosse ugualmente espressivo, non sarebbe mai universale? E poiché niente ci costerebbe d’incomodo l’addottare l’orologio oltremontano, perché mai vorremo usar del nostro, che a nulla più serve, appena passati gli angusti confini del nostro Stato? Non sono i soli oltremontani che per principio della misura del giorno prendano il meriggio. Quasi tutti i popoli a noi vicini se ne prevalgono. Alcuni Stati anche dell’Italia hanno saputo stendere i comodi della vita anche sulla misura del tempo. Col mezzo giorno regolansi gli orologi nel Gran Ducato di Toscana, negli Stati di Modena e Reggio, in tutto il Piemonte, ne’ Ducati di Parma e Piacenza. E questa sì utile mutazione s’è da poco tempo introdotta con tutta la facilità e coll’universale approvazione.
Ma qui taluno degli ostinati adoratori degli usi ereditati se leggesse il Caffè, benché mosso dalle addotte incontrastabili ragioni nell’interno dell’animo, pure con un riso indicatore di disprezzo o compatimento esclamerebbe: e che mai ci viene costui a parlare di facilità di regolar l’oriuolo col mezzo dì? Passi perciò che risguarda la giustezza d’esso; il voler però discorrere di facilità di regolarlo è una somma impudenza. Chi non vede che il popolo non arriverà mai ad intender l’ore all’oltremontana? Chi non vede la difficoltà di regolar l’oriuolo col meriggio che da nissuno si scorge? Laddove il tramontar del Sole e l’oscurità della notte sono un punto sensibile e certo. Potremmo, è vero, prevalerci delle meridiane; ma dove trovarle esatte? Dove rinvenirle in vista al pubblico? Dove trovarle ne’ villaggi e nelle montagne? Come a regolar ci avremo ne’ giorni nuvolosi, sì frequenti in questo nostro clima? Lasciamo una volta quel vizio di biasimare gli stabilimenti antichi e d’introdur nuove usanze, sempre detestabili perché nuove; e poiché abbiamo così vissuto fin ora, potremmo bene continuare sullo stesso piede.
Sottili ragionamenti sono codesti, e provano certamente in chi li produce una rara perspicacia di spirito. Io confesso, la novità di qualunque cosa, comecché ottima, dovere da certuni biasimarsi. Per altro se i virtuosi nostri antenati avessero tanto abborrita la per essi nuova introduzione de’ cammini da fuoco, di ben riparati ed adagiati cocchi, di usci e finestre più adattate, dell’uso della
IL CAFFÈ )( Fogl. XXXV )(
scorza del Perù, chiamata china, dell’unzione del mercurio ben preparato, dell’ago magnetico per la navigazione; se, per finirla, avessero costantemente rigettate queste novità, noi ci scalderemmo, o piuttosto ci affumicheremmo, ad un fuoco posto in mezzo d’una stanza; incomodi sommamente sarebbero i nostri viaggi; e siasi sortendo da casa, o in casa ancora, non sarebbevi riparo contro la inclemenza della stagione, né a nostra voglia guarirebbesi dalla febbre terzana e d’altri malori, né ad appagare la moltitudine de’ nostri bisogni fattizi ci apporterebbe a vil prezzo il sicuro marinaro le droghe e derrate straniere.
Ma poiché l’uso di misurar il giorno col meriggio non è nuovo in Europa, e l’utilità d’una cosa deve considerarsi, non la sua antichità, proseguiamo ad esaminare senza parzialità gli avvantaggi e i difetti delle due misure del tempo.
Se l’uniformità è sempre desiderabile in qualunque siasi cosa, sembrami che particolarmente abbia a ricercarsi nella distribuzione delle ore; in modo che in ogni stagione lo stesso numero d’ore ci avvisasse de’ doveri assegnativi. Ora io considero tutte le pubbliche incumbenze solersi in tutti i mesi dell’anno spedire alcune ore prima o dopo il mezzo giorno, né v’è a mia notizia uffizio alcuno che sogliasi sempre fare poco prima o poco dopo le ventiquattr’ore, e quand’anche ve ne avesse qualcuno, la sera ci avvertirebbe più sicuramente che i nostri oriuoli non possano fare. Varia è fra noi l’ora di recitar mattutino e celebrare l’ultimo sacrifizio della Messa, sicché ed i nostri ecclesiastici hanno sempre a consultare il calendario, e gli o sovverchiamente pigri o troppo affacendati sono in un’inquieta incertezza del quando dirassi l’ultima Santa Messa; e nelle pubbliche feste, nelle conversazioni de’ giovedì, de’ sabbati e nelle vigilie si tiene sempre un almanacco in mano per vedere fino a qual ora possansi mangiare cibi grassi, o quando termini la per alcuni importuna giurisdizione del sabbato e delle vigilie; e contendesi dell’ora precisa della mezza notte. Tutto ciò fammi sentire il bisogno d’esser avvertiti de’ due punti, meriggio e mezza notte. Punti che sono certi e non visibili al volgo, e allo stesso volgo necessari a sapersi. Laddove inutile ci è l’avviso dell’approssimarsi la notte, punto visibile per sé, e vario ed incostante a segno che alle ore 23 e minuti 50, egualmente come dieci e venti minuti ancora dappoi, sentesi dire essere ventiquattr’ore.
Che se parlasi della difficoltà d’intendere questa nuova partizione di tempo e di rinvenire il punto del meriggio, non è egli cosa ridicola il trovar difficile in Milano ciò che sì facilmente praticasi per tutta l’Europa, e s’è recentemente introdotto in molti Stati d’Italia? Non è egli vero che que’ che abitano vicino al Palazzo Ducale od al Castello così bene comprendono le ore oltremontane che vi suonano, come farebbe un tedesco od un francese? Né qui in Milano o in altre città d’Italia mancano meridiane, e quando una sola ve ne fosse per città, essa darebbe regola ad un orologio che servirebbe di modello a tutti gli altri; e se pur anche non ve ne fosse alcuna, la necessità d’averla ne farebbe delineare quante si vuole. Che se vogliasi provedere al comodo degli abitatori delle campagne, porzione la più utile e più rispettabile della nazione, con qual facilità non costruirebbesi un orologio a Sole sulle pareti della parrocchia, che regolasse l’oriuolo a campana? E come non vi s’introdurrebbe quest’usanza, giacché essi per lo più non sogliono misurare il tempo co’ nostri oriuoli, ma col contare tante ore prima o dopo il meriggio e la mezza notte? Quanti sottilissimi mezzi non ci somministra l’astronomia per iscoprire il primo col Sole e la seconda colle fisse? E per una irrefragabile prova di ciò piacemi di qui soggiungere una spedita non meno che sicura maniera di rinvenire il mezzo dì.[178]
Su d’un piano orizzontale esposto al meriggio s’alzi un ago perpendicolare, ed intorno ad esso preso per centro si descriva uno, o per maggior cautela due o tre cerchi. Questo cerchio sia di tal grandezza che allorché è mezzo giorno, ed il Sole più alto renderà più corta l’ombra del gnomone, questa abbia a cadere dentro il circolo. Alla mattina ed alla sera l’ombra sarà tanto estesa che caderà fuori d’esso. Quest’ombra verrà dunque nel suo giro a tagliare in due punti il cerchio, uno alla mattina, l’altro alla sera. Verso il solstizio d’estate, per dare alla linea una perfetta determinazione, perché allora le altezze del Sole sono sensibilmente le medesime in punti egualmente distanti dal meriggio, si notino i due punti già accennati, e da questi tirinsi due linee al centro. L’angolo da esse formato si divida per metà con una linea, che anderà a tagliare per metà l’arco compreso tra i due punti segnati. Quella linea sarà una meridiana, alla cui giustezza non mancherà che di ripetere lo stesso esperimento per due o tre volte per accertarsi d’averlo eseguito con tutta l’esattezza.
Io non pretendo d’avere scritto per gli uomini colti: quest’è il motivo per cui ho sacrificato tutto alla chiarezza, ed hommi sempre proposto d’esser piuttosto diffuso che oscuro. Che queste mie riflessioni ottengano cambiamento nell’epoca degli orologi o non l’ottengano, a me nulla importa. Io sono, della qualunque siasi mia fatica nello stenderle, abbastanza ricompensato coll’avvantaggio d’avermi sviluppate e disposte con qualche metodo quelle idee che aveva sopra questa materia. La mia istruzione sarà sempre l’unico immancabile scopo e premio de’ miei studi.
L. [Alfonso Longo]
Le maschere della commedia italiana
Il nostro buon Demetrio si è lagnato con noi, perché da tanto tempo non si faccia più menzione della sua persona in questi fogli; e per dirla, il nostro buon Demetrio, che ci dà un caffè sì squisito tutti i giorni, che è tanto ragionevole e discreto con tutti, ha ragione di lagnarsi della dimenticanza nostra. Nella scorsa settimana si venne a parlare nella bottega della compagnia de’ commedianti, delle diverse rappresentazioni che si sono fin ora fatte, di quelle che si devon fare, e cose simili. Siete per altro curiosi voi altri Italiani, prese a dire Demetrio, e per verità non so come possiate giustificare il gusto vostro nella scelta delle maschere che avete riposte sul teatro. Lasciamo a parte il Pantalone, che almeno è una figura caricata bensì, ma finalmente figura umana; ma come v’è venuta in capo la fantasia di vestire due personaggi in guisa che abbiano la testa da moro e le mani da bianco, e che questi due mori sieno due originari bergamaschi? Come malanno v’è venuto in capo di fare un Dottore che ha nero il naso e la fronte, e bianco il restante del volto? Per verità, soggiunse, non so trovare né ragionevolezza né origine di sì fatti mostri che avete fissati su i teatri, e che pure su i teatri rappresentano la parte di uomini. Bel bello, amico Demetrio, rispos’io, voi siete greco, e voi altri greci, e particolarmente Greci caffettieri, in fatto di erudizione non potete vantarvi di saperne molta. Ascoltatemi per poco, che potrò forse soddisfarvi.
L’uso di rappresentare sul teatro colla maschera al viso è della più remota antichità teatrale e nella vostra Grecia stessa, ne’ suoi bei giorni, nessun atto si presentava sulle scene altrimenti che colla maschera. Di più. Nell’antica commedia erano le maschere talmente costanti, che v’era la maschera dell’avaro, la maschera del parasito, la maschera del servo fedele, la maschera del servo astuto; cosicché al solo presentarsi l’attore sulla scena con quella maschera, prima anche che parlasse, sapevasi il personaggio che doveva rappresentare; siccome appunto anche fra di noi tutte le maschere d’Arlecchino hanno la medesima figura, tutte le maschere di Brighella, Dottore e Pantalone si rassomigliano per tal modo che nessuno s’aspetta delle dappocaggini dal Brighella o delle astuzie dall’Arlecchino. Cominciamo dunque, Demetrio, a stabilire che il costume d’aver maschere invariabili adattate a un certo carattere viene dalla veneranda antichità de’ teatri greci e romani; e crediatemelo sulla parola, se non volete che vi faccia venire per la posta una eruditissima dissertazione con mille e più citazioni in margine che ve lo provino.
Erano presso i Romani antichi due professioni distinte, quella del commediante e quella del mimo. I mimi avevano la faccia nera, e si mostravano sul teatro fuligine faciem obducti; né accostumavano già essi di comparire sulla scena con calzari rilevati come i commedianti, ma sibbene senza taloni alle scarpe, e perciò avevano il nome di mimo, come ci attesta Diomede: Planipes graece dicitur mimus, adeo autem latine planipes, quod actores planis pedibus proscenium introirent. Eccovi dunque, Demetrio mio, che l’Arlecchino e il Brighella s’assomigliano già a due mimi antichi, e per la faccia bruna, e per la immutabilità della loro maschera, e per i calzari. Ma ciò non basta ancora, direte voi; convien provarmi che anche l’abito del corpo fosse simile presso gli antichi. Benissimo; ed io vi proverò che de’ mimi antichi ve n’erano vestiti appunto come l’Arlecchino nostro. Leggete quel passo d’Apuleio, dove dice: Num ex eo argumentarere uti me consuevisse tragoedi syrmate, histrionis cocota, mimi centuclo. Notate che al mimo si dà per distintivo il centuclus, cioè il vestito di cento pezzi di vari colori, il vestito in somma d’Arlecchino. Di più ancora Vossio nelle Instituzioni poetiche c’insegna che Sanniones mimum agebant rasis capitibus, e notate qui due cose: la prima, che Sannio e Mimus erano dello stesso mestiere; la seconda, che l’Arlecchino e il Brighella si chiamano per antichissima tradizione anche a’ dì nostri Zanni; e Zanni è una voce corrotta da Sannio. Prendetemi dunque un mimo con capo rasato, con faccia annerita, con vestito di vari pezzi a più colori, con scarpe piane, dategli il nome di Sannio, come lo troviamo presso gli antichi, e dubitate se è possibile che questo mimo non sia lo stesso stessissimo del nostro Arlecchino.
Dunque, direte voi, potrem noi credere che il grave Porzio Catone, il grave Marco Tullio Cicerone e sì fatti gravi uomini abbiano veduto l’Arlecchino sulle scene di Roma? Signor sì, che lo potremo credere; ne volete una dimostrazione che Cicerone lo ha veduto? Leggete il libro De oratore, dove descrive l’Arlecchino fedelissimamente con questi termini: Quid enim potest tam ridiculum, quam sannio est, qui ore, vultu, imitandis motibus, voce, denique corpore ridetur ipso! Dubiterete voi dopo ciò che i due Sanni o Zanni della commedia nostra non sieno un avvanzo del teatro antico, trasmessoci senza interruzione dai tempi della repubblica sino ai nostri? Potevano bensì restar oppresse e la tragedia e la buona commedia dai secoli della barbarie in cui fu avvolta l’Italia, ma quel grossolano piacere che ogni più rozza nazione prova co’ spettacoli mimici non si volle mai proscrivere nemmeno nei tempi della maggiore ignoranza, e pare molto verisimile che mentre il teatro d’Italia si perdeva, restassero nondimeno le buffonate mimiche o sulle piazze o in qualche luogo destinato ai spettacoli, e di ciò ne troviamo memoria sino al secolo XII.[179]
Va bene, disse allora Demetrio, voi m’avete impressa nel mimo una profonda venerazione per l’Arlecchino e il Brighella, e rendo onore al vostro talento per fare le genealogie e nobilitare le origini: ma non vorrete già provarmi che il Dottore e il Pantalone sieno d’una sì antica prosapia. No, Demetrio, rispos’io. L’origine del Dottore non oltrepassa il secolo duodecimo, quando Irnerio aprì in Bologna la nuova scuola della giurisprudenza, sulla quale si regge anche al dì d’oggi buona parte dell’Europa. Io credo nata la maschera del Dottore quando i due celeberrimi dottori Bulgaro e Martino disputarono se tutto il mondo fosse dell’Imperatore a solo titolo di proprietà, ovvero anche di usufrutto; e certamente vi voleva una maschera col naso nero, la fronte nera e le guance rosse per rappresentare al naturale un uomo che disputa se tutto l’universo sia d’un solo uomo per proprietà ovvero per usufrutto; ed alcuni eruditi pretendono che il dono di questa maschera sia stato forse il più fortunato che gli uomini abbiano ricevuto dalla scuola d’Irnerio.
Del Pantalone non ci avete fatto rimprovero, o Demetrio; pure, per dirvene una parola, io credo che verso la fine del secolo XIV, o al principio del XV, sia stata accresciuta al nostro teatro questa maschera, nel tempo in cui il vastissimo commercio de’ Veneziani faceva colare nel solo Stato di Milano l’annua somma di zecchini seccento novanta cinque mila per altrettanti lavori di lana che si trasmettevano a Venezia, d’onde si vendevano poi in Levante; del che potete assicurarvi leggendo la disputa contemporanea del doge Tommaso Mocenigo riferita dallo storico Sannudo nel Rerum italicarum scriptores, tom. XXII, pag. 954.
Demetrio si mostrò persuaso delle mie ragioni, e mi pregò di riporle nel foglio, come ho fatto.
P. [Pietro Verri]
Sin tanto che la commedia esporrà su i teatri i vizi degli uomini, poco ne sarà sempre il frutto. Declami sin che vuole il poeta comico o sferzi col terribile flagello del ridicolo l’avaro, l’ipocrita, il sanguinario, il giuocator di mala fede; nessuno di questi l’ascolta. Se ne sta l’uno contando le sue monete, se ne sta l’altro col collo torto truffando il suo prossimo; questi fa un’ingiusta pace di paroli; quell’altro carica le sue pistole; hanno ben da fare costoro, che venire alla commedia! Meglio è, cred’io, il prender di mira i difetti, non i vizi degli uomini.
[Pietro Verri]
Ai giovani d’ingegno che temono i pedanti
Io credo che ciò che constituisce la massima differenza fralle bell’arti e le arti meccaniche ciò sia, che per riuscire eccellente in quelle si richiegga uno spirito che più ricerchi le bellezze di quello che non tema i difetti, laddove il talento che più teme i difetti anzi che cercar le bellezze è quello che fa distinguere nelle arti meccaniche. Un orologiaro, un macchinista qualunque deve principalmente curare che nessuna parte scabrosa o trascurata rimanga del suo ordigno, anzi che adornarlo d’altri vezzi nuovamente ritrovati; che se tal legge sia la norma dello scultore, del pittore, del poeta e dello scrittore, tu vedi agghiacciarsi la mano dell’artefice, pentirsi, ripentirsi e lasciare alla fine un freddo, un affettato, un insipido lavoro. Chi è destinato ad operar colla lima, tema che ogni superficie non sia perfettamente levigata, che ogni costa non sia perfettamente affilata, e chiamando con ogni sforzo tutta l’anima agli occhi, lavori, e sudi, e non si stanchi per giunger alla perfezione; ma colui che assistito dalla natura di un’anima più elevata ed una più fertile immaginazione, esercita una di quelle che con universale vocabolo chiamiamo belle arti, intraprenda ed ardisca, né tema i difetti servilmente, ma secondi quel caldo genio che lo agita e vada con una sorta di feroce talento a carpir le bellezze dell’arte. Le bellezze allogiano vicine ai difetti, e qualunque volta una cosa insipida ricerchi di animare, la spingi appunto verso i difetti; e se di più la inoltri, la inzuppi di follia. I più sublimi tratti d’eloquenza, le più grandi e tragiche espressioni della pittura, le più appassionate inflessioni della musica, il sublime in somma in ogni cosa d’immaginazione è sempre all’orlo del ridicolo e della caricatura; un grado che vi si aggiunga ve lo porta. Un tal linguaggio è sconosciuto a tutte le anime fredde o incallite sotto il giogo della pedanteria; in vano cerchi da esse quel giudizio delle cose che nasce dalla squisita sensibilità e da una sorta di reazion del cuore: se di sì fatti principii con essi ragioni, tu fai lo stesso che parlando di musica al sordo o di pittura al cieco: manca in essi il sensorio, né il ragionamento tuo lo può far nascere.
Nella organizzazione degli uomini v’è qualche cosa di simile a quello che la fisica ci dimostra nell’armonia, cioè che al suono d’una corda le altre che con lei consonano fremon tutte; ma se a questo fenomeno si presenti uno stromento discorde, non ne vedi alcun effetto. Proverem noi a una corda stonante che ora è il tempo di scuotersi? Lo stesso dì de’ pedanti generalmente. Costoro non s’inducon mai a giudicar buona o cattiva una cosa qualunque, perché provino al suo effetto una emozione aggradevole o disgustosa; ma chiaman buono quel che somiglia a un tal modello che si sono prefisso per il modello del buono; chiaman cattivo tutto ciò che da questo si allontana.
Se alla voce d’un oratore, se ad una scena di teatro tu vedi cader le lagrime agli uditori, sappi che queste lagrime sono una matematica dimostrazione dell’eloquenza dell’oratore e della bellezza del dramma. Lascia pur che il pedante di marmo resti solo insensibile, e ti citi una farragine di testi e d’autori di lingua; lascia pur che ti scagli contro le autorità mal intese d’Aristotile, di Quintiliano e d’Orazio; lascialo sminuzzar pezzo a pezzo l’orazione, o la favola, e trovarvi quelle macchie le quali provan che ha de’ difetti, quelle macchie delle quali Orazio non s’offendeva, non ego paucis offendar maculis. Se dopo ciò si ripeta o l’orazione o il dramma, vedrai il ghiacciato pedante pianger di rabbia, perché tutti i sensibili spettatori piangono una seconda volta di tenerezza.
Ma se tu tremi, e se colla penna in mano non sei tu il primo commosso da quel sentimento che vuoi eccitare in altrui, come potrai mai farlo nascere? Se mentre nell’agitata fantasia ti si devono destar le idee, il gelato flagello della pedanteria ti fischia sul capo, e t’innoridisci per tema di non derogar con qualche vocabolo, con qualche frase, all’implacabile autorità de’ parolai, come potrai mai sollevarti dalla mediocrità?
Un uomo, che avea le gambe rattratte dalla podagra, sì che giacea immobile da più anni a sedere, scrisse un compiuto trattato sull’arte di ballare, e con somma fatica s’ingegnò di dimostrare qual uso dovesse farsi ora del tendine d’Achille, ora d’altro muscolo, e come il centro di gravità del corpo umano cader dovesse ora sul calcagno ed ora sulla parte più molle della pianta del piede, e così dicendo. Si fec’egli portar in teatro, dove un eccellente ballerino, ignorantissimo nella scienza de’ muscoli e della statica, rapiva gli applausi di ognuno colla grazia e colla maestria dell’arte: il povero podagroso cercava di far popolo, e strillava, e citava, e dicea molte villanie in buona lingua; ma gli spettatori abbandonavansi alla seduzione dell’eccellente pantomimo, e lasciavano dissertar solo sul ballo l’uomo delle gambe fasciate; per il che prese al gottoso talento di scrivere un libro, e gli diè il sonoro titolo La cannonata teatrale. Questo libro fu ripieno di assai podagrose idee e di assai lepidi sillogismi, co’ punti e virgole religiosamente a lor luogo, per lo che pomposamente vi spiccava la maestà grammaticale. Ei nel suo libro s’era proposto d’insegnare la vera arte del ballo a tutta l’Italia; e l’Italia imparò la vera arte di ridere. Ma come la uniformità del ridicolo annoia, sul punto in cui stavano i leggitori per provar quest’ultimo sentimento, gli rimontò la podagra sino alle mani, e cessò di scrivere. Fortuna per il ballo che i pedanti ballerini son rari, quanto frequenti sono i pedanti delle lettere.
Chiunque si determina a coltivar qualch’una delle belle arti, se non ha quella delicata sensibilità che fa provare un raccapriccio, e scorrere per le vene un dolce freddo in tributo ai colpi maestri dell’arte, non farà mai nulla di buono. Nelle scienze e nelle cose di puro ragionamento il miglior giudizio è quello che si dà dopo un maturo esame; ma se nell’eloquenza, nella poesia, nella pittura, nella musica tu pensi prima di esclamare: bello! buono!, o l’artefice non vale, o non vali tu stesso; poiché succede lo stesso effetto o che tu sia straniero alle cose, o che le cose sieno straniere a te. Non vi perdete, o giovani di talento, a compilar precetti, non siate paurosi nelle bell’arti; lasciate che sfuggano alcuni difetti, purché sieno ricompensati da molte bellezze. I tratti che vi proponete da imitare sian quegli che fan nascere in voi l’emozione; non temete, e non badate a que’ sgherri, a quegli assassini della letteratura ch’io chiamo pedanti; seguite franchi il buon genio che vi guida, e sia questo costantemente l’intimo sentimento. Non v’arrossite di far degli errori; le più belle cose degli uomini ne hanno; le sole mediocri possono non averne, perché le mediocri sole son fatte a sangue freddo; lasciate ai meccanici temer gli errori, voi temete i precetti de’ pedanti, e contenti di quella venustà che danno sempre le buone idee allo stile, e di quella coltura che allontani la lingua vostra dalla barbarie, scrivete, e attraverso del gracchiare di que’ pedanti che cercarono d’avvilire Orazio, che giunsero a far impazzire il troppo compiacente Torquato Tasso, seguite tranquillamente la vostra carriera. Hoc habet ingenium humanum ut cum ad solida non sufficerit, in vacuis et futilibus se atterat. Bac., De aug. scien.
P. [Pietro Verri]
IL CAFFÈ )( Fogl. XXXVI )(
Lo spirito di società
Recede in te ipsum quantum potes, cum his conversare qui te meliorem facturi sunt. Seneca, epist. 7.
Fra le tante cose utili alla società degli uomini che ha prodotte l’universale coltura del secolo presente, deve annoverarsi una certa fratellanza che s’è introdotta da uomo a uomo. I nostri ruvidi antenati se ne stavano racchiusi ne’ solitari loro castelli, sempre Guelfi o Ghibellini, anche cessato che fu il bollore di quelle orrende fazioni che per più di due secoli furono la più seria delle nostre pazzie. Pieni di selvatichezza e d’ignoranza, si guatavano l’un l’altro sospettosamente; nessuno spirito di società, nessuna dolcezza di costumi, nessuna amorevolezza o pulitezza di maniere sembra che regnasse fra loro. Sicari, veneficii, clandestini massacri, inestinguibili inimicizie furono le imprese de’ più potenti in que’ secoli di barbarie, ch’altri chiama i tempi della buona fede. La nobiltà tutta d’Europa aveva tai costumi verso il secolo millesimo e li conservò per lungo tempo dipoi. Di un’ingiuria, di un privato atto d’inimicizia ne trasmetteva il padre la vendetta a’ suoi descendenti: quindi da famiglia a famiglia risse e contese crudeli senza fine. Sanno gli eruditi che a tal segno giunsero queste inimicizie private, chiamate faide negli antichi cronisti, che dovettero i Concili intimare di tempo in tempo le tregue di Dio, così dette perché facevan tregua alle private vendette, che solevano proibire per alcun tempo. Queste tregue di Dio si proclamavano per lo più o nelle occasioni di qualche pubblica letizia, o ne’ tempi destinati particolarmente alla divozione, come di quaresima, giubilei, nozze di principi e simili. Le antiche case di campagna de’ nobili hanno tuttavia le ruine della passata crudeltà, cioè de’ trabocchelli, che ora grazie al Cielo ad altro non servono che di monumento esecrabile della barbarie de’ nostri antichi padri. Né moltissimo sono da noi distanti que’ tempi funesti: ognun sa di quale umore fosse il conte Porrone, la di cui vita è stampata, e ciò che v’è di singolare in essa si è che l’istesso autore, che racconta le non poche di lui crudeltà, le difende ancora e ne fa elogio come frutti d’un animo generoso. Tal era l’idea del giusto e dell’onesto che in faccia al pubblico veniva autorizzata colle stampe. Ora, a gran fortuna del secolo, l’umanità ha ripresi i suoi diritti. Ma non vi sarebbe per avventura qualche altro male in questa novella maniera di vivere? Siamo ben lungi dagli stiletti, e dal veleno, e dai trabocchelli, e faccia il Cielo che più non ritornino sì mostruose invenzioni; ma sonosi cangiati gli orridi costumi antichi così vantaggiosamente che non si abbia se non se guadagnato nella mutazione? Questa domanda mi fa risovvenire d’una espressione del signor De la Bruyere, ed è che gli uomini sono talvolta come i marmi ben tagliati, cioè lisci lisci, ma duri. Con che vuol egli dire che non sempre vera e reale è la coltura e l’umanità de’ costumi, ma bensì apparente. Per me altro non dico, se non se che non può chiamarsi vero spirito di società quello che in altro non consista che in un continuo dissipamento di noi stessi, ma bensì quello che ha per mira quella onesta comunicazione fra gli uomini, per cui tendono a rendersi vicendevolmente la vita più dolce, più aggradevole e più felice. Onde non tenderà a tal fine né il continuo rumoreggiare della grande società, né que’ solenni perditempo chiamati convenienze, offici e pesi necessari per chi vive in società; ma al contrario quello spirito quasi direi di famiglia e quella urbanità di maniere che nasce dalla voglia di piacere altrui. Onde se gli antichi erano troppo selvaggi, forse i moderni sono troppo socievoli; perché il cuore umano è capace di una data quantità di benevolenza; che se questa benevolenza è troppo espansiva di sé, s’ella troppo si sottodivide in minime porzioni, conviene ch’essa manchi talvolta dov’esser vi dovrebbe, e che vi sia dove non vi dovrebb’essere. Io mi spiego. Un uomo che faccia professione d’esser intimo amico di cento persone, conviene che non lo sia veramente di nessuna. Da qui ne viene che lo spirito di amicizia, dolcissimo sentimento, e uno de’ pochi innocenti beni di quaggiù, non sia per lo più che un nome vano; che tanti ossequiosissimi servitori, tanti divotissimi schiavi, tanti rispettosissimi ed amicissimi sino alle ceneri non siano che indifferentissime creature, che vanno ripetendo metodicamente per professione queste superlative menzogne. Da qui ancora ne viene che lo spirito di famiglia s’annienta e s’estingue, poiché gli affetti racchiusi una volta o nelle domestiche mura od in un piccolo e scelto cerchio d’amici, ora diffusi per tutti i canti della città, in tutte le case e sopra tutto il genere umano se fosse possibile, hanno sciolti que’ sagrosanti nodi, quelle umanissime benevolenze di famiglia, che tanto rendono il cuore umano buono e benefico. Dove, per fine, fassi professione, senza scelta e senza fine, di farsi un amico in tutti gli uomini, non se ne può fare veramente nessuno; e perciò ne’ paesi ne’ quali si sa gustare il piacere dell’amicizia e della società, non si ritrova quella sfrenatissima smania d’esser l’amico universale. Non sono fuori del mio proposito le riflessioni di un selvaggio del Canadà andato a Pekino. Questo, vedendo per la prima cosa inginocchione que’ cittadini nella pubblica piazza di quella capitale, uno in faccia dell’altro, domandandosi mille scuse e mille perdoni, ceremoniandosi come sconci scimiotti: Oh, disse quel selvaggio, vedi quanto bene si vogliono queste creature; che sian pur benedette! Gli uomini del mio paese non s’amano in tal guisa; ella è pure una bella cosa l’esser pekinese! Un suo amico pekinese ch’era con lui gli rispose: Oh voi v’ingannate, signor don Canadà. Vedete là quei due, che s’abbracciano teneramente e si stroffinano il viso co’ baci? Quei due là, vedete, quei due istessi cercano ambo una carica nel Consiglio di questa città, sono due rivali giuratissimi, sono due nemici mortali. Finiti che avranno i loro teneri abbracciamenti, andranno ciascuno da qualche pekinessa a lacerarsi vicendevolmente l’un l’altro; gli vedreste allora mutati a segno di non conoscergli più. Oh stravaganza, replicò quel buon Canadà, perché fingono essi adunque un sentimento che non hanno? Amico, caro, gli rispose il pekinese, questa vostra massima vale nulla affatto fra di noi altri uomini civilizzati, e la lasciamo tutta a voi poveri selvaggi. Poiché se questa vostra affatto strana dottrina si cominciasse ad introdurre, come la vorrebbero ammettere tanti ignoranti che non vogliono sentirsi dire che sono ignoranti; tanti mormoratori che non voglion sentirsi dire che sono mormoratori; tanti debitori che non voglion sentirsi dire che è ingiusta cosa, e degna d’esser punita dalle leggi, il vivere deliziosamente de’ pianti altrui e ’l banchettare a spese della fame e della squallida miseria de’ creditori? Voi vedete bene quanto sia necessario il non dir loro sì fatte ingiurie. Tali ragionamenti faceva colui sulla piazza di Pekino, e li faceva sotto voce, perché anche colà non si posson sempre dire tai cose impunemente. Ma quel pekinese, per far nascere nel suo selvaggio alunno altre idee un po’ più socievoli, lo pregò di seco andare in una adunanza, dove avrebbe veduto come ivi si vivesse. Lo vestì adunque alla chinese e lo condusse in casa di un mandarino, in cui si dava quella sera una veglia. Fu colpito il Canadà dalla magnificenza che ivi regnava, dallo splendore fattizio di una vasta sala che ivi imitava la luce del sole, che già aveva abbandonato l’orizzonte, da’ profumi ond’era imbalsamata soavemente l’atmosfera, dallo sfoggio di festoni, di fregi, di tappezzerie, dallo splendore e dalla varietà de’ vestiti, in somma gli parve di essere piuttosto che fra gli uomini fra gli dei. Tant’era nuovo per lui spettacolo sì giocondo a vedersi, e maraviglioso. Un confuso incessante mormorio di voci gravi, mezzane ed acute cominciò ad arrestarlo per ammirazione sulla porta. E che mai è questo rumore? diss’egli. Tale ne fa il mare nel mio paese quando cominciano i venti a turbarlo! Eh nulla affatto, risposegli il pekinese, questi signori hanno tante cose da dirsi, che non altrimenti può finir la faccenda se non parlano tutti in una volta. In questa sala, vedete, si andrà poco a poco addensando l’aria per le folte inezie che vanno sortendo di mano in mano da tutte queste bocche, finché, inzuppata ad un certo segno, si farà grave e narcotica, quindi comincieranno gli sbadigli, poi il sonno. Questi signori probabilmente diranno male di quelli che sono assenti, e partiti eglino, sopravvenendo altri renderanno loro la pariglia. Poi verso la fine ridotti a piccolo cerchio, gli amici intimi della casa avranno due orette di vivissima conversazione, nella quale si faranno le più spiritose e gentili maldicenze del mondo su di tutti quanti. Così l’un l’altro si vanno aiutando a passare alla meglio che si può quel momento di misera vita che respiriamo su questo globo. Voi mi dite cose assai strane, disse il Canadà. Ne vedrete forse di ancor più strane, rispose l’amico pekinese, e glielo disse a tempo, poiché passando in quel momento una pekinessa, che esciva dall’adunanza, guatato don Canadà con due vivissimi occhi, dimandò ad un vicino: Chi è quella sconcia figura? Egli è un Canadà, le rispose l’amico, ho l’onore di presentarvelo, madama. Oh come! Siete di quella razza cagnesca che abita l’America Settentrionale? Sì, rispose don Canadà. Si vede bene, ripigliò la pekinessa, che siete di quel paese, perché non sapete le creanze, e se le aveste sapute non ignorereste che alla soavissima e risplendentissima moglie del principe di Ucam non si risponde senza darle i suoi titoli; e poi dispettosetta se ne andò. Pensate come restasse il povero selvaggio, e quanto strana trovasse l’ira di madama la pekinessa! Ma l’amico lo tolse alle sue riflessioni facendolo attraversare là fra gli urti e l’ammirazione di tutti quelli che lo guatavano come un animale dell’altro mondo; lo presentò alla padrona di casa, che se ne stava agiata su di un sofà. Ella era attorniata da un cerchio di persone, gli occhi de’ quali furono tutti rivolti in un punto sulla figura del selvaggio. Chi può dire le riflessioni che succedettero ad un breve silenzio? Chi è quella figura? chi è quel babbuino? chi è quel brutto animale? Altro non udivasi risonare per tutta l’adunanza. L’amico pekinese era ben mortificato di tale accoglienza. E come: tale è l’ospitalità de’ Pekinesi?, disse all’orecchio all’amico il Canadà. Ma, gli rispose, bisogna sapere che qui non si sono mai veduti Americani. Ebbene gli hanno da dileggiare perciò…? Senza dubbio, rispose l’amico; gli uomini socievoli hanno una sì fatta convulsione ne’ nervi risori, che ridono sempre anche quando sono divorati nel profondo dell’anima da’ più tristi rancori. Ma intanto che tal dialogo facevano que’ due, si avanzò uno e chiamò: Di grazia, il signore di che paese è? Canadà, gli disse. Oh bella, Canadà è vostra eccellenza! esclamò un bello spirito. Oh, disse un altro, che diamine di figura! Eh signor Confusio, disse un altro tale, senta, questo signore è Canadà! Oh miseria, Canadà! E così a poco a poco tutti quanti esclamarono: Un Canadà! Un Canadà! Siete curiosi voi altri Pekinesi, disse naturalmente l’americano; se uno di voi venisse al mio paese, non vi sarebbe alcuno che si maravigliasse di sua persona, come ora voi fate di me. Vi guarderemmo come un animale diverso da noi d’abito e di colore, e nulla più, e vi lasceremmo vivere in pace. Oh questa è bella, disse un lepido ingegno della compagnia, volete paragonarvi a noi, voi signor selvaggio? E già il povero don Canadà cominciava ad avere l’idea della noia, onde lo salvò dall’altrui indiscretezza il suo amico traendolo in disparte, e per sua consolazione gli disse: Sappiate amico caro, che vi sono certi uomini fra di noi che si chiamano filosofi, cioè amanti della verità; questi tali fanno a questo mondo la figura che fate voi in quest’adunanza: quella ammirazione che reca un selvaggio da noi lo reca ancora un filosofo. Ma intanto che questa conversazione si tenea da loro in disparte, si portarono nella sala alcuni giuochi. Cessò a poco a poco il tumulto delle garrule voci, e quasi tutti a due, a tre, a quattro, a cinque in varie parti intorno le tavole si raunarono. Successe un pensieroso e tristo silenzio al furore della lingua. Rimase a tal cangiamento attonito don Canadà; misurò con uno sguardo que’ diversi manipoli de’ giuocatori, e rivolto al suo pekinese: Cos’è questo silenzio, dissegli, agitasi forse qualche serio affare di Stato? Non già, risposegli, questi signori sono occupati al giuoco. E che è mai questo? ridisse don Canadà. Ma questo, lui disse l’amico, è una spezie di commercio, nel quale si può perdere e vincere danaro, secondo la buona o cattiva fortuna; questo divertimento piace tanto che alcuni vi ruinano sé e la loro famiglia. E questo lo chiamate divertimento, disse con sorpresa l’americano, e come lo può essere quello in cui v’è pericolo di uscirne mendico per tutta la vita? Ma che volete che faccia tutta questa gente, gli disse ancora il pekinese, qui tutta sta notte? Parlano, urlano, ridono, s’annoiano, si lamentano del caldo e della cattiva stagione, contano novellette, tutti le odono sbadigliando, e poi tutto in un tratto cessano le idee, e che fare? Queste ed altre cose disse quel buon pekinese per sua consolazione al Canadà; ed intanto dall’adunanza ambi furtivamente sortirono, ed altrove si portarono non so se con animo di ritornarvi ancora. Tali erano le riflessioni di un americano sulla maniera di vivere in società de’ Pekinesi; e benché in tutta confidenza io le abbia sapute, non temo di comunicarle a’ miei discreti lettori, perché alla fine si sa che Pekino è poi lontano le buone centinaia e centinaia di leghe, e che non sapranno mai quello che di loro si scrive qui da noi. E poi se mai lo sapessero, son così buoni que’ Pekinesi!
In somma, per ritornare da Pekino a noi, vi sono due estremi, per mio avviso, egualmente viziosi nell’umano commercio, la selvatichezza e ’l dissipamento. La prima produce la rozzezza de’ costumi, e la ferocia ancora; il secondo fa gli uomini indifferenti, e poco capaci di vera amicizia e di gustarne le delizie. Scegli, esamina chi ti sta d’intorno, non t’abbandona fra le braccia di qualunque incontri per via. Riserva i sentimenti a chi gli merita, sia la dolcezza de’ tuoi costumi reale, non apparente soltanto. Compisci gli doveri della società, ma non fatti un mestiere di spendere in inutili offici tutto il tuo tempo. Sia per fine né americano, né pekinese, che questo è il vero spirito di società.
A. [Alessandro Verri]
Demetrio ai lettori di questi fogli
Gran pazienza è stata la mia, signori miei, di lasciare che tutti que’ che frequentano la mia bottega per lo spazio d’un anno stampassero il mio riverito nome, le mie sensate opinioni, le riflessioni che mi hanno poste in bocca, senza che mai una sol volta io mi sia presa la libertà di parlare al pubblico un po’ da me stesso, e farmi intendere senza interprete. Ma in quest’ultimo foglio almeno io voglio che vi sia qualche cosa del mio… Ma ultimo foglio, direte voi, lettori cortesi, ultimo foglio; e non se ne vedranno più altri? Non è così, signori miei. Questo è l’ultimo foglio del primo tomo; ma dopo quest’ultimo foglio del primo tomo vedrete comparire il primo foglio del tomo secondo; anzi que’ galantuomini che si radunano nel mio caffè hanno più lena presentemente per ricominciare un nuovo anno caffettista di quello che non ne avessero al bel principio; e di ciò cagione ne siete voi lettori, che avete deciso tanto favorevolmente delle diverse cose che vi hanno presentate in quest’anno. Una bottega di caffè è una vera enciclopedia all’occasione, tanto è universalissima la serie delle cose sulle quali accade di ragionare; né v’è pericolo che manchi giammai la materia a chi stiavi spettatore con qualche accorgimento. Io vi prometto, lettori miei, che farò bere agli autori di quell’ottimo caffè alla greca, senza falsificarlo mai; e se a quegli autori è sfuggito qualche buon tratto dalla penna, son persuasissimo ch’egli è partito dal fondo della mia caffettiera. Che nettare, che ambrosia, che inezie della favola antica; vi vuol altro a far bollire la fantasia d’uno scrittore; il Falerno forse risvegliava le menti al tempo d’Augusto, ma le addormenta ai nostri. Caffè, caffè vi vuole; ed io ho fatta la sperienza che alcune cose, che gli scrittori del foglio hanno voluto scrivere la mattina prima di bere il mio caffè, sono d’una tempra ben diversa da quelle altre che scrissero alla sera. Farò dunque il possibile, lettori miei, per tenere in sistema il foglio, e vedrò d’indurre i miei scrittori a non prendere mai la penna se non scorre loro per le vene l’odoroso vivacissimo mio caffè profumato col legno d’aloe. Devo altresì dichiarare al pubblico che ho fatto il possibile per persuadere essi scrittori a dar ragione d’ogni discorso che pubblicavano, e come fosse nato nella bottega, e d’onde venuto; ma, lettori miei, se avete mai in vita vostra avuto a fare con uomini di lettere, avrete potuto accorgervi che hanno per particolare distintivo di voler di raro fare a modo degli altri; godi l’amico col suo difetto. Un’altra dichiarazione pure farò, e sia questa per la pura verità in discolpa de’ miei scrittori del foglio, cioè che se sono trascorsi molti errori di stampa, non è certamente da attribuirsi ad altra cagione se non se a ciò che gli autori del Caffè sono in Milano e la stampa è stata fatta in Brescia; supponete che un errore sfugga dalla penna all’autore, due altri ve ne aggiunge a dir poco il copista, tre per lo meno ve ne accresce il compositore della stampa: sommate, e sono sei spropositi; voglio concedere che il correttore ne tolga tre, restano tre da distribuirsi ai lettori col foglio. In questa materia poi io ho sempre veduto che il torto cade sul conto dello stampatore, com’è di ragione, poiché gli autori scrivono le loro discolpe, e lo stampatore fedelmente le stampa, senza aggiungervi nulla del proprio; e con questa luminosa verità bibliografica io mi prendo congedo da’ miei lettori, e chiudo questo primo tomo.
Fine del tomo primo
NOTE
[1] John Nikolls, Remarque sur les avantages et les désavantages de la France et de la Grande-Bretagne. A Dresde 1754.
[2] In Geremia.
[3] Amsterdam, chez Marc-Michel Rey. 1762.
[4] Le gentil homme cultivateur, à Paris chez P.G. Simon, rue de la Harpe. A Bordeaux chez Chapuis l’ainé. 1763.
[5] Copenaghen 1758.
[6] Edimburgo, presso Donaldson, e si vende in Londra da Millar.
[7] Nei mesi di maggio e di giugno.
[8] A Paris 1752.
[9] Stampato l’anno 1718.
[10] Giornale di commercio del mese di maggio 1759.
[11] Amsterdam 1720, in 8°, ed in Venezia presso l’Albrizzi.
[12] Strasbourg 1737, ed in Venezia presso Colleti.
[13] In Parigi, presso Guerin e de la Tour, 1758.
[14] A Paris 1758, chez Dessaint, rue S. Jean de Beavais.
[15] A Paris, chez Nyon, Quei des Augustins, 1758.
[16] Si vende a Lyon chez Jean Marie Bruyset, rue Merciere au Soleil d’or.
[17] Opera sortita dai torchi di Gleditsch in 8°.
[18] Stampati in Berlino presso Volf.
[19] Vide Sigonium, De antiquitat. iur. civil. Romanor., lib. I, cap. XIV.
[20] Parlasi di virtù puramente umana.
[21] Questo fatto, tuttoché strano, io lo suppongo vero, poiché ragiono sopra i dati che mi somministra la storia, senza entrare in un critico esame; lo riferisce Dionigi d’Alicarnasso, lib. V, cap. I.
[22] Plinius, H. N., l. 8, cap. 60, § ultimi.
[23] Ciò si cava dalle storie; che che ne sia della verità dell’esistenza di Romolo, Numa ec., e dell’incertezza in cui siamo di discernere le favole dalle storie di que’ tempi.
[24] Quanto mai pensa male chi così pensa. La libertà dunque non sarà più carattere di nobiltà? Ma Montesquieu è stato un grand’uomo, più forse per i grandi errori che per le sagge riflessioni che ha fatto.
[25] Si parla con i sentimenti di Montesquieu, per altro non si adottano, perché resterà sempre indeciso qual sia la forma migliore di governo, e non può se non adattarsi l’uomo savio al governo sotto cui vive, e crederlo il migliore.
[26] Esprit des loix, liv. 2, chap. 4; liv. 5, chap. 9; livr. 6, chap. 1; liv. 8, chap. 9; liv. 11, chap. 6.
Le sopraddette note a e b non sono degli autori del foglio.
[27] Vedi Voltaire, Pensées sur l’administration publique, et le chapitre de la noblesse dans l’Histoire générale, e Remarques d’un anonyme sur l’Esprit des loix.
[28] La confessione sincera d’alcuna di queste verità sfuggì allo stesso cardinale de Luca, il quale asserisce “d’avere praticato molti insigni giurisconsulti, per le mani de’ quali sono passate infinite cause di fedecommessi, i quali vedendo e praticando tante cabale e tanti inconvenienti, che da ciò risultavano, gli hanno avuti in abborrimento nelle loro disposizioni”.
[29] Nova methodus jurisprudentiae, p. m. 56.
[30] Esprit des loix, lib. 25, chap. 13.
[31] Dion. Halicar., lib. 2; Tit. Liv., lib. 8, cap. 20, 28; Seneca, epist. 88; Cicer., In Verr., 7. Romolo non permise che due professioni agli uomini liberi, l’agricoltura e la milizia: i mercanti ed i operai non erano nel numero de’ cittadini. Dion. Halic., lib. IX; Cicer., De off., lib. I, cap. 42. Quindi presso i latini scrittori commerciante, operaio e barbaro suonavan lo stesso. An quidquam stultius quam quos singulos sicut operarios, barbarosque contemnas, eos aliquid putare esse universos? Cicer.,Tusc. quaest., lib. V. E nel Codice, l. 5, De naturalibus liberis, si confondono indistintamente la donna quae mercimoniis publice praefuit e la schiava, l’istriona e la scostumata. Veggasi Considerations sur la grandeur et la decadence des Romains, cap. X, e l’Exprit des loix, lib. XXI, cap. X.
[32] Multorum camelorum onus. Eunapius in Vita Aedes., p. 92.
[33] Leges autem redigere in libros: primus consul Pompeius voluit, sed non perseveravit obtrectatorum metu. Isidorus Hispan., Orig., lib. V, cap. 1.
[34] Procopius, Historia arcana.
[35] Eodem.
[36] Eodem.
[37] Procopius, Historia arcana.
[38] Donec igitur populus pro colorum nominibus inter se dissidebat, nulla erat ratio eorum qui in Rempublicam peccabant. Procopius, De bello persico.
[39] § 1 Institutionum.
[40] Iustinianus imperator ex omnibus rebus per suos egregie gestis etc. Agath., Histor., lib. V.
[41] Procopius, Historia arcana. Agathia, Histor., lib. V, dice lo stesso.
[42] Nec Belisario ut triumpharet permisit. Procop., De bello goth., l. III.
[43] Agath., lib. V Histor.
[44] L. 2, § 1 Cod., de veter. iur. enucl.
[45] Il signor Hommel in un suo libro intitolato Letteratura iuris etc., cap. XXII, calcola che il numero degli autori legali monta a quindici mila, ed i libri legali grandi e piccoli a ventimila. Così pure ricavasi dall’indice nominale di Lipenio e dalla Biblioteca legale del Fontana. Con un conto esatto al dì d’oggi si troverebbe che sono anche di più.
[46] L. 5, C., ad L. Iuliam Maiestatis.
[47] L. 2, C., de fratric.
[48] L. 1, § 6, C., de vet. iur. enucl.
[49] L. 2, C., de iur. immunit.
[50] Procop., De bello persico, lib. I.
[51] L’Editto perpetuo è la collezione degli editti de’ pretori, che commentarono i giure-consulti romani, parte de’ quali commenti, che qui disapprova Giustiniano, sono tuttavia ne’ Digesti fatti da lui compilare. Osservisi, per esempio, Paulus ad Edictum, Vulpianus ad Edictum, etc.
[52] Lib. 1, C., de iudiciis.
[53] Cicer., Ad Att., l. VI, ep. I, pag. 136, cum notis variorum.
[54] Medicamentorum autem usum ex magna parte Asclepiades non sine caussa sustulit; et cum omnia fere medicamenta stomachum laedant malique succi sint, ad ipsius victus rationem potius omnem curam suam transtulit. Celsus, lib. V, cap. 1.
[55] La medicina pulsoria è talmente radicata presso a’ Chinesi, che giungono talvolta a predire dal polso un malore che il medico stesso cerca a far nascere poi, acciocché la predizione non rimanga senza effetto; e veggasi su di ciò Memoir. de la Chine del padre Le Comte, alla lettera ottava. Galeno, De crisib., al lib. 3, cap. undecimo, assicura che Ipocrate non avea fatto mai gran caso del polso, sia che non lo conoscesse, sia che non lo credesse (il che è più verosimile) un mezzo sicuro per conoscere le malattie. Eroffilo poi, per testimonianza di Plinio, lib. 29, cap. 1, e lib. undecimo, cap. 38, portò la pazzia pulsoria a segno d’asserire che era necessaria cosa a un medico l’esser musico e geometra per conoscere perfettamente il polso.
[56] Nel celebre giuramento che Ipocrate esiggeva dagl’iniziati nella medicina, stanno rinchiusi tutti i più providi precetti dell’onestà da praticarsi da un medico.
[57] In hac artium sola evenit, ut unicuique se medicum profitenti credatur. Plin., lib. 29, cap. 1.
[58] Malebranche.
[59] Omero dipinge Andromaca a far opere di ricamo. Elena faceva ricchi tapeti. Teocrito, Terenzio e Virgilio e tutti gli autori sacri e profani sono d’accordo su la vita laboriosa ed attiva delle femmine.
[60] Augusto, per rapporto di Svetonio, non portava altri abiti che quelli fatti dall’imperatrice o da sua sorella.
[61] Un profeta dà il nome di colomba alla famosa Semiramide.
[62] Non est ira super iram mulieris.
[63] Il signor abate Coyer, nel libro intitolato La noblesse commerçante, ha scritto con molto spirito di patriotismo su di questo argomento, e le sue ragioni non hanno difficoltà presso gli uomini di buon senso. Vi fu risposto dal cavaliere d’Arc nel suo libro intitolato La noblesse militaire. L’amore del ben pubblico e la buona fede è eguale in tutte due le opere, ma non lo sono le ragioni. Se taluno fosse persuaso che queste brevi riflessioni siano una rapsodia di quell’opera del signor abate Coyer, io gli dirò una cosa che non vorrà credere, cioè che io ho letta quell’opera dopo di aver scritti questi miei pochi periodi. La lettura di quel libro non ha molto offeso il mio amor proprio, poiché nell’istesso tempo che ne ho ammirato il merito, ho veduto che, per quanto in alcune cose ci siamo incontrati, pure la meta che ci proponevamo era differente. Egli agita la questione: se la nobiltà francese debba essere militare o commerciante. Io non parlo né della nobiltà di Francia, nella quale concorrono circostanze particolari che non sono in altri paesi; né se la nobiltà debba essere militare, o commerciante. Ma soltanto se debba commerciare in generale. Egli in somma ha scritto per la sola Francia, io scrivendo non vi ho neppure pensato.
[64] Cicero, De officiis, lib. I.
[65] Vedi L. Iustissime 44. Proponitur ff. de aedilit. aedict. – L. unic. C. de perfectissimis dignitatibus. – L. Milites 15. C. de re militari. – L. Milites 3. C. de locat. – L. 1. C. de praepos. agent. in rebus. – L. cohortales 12. C. de cohortalibus. – L. Umilem. 7. de incestis nuptiis. – Toto titulo C. Negot. ne milit. – L. 3. C. de commerciis et mercatoribus. – L. 6. C. de dignitatibus. – L. ult. de rescind. vendit. etc.
[66] Vedi Esprit des loix, liv. XX, chap. XXII.
[67] Liv. V, chap. VIII.
[68] Xenophon, Cyroped., lib. 8.
[69] Ioseph., Antiquit. iudaic., lib. 11, cap. 6.
[70] Herodot., lib. 8, cap. 98.
[71] Plutarch., lib. 1, De fortuna Alexand.
[72] Xenophon., Cyrop., lib. 1.
[73] Ibid., sect. 2.
[74] Strabo, lib. 7. Aristot., Polit., lib. 1, cap. 10.
[75] Thucid., lib. 1.
[76] Marmor. Arundell., n. 5.
[77] Livius, lib. 31, cap. 24.
[78] Corn. Nep., in Miltiade.
[79] Liv., lib. 31, cap. 24, an. 552 ab u. c.
[80] Plin., lib. 7, cap. 20.
[81] Varen., Geograph. gen., lib. 1, cap. 2.
[82] Plin., lib. 7, cap. 20.
[83] Plin., lib. 7, cap. 20.
[84] Buffon, Hist. nat. de l’age viril de l’homme, tom. 2, in 4°, pag. 552.
[85] Buffon, Hist. nat. du cheval, tom. 4, in 4°, pag. 232.
[86] Liv., lib. 37, c. 7.
[87] Lib. 3, De bello civ.
[88] Senec., epist. 88 e 123. Tacit., Hist., lib. 2, c. 42 et ibi adnot.
[89] Appian. in Mitrid.
[90] Liv., lib. 36.
[91] Sveton., cap. 57.
[92] Sveton. in Aug., c. 49.
[93] Gothofred., Ad Cod. Theod. tit. De cursu publico, leg. 1.
[94] Aurelius Victor, De Traiano, cap. 13. Spartian. in Adriano, cap. 7. Gothofred., Ad Cod. Theodos., ubi supra.
[95] Capitol. in Antonino, c. 12. Gothofr., ubi supra.
[96] Spartian. in Severo, c. 14. Gothofr., ubi supra.
[97] Vedi pure il titolo De cursu publico del Codice di Giustiniano, in cui sono molte leggi che si trovano nello stesso titolo del Codice teodosiano.
[98] Procop., Hist. arcan., c. 30.
[99] Libanius, Orat. in Iuliani necem.
[100] Cassiodor., variant. 47. V. variant. 5 et 39.
[101] Voltaire, Essai sur l’hist. gen., tom. 2, chap. 80.
[102] Tabet, Inter paradoxa regum, p. 112.
[103] Moreau, Tableau etc., chap. 2.
[104] Sleidan, De stat. relig., lib. I.
[105] Veggasi la bell’opera del signor Genovesi che ha per titolo: Storia del commercio della Gran Bretagna, stampata in Napoli, in-8°, tomi tre. Egli attesta questo fatto al tomo 1, pag. 134. Io vorrei trovare espressioni tali da invogliare i miei lettori a provvedersi di quell’opera eccellente del signor Genovesi, la quale sola basta a somministrare una cognizione molto estesa sul commercio. La lettura di quest’opera è molto utile, amena e interessante.
[106] Gli Ottentoti, dice un celebre autore, non vogliono né ragionare né pensare; pensare, dicon essi, è ’l tormento della vita. Quanti Ottentoti fra noi!
Questi popoli s’abbandonano interamente alla pigrizia. Per sottrarsi ad ogni sorta di fatiche ed affari si privano di tutto ciò che loro non è assolutamente necessario. I Caribbei nudriscono la medesima aversione al travaglio ed al pensare; si morrebbono piuttosto di fame, che prepararsi il pranzo. Le loro mogli fanno di tutto. Essi lavorano la terra solamente di due giorni l’uno per due ore e passano il restante del tempo sdraiati su d’un fogliame. Vuolsi comprare il loro letto? Lo vendono la mattina a buon mercato, né prendonsi pena di pensare che ne avranno bisogno la sera.
[107] Cardano ed altri riferiscono d’averne veduti che segnavano distintamente le ore, e ad ogni ora suonavano un colpo. Cardanus, De subtilitate, lib. 2 e 17; e l’articolo Montre del Dictionnaire du commerce par Mr. Savary.
[108] Vedasi Mr. Derham, le Roy, Thiout, Berthoud e massime il P. Allexandre, Traité général des horloges, e Mr. le Paute.
[109] Come quello di Strasburgo, ec.
[110] Mr. Pluche, Spectacle de la nature, t. 5, chap. De la gnomonique.
[111] Voltaire.
[112] Extrait des historiens chinois par Mr. le Roux de Hautes-Rayes.
[113] Vedi Mr. Montucla, Histoire des mathématiques.
[114] Polydor. Virgil., De rerum inventorib., l. 2, c. 5.
[115] De l’origine des loix, des arts et des sciences, t. 2, liv. 3, chap. 2, art. 2.
[116] Gnomone dicesi quello stilo grande o piccolo, dalla cui ombra raccogliesi quando sia mezzo giorno e quando il Sole arrivi alli due tropici.
[117] Memoires de l’Acad. des Inscript., t. 3.
[118] Plin., Histor. natur., l. 36, cap. 9 et 10.
[119] Della maniera colla quale probabilmente gli antichi scoprirono la linea meridiana, vedasi Maupertuis, t. 3 Elémens de géographie, art. 1.
[120] Goguet, De l’origine etc., t. 3, liv. 3, chap. 2, art. 1.
[121] L. 2 , n. 109.
[122] L. 4 Regum, c. 20, et Isaiae, c. 38.
[123] 4 Regum, c. 16.
[124] Hist. natur., l. 2, c. 76.
[125] De rerum inv., l. 2, c. 5.
[126] In Anaximandro.
[127] Salmasii Plin. exercit., pag. 646 etc.
[128] Petavius, De doctrina temporum, t. 3, l. 7, c. 7 et 8.
[129] Montucla, Histoire des mathématiques, t. 1, part. 1, l. 3, p. 5.
[130] Plin., Polid. Virg., l. c., ed altri.
[131] Censorinus, De die natali, c. 19.
[132] Plin., Hist. nat., lib. 7, c. 60 et Polyd. Virg., l. c.
[133] Plin., Hist. nat., lib. 36, c. 9 et 10.
[134] Montucla, l. c.
[135] Mr. le Gendre, Traité de l’opinion, t. 1, lib. 1, p. 2, c. 2.
[136] Cassiodor., l. 1, epist. 45.
[137] I nostri cruscanti non amano che ci si serva di que’ vocaboli che i periti dell’arte o addottaron da’ Greci o produssero per disegnare le diverse sorti d’oriuoli. Essi hanno a voci proprie ed espressive sostituito un nome generico: così dicesi in italiano oriuolo a acqua, oriuolo a Sole, oriuolo a contrappeso, oriuolo a polvere, oriuolo a molla, oriuolo portatile, senza che vi siano i termini toscani esprimenti queste diverse spezie. In questa maniera, oltre il difetto di monotonia per il terminare che fanno sempre le nostre voci in vocale, vi sarà ancora il difetto di ripetizione di termini; cioè monotonia di lettere e monotonia di parole.
[138] Vitruv., lib. 9, c. 9.
[139] Montucla dove sopra.
[140] Ozanam, Recréations mathématiques, t. 2, à la fin.
[141] P. Alexandre, Traité général des horloges, c. 2.
[142] Recueil d’ouvrages curieux de mathématique et de mécanique, ou description du cabinet de Mr. le Chevalier de Serviere, part. 2.
[143] De rerum invent., l. 2, c. 5 et lib. 3, c. 18.
[144] Antiqua deperdita et nova reperta, p. 2, tit. 10.
[145] Vedi Berthoud, Derham, Allexandre, Montucla e l’Histoire de France du Président Hénault.
[146] Genebrard, Chron., lib. 4, pag. 564, et Bozius, De signis Ecclesiae Dei, lib. 22, c. 5, 94, et Ditmarus Mersburgensis in Magdeburgensi chronico, l. 6.
[147] Metropolis Remensis historia, t. 2.
[148] Benedicti Haefteni Monasticae disquisitiones, l. 7, tract. 3, disqu. 1, et tract. 9, disqu. 1 et 2.
[149] Rerum italicar. scriptores, tom. 18.
[150] Raccolta delle esperienze fatte nell’Accademia del Cimento, p. 21.
[151] De horologio e De horologio oscillatorio.
[152] Vedi P. Schotti Soc. Iesu Technica curiosa seu mirabilia artis, l. 9, c. 4, prop.12, e l’articolo Equation, Horlogerie de l’Encyclopédie.
[153] Journal des savans du 15 fevrier 1675, e l’articolo Montre del Dizionario del commercio di Savary.
[154] Articolo Horloge du Dictionnaire du commerce par Mr. Savary.
[155] Derham, Traité de l’horlogerie, sect. 5, chap. 11, p. 2.
[156] Il n’est guères possible (dice un celebre fabbricatore d’oriuoli) d’ajouter beaucoup à la perfection actuelle des montres ni d’en répondre si ce n’est à un minute par jour. Leur exactitude est donc bien moindre que celle des pendules à secondes, puisqu’on peut repondre de celles-ci à une minute par année. Voyez Description de plusieurs ouvrages d’horlogerie par le Sr. le Paute.
[157] Regle artificielle du tems.
[158] Cioè l’arte di far orologi solari. Vedi la Gnomonica del P. Cristoforo Clavio, P. Des Chales, P. Alessandro, la Hire, e l’Enciclopedia all’articolo Cadran, e Montucla, Histoire des mathématiques, t. 1, par. 3, liv. 4, p. 12.
[159] Montucla, ubi supra, l. 1, p. 8.
[160] Vedi il suo Essai sur l’horlogerie, in 2 tomi in 4°.
[161] Connoissance des mouvemens célestes pour l’année 1765, par Mr. de la Lande, p. 222.
[162] Plin., Histor. natur., l. 2, c. 77; Plutarc., Quaestiones romanae, quaest. 84; Aul. Gell., Noct. Attic., l. 3, c. 2, che rapporta Varrone e Virgilio; Censorinus, De die natali, c. 19; Macrobius, Saturnal., c. 3; Cuiacius, t. 1 De diversis temporum praescriptionibus et terminis, et t. 5 ad lib. 1; Pauli ad Edictum ad § 2, l. 2 de verb. signif., et t. 8 et 10 ad eandem l. 2 ; Christophori Clavii e Soc. Iesu Gnomonices; Des Chales e Soc. Iesu, Gnomonic., t. 3, tract. 27; P. Petav. e Soc. Iesu, De doctrina temporum, l. 7, c. 1 ec.; e perciò che risguarda giorno naturale, civile ed artificiale, Mr. Bayle, Dissertation sur le jour.
[163] Vedi Regle artificielle du tems par Mr. Sully.
[164] L’ora dividesi in sessanta minuti, che diconsi minuti primi; ciaschedun di questi sottodividesi in 60 minuti secondi, e così andando avanti. I minuti primi s’esprimono con una picciola linea; i secondi con due linee; i terzi con tre; così ore 2.36’.4’’.45’’’ significa ore due, trentasei minuti primi, quattro minuti secondi e quarantacinque minuti terzi. Queste ore 23.56’.4’’ che impiega la fissa a compiere il suo giro, sono da regolarsi sull’oriuolo regolato al tempo medio, in modo che il Sole fingesi per un di mezzo ritardare costantemente sopra la fissa min. 3’.56’’. Vedansi gli scrittori d’astronomia, ec.; in particolare Leçons elémentaires d’astronomie par Mr. de la Caille, n. 483, etc.
[165] Vedasi il celebre argomento detto d’Achille, all’articolo Zenon d’Elée: Dictionnaire critique, remarque F à la 3e objection.
[166] L’apogeo della Terra, ossia la maggiore sua lontananza dal Sole, non è nel primo punto di Granchio, ma a 8 gradi del detto segno; così il perigeo, o la minima lontananza dal Sole, è a 8 gradi di Capricorno; però la massima velocità non è nel solstizio, ma otto giorni dopo. Tralascerò non ostante di computare questa differenza e seguiterò a citare il solstizio d’estate e quel d’inverno, giacché una maggior esattezza d’espressioni non farebbe che imbrogliare chi non è abituato nell’astronomia.
[167] Non saprei come meglio far intendere cosa vogliasi dire l’aia proporzionale a’ tempi che usando le parole d’un grande scrittore, che avendo unita la chiarezza dell’espressione alla giustezza delle idee onora moltissimo la nostra Italia, e più ancora que’ principi d’oltremonti che ’l vollero alla loro corte e ’l tennero in gran pregio. Il conte Algarotti, dunque, nel I tomo delle sue Opere, Dialogo 5 sopra l’ottica newtoniana, così scrive: Figuratevi un corpo che gira intorno ad un altro, che del suo moto si può dire il centro; e figuratevi ch’e’ giri non già per un cerchio perfettamente tondo, ma che abbia un po’ del bislongo; di maniera che esso centro non sia giusto nel mezzo del cerchio, ma si rimanga un poco da un lato. Segniamo ora colla fantasia un punto del cerchio, dove in questo istante si trovi il corpo che gira. Da quel punto figuratevi tirato un filo o sia una linea al centro; similmente dal punto dove sarà per esempio due ore appresso, tiratene un’altra. Quello spazio triangolare che resta compreso tra le due linee che si stendono dal corpo che gira sino al centro e la porzione di cerchio da lui corsa nelle due ore, chiamasi aia. E queste tali aie, che girandosi il corpo sono formate in tempi uguali, sono uguali tra loro. Così che voi chiaramente vedete, madama, ch’esso ora va più veloce, e ora meno, e in tempi eguali non avrà già corso due porzioni di cerchio eguali, ma due porzioni di cerchio tali che le aie, formate nel modo che abbiam detto, verranno ad uguagliarsi tra loro ec.
[168] Intendo qui e dappoi per tempo di 24 ore quel tempo che passa da un mezzo dì all’altro ne’ giorni medi.
[169] Essai sur l’horlogerie, t. I, tab. I, II, III, IV.
[170] Vedi il detto articolo, che succede a quello Equation di Mr. d’Alembert.
[171] Connoissance des tems.
[172] Connoissance des mouvemens célestes.
[173] Regle artificielle du tems.
[174] Traité général des horloges.
[175] Vedi Thiout, Berthoud e l’articolo Equation, Horlogerie nell’Enciclopedia.
[176] Ho calcolata la lunghezza de’ giorni ne’ solstizi e negli equinozi per l’orizzonte astronomico di Milano, non per il nostro orizzonte fisico. Se però alla lunghezza de’ giorni da me indicata si aggiunga circa tre quarti d’ora negli equinozi ed un’ora circa ne’ solstizi, principalmente a quello di dicembre, s’avrà la lunghezza de’ giorni apparente in quelle stagioni. La diversità delle accennate quantità di tempo, che devesi aggiungere al giorno astronomico per avere la quantità giusta del giorno apparente, proviene dalla differenza delle rifrazioni orizzontali dell’atmosfera terrestre, maggiore in inverno che in estate.
[177] Ogni cerchio dividesi in 360 gradi. Ogni grado in 60 minuti primi. Ognuno di questi in 60 minuti secondi.
[178] Vedi des Chales, Gnomonica, t. 3, tract. 27 , et lib. 1, propos. 17, tract. 25.
[179] Su di quest’argomento chi voglia erudirsi più ampiamente vegga Nieuport, Rituum qui apud Romanos obtinuerunt; Du Bos, Reflexions sur la poesie et la peinture, tom. III; ed il Trattato sul teatro italiano del Riccoboni.
